Il caso Scurati è archiviato. Intendo proprio archiviato, cioè, negli anni nei decenni e nei secoli si troverà negli archivi che il capo del governo italiano, anno 2024, non ha gradito un monologo sul 25 aprile (è domani! Evviva!). Dico archiviato proprio nel senso che se ne troverà traccia per sempre, dal Guardiana Le Monde, dalla Frankfurter Allemaigne al Times, e giù per li rami, fino al Mongolian Monitor o Philippine Today, insomma una notizia di portata mondiale anche se non è una notizia: ai fascisti non piace l’antifascismo, fingiamo stupore.
 Lasciamo i dettagli ai bravi cronisti, ai Mazzinologi, intesi come esegeti del potere a viale Mazzini, con appena una notazione in margine. Con la sua telefonata ai gerarchi del servizio fu pubblico in cui Giorgia Meloni ha fatto notare che dovevano metterla subito sui soldi – cioè infangare uno scrittore perché non lavora gratis, e diventa ricco con la Resistenza (ahah, ndr) – la capa del governo ha certificato una sua propensione in scienze e tecniche della censura. Cioè: non ha cazziato i suoi perché l’avevano fatto, ma perché l’avevano fatto male, maldestramente. Infangare il censurato, delegittimare chi dice una cosa sgradita, pungerlo in un punto che non riguarda le sue parole, ma tutto il resto, per quanto grottescamente strumentale e belluino, è esattamente un metodo fascista. Quindi, per paradosso, Meloni ha rimproverato i suoi non già di aver fatto un autogol, ma di non aver applicato un metodo; non di aver bastonato, ma di aver bastonato male, da dilettanti.
Lasciamo i dettagli ai bravi cronisti, ai Mazzinologi, intesi come esegeti del potere a viale Mazzini, con appena una notazione in margine. Con la sua telefonata ai gerarchi del servizio fu pubblico in cui Giorgia Meloni ha fatto notare che dovevano metterla subito sui soldi – cioè infangare uno scrittore perché non lavora gratis, e diventa ricco con la Resistenza (ahah, ndr) – la capa del governo ha certificato una sua propensione in scienze e tecniche della censura. Cioè: non ha cazziato i suoi perché l’avevano fatto, ma perché l’avevano fatto male, maldestramente. Infangare il censurato, delegittimare chi dice una cosa sgradita, pungerlo in un punto che non riguarda le sue parole, ma tutto il resto, per quanto grottescamente strumentale e belluino, è esattamente un metodo fascista. Quindi, per paradosso, Meloni ha rimproverato i suoi non già di aver fatto un autogol, ma di non aver applicato un metodo; non di aver bastonato, ma di aver bastonato male, da dilettanti.
Per paradosso, alle voci favorevoli alla censura (tutta la stampa di destra del Paese, con l’eleganza che la contraddistingue) se ne uniscono alcune ambigue per altri versi. Una vulgata che vuole la censura come inefficace e stupida perché otterrebbe l’effetto opposto, cioè: ah, che fessi i censori, finiscono per diffondere ciò che volevano bloccare. E’ un argomento molto scivoloso, perché noi non sapremo mai quanti e quali episodi di censura sono andati invece a buon fine, quali pressioni hanno funzionato (si suppone decine, centinaia) a fronte di un caso che è arrivato all’onore delle prime pagine. E’ la storia dell’iceberg, di cui vediamo la punta, ma se non siamo scemi sappiamo che là sotto c’è una gran massa che non si vede.
In un bel volume di Riccardo Cassero (Le veline del Duce, come il fascismo controllava la stampa, Sperling & Kupfer, 2004) si può cogliere fior da fiore da quella prepotente idiozia che fu la censura ai tempi del Puzzone. Deliziosi scampoli di prosa come “Continuare a non toccare l’argomento delle code davanti ai negozi per l’acquisto di vari generi” (13 febbraio 1941). Oppure: “Non parlare per ora di richieste di aumenti di stipendio degli impiegati” (9 marzo 1939), e via così, in un florilegio esaltante di divieti, ammonimenti, minacce, esilaranti noterelle di vita e costume: “Non dev’essere assolutamente recensito il libro di Eleonora della Pura ‘Lo scolaro Benito Mussolini’” (23 giugno 1938), o anche “Basta con Greta Garbo!” (14 marzo 1938).
Oggi i mezzi sono più raffinati, certo, ma non meno ridicoli e violenti. Per difendersi, bisognerebbe tenere conto che per una censura che va a vuoto ce ne sono mille che vanno a segno, e che il censore esiste non perché ogni tanto fa una figura di merda, ma perché spesso riesce nel suo intento. Insomma, bisognerebbe stare più attenti non solo a quello che si dice, ma anche a quello che non si può dire, e infatti non si dice. E’ antifascismo anche questo. Buon 25 aprile.
-
 E così, la nuova Alfa Romeo, cambia nome prima ancora di nascere, come quei bambini che secondo la nonna dovevano chiamarsi Mario e invece no, li chiamano Kevin, o Deborah con l’acca. Bene, una vittoria del made in Italy, anche se non è andata proprio così, e la cosa fa ancora più ridere. Sì, perché la nuova Alfa – fatta in Polonia, a Tychy – doveva chiamarsi “Milano”, ma Adolfo Urso, che si fregia (“me ne fregio!”) del titolo di ministro del Made in Italy, si è un po’ imbizzarrito sostenendo che non si può chiamare “Milano” una cosa fatta a ottanta chilometri da Cracovia, sacrilegio. E allora, in segno di distensione e “per promuovere un clima di serenità” (testuale), l’Alfa Romeo la chiamerà “Junior”. Il ministro Urso ha detto che “è una buona notizia” (testuale). Cioè, la nuova Alfa continueranno a farla in Polonia, ovvio, pagando stipendi polacchi, ovvio, ma non subiremo l’affronto di sentirla chiamare con il nome di una città italiana. Non sentite anche voi questo profondo sollievo?
E così, la nuova Alfa Romeo, cambia nome prima ancora di nascere, come quei bambini che secondo la nonna dovevano chiamarsi Mario e invece no, li chiamano Kevin, o Deborah con l’acca. Bene, una vittoria del made in Italy, anche se non è andata proprio così, e la cosa fa ancora più ridere. Sì, perché la nuova Alfa – fatta in Polonia, a Tychy – doveva chiamarsi “Milano”, ma Adolfo Urso, che si fregia (“me ne fregio!”) del titolo di ministro del Made in Italy, si è un po’ imbizzarrito sostenendo che non si può chiamare “Milano” una cosa fatta a ottanta chilometri da Cracovia, sacrilegio. E allora, in segno di distensione e “per promuovere un clima di serenità” (testuale), l’Alfa Romeo la chiamerà “Junior”. Il ministro Urso ha detto che “è una buona notizia” (testuale). Cioè, la nuova Alfa continueranno a farla in Polonia, ovvio, pagando stipendi polacchi, ovvio, ma non subiremo l’affronto di sentirla chiamare con il nome di una città italiana. Non sentite anche voi questo profondo sollievo?
Se volete provare un altro grande sollievo a proposito del made in Italy e della gioia di produrre in Italia merci italiane, potete fare un viaggetto in Lombardia, alle porte di Milano (pardon, Junior) e precisamente ad Arese, dove c’era un tempo il grande stabilimento dell’Alfa Romeo e ora c’è il centro commerciale sedicente più grande d’Europa. Nel 1982, anno di massima occupazione, lavoravano lì dentro 19.000 operai, e oggi, se va bene, ci lavorano trecento commesse. Una prece.
Che il ministro Urso fosse nei giorni scorsi in trance agonistica si spiega con una grande celebrazione, cioè la prima giornata del made in Italy, una data ricca di eventi, celebrazioni, manifestazioni su quanto siamo bravi noi e pippe tutti gli altri, fissata non a caso il 15 aprile, il giorno del compleanno di Leonardo Da Vinci, uno che tra l’altro finì a lavorare in Francia, non fa una piega.
Tra le norme sollevate per convincere Alfa Romeo a cambiare il nome della sua macchina ci sono quelle sull’italian sounding, che si chiama proprio così, in inglese, per dire che non solo il made in Italy va fatto in Italia, ma che non si può nemmeno fare i furbetti richiamando vagamente nomi italiani, bandierine, tricolori, parole, Colossei e torri di Pisa o cose così, tipo il formaggio Parmesan. Che le due espressioni che ci difendono dai cattivi stranieri che fingono di produrre cose italiane siano in inglese (“made in Italy” e “italian sounding”) fa un po’ ridere anche quello, ma non ci scandalizzeremo essendo un paese di crazy.
Di italian sounding, comunque, ha parlato anche la capa del ministro Urso, il/la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla fiera del vino di Verona, con i soliti toni volitivi e mascelluti: “Saremo implacabili contro chi pensa di usare il nome italiano per vendere prodotti che non hanno l’eccellenza che l’Italia può vantare”. Implacabili contro il vino “Barollo” (due elle) venduto in America, o il formaggio “Parmesao” che impazza in Brasile. Spezzeremo le reni all’aceto “Deutscher Balsamico”, insomma, lo inchioderemo sul bagnasciuga, nessuna pietà.
Il tutto mentre le aziende italiane ce le comprano i francesi (moda e lusso), gli spagnoli (cibo), gran parte del patrimonio immobiliare della città di Milano è in mano a fondi d’investimento de Quatar, le due grandi squadre di calcio della città di Junior sono una cinese e l’altra americana, e negli ultimi dieci anni oltre 400 mila giovani italiani tra i 20 e i 34 anni sono andati a vivere all’estero. Insomma, in made in Italy è bello, ma non ci vivrei.
Ehi, voi! Il 4 maggio la compagnia I Pinguini Theatre (ri)mette in scena “Montabbano sono!”, al Teatro San Leone di Firenze. E’ una commediola che viene da un racconto che stava in un mio vecchio libro (Piovono Pietre, cronache marziane da un paese assurdo) e che il bravo Luca Palli, col mio modesto aiuto, ha trasformato in una pièce per il palcoscenico. La regia è di Pietro Vené, le musiche di Marco Morandi. Poi ci sono gli attori, tutti bravissimi: Pietro Venè, Marco Bartolini, Cristina Bacci, Iacopo Biagioni, Bettina Bracciali, Paolo Gualtierotti, Ilaria Morandi.
Insomma, magari qualcuno vuole andare a teatro, pensa che matto!
Qui c’è il pezzo de La Nazione
 Se ci fate caso quando vogliono tirarvi una fregatura, ma di quelle belle grosse, la battezzano con qualche parola inglese, tipo il Jobs Act, per intenderci. Eccezione notevole, ormai più che ventennale, una fregatura, ma di quelle grosse, battezzata con qualche parola latina: la par condicio. Luminosissimo esempio di brutta legge che andava fatta perché Silvio buonanima aveva le sue tivù, e poi aveva anche le tivù di tutti, cioè quelle pubbliche, e allora si dovette tentare un argine, per quanto risibile, e regolare gli spazi, in modo che non parlasse solo lui. Che oggi si discuta su come modificare quell’obbrobrio per cui se arriva uno che dice A ci vuole per forza uno che dica B è abbastanza logico: tutti tirano la coperta dalla loro parte. Il governo vuole che i suoi ministri siano considerati esterni al meccanismo, per esempio. Cioè in un dibattito potremmo avere la parola del governo, poi la parola di uno di destra, e poi la parola di uno di sinistra (mi scuso per le parolacce), e quindi ecco che avremmo la tris condicio. Poi c’è la proposta Boschi, povera stella, che vorrebbe applicare la par condicio anche ai non politici, cioè praticamente fare un esame del sangue a giornalisti e commentatori, per ammettere ai dibattiti televisivi solo quelli neutri come il sapone per neonati, che non sporchino, che non stiano da nessuna parte, che non rompano i coglioni con le domande, tanto varrebbe mettere un vaso col ficus. Ricorda un po’ quei film americani dove gli avvocati scelgono le giurie: questo no perché è portoricano, questo no perché ha un figlio che fa il marine, questo no perché nel 2013 ha fatto un tweet contro la Leopolda, eccetera eccetera. Piuttosto divertente. Chi decide come e quanto, e in quale nuance o sfumatura un giornalista sia schierato, non si capisce, ma forse ci sarebbe una speciale commissione, e poi una commissione per scegliere la commissione, e in sostanza farei fare tutto alla Boschi, così finalmente si trova un lavoro.
Se ci fate caso quando vogliono tirarvi una fregatura, ma di quelle belle grosse, la battezzano con qualche parola inglese, tipo il Jobs Act, per intenderci. Eccezione notevole, ormai più che ventennale, una fregatura, ma di quelle grosse, battezzata con qualche parola latina: la par condicio. Luminosissimo esempio di brutta legge che andava fatta perché Silvio buonanima aveva le sue tivù, e poi aveva anche le tivù di tutti, cioè quelle pubbliche, e allora si dovette tentare un argine, per quanto risibile, e regolare gli spazi, in modo che non parlasse solo lui. Che oggi si discuta su come modificare quell’obbrobrio per cui se arriva uno che dice A ci vuole per forza uno che dica B è abbastanza logico: tutti tirano la coperta dalla loro parte. Il governo vuole che i suoi ministri siano considerati esterni al meccanismo, per esempio. Cioè in un dibattito potremmo avere la parola del governo, poi la parola di uno di destra, e poi la parola di uno di sinistra (mi scuso per le parolacce), e quindi ecco che avremmo la tris condicio. Poi c’è la proposta Boschi, povera stella, che vorrebbe applicare la par condicio anche ai non politici, cioè praticamente fare un esame del sangue a giornalisti e commentatori, per ammettere ai dibattiti televisivi solo quelli neutri come il sapone per neonati, che non sporchino, che non stiano da nessuna parte, che non rompano i coglioni con le domande, tanto varrebbe mettere un vaso col ficus. Ricorda un po’ quei film americani dove gli avvocati scelgono le giurie: questo no perché è portoricano, questo no perché ha un figlio che fa il marine, questo no perché nel 2013 ha fatto un tweet contro la Leopolda, eccetera eccetera. Piuttosto divertente. Chi decide come e quanto, e in quale nuance o sfumatura un giornalista sia schierato, non si capisce, ma forse ci sarebbe una speciale commissione, e poi una commissione per scegliere la commissione, e in sostanza farei fare tutto alla Boschi, così finalmente si trova un lavoro.
La par condicio, o quel che le somiglia ormai molto vagamente, si applica fortunatamente solo nell’imminenza delle scadenze elettorali e non tutto il resto dell’anno, quando gente che ha il due o il tre per cento – non voglio fare nomi, non è che ce l’ho con Calenda – passa le sue giornate e serate in tivù a pontificare come in una dittatura dell’Asia centrale. In quel caso – e solo quando parli qualcuno che non si allinea – il refrain è un altro, quello intramontabile del “contraddittorio”. Meccanismo geniale e micidiale, per cui ogni affermazione dovrebbe essere corredata da un’affermazione speculare e contraria, pena il drizzarsi in piedi di qualche solerte pipicchiotto che urla: “E senza contraddittorio!”. Suggerirei in questo caso di applicarla a tutto lo scibile umano e ad ogni espressione di pensiero, che so, alla lettura del Quinto Comandamento, “Non uccidere”, dovrebbe intervenire qualche serial killer con i suoi solidi argomenti: “Beh, pariamone…”.
Ciò che si desidera, alla fine, è una neutralità inodore, insapore, vuota, che equipari le cose sensate alle scemenze, i cacciaballe professionali a gente più critica e informata, che comunque potrebbe risultare “schierata” e quindi nemmeno invitata alla festa. Insomma, una difesa preventiva, che serve ad agevolare chi comanda al momento, e che era nata – per paradosso e strabiliante contrappasso – proprio per arginarne lo strapotere di chi comandava in un altro momento, sempre nell’ottica ideologico-tramviaria che non si disturba il manovratore.
Un libro, un film, una musica e altre cosette. L’isola deserta di Chiara Valerio su Radio Tre Rai (audio)
 Ma chissà perché con salari fermi da trent’anni, l’inflazione che si mangia il carrello della spesa, i giornali che invocano la guerra, i diritti in ritirata, la sanità pubblica gravemente ammalata e un dieci per cento della popolazione che balla intorno alla soglia di povertà, gli italiani fanno sempre meno figli. E’ davvero un mistero, porca miseria, chi l’avrebbe mai detto? Vabbé, comunque auguri ai 379.000 piccoletti nati nel 2023, pochi ma buoni, benvenuti! E mentre loro se ne stanno beati e ignari nelle loro culle e carrozzine, noi, qui, dobbiamo fare i conti con i giovani italiani che mancano, dannazione.
Ma chissà perché con salari fermi da trent’anni, l’inflazione che si mangia il carrello della spesa, i giornali che invocano la guerra, i diritti in ritirata, la sanità pubblica gravemente ammalata e un dieci per cento della popolazione che balla intorno alla soglia di povertà, gli italiani fanno sempre meno figli. E’ davvero un mistero, porca miseria, chi l’avrebbe mai detto? Vabbé, comunque auguri ai 379.000 piccoletti nati nel 2023, pochi ma buoni, benvenuti! E mentre loro se ne stanno beati e ignari nelle loro culle e carrozzine, noi, qui, dobbiamo fare i conti con i giovani italiani che mancano, dannazione.
Questo è un problema che ci esporrà a enormi rischi, per esempio quello di leggere altri tweet del ministro Valditara, una specie di incontro di wrestling con la grammatica e la sintassi, dove la grammatica e la sintassi hanno la peggio. Oppure – altro rischio molto sbandierato – di essere vulnerabili ad assalti stranieri all’arma bianca. Nel caso qualcuno ci attaccasse, il nostro esercito è fatto quasi tutto da graduati adipe-muniti, età media altina, reddito basso ma sicuro. Perché, come pare si stia riflettendo negli ambienti della Difesa, non ricorrere ad arruolamenti tra gli immigrati? Una specie di legione straniera, insomma. Non saranno gli “otto milioni di baionette” del Puzzone, d’accordo, ma qualcosa si può fare, e già si ventila – secondo numerose indiscrezioni – di attirare volontari con la promessa della concessione della nazionalità italiana. Insomma, ai “patrioti” che ci governano, che i soldati di truppa abbiano un’altra patria non importerebbe granché. E così assisteremmo al divertente paradosso che se imbracci un fucile ti facciamo diventare italiano, mentre se sei uno straniero – anche nato in Italia – e frequenti le elementari, o le medie, o le superiori, o ti laurei e diventi dottore no, non sei pronto.
Naturalmente non è una cosa nuova, questa di prendere stranieri e di fargli fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare, basta dare un’occhiata a qualunque cantiere, a qualunque consegna di cibo a domicilio, a qualunque lavoro sottopagato, senza formazione e meno ancora diritti. Insomma, al fronte gli stranieri li mandiamo già, fronte interno, basti vedere i funerali dei lavoratori caduti al cantiere Esselunga di Firenze poco più di un mese fa: per quattro quinti di provenienza straniera (Tunisia e Marocco), alcuni fuori da ogni regola, che meriterebbero almeno una lapide: “Caduti sul fronte appalti & subappalti”.
Insomma, la “sostituzione etnica” tanto temuta dal ministro cognato è in atto, e riguarda soprattutto i lavori di merda, rischiosi e sottopagati. Un vero peccato che non si possano mettere gli stranieri a fare anche altre cose che gli italiani non vorrebbero fare. Per esempio i malati. Quel 6,6 per cento di italiani che hanno dovuto chiedere prestiti per pagarsi cure che la Costituzione gli garantirebbe gratis, oppure quei 9 milioni che si dichiarano in difficoltà perché non riescono ad accedere alla sanità pubblica, non potrebbero essere sostituiti da pazienti stranieri? In cambio potremmo dargli la cittadinanza, dopo il funerale. O ancora, oltre al soldato, o all’operaio edile, o al consegnatore di pizze, agli stranieri potremmo affidare anche lavori che gli italiani non sono in grado di fare con i necessari requisiti di “dignità e onore”, come per esempio il ministro del Turismo. E’ possibile che tra Ghana, Togo e altri paesi esotici se ne trovi uno non iscritto al registro degli indagati. Proviamo!
Un po’ di rassegna stampa, due recensioni e un’ottima riflessione di Antonio calabro sul Sole 24 Ore
 “Unire i puntini” è quel famoso gioco enigmistico che consente di tracciare linee tra vari punti apparentemente incongrui per formare un disegno di senso compiuto. E’ anche il mettere insieme indizi e segnali per arrivare a una visione più complessiva (e complessa) della realtà. Così potrebbe capitarvi, con in mano un quotidiano, di tracciare piccole linee mentali tra le prime pagine dense di guerra, minacce di mobilitazioni, invio di truppe, spese militari, carri armati da acquistare al più presto, arsenali da riempire, e le pagine interne, lontane lontane, dove si dice che in Italia (ma anche in Europa, in misura minore) aumenta vertiginosamente la povertà. Per restare alle (brutte) metafore, si può dire che nelle prime pagine si chiedono a gran voce cannoni, e a pagina trenta, o anche più avanti, si registra sommessamente che manca il burro.
“Unire i puntini” è quel famoso gioco enigmistico che consente di tracciare linee tra vari punti apparentemente incongrui per formare un disegno di senso compiuto. E’ anche il mettere insieme indizi e segnali per arrivare a una visione più complessiva (e complessa) della realtà. Così potrebbe capitarvi, con in mano un quotidiano, di tracciare piccole linee mentali tra le prime pagine dense di guerra, minacce di mobilitazioni, invio di truppe, spese militari, carri armati da acquistare al più presto, arsenali da riempire, e le pagine interne, lontane lontane, dove si dice che in Italia (ma anche in Europa, in misura minore) aumenta vertiginosamente la povertà. Per restare alle (brutte) metafore, si può dire che nelle prime pagine si chiedono a gran voce cannoni, e a pagina trenta, o anche più avanti, si registra sommessamente che manca il burro.
Puntuale come le cambiali, infatti, ecco il rapporto Istat che fotografa l’Italia del 2023, un disastro. Il 9,8 per cento degli italiani vive sotto o al limite della soglia di povertà, cioè fatica a procurarsi beni essenziali (era il 9,7 nel 2022, era il 6,9 nel 2014, dieci anni fa). Diventano più poveri anche gli occupati, l’8,2 per cento combatte con il frigo vuoto pur avendo un lavoro, precario, o malpagato, o ridotto in ore e diritti. Quasi un milione di famiglie (944.000) si collocano sotto la soglia di povertà pur avendo un lavoratore dipendente al loro interno, quei lavoratori che la leggenda italiana vuole più protetti e garantiti, una leggenda, appunto.
Si potrebbe continuare per ore, le statistiche sono fonte inesauribile di paragoni, confronti, misurazioni, ma naturalmente non è lì la verità. La verità si può trovare forse nelle facce, nelle vite, nelle storie di fatica quotidiana che fanno donne e uomini sottoposti a questa privazione costante e continua di bisogni e desideri, a questa ingiustizia. Se volete unire i puntini, potete farlo agevolmente: tracciate una linea dritta tra l’abolizione dell’unica misura a sostegno dei “poveri” – il reddito di cittadinanza abolito dal governo Meloni – e i dati sui nuovi poveri, quelli che per anni furono accusati e sbeffeggiati, insultati e derisi perché erano “fannulloni sul divano”. O, se volete un’altra linea dritta, tracciatela tra i poveracci che non possono riempire il frigorifero e gli extraprofitti delle banche (più 80 per cento nel 2023) che si dovevano tassare e poi non se n’è fatto niente, perché le banche hanno una lobby forte, e i poveri no.
Poi ci sono altri puntini da unire, apparentemente più lontani, quelli del vento di guerra che spira tutto intorno a noi. E se andate a vedere da vicino è una faccenda che intreccia geopolitica e finanza, geopolitica e economia, poteri forti e fortissimi, lobby danarose e miliardarie, apparati industriali, politici che di quegli apparati industriali sono solerti camerieri e servitori benemeriti. Chi vuole mandare truppe, comprare più armi, aumentare le spese militari – parlo dei politici, ma anche dell’informazione – è ascrivibile al sistema delle élite. L’Europa – parlandone da viva – che auspica (testuale) “un’economia di guerra” è a loro che pensa e si rivolge, non a quei numeri delle statistiche che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena. Perché la guerra è un affare di ricchi e ricchissimi che pagheranno i poveri. Qui, in Ucraina, in Russia e ovunque. Lo diceva Bertold Brecht, ed è passato quasi un secolo, e i puntini sono ancora tutti lì, praticamente uguali, vergognosamente uguali, bisognerebbe unirli.
 Di tutte le tentazioni fetish che possono aggredire un uomo, potrei scegliere la più bizzarra: diventare calendiano. Certo, sarebbe un problema dirlo agli amici, è più facile confessare di provare piacere a farsi mummificare col domopak, o farsi appendere al lampadario legato come un salame spalmato di senape in grani; sarebbe – per quanto difficile da accettare – più comprensibile, meno ridicolo, ecco. E però non bisogna mai sottovalutare il fascino della trasgressione: diventare calendiano serve a stupire, assicura un’aura di prevedibilissima imprevedibilità che sconcerta, che spiazza. Davanti a una torta di mele, per esempio, un calendiano può mangiarla, usarla per il tiro al piattello, sedercisi sopra o inventarsi qualunque altra azione che ne faccia intuire la creatività un po’ bislacca ma divertente. E’ blu, no è giallo, ma hai detto che è blu!, no è verde! Lo strabiliante daltonismo del calendiano fa in modo che si perdano confini e ancoraggi alla realtà. Insomma, se vuoi essere veramente libero di dire una cosa alla mattina, il contrario nel pomeriggio, tornare a dire la cosa della mattina prima di andare a dormire la sera e svegliarti con un’altra idea, fidati, diventa calendiano, assicura una straordinaria libertà di parola e di indipendenza, specie da te stesso..
Di tutte le tentazioni fetish che possono aggredire un uomo, potrei scegliere la più bizzarra: diventare calendiano. Certo, sarebbe un problema dirlo agli amici, è più facile confessare di provare piacere a farsi mummificare col domopak, o farsi appendere al lampadario legato come un salame spalmato di senape in grani; sarebbe – per quanto difficile da accettare – più comprensibile, meno ridicolo, ecco. E però non bisogna mai sottovalutare il fascino della trasgressione: diventare calendiano serve a stupire, assicura un’aura di prevedibilissima imprevedibilità che sconcerta, che spiazza. Davanti a una torta di mele, per esempio, un calendiano può mangiarla, usarla per il tiro al piattello, sedercisi sopra o inventarsi qualunque altra azione che ne faccia intuire la creatività un po’ bislacca ma divertente. E’ blu, no è giallo, ma hai detto che è blu!, no è verde! Lo strabiliante daltonismo del calendiano fa in modo che si perdano confini e ancoraggi alla realtà. Insomma, se vuoi essere veramente libero di dire una cosa alla mattina, il contrario nel pomeriggio, tornare a dire la cosa della mattina prima di andare a dormire la sera e svegliarti con un’altra idea, fidati, diventa calendiano, assicura una straordinaria libertà di parola e di indipendenza, specie da te stesso..
Anche per questo, mi stupisco che Calenda si ostini a voler guidare un partito e non fondi una religione. I Calendiani del Settimo Giorno sarebbe perfetto, così potrebbero smentire quello che hanno detto il sesto giorno, che era ovviamente diverso da quanto sostenuto nel quinto, ma molto simile alla tesi propugnata il quarto giorno. Il calendario di frate Calenda farebbe da bussola e programma, con consigli per tutti, lezioncine, ditini alzati a mo’ di ammonimento e, naturalmente proverbi che indirizzino i comportamenti dei fedeli, ma in modo sèrio. La codificazione della dottrina non sarebbe un problema: ci sarebbero i dieci comandamenti calendiani, no otto, no, tredici, ventuno, diciassette, no, due. A seconda di come si sveglia Calernda.
E ritengo anche colpevole, nel suo complesso, l’intera informazione italiana che, pur intervistando Calenda copiosamente ogni quarantacinque minuti, ospitandolo diuturnamente in tivù, interrogandolo alla radio e rilanciandone ogni sospiro, non ha veramente capito la grandezza mistica del fenomeno. Calenda è ciò che ogni marito vorrebbe essere, con una scritta al neon sulla fronte: “Cara, non è come sembra”. Invece, risulta che ancora qualcuno lo prenda sul serio, come nel triste caso della Basilicata dove i Calendiani del Settimo Giorno si presenteranno alle elezioni con la destra, perché i Cinquestelle cattivi non li vogliono dopo aver ricevuto ogni tipo di insulto e sberleffo, derisione e reprimenda. Insomma, Calenda voleva scegliere il candidato, e siccome gli hanno detto “Guardi, no grazie, come accettato”, trasmigra in un posto dove il candidato l’ha scelto Meloni, non fa una piega. Del resto questo avviene nel settimo giorno, per l’appunto, mentre nel sesto aveva detto “mai coi Cinquestelle” (dopo aver perso in Abruzzo) e nel quarto aveva detto “Bisogna parlare con Conte” (dopo che gli altri, senza di lui, avevano vinto in Sardegna).
Insomma, fidatevi, fate come me, diventate calendiani, chi l’ha detto che bisogna sostenere la stessa idea per più di due ore? Pensateci!
PS) Leggere questo pezzo vi ha privato di due minuti e quaranta secondi della vostra vita. Direi che per oggi vi siete occupati abbastanza di Calenda, potete passare a cose più serie.
 Insomma, la guerra. La guerra di oggi, anzi le guerre, il genocidio della potenza coloniale israeliana ai danni del popolo palestinese, la carneficina senza fine in Ucraina, le altre guerre sparse per il pianeta (parecchie) che nemmeno arrivano ai media, i massacri, le popolazioni colpite, gli effetti collaterali, fame, malattie, disperazione. La guerra, insomma, che sembra una componente naturale, endemica, delle faccende umane, in qualche modo accettata e – è storia recente e recentissima – benedetta e sostenuta da un apparato informativo che sembra proprio quel che è: l’ufficio stampa della guerra.
Insomma, la guerra. La guerra di oggi, anzi le guerre, il genocidio della potenza coloniale israeliana ai danni del popolo palestinese, la carneficina senza fine in Ucraina, le altre guerre sparse per il pianeta (parecchie) che nemmeno arrivano ai media, i massacri, le popolazioni colpite, gli effetti collaterali, fame, malattie, disperazione. La guerra, insomma, che sembra una componente naturale, endemica, delle faccende umane, in qualche modo accettata e – è storia recente e recentissima – benedetta e sostenuta da un apparato informativo che sembra proprio quel che è: l’ufficio stampa della guerra.
La guerra “giusta”, la guerra “nostra”. Piazzisti.
Strabiliante: non c’è attività umana che non venga letta in termini economici, che non venga analizzata per quel che produce o consuma in termini di ricchezza. Sappiamo tutto di industrie, di mercati, di speculazioni, di guadagni, di dinamiche macroeconomiche di ogni settore, e non sappiamo niente – è una specie di tabù –dell’economia della guerra, di chi la gestisce, di chi ci guadagna, di chi ne fa corebusiness. Il primo a nominare – e in qualche modo a battezzarlo – il “complesso militare industriale” fu Eisenhower, presidente americano che una guerra l’aveva vinta da generale. Correva il 1961 e lui metteva in guardia la prima potenza mondiale proprio da quell’intreccio inestricabile che poi avrebbe contagiato il mondo: la politica, l’industria bellica (nella neolingua tanto in voga da sempre, la guerra si chiama “difesa”), la finanza, alleate a gonfiare un apparato micidiale. Un sistema economico che doveva produrre armi, quindi usarle, quindi costruirne di nuove, quindi spingere sul comparto “ricerca e sviluppo” con esseri umani come cavie. E quindi combattere ogni voce di pace, quindi soffiare su ogni focolaio, su ogni principio d’incendio per farlo divampare.
Dalla guerra “Sola igiene del mondo” della macchietta futurista italiana, si è passati in pochissimi anni alla guerra come “Sola economia del mondo”. Difficile pensare a un comparto economico che aumenta il fatturato in doppia cifra ogni anno ininterrottamente da almeno trent’anni, il cui giro di affari è arrivato (fonte: Sipri, Stockholm International Peace Research Institute) nel 2022 a 2.240 miliardi di dollari l’anno (in vorticosa crescita), il 40 per cento dei quali americani (seguono Cina, che spende un terzo degli Usa, e Russia, che spende un decimo). Non solo armi, ma tutto quel che ne consegue, personale, strutture, ricerca, apparati, informazione. Parliamo insomma della prima industria mondiale, il che dovrebbe chiarire a tutti e per sempre che ogni discorso bellico favorevole a questo o quel conflitto (abbiamo in questi giorni luminosi esempi, quelli che non saprebbero gestire una gelateria ma danno lezioni al papa, per dire) può essere agevolmente letto come un’interessata attività di lobbyng, di sostegno a tassametro, degli interessi tesi alla realizzazione della guerra.
Si parla, infatti, di uno stato di guerra permanente, con vari fronti, con varie declinazioni e vari gradi di intensità, ma con tutte le guerre – tutte – ad esclusivo vantaggio di quell’apparato transnazionale controllato da non più di qualche migliaio di persone. Se esiste oggi una perfetta metafora del capitalismo, è la guerra: la disperazione di molti e il guadagno di pochissimi, quelli che un tempo si chiamavano “i signori della guerra”, sempre più signori e con sempre più guerre su cui lavorare, perché se l’affare è la guerra, la pace fa male agli affari. Ai loro.
 Parafrasando una vecchia battuta cara ai romani quando se la prendono con Milano, si può dire che la cosa più bella dell’Italia è il treno per l’Europa, almeno se hai una vita davanti, delle aspettative, qualche ambizione non strangolata nella culla. Dice il Censis che nell’ultimo anno i giovani espatriati (una volta si sarebbe detto emigrati) sono stati più di cinquantamila, oltre il sessanta per cento del totale di chi ha scelto di andarsene da qui.
Parafrasando una vecchia battuta cara ai romani quando se la prendono con Milano, si può dire che la cosa più bella dell’Italia è il treno per l’Europa, almeno se hai una vita davanti, delle aspettative, qualche ambizione non strangolata nella culla. Dice il Censis che nell’ultimo anno i giovani espatriati (una volta si sarebbe detto emigrati) sono stati più di cinquantamila, oltre il sessanta per cento del totale di chi ha scelto di andarsene da qui.
Per il governo dei patrioti non è un bel segnale che ci sia la fila per lasciare la patria, ed è un ulteriore contrappasso il fatto che le fughe siano in aumento da quando governa Giorgia Meloni che fu “ministro per la gioventù” sotto Berlusconi (altro che underdog, era ministra a trentun anni). Insomma, non sembra che i giovani siano convintissimi delle sorti luminose e progressive della Nazzzione, e non parlo solo di quelli bastonati qui e là, a Pisa da ultimo ma anche prima (e anche da governi precedenti, peraltro). E resta un fatto: il famoso “giovane”, che rischia di diventare sempre più raro per questioni demografiche (una specie di crisi industriale: nessuno li produce più) si configura come nemico da battere per questa maggioranza un po’ ardita e molto ideologica.
Non a caso il governo cominciò la sua opera con un decreto che inaspriva le pene per i rave party, un’emergenza che – tra le emergenze italiane – sta davvero in fondo alla lista. E ancora oggi nei suoi comizi-teatrino, tra faccette e vocette e smorfiette, il/la premier ci ricorda di aver fermato i rave con l’orgoglio di chi dice di aver sconfitto la fame nel mondo, generando in chi l’ascolta una stupita ammirazione (tradotto: me cojoni!). Era solo l’inizio. E’ seguita una girandola di inasprimenti delle pene come soluzione ai mali del mondo, tra cui carcere e risarcimenti per quelli che si chiamano “eco-vandali”, cioè i giovani che protestano per il cambiamento climatico. Come se l’eco-vandalo sia chi tira una tazza di zuppa in un museo o blocca una strada, e non chi da decenni avvelena fiumi, aria e popolazioni: i miracoli della neolingua.
C’è in tutto questo un bel pezzo della retorica law and order cara alla destra, sorvegliare e punire, anche se naturalmente si tratta di sorvegliare e punire chi dicono loro, perché invece per i colletti bianchi, l’affarismo politico e la corruzione dei piani alti i cordoni si allentano parecchio, tra abuso d’ufficio, traffico d’influenze e altro: né sorvegliare né punire. Un classico.
Punire si punisce, eh! Mai come quest’anno, per esempio, a causa dello sbandierato decreto Caivano, sono finiti dietro le sbarre tanti minorenni, come se la galera fosse l’unica risposta al disagio giovanile in zone ad alto rischio. Si aggiungano le piccole (?) norme repressive vagheggiate, o proposte, o caldeggiate dal ministro dell’Istruzione Valditara, i cinque in condotta minacciati, le bocciature, le sospensioni, persino una divertente inversione dell’onere della prova, per cui chi occupa un liceo, per dire, dovrà “dimostrare di non essere coinvolto (sic) in eventuali danneggiamenti”. Secoli di cultura giuridica che si rivoltano nella tomba perché è arrivato il ministro del Merito (ahahah! Ndr). Forse non è (solo) per questa mascelluta e volitiva opera balilla di “rimetterli al loro posto”, che i giovani se ne vanno, però l’atmosfera non invoglia a restare, Un vero peccato per chi si immagina una disciplinata gioventù littoria: di questo passo il salto nel cerchio di fuoco dovranno farlo i sessantenni.
 Dunque riassumiamo: Giorgia Meloni è battibile, non è l’invincibile armata che tutti dicevano, lei per prima. Non è un fenomeno. Non è la donna della provvidenza. E’ una che ha scelto personalmente il candidato alla regione Sardegna, l’ha imposto con un diktat, e ha scelto il sindaco meno amato d’Italia, uno che nella città che amministra non ha vinto nemmeno in un seggio, nemmeno in quello sotto casa. Insomma, il tocco magico di Giorgia è un’invenzione della propaganda, come si sapeva, e come finalmente si vede a occhio nudo. E si scopre che anche quelli usi a sputare sull’opposizione (“con questa opposizione Giorgia governa vent’anni!”) fanno un po’ la figura dei cioccolatai, e con quella frase confessano soltanto i propri desideri, cioè che Giorgia governi vent’anni, desideri che ora scricchiolano un po’. Le cronache riferiscono di un burrascoso consiglio dei ministri, con Salvini molto nervoso. E questo anche prima che arrivassero le cifre dei voti di lista, con la Lega che sotto il quattro per cento (contro l’undici e passa di cinque anni fa). Se va avanti così, ai prossimi consigli dei ministri Salvini porterà i caffè, sempre che sia un compito alla sua altezza, è tutto da vedere.
Dunque riassumiamo: Giorgia Meloni è battibile, non è l’invincibile armata che tutti dicevano, lei per prima. Non è un fenomeno. Non è la donna della provvidenza. E’ una che ha scelto personalmente il candidato alla regione Sardegna, l’ha imposto con un diktat, e ha scelto il sindaco meno amato d’Italia, uno che nella città che amministra non ha vinto nemmeno in un seggio, nemmeno in quello sotto casa. Insomma, il tocco magico di Giorgia è un’invenzione della propaganda, come si sapeva, e come finalmente si vede a occhio nudo. E si scopre che anche quelli usi a sputare sull’opposizione (“con questa opposizione Giorgia governa vent’anni!”) fanno un po’ la figura dei cioccolatai, e con quella frase confessano soltanto i propri desideri, cioè che Giorgia governi vent’anni, desideri che ora scricchiolano un po’. Le cronache riferiscono di un burrascoso consiglio dei ministri, con Salvini molto nervoso. E questo anche prima che arrivassero le cifre dei voti di lista, con la Lega che sotto il quattro per cento (contro l’undici e passa di cinque anni fa). Se va avanti così, ai prossimi consigli dei ministri Salvini porterà i caffè, sempre che sia un compito alla sua altezza, è tutto da vedere.
Naturalmente le dichiarazioni del giorno dopo sono un po’ roba di repertorio, come sempre succede con le reazioni a caldo. Di colpo – per chi ha perso – la consultazione sarda non è indicativa, è un incidente trascurabile, un intoppo secondario. Si dice sempre così, quando si perde, c’è da capirli, ma nei prossimi giorni vedremo bene che voleranno schiaffoni in una coalizione dove nessuno è esente da colpe, con di fronte altre elezioni regionali e all’orizzonte le elezioni europee, Salvini imbizzarrito e i colonnelli di Giorgia coi i nervi a fior di pelle.
Tra gli sconfitti – e questa è una confortevole tradizione nazionale – c’è anche Carlo Calenda, ovvio, e come ti sbagli, che aveva tentato di far vincere la destra candidando Renato Soru. Nelle sue dichiarazioni post voto – perché Calenda dichiara a nastro, sempre, ovunque – ce n’è una divertente: “In Sardegna c’è stato detto o la candidata 5 stelle o morte”. Lui ha scelto “morte”, cioè di non arrivare nemmeno al consiglio regionale. Bravo. E poi, con sano e virile sprezzo del ridicolo, eccolo esprimere la speranza che “Il Pd diventi meno massimalista”. Urca, non si sentiva la parola “massimalista” dai tempi di Turati, e ora la sentiamo pronunciare da uno che, pur di ostacolare la vittoria di Pd-5stelle, ha sostenuto un candidato perdente insieme a Rifondazione comunista, per dire del massimalismo. Vertigine.
Fa scopa con Calenda l’altra dichiarazione che viene dal “centro”, cioè dalla pattuglia renzista per bocca dell’ineffabile Raffaella Paita. Anche loro sostenitori della lista di disturbo Soru, pur più defilati di Calenda. Testuali parole: “In Italia si vince solo se ci si allea anche con il centro”, che – detto dopo una vittoria raggiunta senza il centro – fa oggettivamente un po’ ridere.
Insomma la Sardegna non sarà la soluzione a tutti i mali, ma qualche indicazione la dà, prima tra tutte che la capillare propaganda, l’occupazione asfissiante degli spazi di comunicazione, le veline governative, non bastano, da sole, a garantire alla destra la sicurezza della vittoria. Dopo secoli di cronache e aneddoti sulla sinistra litigiosa e divisa, prepariamoci allo spettacolo della destra che si prende a pesci in faccia da sé, un’inversione di tendenza, l’inizio della fine della leggenda fantasy di Giorgia invincibile.
 Non si parla abbastanza di un grande successo di Giorgia Meloni e della sua famiglia al governo: il liceo del made in Italy, una grande intuizione del ministro Valditara, quello che confondeva umiltà (atteggiamento richiesto agli studenti che si avvicinano al sapere) con umiliazione (pratica con cui Valditara vorrebbe avvicinare gli studenti al sapere). Il liceo del made in Italy – usiamo umilmente (ma anche un po’ umiliati) le parole del ministro – dovrebbe ampliare l’offerta scolastica con “una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale”. Apperò! A prima vista sembrerebbe stimolante: l’ora di pizza margherita, l’ora di Sinner, e anche certe trappole scolastiche che rischiano di rovinare la media se condotte a digiuno, tipo la verifica di prosecco.
Non si parla abbastanza di un grande successo di Giorgia Meloni e della sua famiglia al governo: il liceo del made in Italy, una grande intuizione del ministro Valditara, quello che confondeva umiltà (atteggiamento richiesto agli studenti che si avvicinano al sapere) con umiliazione (pratica con cui Valditara vorrebbe avvicinare gli studenti al sapere). Il liceo del made in Italy – usiamo umilmente (ma anche un po’ umiliati) le parole del ministro – dovrebbe ampliare l’offerta scolastica con “una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale”. Apperò! A prima vista sembrerebbe stimolante: l’ora di pizza margherita, l’ora di Sinner, e anche certe trappole scolastiche che rischiano di rovinare la media se condotte a digiuno, tipo la verifica di prosecco.
Naturalmente nulla si fa per nulla, e la chiosa ai roboanti annunci di Valditara era la soddisfazione di “venire incontro alle nuove esigenze del mondo del lavoro”, il che fa sperare nell’istituzione di speciali corsi di sopravvivenza al precariato, che è, in effetti, un’eccellenza italiana.
La nuova offerta formativa gentilmente proposta dal governo Meloni, che si accompagna all’istituzione della “giornata del made in Italy”, il 15 aprile (colpevolmente non il primo di aprile) è affiancata da entusiasmanti iniziative, come la creazione di una fondazione chiamata “Imprese e competenze per il Made in Italy”, che fungerà da “raccordo tra il nuovo liceo e le imprese”. Insomma, se poi nel curriculum mettete “cameriere stagionale” va bene lo stesso, eh!
Il liceo del made in Italy ha riscosso un fiammeggiante successo presso le famiglie italiane: gli ardimentosi che hanno creduto alla nuova proposta formativa del collettivo studentesco Valditara-Urso-Meloni sono stati, al momento delle iscrizioni, la bellezza di 375. Mila?, direte voi. No, no, proprio 375, cioè lo 0,08 per cento delle iscrizioni alle scuole superiori, e così i novantadue istituti che si erano detti disposti alla coraggiosa innovazione si troveranno in media con 4 studenti per ogni nuova scuola. Un successo che si inserisce nel solco dei grandi trionfi del governo di Giorgia Meloni, come lo “storico” accordo con la Tunisia (fallito dopo sei minuti), lo “storico” accordo con l’Albania sui migranti (che ci costerà come regalare una Porsche ad ogni migrante deportato), o lo “storico” piano Mattei, per cui in Africa stanno ancora ridendo.
La questione, come ovvio, ha avuto ricadute piuttosto ridicole, per esempio a Crema, Istituto Munari, dove al liceo del made in Italy si è iscritto un solo studente (uno) e il preside Pierluigi Tadi ha pensato di arrivare a 25 rastrellando con sorteggio ragazzi che avevano scelto un altro indirizzo scolastico. La cosa è poi rientrata con una discreta marcia indietro, ma insomma, il gradimento degli studenti italiani per il nuovo indirizzo di studi teso a valorizzare il made in Italy e le eccellenze nazionali sembra un po’ scarsino, a dispetto della fragorosa accoglienza che l’annuncio ebbe su giornali e telegiornali, ulteriore prova che il mondo reale vince sempre sul mondo surreale della propaganda. Consiglierei comunque di perseguire l’obiettivo, di precisare il piano di studi, di affinare un’idea così luminosa che solo tre settimane fa il ministro del made in Italy Urso definiva “Un grande successo” (in tivù) e “Un baluardo che valorizza eccellenze italiane” (alla Camera). Bello. Poi via, tutti di corsa a iscriversi al liceo. Quell’altro, però, quello vero.
 Lei è poeta? Bene, allora faccia il poeta e non rompa i coglioni. In sintesi la serena posizione della destra fantasy al potere in Italia su argomenti come “arte e politica”, “arte e società” e altre questioncelle di cui si dibatte da alcune migliaia di anni è questa, come potete vedere, molto articolata. In confronto, le scritte nelle osterie ai tempi del Ventennio – “Qui non si parla di politica” – erano un trattato di densa complessità semantica. Ora no, niente di tutto questo, ora si va per le spicce, come dice il deputato Giorgio Mulé di Forza Italia: “A Sanremo si va per cantare”. Ecco, bon, finito. E se qualcuno, oltre a cantare (e magari pure cantando!) dice delle cose sul mondo – dall’immigrazione all’ambiente, dalla guerra al genocidio di Gaza, alla fame nel mondo, ai salari bassi – ecco che “è uno sproloquio”, oppure (per i più colti) “le cose vanno dette nel loro contesto”, oppure, “ecco vuole farsi pubblicità”, o ancora “non sa quel che dice”. All’ultimo step c’è anche il non mettere in difficoltà la sora Mara Venier, poverina, che all’età di 73 anni, e installata in tivù da quando c’erano i tram a cavalli, si presta alla lettura di un comunicato Eiar sollecitato dall’ambasciatore di Israele per paura di non fare carriera. Cerchiamo di capirla.
Lei è poeta? Bene, allora faccia il poeta e non rompa i coglioni. In sintesi la serena posizione della destra fantasy al potere in Italia su argomenti come “arte e politica”, “arte e società” e altre questioncelle di cui si dibatte da alcune migliaia di anni è questa, come potete vedere, molto articolata. In confronto, le scritte nelle osterie ai tempi del Ventennio – “Qui non si parla di politica” – erano un trattato di densa complessità semantica. Ora no, niente di tutto questo, ora si va per le spicce, come dice il deputato Giorgio Mulé di Forza Italia: “A Sanremo si va per cantare”. Ecco, bon, finito. E se qualcuno, oltre a cantare (e magari pure cantando!) dice delle cose sul mondo – dall’immigrazione all’ambiente, dalla guerra al genocidio di Gaza, alla fame nel mondo, ai salari bassi – ecco che “è uno sproloquio”, oppure (per i più colti) “le cose vanno dette nel loro contesto”, oppure, “ecco vuole farsi pubblicità”, o ancora “non sa quel che dice”. All’ultimo step c’è anche il non mettere in difficoltà la sora Mara Venier, poverina, che all’età di 73 anni, e installata in tivù da quando c’erano i tram a cavalli, si presta alla lettura di un comunicato Eiar sollecitato dall’ambasciatore di Israele per paura di non fare carriera. Cerchiamo di capirla.
Gli argomenti per dire ad artisti, cantanti, scrittori, registi e altri esponenti della cultura il classico e volitivo “Stai al posto tuo” sono numerosi e, ahimé, sempre gli stessi. Il primo e più gettonato è l’intramontabile “non è il momento”, “non è il posto giusto”, “il contesto non è quello adatto”. Insomma, come ha detto zia Mara, “Questa è una festa e si parla di musica”, mica di immigrati (questo zittendo Dargen D’Amico), anche se poi ha letto il famoso comunicato, che non parlava di musica per niente. E vabbé.
Poi c’è un altro classico e sempreverde manganello per chi si ostina a occuparsi del mondo oltre a cantare una canzone (come se cantare una canzone non fosse occuparsi del mondo, poi!), ed è l’accusa di guadagnarci qualcosa, di lucrare in popolarità. “Vuole farsi notare!”, è la terribile accusa, magari pronunciata da politici di seconda, terza e quarta fila che venderebbero la madre per veder pubblicata una loro dichiarazioncina con fotina annessa. Questo fa sempre molto ridere, perché di solito – come nel caso di Ghali – quello accusato di volersi fare pubblicità dicendo “cessate il fuoco” è già molto, ma molto, ma molto più popolare e noto del pupazzetto che si indigna. Seguendo lo stesso ragionamento potremmo dire che Mulé (e altri) si fanno pubblicità parlando di Ghali, sarebbe più sensato, perché sono in effetti meno popolari e molto meno amati dal pubblico.
L’ultima cartuccia per tenere gli artisti “al posto loro” se la giocano in molti, compresi corsivisti, commentatori e paraguru dell’informazione, ed è – nell’impossibilità di smontare l’argomento – l’operazione di svilire chi lo pronuncia. Insomma, siccome è difficile di fronte a un “Basta con il genocidio!” rispondere “No, no, avanti con il genocidio!”, si contesta la lucidità, o la conoscenza dei fatti, o l’autorevolezza di chi lo dice. Come se si dovesse essere chissà quanto autorevoli per dire che non bisogna assassinare donne e bambini. Insomma è una variante del “Che ne sai tu che fai il cantante!”, detto quasi sempre da gente che ne sa infinitamente meno, ma si adegua. Deve sembrare ai volenterosi censori un’arma invincibile e acuminata. Insomma! Che ne sa un cantante di genocidi? Chi si crede di essere, eh, la Corte dell’Aja? Ops…
 La dichiarazione di guerra è stata consegnata nelle mani di alcuni milioni di italiani, quelli poveri, che si ostinano a esserlo e a rimanerlo, nonostante i proclami del clan famigliare al governo e le magnifiche sorti del Paese illustrate ogni sera dai cinegiornali Luce, un tempo detti Tg. Una sistematica opera di bonifica ai danni di una parte non esigua della popolazione, quella che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quella che – anche lavorando – si ritrova ai confini della soglia di povertà, o addirittura sotto. Tolto il reddito di cittadinanza a un milione di famiglie (a 400.000 via sms), dopo una campagna stampa trasversale durata anni tesa a descrivere ogni meno abbiente del paese come un bieco truffatore, le famiglie con un sussidio sono oggi 288 mila, ma il sussidio sono due carote e un pomodoro, e per averlo bisogna avere un Isee di tipo sahariano: 6.000 euro all’anno, che in una città come Milano, per dire, non ti bastano nemmeno per andare alla Caritas in tram.
La dichiarazione di guerra è stata consegnata nelle mani di alcuni milioni di italiani, quelli poveri, che si ostinano a esserlo e a rimanerlo, nonostante i proclami del clan famigliare al governo e le magnifiche sorti del Paese illustrate ogni sera dai cinegiornali Luce, un tempo detti Tg. Una sistematica opera di bonifica ai danni di una parte non esigua della popolazione, quella che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, quella che – anche lavorando – si ritrova ai confini della soglia di povertà, o addirittura sotto. Tolto il reddito di cittadinanza a un milione di famiglie (a 400.000 via sms), dopo una campagna stampa trasversale durata anni tesa a descrivere ogni meno abbiente del paese come un bieco truffatore, le famiglie con un sussidio sono oggi 288 mila, ma il sussidio sono due carote e un pomodoro, e per averlo bisogna avere un Isee di tipo sahariano: 6.000 euro all’anno, che in una città come Milano, per dire, non ti bastano nemmeno per andare alla Caritas in tram.
Alcuni – fortunelli – hanno ricevuto da Yo soy Giorgia una carta alimentare, una moderna carta annonaria, da 382,5 euro all’anno (1,04 euro al giorno, non scialate). Insomma, chi non ce la faceva, o ce la faceva a malapena con grande fatica, è stato prima preso a ceffoni dai giornali (i famosi fannulloni sul divano) e poi direttamente affamato dal governo. Chi ha fatto i conti stima più o meno un risparmio di quattro miliardi per i tagli al reddito e un esborso di mezzo miliardo per il caritatevole obolo di un euro al giorno, che fa un risparmio secco di tre miliardi e mezzo: non volendo prenderli dagli extraprofitti delle banche – sacrilegio! – li si prende dagli extrasfigati, componente sociale in continuo aumento.
Naturalmente finché c’è la salute c’è tutto, e se la salute non c’è, cazzi vostri. Se ti serve un esame urgente o una cura veloce e non puoi aspettare un anno, e non puoi pagarti una sanità privata (tipo quella che possiede i giornali che sostengono vibratamente Yo soy Giorgia) che ti devo dire, pazienza, verremo al funerale. Alla sanità sono finiti tre miliardi, che andranno quasi tutti in contratti del personale, e undici italiani su cento rinunciano a curarsi per mancanza di soldi.
Il grande vanto e ostentazione della famiglia (sur)reale di Chigi Palace per la valanga di soldi destinati agli anziani è tragicomico. Un po’ perché si sventolano soldi che già arrivavano, e un po’ perché la platea è composta da ultraottantenni non autosufficienti, gravissimi, con un Isee inferiore a 6.000 euro: meno di trentamila persone nel 2025 e meno di ventimila nel 2026 (la strategia è puntare sulle esequie, insomma).
Però, per fortuna, si aiutano le donne. Oddio, non esageriamo. Forse era una buona idea quella della decontribuzione (fino a 3.000 euro lordi) per le donne che lavorano, poi però ecco la sorpresa: vale solo per le donne che hanno tre figli (tre!) e che siano lavoratrici assunte regolarmente a tempo indeterminato, nell’ecosistema italiano, animali piuttosto rari. Se vuoi lo sconto sui contributi – ma solo per un anno – devi avere almeno due figli, se no, zero. E’ una variante dei fannulloni sul divano: solo che qui si consiglia di stare sul divano a figliare. Tra l’altro, se hai un bambino solo, ti paghi l’asilo, perché per avere un contributo, di figli devi averne almeno due, se no zero pure qui.
Questo è il contenuto della dichiarazione di guerra. Come andava di moda dire, c’è un aggressore e un aggredito, che nei cinegiornali della sera non si vede mai.
Qui c’è l’intervista di Marta Ghezzi su Il Corriere della Sera Milano, per annunciare il Reading di martedì al teatro Parenti (ore 19.30). Letture mie e di Luca Nucera, suoni di Tommaso Toma. Venite!
 Visto che non si può parlare di lotta di classe – perché saltano su come tappi i soliti pipicchiotti sedicenti liberali a dire che è solo invidia sociale – che si parli almeno di lotta di tasse. E per quanto stupefacente, eccoci d’accordo con una bizzarra congrega di miliardari del pianeta, che chiedono di essere tassati di più. Per dirlo hanno approfittato del recente World Economic Forum di Davos, che è un po’ la serata degli Oscar dei padroni (and the winner is…): quasi trecento miliardari hanno preso carta e penna (d’oro, si suppone) per chiedere ai governi del mondo di aumentare le tasse sulla ricchezza. Il ragionamento è semplice e, in qualche modo, ragionevolmente difensivo. Probabile che nelle loro ville di Malibu o di Sankt Moritz, i super-ricchi del pianeta abbiano letto le cifre del rapporto Oxfam sulle diseguaglianze, tipo quella che loro – i miliardari del pianeta – sono sempre più miliardari, che i primi cinque nella loro classifica hanno raddoppiato le loro fortune negli ultimi tre anni, mentre cinque miliardi di persone, cinquemila milioni di povericristi, si sono impoveriti. Ragionamento che non fa una piega, come si legge nell’appello: per noi non cambia niente, il nostro tenore di vita non ne risentirà, ne per i nostri figli, né per i nostri nipoti, né per le nostre aziende. Sono ricchi, non sono mica scemi, sanno che se la faccenda si sbilancia troppo e se alcuni miliardi di poveracci si incazzano con qualche migliaio di ricconi la questione si può mettere male. Ma in ogni caso c’è una verità incontestabile: la “ricchezza privata estrema” (come la chiamano loro) è un problema per la democrazia in tutto il mondo. Parole sagge, e meno male che le dicono i miliardari, perché quando lo dice un sindacalista, o un lavoratore, viene subito accusato di tendenze comuniste, ambizioni di esproprio proletario e invidia sociale (e ridaje, ndr).
Visto che non si può parlare di lotta di classe – perché saltano su come tappi i soliti pipicchiotti sedicenti liberali a dire che è solo invidia sociale – che si parli almeno di lotta di tasse. E per quanto stupefacente, eccoci d’accordo con una bizzarra congrega di miliardari del pianeta, che chiedono di essere tassati di più. Per dirlo hanno approfittato del recente World Economic Forum di Davos, che è un po’ la serata degli Oscar dei padroni (and the winner is…): quasi trecento miliardari hanno preso carta e penna (d’oro, si suppone) per chiedere ai governi del mondo di aumentare le tasse sulla ricchezza. Il ragionamento è semplice e, in qualche modo, ragionevolmente difensivo. Probabile che nelle loro ville di Malibu o di Sankt Moritz, i super-ricchi del pianeta abbiano letto le cifre del rapporto Oxfam sulle diseguaglianze, tipo quella che loro – i miliardari del pianeta – sono sempre più miliardari, che i primi cinque nella loro classifica hanno raddoppiato le loro fortune negli ultimi tre anni, mentre cinque miliardi di persone, cinquemila milioni di povericristi, si sono impoveriti. Ragionamento che non fa una piega, come si legge nell’appello: per noi non cambia niente, il nostro tenore di vita non ne risentirà, ne per i nostri figli, né per i nostri nipoti, né per le nostre aziende. Sono ricchi, non sono mica scemi, sanno che se la faccenda si sbilancia troppo e se alcuni miliardi di poveracci si incazzano con qualche migliaio di ricconi la questione si può mettere male. Ma in ogni caso c’è una verità incontestabile: la “ricchezza privata estrema” (come la chiamano loro) è un problema per la democrazia in tutto il mondo. Parole sagge, e meno male che le dicono i miliardari, perché quando lo dice un sindacalista, o un lavoratore, viene subito accusato di tendenze comuniste, ambizioni di esproprio proletario e invidia sociale (e ridaje, ndr).
Passando al piccolo mondo antico dell’Italietta meloniana (ma anche pre-meloniana e, sono sicuro, post-meloniana), ci dobbiamo accontentare dell’Ocse che non pensa tanto ai povericristi ma al nostro debito pubblico e suggerisce di rivedere più che qualcosa nel sistema fiscale. La tassa di successione, per esempio, è tra le più basse del pianeta, il che, oltre ad essere ingiusto, è un motore primario di diseguaglianza (in parole povere i ricchi sono ricchi per successione dinastica, altro che pippe sul merito!). In più, la rendita improduttiva è tassata meno del lavoro produttivo. In più, ci sono pensioni d’oro a fronte di pensioni che non garantiscono nemmeno la sussistenza. Insomma, un paese che premia i ricchi e penalizza i poveri, come anche il recente ridisegno di alcune discipline fiscali conferma.
In tutto questo, che è macroscopicamente sotto gli occhi di tutti, si assiste a un bizzarro fenomeno di ipnosi di massa, per cui appena qualcuno pronuncia la parola “patrimoniale” si schierano le armate del Capitale come di fronte a una rivoluzione bolscevica. Davvero stupefacente vedere gente che paga il mutuo per un bilocale alla periferia di Novara strepitare contro una tassazione per chi ha patrimoni superiori a dieci milioni, la sede fiscale all’estero, la cittadinanza a Montecarlo e cinque Bentley in garage. Di tutte le ingiustizie e le follie in materia di diseguaglianze, questa è la più strabiliante: neo-poveracci del fu ceto medio che difendono come tanti piccoli Milei i privilegi di una manciata di miliardari globali, senza pensare – fessi – che in proporzione pagano molte più tasse di loro.
 La cosiddetta riforma dell’abuso d’ufficio, insieme all’astuto ridisegno delle norme sul traffico di influenze, apre nuovi entusiasmanti scenari nella giustizia italiana: finalmente ras dell’amministrazione, primari ospedalieri, baroni universitari e altri italiani in posti di potere, potranno indossare senza problemi la felpa con scritto: “Faccio il cazzo che voglio”. Votata in commissione dalla destra moderata (Forza Italia), dalla destra radicale (Fratelli d’Italia, Lega) e dalla destra saudita (Italia Viva), la riforma veleggia ora verso il Senato, dove forse incontrerà alla buvette le norme che vietano la pubblicazione delle ordinanze cautelari. Due provvedimenti che si sposano alla perfezione: se uno viene arrestato non si potrà scrivere perché e percome, ma d’altra parte possiamo stare tranquilli che per traffico d’influenze o abuso d’ufficio nessuno sarà arrestato: non fa una piega.
La cosiddetta riforma dell’abuso d’ufficio, insieme all’astuto ridisegno delle norme sul traffico di influenze, apre nuovi entusiasmanti scenari nella giustizia italiana: finalmente ras dell’amministrazione, primari ospedalieri, baroni universitari e altri italiani in posti di potere, potranno indossare senza problemi la felpa con scritto: “Faccio il cazzo che voglio”. Votata in commissione dalla destra moderata (Forza Italia), dalla destra radicale (Fratelli d’Italia, Lega) e dalla destra saudita (Italia Viva), la riforma veleggia ora verso il Senato, dove forse incontrerà alla buvette le norme che vietano la pubblicazione delle ordinanze cautelari. Due provvedimenti che si sposano alla perfezione: se uno viene arrestato non si potrà scrivere perché e percome, ma d’altra parte possiamo stare tranquilli che per traffico d’influenze o abuso d’ufficio nessuno sarà arrestato: non fa una piega.
Lascerei le questioni giuridiche ai giuristi, comunque, non mi addentrerò nei tecnicismi. Quel che preme sottolineare qui è una rivoluzionaria visione del mondo, per cui essendo il reato scomodo e fastidioso a chi comanda, basta abolirlo. E se resta scomodo, basta non poterne parlare. E in ogni caso i reati, sia chiaro, restano patrimonio dei poveracci.
Ecco, non lascerei questa rivoluzione a metà, ma l’amplierei e la preciserei per altri reati. Il furto, per dirne una, va contestualizzato. Un conto è un povero che ruba per invidia sociale, un altro conto è il ricco che ruba per far rendere meglio la refurtiva, investirla, creare posti di lavoro, come è noto facciano i ricchi, munifici e generosi, per aiutare i poveri, dandogli addirittura un salario. Prossima riforma, dunque, presentare l’Isee al momento dell’arresto. Ottimi sviluppi sul divieto di sosta: se in divieto è parcheggiata una Panda marcia, multa sicura. In caso di parcheggio illegale di una fuoriserie, invece, è chiaro che abbellisce la città e dona un certo tono all’intera strada, urge sanatoria.
In generale, se ne ricava che la miglior battuta satirica è ancora “La legge è uguale per tutti”, con la sua variante “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”, che in effetti fa sbellicare.
Divertente notazione in margine: la “riforma” dell’abuso d’ufficio viene presentata come norma “liberale”, e si sa che ormai la parola “liberale” si usa in modo piuttosto liberale per intendere di limitare i poteri dello Stato e altre seccature. Quelle cose che impediscono colpevolmente – per intenderci – di attribuire i lavori pubblici alla ditta di tuo cugino o di promuovere viceprimario chi manda molti clienti alla clinica privata del primario. Peccato che il concetto di abuso (d’ufficio e di potere) sia entrato negli ordinamenti europei dopo la rivoluzione francese, ispirato proprio da una filosofia liberale del diritto. La possibilità di essere cittadini e non sudditi, era in effetti una cosa piuttosto liberale, che chi si dice “liberale” oggi tende a contestare. In poche parole, la libertà insindacabile di un amministratore, di un pubblico ufficiale, di un qualsiasi detentore di potere decisionale, ci riporta dalle parti di Carlo Magno, o almeno del Marchese del Grillo. E quindi ecco che (trucco molto in voga) si traveste da liberale ciò che invece è profondamente autoritario e si compone, alla fine, un divertente disegnino per cui chi occupa posti di potere può vantare un codice penale diverso dagli altri. Gli si garantisce, insomma, che il suo potere può contenere anche un abuso, e gli abusati, peggio per loro.
 Poi dice che non si infrangono i luoghi comuni. Niente di più falso. Per dirne uno – il più evidente – ecco che la formuletta storica della destra come portatrice di “legge e ordine” va allegramente a farsi benedire, e se ci fosse una sintesi per l’attuale destra che comanda in Italia sarebbe piuttosto il contrario: “fuorilegge e disordine”, dovrebbero stamparselo sulle magliette. Con l’aggravante che le vediamo ogni minuto, questa destra e la sua capa, battersi sul petto, indicare nemici immaginari e berciare di “orgoglio”, “patria”, “nazione” e altre bellurie mascellute e paralittorie: i fumogeni della propaganda diventano un po’ grotteschi.
Poi dice che non si infrangono i luoghi comuni. Niente di più falso. Per dirne uno – il più evidente – ecco che la formuletta storica della destra come portatrice di “legge e ordine” va allegramente a farsi benedire, e se ci fosse una sintesi per l’attuale destra che comanda in Italia sarebbe piuttosto il contrario: “fuorilegge e disordine”, dovrebbero stamparselo sulle magliette. Con l’aggravante che le vediamo ogni minuto, questa destra e la sua capa, battersi sul petto, indicare nemici immaginari e berciare di “orgoglio”, “patria”, “nazione” e altre bellurie mascellute e paralittorie: i fumogeni della propaganda diventano un po’ grotteschi.
Riassumendo, rischi anni di galera se vai a un rave party, ti identifica la Digos se gridi “Viva l’Italia antifascista” all’Opera, ma puoi allegramente fare il saluto romano insieme a un migliaio di balilla, gridare “presente!” e “boia chi molla”. L’adunata di Acca Larentia ha fatto il giro del mondo, con la sua estetica da falange nazi, tipo raduno di Norimberga, file strette e ordinate, coreografia da notte dei cristalli, forse era scomodo andare in una birreria di Monaco, o forse non conveniva, perché a Monaco, in Baviera, se fai apologia di fascismo ti prendono e ti portavo via, qui no.
Mi stupisco dello stupore, e anche un po’ dell’ingenuità. In sostanza si chiede a Fratelli d’Italia di dissociarsi da un ambiente da cui proviene larga parte dei suoi dirigenti, la sua cultura, la sua visione storica e anche un po’ il suo senso estetico da raduno falangio-predappista. Abbiamo un ministro-cognato che considera il criminale di guerra Graziani “un punto di riferimento”, la seconda carica dello Stato che colleziona cimeli mussoliniani, un sottosegretario che si vestiva da nazista per l’addio al celibato, un deputato che sparacchia alle feste di Capodanno e una presidente del consiglio che di fronte a un assalto fascista alla Cgil disse “Non conosco la matrice”. (Parentesi: quel Giuliano Castellino condannato in primo grado a otto anni per l’assalto alla Cgil compare in una foto insieme a Giorgia Meloni, nel 2008, proprio in via Acca Larentia, non conoscerà la matrice, ma non frequenta benissimo, diciamo).
Insomma, la vulgata è che Giorgia è brava e bella, ma purtroppo non tutti i suoi sono all’altezza, la famosa teoria delle mele marce, che in una cesta ce ne sono sempre due o tre, ma le altre sono mele belle, sane e forti. Il fatto è che di solito, di fronte a questi numerosissimi indizi di nostalgia canaglia (e fascista) ci si appella alla cristallina onestà. Vabbè, saranno un po’ indecenti, ma sull’onestà non si scherza, eh! E anche qui la leggenda fa acqua da tutte le parti, perché tra conflitti di interesse grandi come una casa – dalla Difesa al Turismo – , rivelazioni di segreti d’ufficio al coinquilino, quadri misteriosamente scomparsi e ricomparsi con una fiaccola che prima non c’era, parlamentari condannate in via definitiva per peculato (bella parola, ma vuol dire furto, ndr) promosse a vigilare sulla Rai, più che le mele marce, nella cesta, bisogna cercare quelle sane. Siamo ottimisti: due o tre ci saranno pure.
Per fortuna, però, sono attenti ai ceti deboli, dalla parte del popolo, così convintamente che ora dovranno tagliare la spesa sociale di 12 miliardi all’anno, una bella rasatura al diritto alla salute, allo studio, al welfare in generale, mentre il 46 per cento della ricchezza del Paese è in mano a un 5 per cento di privilegiati. “Fuorilegge e disordine”, insomma, e (strabiliante!) funziona.
 Né ridendo né scherzando, è arrivato l’anno nuovo. Sono in ritardo per gli auguri, e per fortuna, perché a parte la sopravvivenza, o di riuscire a pagare le bollette, o di non dover prenotare una visita specialistica tra otto mesi e mezzo, non saprei cosa augurarvi. Mi spiace, non vorrei essere pessimista, non lo sono di natura, ma mi sembra che i tempi suggeriscano questo: il realismo è già una notevole vocazione al disastro.
Né ridendo né scherzando, è arrivato l’anno nuovo. Sono in ritardo per gli auguri, e per fortuna, perché a parte la sopravvivenza, o di riuscire a pagare le bollette, o di non dover prenotare una visita specialistica tra otto mesi e mezzo, non saprei cosa augurarvi. Mi spiace, non vorrei essere pessimista, non lo sono di natura, ma mi sembra che i tempi suggeriscano questo: il realismo è già una notevole vocazione al disastro.
In cerca di qualche buona notizia per allietarci l’inizio del 2024, mi accorgo che non ce ne sono, e le migliori dovrei inventarmele di sana pianta. Tipo, che so, la scoperta di una fitta rete di tunnel sotto Firenze, che collega le varie residenze dei Verdini. Essendo tutti ai domiciliari, hanno scavato per passarsi bottiglie di champagne e verbali delle intercettazioni. A piede libero è rimasta quasi solo la figlia, che però, essendo fidanzata con Salvini, è quella che ha la condanna peggiore. Dove sono i garantisti quando servono? Eh?
Potremmo svagarci un po’ con il fenomeno dell’anno, Javier Milei, il nuovo presidente dell’Argentina, idolo dei liberisti di tutto il mondo, un mix micidiale tra Milton Friedman, il dittatore dello stato libero di Bananas e un vicedirettore de Il Foglio. Ho letto l’elenco delle sue riforme e in effetti manca solo “da domani la lingua ufficiale sarà lo svedese”, il resto c’è tutto, compresi il divieto di manifestare, di scioperare e di non dire “viva Milei”. Non vi sfugga la geniale innovazione: eravamo abituati ai liberali che aprono la porta al fascismo, qui si salta un passaggio (inutile lungaggine burocratica), e il liberale diventa automaticamente lui, il fascismo. Fidatevi, si risparmia. Resta solo una considerazione un po’ amara: per aver votato questo qui, pensa com’erano gli altri, che è un po’ quello che diremo tutti noi dopo le elezioni europee.
Poi, per tirarsi un po’ su il morale, non c’è nulla come le buone letture. Vi consiglio il Bloomberg Billionaire Index, cioè l’annuale hit parade dei miliardari del pianeta. Istruttivo, anche se non favorisce la digestione. Stando alle recenti quotazioni di Borsa, il più ricco del mondo è ElonMusk, con 232 miliardi di dollari in tasca, 93 in più rispetto all’anno precedente, che fa dieci milioni e mezzo di dollari all’ora, un salario minimo abbastanza soddisfacente. Forse per quello la “destra sociale” l’ha applaudito tanto, alla sagra fantasy di Atreju, perché “destra” va molto di moda, ma “sociale” non si porta più, è un po’out.
Una nota triste, il rischio di indigenza per Bernard Arnault, il capo mondiale del lusso, che si ferma a 178 miliardi: qualcuno nel 2023 si è scordato di smacchiare la borsa Louis Vuitton con lo champagne millesimato, e lui ne paga le tristi conseguenze passando dal primo al secondo posto, che decadenza, suggerirei di lanciare una sottoscrizione.
In tutto questo, una nota di orgoglio nazionale: grazie al governo della destra, e al signor Giorgetti in particolare, dovremo tagliare dal bilancio dello Stato 12 miliardi e mezzo all’anno fino al 2031. Lasciamo stare che quelli che hanno firmato questo patto sono gli stessi che hanno vinto le elezioni dicendo “Mille euro a testa con un click”, tipo la sora Giorgia, “uomo dell’anno”, quisquilie, non fermatevi ai dettagli. E’ bello avere questa vocazione al risparmio, e potrei anche suggerire dove tagliare visto che spenderemo 13 miliardi all’anno in armamenti, difesa, carri armati e altri giocattolini. Che ci vuole, basterebbe prenderli da lì.
No, eh? Mi pareva. Buon anno lo stesso.
 Eccoci, finalmente. Erano due anni che non usciva un nuovo romanzo con il Monterossi, la sua banda, Ghezzi, Carella eccetera eccetera.
Eccoci, finalmente. Erano due anni che non usciva un nuovo romanzo con il Monterossi, la sua banda, Ghezzi, Carella eccetera eccetera.
Non so dire esattamente perché è passato tanto tempo, ma volevo che fosse perfetto, mi piacerebbe dire – come ha fatto ogni tanto Dylan – che cercavo un suono preciso.
E’ una storia di “pesci piccoli”, con vari intrecci, svolte, cose che accadono, con una protagonista femminile, Teresa, che amo molto, che merita tutto.
Non dirò, altro, per ora, ma è un libro a cui tengo molto per vari motivi, ne parleremo, qui e altrove, ma insomma, intanto ecco l’annuncio.
Esce il 23 gennaio. Prenotatelo in libreria, sulle piattaforme online, dove volete voi. E’ per tutti i pesci piccoli e tutte le Terese del mondo.
Buona lettura
 Non mi occupo della guerra, è la guerra che si occupa di me. Sono in una zona sicura, tranquilla, in altre occasioni avrei detto che la guerra la vedo al telegiornale, oggi non posso nemmeno dire questo, perché al telegiornale la guerra non c’è, o ce n’è poca, o bisogna star lì con un setaccio fine a distinguere le notizie dalla propaganda; alle immagini della terra bruciata dopo un bombardamento segue il servizio riparatore sui buoni e i cattivi, i valori dell’Occidente, cos’ha detto Biden, come si comporterà l’Iran, o l’Egitto, o l’Europa, che non si comporta mai, cioè male. L’infinitamente grande – la geopolitica mondiale, le cancellerie, le strategie – nasconde e oscura l’infinitamente piccolo, che invece è enorme, insopportabile: una famiglia sterminata, un ospedale bombardato, i feriti, i bruciati, quelli operati senza anestesia. Tento di resistere. Mi fa orrore la disputa sui morti, è come se per dimostrare l’imperativo umano di non ammazzare civili, innocenti, donne e bambini, uno dovesse sottolineare i numeri di civili innocenti, donne e bambini ammazzati. Quasi sbandierarli, a sostegno di una tesi così semplice e disarmante: non bisogna ammazzarli. Umiliante. Le ultime cifre, accettate più o meno da tutti, dicono oltre ventimila uccisi, ottomila bambini, numeri che saranno certamente aumentati quando leggerete queste righe. Si parla di cadaveri come si parla di milioni durante la manovra finanziaria: cento più, cento meno, che vuoi che sia. Penso a quelli che non rientrano nel computo dei ragionieri della guerra: quelli senza più un occhio, o una gamba, o un braccio, senza più nemmeno un barlume di futuro. Poi ci sono i negazionisti, quelli che “le bombe sono chirurgiche”, che negano l’eccidio quotidiano, che minimizzano, appena un po’ meno ripugnanti degli esaltati che teorizzano apertamente il genocidio, l’annientamento di Gaza, con dentro due milioni e mezzo di persone. “Fino all’ultimo ratto”, ha scritto una invasata suprematista su un social: sono rimasto paralizzato a leggere quelle parole, ho pensato a tutte le volte in cui ci siamo chiesti – a proposito del nazismo – come si era potuti arrivare a quel punto. Ecco. Così.
Non mi occupo della guerra, è la guerra che si occupa di me. Sono in una zona sicura, tranquilla, in altre occasioni avrei detto che la guerra la vedo al telegiornale, oggi non posso nemmeno dire questo, perché al telegiornale la guerra non c’è, o ce n’è poca, o bisogna star lì con un setaccio fine a distinguere le notizie dalla propaganda; alle immagini della terra bruciata dopo un bombardamento segue il servizio riparatore sui buoni e i cattivi, i valori dell’Occidente, cos’ha detto Biden, come si comporterà l’Iran, o l’Egitto, o l’Europa, che non si comporta mai, cioè male. L’infinitamente grande – la geopolitica mondiale, le cancellerie, le strategie – nasconde e oscura l’infinitamente piccolo, che invece è enorme, insopportabile: una famiglia sterminata, un ospedale bombardato, i feriti, i bruciati, quelli operati senza anestesia. Tento di resistere. Mi fa orrore la disputa sui morti, è come se per dimostrare l’imperativo umano di non ammazzare civili, innocenti, donne e bambini, uno dovesse sottolineare i numeri di civili innocenti, donne e bambini ammazzati. Quasi sbandierarli, a sostegno di una tesi così semplice e disarmante: non bisogna ammazzarli. Umiliante. Le ultime cifre, accettate più o meno da tutti, dicono oltre ventimila uccisi, ottomila bambini, numeri che saranno certamente aumentati quando leggerete queste righe. Si parla di cadaveri come si parla di milioni durante la manovra finanziaria: cento più, cento meno, che vuoi che sia. Penso a quelli che non rientrano nel computo dei ragionieri della guerra: quelli senza più un occhio, o una gamba, o un braccio, senza più nemmeno un barlume di futuro. Poi ci sono i negazionisti, quelli che “le bombe sono chirurgiche”, che negano l’eccidio quotidiano, che minimizzano, appena un po’ meno ripugnanti degli esaltati che teorizzano apertamente il genocidio, l’annientamento di Gaza, con dentro due milioni e mezzo di persone. “Fino all’ultimo ratto”, ha scritto una invasata suprematista su un social: sono rimasto paralizzato a leggere quelle parole, ho pensato a tutte le volte in cui ci siamo chiesti – a proposito del nazismo – come si era potuti arrivare a quel punto. Ecco. Così.
Tento di rifugiarmi nelle prospettive, il “che fare?”, le soluzioni, gli sviluppi. Non ci riesco. Non credo ci siano sviluppi possibili finché cadono bombe da duecento libbre su casermoni pieni di gente in fuga. E poi le prospettive, le soluzioni, gli sviluppi, paiono quasi peggio del presente. Immedesimarsi non è possibile, e con chi, poi? Non credo che, avvolti come siamo nelle nostre confortevoli sicurezze – l’albero di Natale, i pacchettini, i parenti, lo spumante – riusciremmo davvero a capire l’enormità di quel dolore. Se penso al “dopo” aumenta lo sconforto. “Dopo” cosa? Pensa di essere un ragazzino a Gaza, la casa rasa al suolo, la famiglia decimata, magari orfano, magari con fratelli uccisi, mi chiedo cosa possa restarti oltre l’odio più cristallino. Pensa di essere un ostaggio di Hamas, forse ti chiederesti come ti aiuta, come ti serve, questa mattanza di civili in rappresaglia, se davvero aiuterà a farti tornare a casa. Visto da qui, dal Natale 2023, sembra tutto così plumbeo e definitivo, così inevitabile, con ogni discorso sensato, umano, ragionevole, spezzato in ogni momento da altro lutto, altro dolore, altri balletti sul lutto e sul dolore. “Cessate il fuoco” mi pare è l’unico augurio possibile, per il Natale passato e per il Capodanno che arriva. Non “Buon anno” – non lo sarà – ma “Cessate il fuoco”, subito.
 Non ho niente contro il Fantasy, sia chiaro, la letteratura di genere ha il suo fascino e il suo perché, conosco raffinati estimatori di draghi che sputano fuoco dalle narici, principesse che diventano indomiti guerrieri, gnomi di talento, cani volanti, eccetera eccetera. Bello, divertente, e con un vantaggio inestimabile: la realtà non c’entra niente, la creazione di un mondo immaginario da cui vengono espulse le seccature della vita reale può essere piacevole e, se ti capita di governare, persino utile. Nel fantasy – così come nei comizi di Giorgia Meloni – nessuno va a fare la spesa notando che tutto costa più caro, nessuno prende stipendi da fame pur facendosi un culo a paiolo, e nessuno aspetta otto mesi per una mammografia, al massimo può capitarti di lottare contro nemici immaginari. Così, ho seguito – senza veramente seguirlo, ma travolto mio malgrado da una copertura mediatica degna delle Olimpiadi – il party fantasy della compagnia di Giorgia Meloni, detto Atreju, che quest’anno è stato la celebrazione del popolo dell’Anello arrivato finalmente al potere, e ora sono cazzi vostri. Come Giorgia aveva già detto in un altro comizio, citando l’amato Tolkien, “Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo”. Peccato. Vabbé, aspettiamo.
Non ho niente contro il Fantasy, sia chiaro, la letteratura di genere ha il suo fascino e il suo perché, conosco raffinati estimatori di draghi che sputano fuoco dalle narici, principesse che diventano indomiti guerrieri, gnomi di talento, cani volanti, eccetera eccetera. Bello, divertente, e con un vantaggio inestimabile: la realtà non c’entra niente, la creazione di un mondo immaginario da cui vengono espulse le seccature della vita reale può essere piacevole e, se ti capita di governare, persino utile. Nel fantasy – così come nei comizi di Giorgia Meloni – nessuno va a fare la spesa notando che tutto costa più caro, nessuno prende stipendi da fame pur facendosi un culo a paiolo, e nessuno aspetta otto mesi per una mammografia, al massimo può capitarti di lottare contro nemici immaginari. Così, ho seguito – senza veramente seguirlo, ma travolto mio malgrado da una copertura mediatica degna delle Olimpiadi – il party fantasy della compagnia di Giorgia Meloni, detto Atreju, che quest’anno è stato la celebrazione del popolo dell’Anello arrivato finalmente al potere, e ora sono cazzi vostri. Come Giorgia aveva già detto in un altro comizio, citando l’amato Tolkien, “Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo”. Peccato. Vabbé, aspettiamo.
La componente fantasy della kermesse era impreziosita da giganti del pensiero, tipo quel Rampelli che dichiarò guerra alle parole inglesi fino a proporre multe per chi le usa, e che fece il diavolo a quattro per una stella rossa usata come puntale dell’albero di Natale, chiaro segnale di comunismo. E’ un classico dei personaggi fantasy avere nemici oscuri e immaginari, che non esistono, tipo i draghi, gli orchi e, appunto, il comunismo. Poi, appena un minuto prima di tuonare davanti alle masse plaudenti che “i bambini non si comprano e non si vendono!”, ovazioni e celebrazioni per un miliardario fantasy pure lui, Elon Musk, che un bambino se l’è comprato. Pazienza, troveremo certamente in millemila pagine di saghe e battaglie e leggende e paccottiglia para-mistica qualche frasetta buona ad archiviare la coerenza.
Ma è chiaro che c’è qualcosa che fa da tessuto connettivo, una sostanza collosa che tiene tutto insieme, che giustifica l’atteggiamento di chi, pur governando tutto e controllando tutto, ancora si finge oppresso ed emarginato. E’ questo il vero fantasy meloniano: il vittimismo in servizio effettivo e permanente di una tribù che tutto controlla (i media pubblici, in primis), ma che si ostina a fingersi discriminata e osteggiata. Ridicolo, almeno come una che diventa presidente del Consiglio a 42 anni e si definisce “underdog” pur avendo fatto il ministro quando ne aveva 30.
A sentire l’infervorato comizio dell’arruffapopoli della Garbatella che chiudeva il festival fantasy, si sposavano così differenti sensazioni: da un lato quella di una comunità oppressa, vittima, bastonata, minoritaria, che però comanda tutto (molto fantasy, in effetti); e dall’altro una fiera ostentazione dei successi raggiunti (“Quest’anno non c’è stato nessun rave illegale”, me cojoni, ndr). Con la piccola contraddizione interna che chi dice che va tutto bene, siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto benissimo, di solito non lo fa urlando come un ultras allo stadio, con le vene del collo gonfie e gli occhi strabuzzati dallo sforzo. Urlare a pieni polmoni “Non-sono-nervoso!!!” dà solitamente la sensazione opposta, cioè che sei parecchio agitato e non troppo sicuro di te stesso, anche se – niente male come emarginazione – a reti unificate.
 Questa è la storia di come un governo (il nostro) ruba soldi, risorse, possibilità di riscatto e opportunità ad alcune migliaia di ragazzini. Non è un giallo, ma un delitto sì, e lo trovate scritto in un emendamento alle legge di bilancio passato qualche giorno fa al Senato della Repubblica italiana, sapete, quella là fondata sul lavoro eccetera, eccetera. Succede infatti che ci si trovi a dover aumentare i fondi per il comparto sicurezza (previdenza integrativa di polizia e forze armate) e si raschi qualche milioncino qui e là. E ad essere raschiato è il fondo per l’accoglienza dei migranti minori, fondo già di ridicola entità (68 milioni, con cui i comuni fanno salti mortali), da cui ne spariscono 15, che per tre anni fa 45.
Questa è la storia di come un governo (il nostro) ruba soldi, risorse, possibilità di riscatto e opportunità ad alcune migliaia di ragazzini. Non è un giallo, ma un delitto sì, e lo trovate scritto in un emendamento alle legge di bilancio passato qualche giorno fa al Senato della Repubblica italiana, sapete, quella là fondata sul lavoro eccetera, eccetera. Succede infatti che ci si trovi a dover aumentare i fondi per il comparto sicurezza (previdenza integrativa di polizia e forze armate) e si raschi qualche milioncino qui e là. E ad essere raschiato è il fondo per l’accoglienza dei migranti minori, fondo già di ridicola entità (68 milioni, con cui i comuni fanno salti mortali), da cui ne spariscono 15, che per tre anni fa 45.
Per decreto, insomma, i ragazzini immigrati non accompagnati di sedici anni diventano “quasi maggiorenni” (sic!), si inventa la categoria inedita degli “ultrasedicenni” (ri-sic!), e una volta sbarcati li si manda nei centri di detenzione (“accoglienza” ahah) dove stanno i migranti adulti, vale a dire in galera, senza possibilità di riscatto, inserimento, integrazione o altro. Stiamo parlando di più di venticinquemila persone di ambo i sessi, arrivate avventurosamente in Italia dopo averne passate di tutti i colori, tra violenze e sopraffazioni; diecimila l’anno scorso, sedicimila quest’anno, che secondo vari accordi internazionali (anche convenzioni dell’Onu) dovrebbero avere tutele particolari. In soldoni, invece dei 100 euro a testa stanziati per i centri specializzati, per questi “quasi maggiorenni” se ne spenderanno 30, come per i loro compagni di viaggio adulti, ed ecco che viene fuori una manciata di milioncini. Briciole, nella legge di bilancio dello Stato, che certo non risolveranno i problemi delle pensioni integrative del comparto sicurezza, e che invece denunciano in pieno un accanimento ideologico verso la parte più debole del popolo migrante: i minorenni che hanno affrontato un viaggio infernale senza essere accompagnati.
Prendersela con i ragazzini, considerarli adulti quando non lo sono, negare loro un percorso che potrebbe inserirli nella nostra società, risponde dunque a due esigenze, fare un po’ di cassa sulla loro pelle (ma pochissima cassa) e soddisfare le fregole razziste dei “patrioti”, timorosi della “sostituzione etnica”. Un refrain, questo, caro alla famiglia Meloni (sia a lei che al cognato): non sia mai che quei ragazzini diventino bravi cittadini, imparino un lavoro, magari facciano un domani dei figli. Aspettiamo con pazienza i primi ricorsi, quando qualche tribunale farà notare che considerare maggiorenni dei minorenni non si può, e che ci sono leggi superiori a cui bisogna ubbidire, con conseguenti attacchi al giudice di turno. Nel frattempo, possiamo apprezzare in tutta la sua gloriosa magnificenza la doppia morale applicata agli adolescenti: i nostri considerati soggetti da iperproteggere, in una società anziana dove si è giovani fino a trenta-quarant’anni, e gli altri, invece, gli immigrati, quelli che vengono qui sperando di avere una vita meno grama, sbattuti dietro un filo spinato, considerati un problema, magari, un domani, spediti in Albania o chissà dove.
Insomma, un basilare principio di giustizia e umanità viene valutato 45 milioni di euro in tre anni, pochino, che già sarebbe vergognoso. Quanto invece a rinunciare alla possibilità di acquisire qualche migliaio nuovi italiani, insegnargli la lingua e un lavoro, ha a che vedere soltanto con la variante “patriottica” della stupidità umana.
 Tutto avrei pensato nella mia vita tranne che di essere testimone – nel mio tempo – di così tanti accordi “storici” che cambieranno le sorti dell’umanità, del pianeta e del Paese (pardon Nazzione). Capisco che al mascellone volitivo e al fiero nazionalismo in favore di telecamera vadano affiancate parole importanti, e che la retorica – e anche la fuffa – abbia bisogno di un vocabolario roboante. Però, metterei un po’ in guardia dall’uso di termini troppo impegnativi, come, appunto, l’aggettivo “storico”.
Tutto avrei pensato nella mia vita tranne che di essere testimone – nel mio tempo – di così tanti accordi “storici” che cambieranno le sorti dell’umanità, del pianeta e del Paese (pardon Nazzione). Capisco che al mascellone volitivo e al fiero nazionalismo in favore di telecamera vadano affiancate parole importanti, e che la retorica – e anche la fuffa – abbia bisogno di un vocabolario roboante. Però, metterei un po’ in guardia dall’uso di termini troppo impegnativi, come, appunto, l’aggettivo “storico”.
Era ancora estate (luglio 2023) quando Giorgia Meloni sbandierava come una sua vittoria personale – lei sì che ci sa fare – lo “storico accordo” con la Tunisia, che per essere “storico” era un po’ la solita solfa: soldi in cambio di migranti, voi li fermate lì, non li fate partire, e noi – intesi come Europa – vi sganciamo qualche milione. Strette di mano, foto solenni e titoloni sullo “storico accordo”, Giorgia sembrava Churchill, con rispetto parlando. Non sono passati nemmeno tre mesi e il trucco da magliari è venuto a galla con un certo clamore: la Tunisia ci rendeva i soldi che erano stati promessi da anni per altre faccende e mai sborsati, e lo “storico accordo” naufragava nel Mediterraneo come tanti povericristi.
Robetta più recente: un fumoso protocollo tra Italia e Germania per un punto d’intesa sul patto di stabilità, niente di che, col corollario del solito summit tra industriali e banchieri, ma basta e avanza perché il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Foti, lanci in pompa magna l’annuncio epocale: “Accordo storico Italia-Germania”, roba da scendere in piazza con le bandiere. Passano pochi giorni ed ecco un altro salto sulla sedia, corredato da titoli e commenti entusiasti: “Accordo storico tra governo e Regione Lazio”, annunciato da certi siti e giornali come un trattato di pace, ma sempre di soldi si parla: un miliardo e due per la Regione dell’amico Francesco Rocca, accordo di cui rallegrarsi, perché no?, anche se definire “storico” l’aumento della sicurezza infrastrutturale sulla linea Roma-Civita Castellana pare un po’ esagerato. Non importa: il “miglioramento dei flussi sulle complanari del Gra di Roma” non sarà l’Impero, o la presa di Addis Abeba, ma è già qualcosa.
Il tutto, ovvio, a corollario del grande “accordo storico” con l’Albania, sempre per posteggiare migranti e richiedenti asilo che non vogliamo trovarci tra i piedi. Qui c’è poco da spiegare, perché i giornali ne hanno parlato come se fosse il trattato di Versailles, “storico”, appunto. Ora emerge, da documenti interni del governo rivelati dalla stampa, che l’accordo “storico” con l’Albania costerebbe un botto: 95,2 milioni di euro il primo anno e poi altri 49 milioni all’anno per quattro anni, il tutto per trattenere dietro il filo spinato al massimo 720 migranti (non 3.000), e questo al netto di altri sostanziosi costi, ricorsi, trasporti, lavori, eccetera eccetera. Si calcola insomma di una spesa di 300 milioni per poco più di settecento persone all’anno, per cinque anni. Non è niente male come “accordo storico”, anche se naturalmente sembrerebbe, a naso, più “storico” spendere quei soldi per integrarli, insegnargli la lingua e un mestiere, magari uno di quei mestieri per cui i nostri imprenditori frignano tanto deprecando l’assenza di addetti e giovani che “non hanno voglia di lavorare”. Ma chi siamo noi per giudicare la Storia della Nazzione? Limitiamoci ad essere testimoni del nostro tempo concedendoci al massino una risata. Storica, ovvio.
 Non potendo cambiare la Storia – nonostante innumerevoli tentativi – cambiare la geografia deve essere sembrata un’idea entusiasmante al governo della destra italiana. E siccome (da anni) si discute di come regolamentare un po’ meno vergognosamente le concessioni balneari italiane con l’applicazione della famigerata direttiva Bolkentein, è stata istituita una speciale commissione con un compito titanico: contare i chilometri (lineari e quadrati) delle coste italiane. L’obiettivo: dimostrare che le concessioni balneari in Italia (traduco: le spiagge privatizzate cedute dallo Stato per due cipolle e un pomodoro a fronte di ottimi guadagni) non sono poi così tante rispetto al totale dei metri di terra che si affacciano sul mare. E infatti la commissione ha fatto il suo lavoro con il metro in mano e… colpo di scena: le coste italiane sono passate in pochi mesi da circa ottomila chilometri a più di undicimila, tremila chilometri di coste in più, che manco i pani e i pesci del famoso miracolo.
Non potendo cambiare la Storia – nonostante innumerevoli tentativi – cambiare la geografia deve essere sembrata un’idea entusiasmante al governo della destra italiana. E siccome (da anni) si discute di come regolamentare un po’ meno vergognosamente le concessioni balneari italiane con l’applicazione della famigerata direttiva Bolkentein, è stata istituita una speciale commissione con un compito titanico: contare i chilometri (lineari e quadrati) delle coste italiane. L’obiettivo: dimostrare che le concessioni balneari in Italia (traduco: le spiagge privatizzate cedute dallo Stato per due cipolle e un pomodoro a fronte di ottimi guadagni) non sono poi così tante rispetto al totale dei metri di terra che si affacciano sul mare. E infatti la commissione ha fatto il suo lavoro con il metro in mano e… colpo di scena: le coste italiane sono passate in pochi mesi da circa ottomila chilometri a più di undicimila, tremila chilometri di coste in più, che manco i pani e i pesci del famoso miracolo.
In pratica, i geometri del governo hanno contato aree urbane, il perimetro dei Faraglioni, gli scogli, i frangiflutti, le spiaggette di due metri incastrate tra promontori a strapiombo, le scogliere scoscese. Vai al mare? Portati una picozza e i chiodi da roccia. Tutto quello che affaccia sulle onde fa il totale, e gira che ti rigira, giocando su chilometri quadrati oltre che su quelli lineari, è saltato fuori – vedi a volte i miracoli – che le spiagge date in concessione per turismo sarebbero il 19 per cento dei terreni demaniali anziché il 65. E’ un po’ come quando si contano i disoccupati, che, per dire che sono pochi, vengono calcolati in modo assurdo e risulta occupatissimo anche chi ha lavorato un’oretta a settimana: scienza statistica applicata all’ideologia.
Va bene, allora, abbiamo più accessi al mare di quanti ne abbiamo mai conosciuti, hurrà! Quindi, siamo lieti di dare una buona notizia a chi quest’estate vorrà andare a fare il bagno senza rompere tanto i coglioni al libero mercato e senza svenarsi: potrà recarsi in una zona industriale, una raffineria, un porto commerciale, un’area marina protetta, oppure nuotare fino a posti irraggiungibili, o piantare l’ombrellone su uno scoglio.
La Commissione Europea, che i nostri eroi pensavano di inchiodare sul bagnasciuga come da antica tradizione, ha fatto un sonoro marameo, dopo essersi accorta che i calcoli includevano zone escluse dalla possibilità di sfruttamento turistico. Insomma, nonostante il fantasioso tentativo del genio italico, dall’Europa fanno sapere di non avere la sveglia al collo e di non essere così scemi come il nostro governo spererebbe con il suo trucchetto da magliari. E del resto, si può dire che la destra italiana, pur di non affrontare il tema delle concessioni e del malcontento dei balneari, suoi grandi elettori, le ha davvero provate tutte. Ancora si ricorda, ad esempio, la giaculatoria triste del ministro del Turismo (!) Santanché, che a un incontro con Confesercenti, magnificando le spiagge private italiane (tipo quella di cui era azionista), denunciava il degrado di quelle pubbliche “piene di tossicodipendenti e rifiuti”.
Insomma, allegri! Se siete di quelli che lamentano, una volta arrivati in vacanza, che la spiaggia pubblica sia lunga qualche metro e quella a pagamento alcuni chilometri, avrete la vostra rivincita. Più spiagge per tutti: private quella dove fare il bagno e sdraiarsi al sole, e pubbliche quella dove potrete sedervi al tramonto e dire: “Ma guarda che bella raffineria!”.
 Forse dovremmo tenercelo stretto, questo Javier Milei, il nuovo presidente argentino, e non solo per la mole spaventosa di aneddoti, curiosità da manicomio, cani clonati, ricorso ai tarocchi come ispiratori di linea politica, e altre divertenti amenità che sembrano saltate fuori da un romanzo real-maravillosodella letteratura sudamericana. Un po’ Trump (non solo per la ridicola anarchia tricologica), un po’ Bolsonaro (“Che problema c’è se un’azienda inquina un fiume?”), ma poi gratta gratta, molto Thatcher e molto liberismo, anzi più liberismo, anzi più più liberismo di quanto riuscireste a immaginarne sotto l’effetto di acidi: uno per cui la compravendita di organi umani sarebbe “un mercato come un altro”. Ce n’è abbastanza per quel tipo di risata che si conclude immancabilmente con la smorfia: non c’è niente da ridere.
Forse dovremmo tenercelo stretto, questo Javier Milei, il nuovo presidente argentino, e non solo per la mole spaventosa di aneddoti, curiosità da manicomio, cani clonati, ricorso ai tarocchi come ispiratori di linea politica, e altre divertenti amenità che sembrano saltate fuori da un romanzo real-maravillosodella letteratura sudamericana. Un po’ Trump (non solo per la ridicola anarchia tricologica), un po’ Bolsonaro (“Che problema c’è se un’azienda inquina un fiume?”), ma poi gratta gratta, molto Thatcher e molto liberismo, anzi più liberismo, anzi più più liberismo di quanto riuscireste a immaginarne sotto l’effetto di acidi: uno per cui la compravendita di organi umani sarebbe “un mercato come un altro”. Ce n’è abbastanza per quel tipo di risata che si conclude immancabilmente con la smorfia: non c’è niente da ridere.
Provinciali come sa essere solo chi considera via del Corso, o piazza del Duomo, il centro del mondo conosciuto, dell’Argentina sappiamo pochissimo, a parte che giocano bene a pallone e che ballano il tango (luogocomunismo livello Pro), e molti scoprono solo ora che laggiù c’è un’inflazione del 140 per cento e il tasso di povertà sfiora la metà della popolazione. Oggi, ecco che arriva questo “loco” che vuole smantellare i ministeri, la Banca Centrale, escludere ogni attività dello Stato dagli affari non dico economici, ma sociali, o addirittura umani, privatizzare tutto, la scuola, la sanità, il territorio, “dollarizzare” il suo paese. E nel farlo (cioè, nell’annunciare di volerlo fare), en passant, nega una delle dittature più sanguinose del Novecento, quella di Videla e complici, e si aggrappa ad economisti altrettanto sanguinosi. Ha chiamato uno dei suon cani, per esempio, Milton Friedman, il famoso economista liberista, le cui teorie fecero da base teorica al regime fascista di Pinochet, in Cile.
Sì, credo che forse un tipo simile dovremmo tenercelo stretto, perché Milei è una caricatura rivelatrice, e come tutte le caricature spiega bene, con tratti estremi ed elementi esasperati, quella che è una tendenza mondiale almeno dagli anni Ottanta in poi (Reagan, la Thatcher, eccetera, fino a Trump e altri campioncini dell’ultra-liberismo): il più forte vince, il mercato sistema tutto, chi non ce la fa cazzi suoi, le politiche di welfare sono una perdita di tempo e di soldi, il darwinismo sociale è la soluzione, e come si permette lo Stato di impedire a un povero di vendersi un rene?
Per quanto possa sembrare ridicola e grottesca (appunto: caricaturale), la figura di Milei rivela che quella corrente di pensiero – economico ma non solo – è in grande spolvero su tutto il pianeta, non a caso i primi ad applaudire e a congratularsi sono stati i campioni planetari della destra: Bolsonaro, Trump. Meloni, Salvini, tutti a battere le mani a un tizio che dice che il papa è “il rappresentante del Maligno sulla terra”. Non mancano, naturalmente, teorici e pensatori ultra-liberisti, bei tomi da social (e anche prestigiosi – ahah – istituti e centri studi) che dicono che lo Stato è una specie di associazione a delinquere, che deruba la gente con le tasse e impedisce la libera espressione del libero pensiero del cittadino e la sua libertà di farsi – perdonate il francesismo – i cazzi propri. Ora vedremo se il “loco” rispetterà le sue promesse, cosa di cui è lecito dubitare, e per una volta potremmo concederci il lusso di vedere in bicchiere mezzo pieno (non siamo argentini), con l’ansia di vederlo un domani mezzo vuoto (potremmo diventarlo).
 Da settimane, anzi da mesi, mi tormenta una domanda. Potrà sembrare una domanda peregrina, con quello che succede nel mondo, ma sapete com’è, certi interrogativi si insinuano nella mente, si installano lì e non se ne vanno finché non arriva una risposta, o almeno qualcosa che le assomiglia. Ed ecco la domanda: dove sono finiti gli immigrati venezuelani che Giorgia Meloni voleva importare per dare braccia all’economia italiana? Qualcuno ha visto in giro un venezuelano? Qualcuno ha sentito sussurrare, in un mercato, in una fabbrica “Qui si sta molto bene, ma ho nostalgia di Caracas”? Vi prego, fatemelo sapere, non posso vivere con questo tarlo.
Da settimane, anzi da mesi, mi tormenta una domanda. Potrà sembrare una domanda peregrina, con quello che succede nel mondo, ma sapete com’è, certi interrogativi si insinuano nella mente, si installano lì e non se ne vanno finché non arriva una risposta, o almeno qualcosa che le assomiglia. Ed ecco la domanda: dove sono finiti gli immigrati venezuelani che Giorgia Meloni voleva importare per dare braccia all’economia italiana? Qualcuno ha visto in giro un venezuelano? Qualcuno ha sentito sussurrare, in un mercato, in una fabbrica “Qui si sta molto bene, ma ho nostalgia di Caracas”? Vi prego, fatemelo sapere, non posso vivere con questo tarlo.
Eppure – correva l’anno 2018 – Giorgia Meloni assicurava che in Venezuela (testuale) “milioni di persone stanno letteralmente morendo di fame”, con il che non si sarebbe trattato soltanto di un’importazione di lavoratori a basso costo, ma addirittura di una missione umanitaria, un’azione benemerita. Niente di niente. Non solo qui non ci sono venezuelani, nonostante la generosa offerta di Giorgia, ma non c’è nemmeno notizia (per fortuna) che in Venezuela ci siano state milioni di persone “letteralmente” morte di fame.
Questa faccenda dei venezuelani da importare al posto dei neri che vengono dall’Africa (che nel caso potrebbero andare in Venezuela, chissà) ci dice due cose. La prima: se stai all’opposizione puoi dire e pensare e urlare nei comizi tutte le puttanate che vuoi. La seconda: quando sei al governo i venezuelani te li scordi e devi fare i conti con le faccende reali, e la faccenda reale è che da quando Meloni è al governo gli arrivi di migranti da sud (non dal Venezuela) sono raddoppiati.
Questo non significa affatto che se sei al governo smetti di dire scemenze. Una delle più divertenti fu l’accordo con la Tunisia, accordo definito “storico” dai giannizzeri di Giorgia (ci metto anche un bel pezzo di stampa italiana), forse perché questa questione della Storia, che li ha presi a schiaffoni ottant’anni fa, ancora non l’hanno digerita. La solita solfa: soldi (nostri ed europei) in cambio di filtri, vi tenete qualche milioncino di euro, però vi tenete anche i migranti africani che, stufi di farsi torturare in Libia, deviano verso la Tunisia. Grande delusione: la Tunisia, dopo le foto di rito e le strette di mano, ha fatto un gigantesco marameo, e l’accordo storico – una variante del lodo Minniti con la Libia – ha vissuto un paio di settimane, pure meno.
Ora, come tutti sanno, vanno di moda Edi Rama e l’Albania, con un altro accordo storico (ahah, ndr) per cui l’Albania ci presta un paio di terreni, noi ci costruiamo delle piccole Guantanamo mediterranee e ci spediamo i migranti, un po’ in attesa della decisione sulla loro richiesta d’asilo e un po’ in stato di detenzione. Tremila al mese – perché secondo Giorgia in ventotto giorni si deciderà sulla loro sorte – per un totale di trentaseimila l’anno. Calcolo bizzarro, perché oggi a formalizzare una domanda di asilo ci mettiamo quasi dodici mesi e non si capisce come, per magia, dovremmo mettercene uno solo. Il tutto mentre l’ideuzzologo di Giorgia, Fazzolari, dice che nella piccola Guantanamo albanese si potrà restare anche 18 mesi, e non i 28 giorni promessi a Edi Rama. Il quale, va detto, si è comportato molto bene, è stato gentile, sorridente e fascinoso come un Sean Connery dei Balcani, ha dimostrato grande amicizia e ha risposto con cortesia a tutti i giornali che gli chiedevano dell’accordo: “Non servirà a niente e non risolverà il problema”.
Arriva oggi (Prime Video) la seconda stagione di Monterossi, la serie. Ne parleremo, magari, ma intanto, ecco. Qui c’è la recensione di Antonio Di Pollina sul Venerdì di Repubblica e quella di Sara Sirtori su Style Magazine del Corriere della Sera
 Da qualche giorno (me ne scuso) rifletto sul mio status di occidentale, che secondo alcuni acutissimi osservatori, commentatori, corsivisti, strateghi, arruffapopoli e guerrieri da divano, dovrebbe essere la mia collocazione naturale nei conflitti armati in giro per il mondo. Abitando a Milano (che è per metà del Qatar), in effetti sono più occidentale di uno che sta a Brescia, un po’ meno di uno che sta a Torino e devo ammettere che uno di Lisbona è molto più occidentale di me. Con una grande confusione geografica, però, perché risulta che uno di Casablanca, per dire, non è così tanto occidentale, mentre uno che compra la Lamborghini a Dubai sì, lo è parecchio, e lo dice su Tik Tok.
Da qualche giorno (me ne scuso) rifletto sul mio status di occidentale, che secondo alcuni acutissimi osservatori, commentatori, corsivisti, strateghi, arruffapopoli e guerrieri da divano, dovrebbe essere la mia collocazione naturale nei conflitti armati in giro per il mondo. Abitando a Milano (che è per metà del Qatar), in effetti sono più occidentale di uno che sta a Brescia, un po’ meno di uno che sta a Torino e devo ammettere che uno di Lisbona è molto più occidentale di me. Con una grande confusione geografica, però, perché risulta che uno di Casablanca, per dire, non è così tanto occidentale, mentre uno che compra la Lamborghini a Dubai sì, lo è parecchio, e lo dice su Tik Tok.
Ma siccome quando si dice Occidente si intende un sistema di valori e un certo standard di vita, non posso negare: ho una casa, una macchina, figli che studiano, vado moderatamente a cena fuori, nessuno occupa la mia casa, l’ospedale non è una sciccheria ma nessuno lo bombarda, non ammazzo per questioni etniche, o religiose, le ragazze che conosco non vengono picchiate per come tengono i capelli.
Insomma sì, sono occidentale, il che dovrebbe – nei sogni di quelli che bramano lo scontro di civiltà, da Oriana Fallaci in poi – arruolarmi di diritto da una parte, ed è qui che il mio essere occidentale vacilla un po’. Perché – mi viene in mente – era occidentale anche Colin Powell con la sua boccettina di antrace all’Onu. Erano occidentali quelli che torturavano la gente a Abu Ghraib, e se ho visto quelle prodezze occidentali è grazie a un giornalista occidentale, Julian Assange, che adesso sta detenuto (in Occidente, non in Iran) per avermele fatte vedere. Leggo che oggi lo Stato di Israele sarebbe un baluardo per l’Occidente, anche se ha ammazzato diecimila persone e migliaia di bambini in un mese, in rappresaglia ormai di uno a dieci, per l’aggressione di Hamas, altri morti innocenti e altri bambini vittime.
Ovviamente non mi si chiede di essere occidentale per accidente geografico, ma per condivisione di valori, e qui, se possibile, la cosa si complica ancora di più. Anche gli imbecilli che accusano chiunque dica “Cessate il fuoco” di simpatizzare con Hamas sono occidentali, e prima o poi tocca a tutti, dal papa ad Amnesty International, dall’Onu a Greta Thunberg, fino alle centinaia di migliaia di occidentali di religione ebraica che chiedono la stessa cosa.
Poi magari mi sbaglio, ma considero la laicità, la separazione delle questioni di Stato e di governo da quelle religiose, una faccenda piuttosto occidentale. E invece sto assistendo a una guerra senza esclusione di colpi tra gente che sbudella gli occupanti infedeli in nome di Allah e altra gente (il baluardo dell’Occidente, secondo gli accecati) che cita il profeta Isaia, che parla esplicitamente di “vendetta” come ha fatto Netanyahu citando un passo della Bibbia su Amalek, passo che sono andato a cercare: “Ora va’ e colpisci Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che hanno e non risparmiarli, ma uccidi uomo e donna, bambino e lattante, bue e pecora, cammello e asino” (Samuele 15:3).
Come baluardo dell’Occidente, e lo dico da occidentale, non mi piace per niente, ecco. Come non mi piaceva il Sudafrica dell’apartheid, come non mi piacciono i coloni illegali in Cisgiordania, o i matti che, pur facendo i ministri in un governo baluardo dell’Occidente, sognano l’atomica su due milioni di persone innocenti. Io no, grazie, declino gentilmente l’offerta di reclutamento. Occidentale, va bene, ma preferisco disertare.
 Il magico mondo delle riforme fatte con l’elastico ci compare di fronte come un luogo meraviglioso, dove si incassa consenso con annunci roboanti e poi si tira indietro la mano, si monetizza la bella (?) figura senza poi monetizzare niente. Insomma, è un Paese delle meraviglie, di novità annunciate e poi rimangiate con un certo aplomb, un garbo fascinoso simile alla faccia di Tajani quando sorride: ci sono spettacoli migliori.
Il magico mondo delle riforme fatte con l’elastico ci compare di fronte come un luogo meraviglioso, dove si incassa consenso con annunci roboanti e poi si tira indietro la mano, si monetizza la bella (?) figura senza poi monetizzare niente. Insomma, è un Paese delle meraviglie, di novità annunciate e poi rimangiate con un certo aplomb, un garbo fascinoso simile alla faccia di Tajani quando sorride: ci sono spettacoli migliori.
Era agosto quando il governo Meloni annunciava con grande clamore una tassa sugli extraprofitti delle banche, “una misura di equità sociale”, come disse Yo soy Giorgia, rimettendo per un attimo il costume da destra sociale che le donava tanto in campagna elettorale. Matteo Salvini, come sua consuetudine preciso al centesimo e rigorosissimo, parlava di un incasso per lo stato di “alcuni miliardi”, zero più, zero meno. Insomma si prefigurava questo scenario: le grandi banche preoccupate di dover pagare, i cittadini sicuri che qualunque esborso sarebbe ricaduto sul loro groppone in forma di rincari vari, le lobby e i gruppi di pressione al lavoro sottotraccia. Ora che quella tassa è conclamata e definitiva, il risultato è che i tassati (le banche) possono decidere di non pagarla (manco morti) purché usino quei soldi (qualcosa in più) per rinforzare il proprio patrimonio. E’ un po’ come dire al contribuente: puoi pagare questa tassa, oppure puoi mettere l’importo in un cassetto, o comprati una Porsche, e “l’equità sociale” la salutiamo, ciao ciao, con un fruscio gommoso di elastico, la tassa torna indietro.
Altro caso di scuola interessante, la cedolare secca sugli affitti brevi: dal 21 al 26 per cento, presentata con varie motivazioni. La prima e più evidente non ha osato pronunciarla nessuno: non è giusto che la rendita sia tassata più del lavoro, argomento così démodé che non si dice nemmeno a sinistra. Poi, però, bisognava tirare un osso a Forza Italia, placare Tajani, accontentare los liberistas che gridavano al socialismo reale nei B&b. Risultato: pagheranno una tassa più alta i proprietari di appartamenti in affitto che ne abbiano almeno tre, che abbiamo un nipote che si chiama Gualtiero, meno di dieci diottrie, un principio di gotta. E’ vero, la platea si restringe un po’ (di circa il 90 per cento), soldi ne arriveranno pochi, il dumping sul mercato degli affitti resterà intatto, ma Yo soy Giorgia e Yo soy Giorgetti potranno menare vanto per una misuretta di “equità sociale” (risate in sottofondo).
Il capolavoro arriva invece con l’Iva raddoppiata sui prodotti per l’infanzia e quella che pudicamente i giornali chiamano “l’igiene femminile” (traduco in italiano: gli assorbenti). L’iva sul latte in polvere era del cinque per cento (manovra 2023, sbandierata da Meloni come un grande successo a vantaggio della natalità della Nazzione) e balza al dieci (manovra 2024), con la sublime motivazione che la norma “non ha funzionato”. Cioè gli italiani, farabutti, non hanno approfittato di quello sconto di pochi centesimi su pannolini, semolini e latte per neonati per figliare come conigli. Hanno perso un’occasione d’oro, maledetti, e, distratti dall’inflazione e dai bassi salari, hanno perso una straordinaria opportunità di risparmio, oltre che di gioia genitoriale. Non ha funzionato, ecco, nel dubbio aumentiamo, non fa una piega. Alla fine la manovra con l’elastico verrà votata così, senza odiosi emendamenti, con la consistente soddisfazione di aver penalizzato le pensioni, la scuola, la sanità. Yo soy Draghi, Yo soy Fornero, che spettacolo!
 Essendo il mondo, per com’è messo, già deprimente di suo, consiglierei di non guardare le statistiche, gli studi, le elaborazioni di dati economici, per non precipitare nello sconforto più nero, per esempio lo sconforto che prova una famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. Secondo Eurostat in questa condizione ci sarebbe il 45,5 dei cittadini europei, che già è un dato spaventoso, cifra che in Italia si impenna fino al 63 per cento e passa, il che significa che per più di tre persone su cinque l’orizzonte tra una busta paga e quella successiva si presenta come una marcia su un campo minato. Si sa che le statistiche sono fredde e distanti, che i numeri sono una cosa e la vita un’altra cosa, e dunque possiamo metterla così: una moltitudine di italiani si alza ogni mattina pregando che non succeda nulla di imprevisto, che Gino non rompa gli occhiali, che la lavatrice non faccia le bizze, che non aumenti la retta dell’asilo, o i libri per la scuola dei figli, che la nonna non debba andare dal dentista, che non serva una visita urgente. Una vita con in tasca un cornetto scaccia-sfiga, che significa una vita in affanno, in difesa, sempre con la lima in mano per smussare una spesa qui e una spesa là, per vivere un po’ peggio.
Essendo il mondo, per com’è messo, già deprimente di suo, consiglierei di non guardare le statistiche, gli studi, le elaborazioni di dati economici, per non precipitare nello sconforto più nero, per esempio lo sconforto che prova una famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. Secondo Eurostat in questa condizione ci sarebbe il 45,5 dei cittadini europei, che già è un dato spaventoso, cifra che in Italia si impenna fino al 63 per cento e passa, il che significa che per più di tre persone su cinque l’orizzonte tra una busta paga e quella successiva si presenta come una marcia su un campo minato. Si sa che le statistiche sono fredde e distanti, che i numeri sono una cosa e la vita un’altra cosa, e dunque possiamo metterla così: una moltitudine di italiani si alza ogni mattina pregando che non succeda nulla di imprevisto, che Gino non rompa gli occhiali, che la lavatrice non faccia le bizze, che non aumenti la retta dell’asilo, o i libri per la scuola dei figli, che la nonna non debba andare dal dentista, che non serva una visita urgente. Una vita con in tasca un cornetto scaccia-sfiga, che significa una vita in affanno, in difesa, sempre con la lima in mano per smussare una spesa qui e una spesa là, per vivere un po’ peggio.
A rischio povertà ed esclusione sociale sarebbe il 26,4 delle famiglie con figli a carico (e senza figli non è che si stappa lo spumante: 22,6). Secondo il rapporto di Action Aid, pubblicato qualche giorno fa, otto milioni di persone (il 12 per cento della popolazione) vive una “deprivazione alimentare materiale”, il che significa non riuscire a procurarsi tutti i giorni un pasto completo dal punto di vista nutrizionale, o abbastanza frutta e verdura. Insomma non è vero, ma nemmeno un po’, che “i poveri mangiano meglio”, come dice il ministro-cognato, ed è più realistico pensare – dati alla mano – che i poveri mangino meno.
Ripeto il consiglio: non guardare le statistiche. Perché a guardarle viene un po’ meno la retorica della Nazione (sic) che si rialza, che guarda avanti, che spera, e tutte le fregnacce della propaganda che conosciamo. Liste d’attesa per curarsi, ultimi, spesa per la sanità, ultimi o penultimi, stipendi dei medici, in fondo alla fila in compagnia di Grecia e Portogallo. Però siamo primi in emigrazione: quasi sei milioni di italiani vivono all’estero e quasi un milione e mezzo hanno tra i 18 e i 34 anni, il che significa che a scappare per primi, a mettersi in salvo, sono le forze più produttive.
A compensare (?) il calo di potere d’acquisto delle famiglie e la curva discendente della propensione al risparmio, ci sarebbe un bel segno più, che riguarda i profitti delle aziende, e questo ce lo dicono altre ricerche e statistiche, come quella dell’Istat sul 2022 diffusa un paio di settimane fa: redditi scesi dell’1,6 in valori reali, stante un’inflazione a due cifre, e valore aggiunto delle aziende non finanziarie cresciuto del 9,1, con un tasso di profitto superiore al 45 per cento. Un dato che affonda definitivamente la retorica del “siamo sulla stessa barca”, cioè la barca sarà la stessa, ma le differenze tra prima, seconda e terza classe si fanno sempre più evidenti. Una cosa che getta una luce un po’ sinistra su quella formuletta tanto in voga della “coesione sociale”, due parolette che sembrano una foglia di fico messa lì a coprire certe vergogne sempre più difficili da nascondere, un po’ irritanti, uno sberleffo, perché – guardando le statistiche – di sociale ce n’è poco, e di coesione nemmeno l’ombra.Statistiche.Italiani più poveri, aziende picriche: dov’è la “coesione sociale”?
 Se prendi un cretino che dice una cosa sensata, l’effetto è assicurato: non è che il cretino sembrerà di colpo intelligente, è più facile che la cosa sensata sembri cretina anche lei. Il metodo è diventato una regola che si può comodamente osservare, applicata con qualche variante, nelle più disparate faccende del mondo, e pare che qui, in Italia, venga utilizzata con una certa pervicace costanza. L’esempio più attuale – e tragico – ci viene dalle questioni palestinesi: non c’è giorno che non si leggano sui giornali della destra (e non solo della destra) strali feroci sui “sostenitori di Hamas”, che abiterebbero notoriamente a sinistra. Uno si aspetta che davvero, là fuori, ci siano voci che inneggiano ai tagliagole, che approvino l’uccisione di civili e bambini. Invece no, non risulta. Leggendo i giornali (molti giornali) e guardando la tivù (molta tivù), ma anche chiacchierando al bar, o con i colleghi, o con chiunque altro, non ho letto né sentito nessuno sano di mente dire che Hamas “ha fatto bene”. Il trucco, nemmeno nascosto, è dunque quello di attribuire a chi non si allinea con una voce univoca (nel caso specifico quella della rappresaglia, della vendetta, della reazione totale, dello “spianare” Gaza, del sangue contro sangue) una posizione indicibile, che infatti nessuno dice, a parte qualche squinternato scovato con il lanternino in pieghe molto nascoste e irrilevanti della società. Chi dubita della reazione israeliana in atto in Palestina, insomma, corre il rischio di essere automaticamente arruolato nelle fila del terrorismo più odioso.
Se prendi un cretino che dice una cosa sensata, l’effetto è assicurato: non è che il cretino sembrerà di colpo intelligente, è più facile che la cosa sensata sembri cretina anche lei. Il metodo è diventato una regola che si può comodamente osservare, applicata con qualche variante, nelle più disparate faccende del mondo, e pare che qui, in Italia, venga utilizzata con una certa pervicace costanza. L’esempio più attuale – e tragico – ci viene dalle questioni palestinesi: non c’è giorno che non si leggano sui giornali della destra (e non solo della destra) strali feroci sui “sostenitori di Hamas”, che abiterebbero notoriamente a sinistra. Uno si aspetta che davvero, là fuori, ci siano voci che inneggiano ai tagliagole, che approvino l’uccisione di civili e bambini. Invece no, non risulta. Leggendo i giornali (molti giornali) e guardando la tivù (molta tivù), ma anche chiacchierando al bar, o con i colleghi, o con chiunque altro, non ho letto né sentito nessuno sano di mente dire che Hamas “ha fatto bene”. Il trucco, nemmeno nascosto, è dunque quello di attribuire a chi non si allinea con una voce univoca (nel caso specifico quella della rappresaglia, della vendetta, della reazione totale, dello “spianare” Gaza, del sangue contro sangue) una posizione indicibile, che infatti nessuno dice, a parte qualche squinternato scovato con il lanternino in pieghe molto nascoste e irrilevanti della società. Chi dubita della reazione israeliana in atto in Palestina, insomma, corre il rischio di essere automaticamente arruolato nelle fila del terrorismo più odioso.
Potremmo chiamarlo uno schema, una dinamica della dialettica della contrapposizione, che ha avuto la sua prova generale, il suo battesimo di fuoco, nella stagione del Covid. Un’emergenza vera, una paura palpabile, che produsse un pensiero unico: guai a contestare la tecnica del lockdown, per esempio, guai ad avanzare perplessità sul greenpass: chi osava farlo, o anche solo chi problematizzava un po’ la questione, passava immediatamente per un picchiatello che teme il 5g iniettato nel sangue, un medievale terrapiattista, additato al pubblico ludibrio, irriso, emarginato dal discorso pubblico. Fino al paradosso che quando criticavano il lasciapassare per lavorare, persino i trivaccinati venivano accomunati agli ultras novax. Che è un po’ come quando si accusa Moni Ovadia di stare con Hamas: una scemenza di portata planetaria.
Lo schema si riprodusse dopo l’invasione russa dell’Ucraina: l’accusa di putinismo o filo putinismo per chiunque non si allineasse alla guerra a oltranza, per cui si arruolava sotto le bandiere del Cremlino anche chi chiedeva un semplice cessate il fuoco, o trattative, o un qualche anche generico sbocco di umanità che mettesse fine a una mattanza spaventosa. Una molla generatrice di questo schema (se non stai con me stai con Hamas, stai con Putin, sei antiscientifico e terrapiattista) è l’emotività dei media. Un po’ si può capirla, perché la prima cosa che pensi quando uno ti tampona con la macchina è: ora scendo e gli spacco la faccia. Nella vita reale dura un minuto e poi passa, per fortuna, ma pare che invece nella formazione-manipolazione dell’opinione pubblica duri più a lungo, venga reiterata e rilanciata. Poi, con il tempo, gli angoli si smussano, piano piano, con calma, cercando di far dimenticare le scemenze estremiste teorizzate per mesi. Colpo di scena: puoi volere che si smetta di morire in Ucraina senza essere Putin, e puoi volere uno stato palestinese senza essere Hamas, anzi provandone orrore.
 La guerra bisogna vederla dal basso, dalla parte di chi la subisce. Perlopiù ce la raccontano dall’alto, dalla parte di chi la fa: tattiche, strategie, azioni militari, con parole antichissime (assedio) e nuove (droni, cyber war), si tende a guardare tutto dalla parte di chi tiene il fucile e non da quella di chi guarda il buco nero della canna rivolta verso di lui. Vale per tutti i civili, ovviamente, da qualunque parte, in qualunque guerra. Vale per gli ucraini, per gli armeni costretti a scappare, per gli israeliani ammazzati in casa o al rave party, per i due milioni di abitanti di Gaza a cui ora si chiudono luce, gas, acqua, approvvigionamenti di cibo, mentre li si bombarda indiscriminatamente, ospedali, moschee, case, nella febbre della rappresaglia, nell’esaltazione del “sangue contro sangue”: comandano gli estremi.
La guerra bisogna vederla dal basso, dalla parte di chi la subisce. Perlopiù ce la raccontano dall’alto, dalla parte di chi la fa: tattiche, strategie, azioni militari, con parole antichissime (assedio) e nuove (droni, cyber war), si tende a guardare tutto dalla parte di chi tiene il fucile e non da quella di chi guarda il buco nero della canna rivolta verso di lui. Vale per tutti i civili, ovviamente, da qualunque parte, in qualunque guerra. Vale per gli ucraini, per gli armeni costretti a scappare, per gli israeliani ammazzati in casa o al rave party, per i due milioni di abitanti di Gaza a cui ora si chiudono luce, gas, acqua, approvvigionamenti di cibo, mentre li si bombarda indiscriminatamente, ospedali, moschee, case, nella febbre della rappresaglia, nell’esaltazione del “sangue contro sangue”: comandano gli estremi.
In questa tenaglia finiscono i civili, quelli che non c’entrano, che semplicemente stanno lì. Succede che la valvola della pentola a pressione salti, che la fiammata ammazzi qualcuno, quasi sempre qualcuno che non c’entra, gli innocenti, quella “povera gente”, per citare Bertold Brecht, che in seguito alle guerre farà la fame, da vinti e da vincitori.
La questione palestinese se ne sta lì da molto più di mezzo secolo, a volte assopita, a volte clamorosamente scottante, un bubbone aperto che si spera non erutterà – figurarsi – con un Paese governato da una destra estrema, con ministri fanatici, con insediamenti illegali che rosicchiano terre e case al nemico, con esercito e servizi fino a ieri considerati efficientissimi; e un’altra popolazione prigioniera, che dipende in tutto e per tutto dall’occupante. Quello che succede oggi è figlio di una storia complessa, intrecciata in anni e anni di ingiustizie, tormenti, risoluzioni Onu mai rispettate, repressione, apartheid, formazioni terroristiche. Ma è figlio anche di uno schema che è andato precisandosi e affinandosi, che la guerra in Ucraina ha affilato come una lama, che viene imposto nella narrazione corrente, reso obbligatorio: il buono e il cattivo. Se perde il buono perderemo tutti, è l’assunto che rafforza la tesi, una tesi che la famosa Europa sembra sposare sempre in modo meccanico e acritico, si veda la favola bella che armiamo fino ai denti l’Ucraina per difendere Berlino, Roma, Parigi, l’Occidente, eccetera eccetera. Balle, come gran parte dell’opinione pubblica sa da tempo. E guai a dire che il buono non è così buono come lo si descrive, perché il sistema binario è subito applicato con rigore chirurgico: dopo il retorico “sei putiniano”, aspettiamoci il più risibile e ridicolo “sei terrorista”. Un sistema binario che è esso stesso guerra, che serve ad alimentare lo scontro, non a fermarlo.
Così oggi quello che la narrazione corrente chiede – una vera chiamata alle armi – non è di capire o di fermare il massacro, o di ragionare, ma di schierarsi senza se e senza ma. Eppure, a dispetto della propaganda, no, noi non siamo Israele, e naturalmente no, noi non siamo Hamas (tocca dirlo, purtroppo, anche se pare assurdo, per prevenire i propagandisti), e questo chiederci di essere questo o quello – senza sfumature, senza dubbi – non è che un ennesimo portato della guerra, un arruolamento forzato delle coscienze. E’ un altro modo – da qui, dal divano – di fare la guerra, mentre il contrario – fermarsi, ragionare, accettare le differenze, lavorare sulle cause, rimuovere le ingiustizie, isolare gli estremi – è l’unico modo, invece, per fare la pace. Non succederà. Non ora, almeno. Ed è un altro crimine.
 Tutti abbiamo avuto un compagno di classe così, dalle elementari alla laurea, uno che “E’ colpa della maestra”, che “Il prof ce l’ha con me”, che “Il cane mi ha mangiato i compiti”, insomma uno che si arrampica su molti specchi, molto insaponati, per dire che lui è bravo, ma il mondo cattivo lo ostacola e lo umilia. Insomma, una specie di governo Meloni, dove non è dato l’errore, o l’inadeguatezza, ma solo l’accanimento altrui. A fare l’elenco dei nemici, c’è davvero da stupirsi che l’esecutivo sia ancora in piedi, forse perché invece di fare leggi scritte decentemente o mettere a punto una politica sensata, si passano ore e ore a cercare avversari, probabilmente a Palazzo Chigi hanno un “ufficio nemici” che si riunisce ogni mattina per rispondere alla domanda: “A chi diamo la colpa oggi?”.
Tutti abbiamo avuto un compagno di classe così, dalle elementari alla laurea, uno che “E’ colpa della maestra”, che “Il prof ce l’ha con me”, che “Il cane mi ha mangiato i compiti”, insomma uno che si arrampica su molti specchi, molto insaponati, per dire che lui è bravo, ma il mondo cattivo lo ostacola e lo umilia. Insomma, una specie di governo Meloni, dove non è dato l’errore, o l’inadeguatezza, ma solo l’accanimento altrui. A fare l’elenco dei nemici, c’è davvero da stupirsi che l’esecutivo sia ancora in piedi, forse perché invece di fare leggi scritte decentemente o mettere a punto una politica sensata, si passano ore e ore a cercare avversari, probabilmente a Palazzo Chigi hanno un “ufficio nemici” che si riunisce ogni mattina per rispondere alla domanda: “A chi diamo la colpa oggi?”.
Del resto, “Tanti nemici tanto onore” è una massima di famiglia, indicare complotti e trame compatta e tempra, serra le fila, vecchia storia. Sono passati solo sei mesi da quando Guido Crosetto allarmava il paese dicendo che i migranti ce li mandava la Wagner per destabilizzarci. Fantasioso. Lo stesso Crosetto dello “schiaffo a Sholtz” di questi giorni (titolo molto gettonato sui giornali amici), perché ora la tesi vittimista è che i migranti ce li manda la Germania (che, sia detto per inciso, ne prende più di noi). Al complotto contribuisce anche Joseph Borrell, alto rappresentante della politica estera Ue: è lui il cattivo che ostacola il “Patto storico con la Tunisia” (sempre i giornali amici), che dovrebbe fermare i migranti a Tunisi, così come i decreti Minniti dovevano fermarli a Tripoli (si è visto, ndr). Se poi i bersagli politici sono troppo grossi, ecco il piano B, attaccare giudici e sentenze, colpevoli di andare contro il governo, cioè di applicare le leggi, risvegliando così un vecchio sogno mai sopito di sottomettere la magistratura al potere politico.
Se si passa all’economia, peggio mi sento. Il cattivo è Gentiloni che non è abbastanza patriota, cioè – dice il vittimismo meloniano – fa il commissario europeo e si dimentica di essere italiano, che è un po’ come indignarsi perché il dottore non ti fa saltare la fila anche se è tuo cugino. Era nemico Macron, quindi asse con la Germania, ora è nemico Sholtz, quindi asse con Macron. E’ amico Orban, che però i migranti non li prende. Anche dal punto di vista del semplice lettore di giornali è un lavoraccio, bisogna tenere il conto aggiornato dei nemici, farsi una tabella, un foglio excel, dove si collocano e si aggiornano le caselle dei cattivi che ostacolano Meloni, che è tanto buona e brava, e ha fatto anche cose buone, tipo spezzare le reni ai rave party.
Non bastasse il vittimismo tattico – ora questo, ora quello – è bene tenersi in caldo un vittimismo strategico. Ed ecco i “poteri forti” che tutto possono e tutto controllano, e che se ne stanno acquattati nell’ombra aspettando di estrarre un Draghi dal cilindro, di realizzare un governo tecnico che – a pensarci bene – sarebbe l’unico vero asso nella manica di Meloni, che dopo prenderebbe l’ottanta per cento. Peccato che l’unico potere forte a cui il governo Meloni abbia creato qualche vago disturbo sia quello bancario, davanti al quale, sugli extraprofitti, ha fatto repentina ed esilarante retromarcia: la tassa che doveva riequilibrare un po’ i conti è diventata una mancetta per il caffè, abbiamo scherzato. Così mentre tutti guardano ai nemici, loro tagliano la sanità, all’attacco di nemici più alla loro portata: non l’avranno vinta, quei bastardi dei malati!
 Un vecchio proverbio brasiliano dice: “Accendo la tivù e c’è tutto, apro il frigo e non c’è niente”. Uff, populista, massimalista, sempre a lamentarsi, che palle. Accendere la tivù, invece, non è mai stato rilassante come oggi, almeno qui, dove qualche telegiornale sta diventando la sezione costume di un rotocalco degli anni Cinquanta, un catalogo dell’Italia Bella, quella che vorremmo, colorata, affollata di turisti a bocca aperta per le sue meraviglie, intenta a passioni solide e tradizionali, come il giardinaggio, o la cucina regionale. Sì, è vero, si parte sempre con qualche seccatura, i migranti o l’economia, pure la guerra, qualche frase di politico, le faccette di Giorgia che sono diventate un format. Ma poi, ecco che si apre la prateria dei nostri sogni, il racconto garrulo e soave di un paese che ha molti problemi, ma il più pressante sembra questo: sui nostri balconi, gardenie o gerani? Una sarabanda fantastica: il mercatino di tendenza, la pasta coi tuberi gialli, l’annata del tartufo, il caso umano di riscatto e rinascita (“facevo il manager, ora bado le pecore e sono felice”), il cane che conta fino a sei, la sagra delle roselline a Vergate sul Membro e il neonato che riporta la vita nel borgo abitato da sei persone. Alla fine del Tg abbiamo assistito a venti minuti di diretta dal Paese dei Balocchi, un vorticoso cinegiornale strenuamente impegnato con parole e opere (e soprattutto omissioni) a disegnare un Paese rilassato e ottimista, speranzoso nel futuro, che guarda al domani con lo sguardo fervido e acceso del pioniere del benessere.
Un vecchio proverbio brasiliano dice: “Accendo la tivù e c’è tutto, apro il frigo e non c’è niente”. Uff, populista, massimalista, sempre a lamentarsi, che palle. Accendere la tivù, invece, non è mai stato rilassante come oggi, almeno qui, dove qualche telegiornale sta diventando la sezione costume di un rotocalco degli anni Cinquanta, un catalogo dell’Italia Bella, quella che vorremmo, colorata, affollata di turisti a bocca aperta per le sue meraviglie, intenta a passioni solide e tradizionali, come il giardinaggio, o la cucina regionale. Sì, è vero, si parte sempre con qualche seccatura, i migranti o l’economia, pure la guerra, qualche frase di politico, le faccette di Giorgia che sono diventate un format. Ma poi, ecco che si apre la prateria dei nostri sogni, il racconto garrulo e soave di un paese che ha molti problemi, ma il più pressante sembra questo: sui nostri balconi, gardenie o gerani? Una sarabanda fantastica: il mercatino di tendenza, la pasta coi tuberi gialli, l’annata del tartufo, il caso umano di riscatto e rinascita (“facevo il manager, ora bado le pecore e sono felice”), il cane che conta fino a sei, la sagra delle roselline a Vergate sul Membro e il neonato che riporta la vita nel borgo abitato da sei persone. Alla fine del Tg abbiamo assistito a venti minuti di diretta dal Paese dei Balocchi, un vorticoso cinegiornale strenuamente impegnato con parole e opere (e soprattutto omissioni) a disegnare un Paese rilassato e ottimista, speranzoso nel futuro, che guarda al domani con lo sguardo fervido e acceso del pioniere del benessere.
Insomma ci si lamenta molto – e giustamente – dello stato dell’informazione italiana, della sua sudditanza al potere e del controllo politico, ma la narrazione si fa anche in altri modi e maniere, meno diretti e anche più ideologici. Visto che si sono buttati fiumi d’inchiostro sul primo anno di Meloni – e giù osanna dai suoi, nonostante i millemila fallimenti – è forse il caso di guardare a un anno di narrazione del paese, il famoso paese reale. E quello che ne esce, in effetti, è una specie di buco spazio temporale: fuori dal tuo incubo di inflazione, recessione, benzina, mutui, c’è tutto un mondo di notizie fantastiche: asteroidi bellissimi pieni d’oro, progressi della scienza, città meravigliose fondate dagli antichi romani, che saremmo noi di questa Nazzione. Alla fine, ti senti veramente un coglione, ad esserti occupato di cose così meschine come i Cpr o il caro-affitti, e se ti chiedessero “dove vuoi vivere?” non avresti esitazioni: “Nella seconda parte del Tg1”.
In sostanza, non sarebbe un’ambizione sbagliata, e tutti dovremmo tendere a vivere in un mondo senza spigoli, dove non bisogna mettere insieme il pranzo con la cena o pagare la benzina come lo champagne, un mondo di progressi scientifici e sagre paesane dove noi – perché siamo dei geni italiani – ce la caveremo sempre.
Insomma, la narrazione sì, è un po’ cambiata in questo anno, anche se la tendenza è antica e stratificata e non c’è nulla di veramente nuovo, a parte l’abuso della parola Nazione, ormai spolverata come zucchero a velo, e spesso a vanvera, su ogni discorso. Un po’ poco, in effetti, per la poderosa seduta di ipnosi che servirebbe a scordarci la realtà, ma chissà, forse si può migliorare, colorare di più, esagerare. Fornire insomma una narrazione del Paese tutta virtuale e rassicurante, va tutto benissimo, siamo felici, un’Italia a realtà aumentata, che sarebbe tra l’altro l’unica cosa che aumenta nell’anno uno dell’era meloniana.
 I sogni son desideri, cantava la Cenerentola di Walt Disney, ed è probabile che lo canti anche Giorgia Meloni, e poi ognuno ha i sogni che si merita e che si coltiva, ovvio. Così si suppone che nelle fantasie della presidentessa del Consiglio ci siano desideri intensi e frementi. Tipo questo: vai a fare benzina, la paghi sopra i due euro al litro, e mentre il contatore del distributore gira più veloce del tassametro di un taxi tu pensi: ah, maledetta Ue che non sgancia i soldi a un dittatore africano per fermare l’invasione di immigrati! Complotto!
I sogni son desideri, cantava la Cenerentola di Walt Disney, ed è probabile che lo canti anche Giorgia Meloni, e poi ognuno ha i sogni che si merita e che si coltiva, ovvio. Così si suppone che nelle fantasie della presidentessa del Consiglio ci siano desideri intensi e frementi. Tipo questo: vai a fare benzina, la paghi sopra i due euro al litro, e mentre il contatore del distributore gira più veloce del tassametro di un taxi tu pensi: ah, maledetta Ue che non sgancia i soldi a un dittatore africano per fermare l’invasione di immigrati! Complotto!
Sogno un po’ improbabile, ma si sa, l’attività onirica non si controlla benissimo, è un po’ come Salvini, fa il cazzo che le pare. Un altro sogno è che uno va al supermercato e trova che tutto costa il dieci-quindici per cento in più dell’anno scorso. Quando trova qualcosa che costa uguale, sciambola!, si accorge che la confezione non è più da mezzo chilo, ma da trecentocinquanta grammi. Insomma, avrebbe tutti i motivi del mondo per sentirsi derubato, truffato, vilipeso, e allora pensa: ah, dannazione, la sostituzione etnica! Oppure: basta! Torniamo al sei in condotta!
Il trucchetto di Meloni con l’uso politico dei migranti è un po’ come la teoria del dolore prevalente: ti do un calcio nelle palle, così smetti di lamentarti per il mal di denti. Funziona per un quarto d’ora, e poi non funziona più, ti restano due dolori, anzi tre, se aggiungi la voce “mutuo/affitto”, anzi quattro, se aggiungi la voce “salario di merda”. Tutte cose di cui è piuttosto difficile accusare un disperato in ciabatte che sbarca a Lampedusa dopo tre anni di botte, fughe e torture.
In più, c’è l’ardita arrampicata sui vetri insaponati e l’ipercollaudata teoria fascio-vittimista del complotto. E’ la Ue che ci manda le barche di neri! No, peggio, è la Ue di concerto con il Pd! Dove quel che sorprende è la schizofrenia della narrazione, per cui il famoso Pd sarebbe ora un totale incapace imbelle in stato confusionale, e un attimo dopo, oplà, un diabolico tessitore di complotti pluto-demo-comunitari per mandarci qui il disperato di cui sopra. Disperato, tra l’altro, a cui non insegneremo l’italiano, né un mestiere, né i rudimenti della nostra gloriosa cultura nazionale, no. Lo metteremo per diciotto mesi in strutture realizzate dall’esercito “in località a bassissima densità abitativa facilmente perimetrabili e sorvegliabili”, (in italiano: campi di concentramento), consegnandolo quindi alla marginalità perenne.
Il tutto mentre la legge-cardine su cui ancora oggi (2023) si basano le politiche italiane dell’immigrazione si chiama Bossi-Fini (2002), è cioè intitolata a due antichi leader in disuso, scritta più di vent’anni fa. E’ come tentare la conquista dello spazio con le macchine a vapore, o dire che l’intelligenza artificiale è regolata dalla legge Cavour-Giolitti. Ma nessuno ha mai voluto metterci mano seriamente perché, alla fine, tirare fuori dal cappello un’emergenza periodica e improvvisa serve a tutti. Il Minniti degli accordi con le tribù libiche (ahah, ndr) non è diverso in nulla dalla Meloni che sbandiera “lo storico accordo” (ahah, ndr) con la Tunisia, promettendo a un dittatore fondi che non dipendono da lei, insomma, esercitando la nobile arte del venditore di tappeti che i tappeti da vendere, però, non ce li ha. In tutto questo, a pagare di più sarà il disperato sbarcato dopo la sua odissea mediterranea, ieri carne per trafficanti, oggi buono per i giochetti politici di un governo che non ne azzecca una nemmeno per sbaglio.
 Dopo l’entusiasmante uscita per cui i poveri mangiano meglio dei ricchi, perla (ahimè, non rara) del ministro-cognato Lollobrigida, aspettiamo con ansia nuove illuminazioni sulla salute degli italiani. Chissà, qualcuno potrebbe venirci a decantare il ritorno dei vecchi cari rimedi della nonna, gli impacchi con la polenta, le sanguisughe, radici curative raccolte nel bosco, o altre diavolerie medievali per cui superstizione e arte di arrangiarsi – due must dei fortunatissimi poveri – fanno premio sulla ricerca e sull’assistenza. Insomma, urge nuova narrazione sull’invidiabile culo dei meno abbienti, categoria sociale in vertiginoso aumento, anche in tema di sanità, perché soldi non ce ne sono, le liste d’attesa si allungano di mesi e anni, e forse per fargli finalmente le analisi prenotate a suo tempo bisognerà riesumare il cadavere del nonno, che nel frattempo ha tolto il disturbo.
Dopo l’entusiasmante uscita per cui i poveri mangiano meglio dei ricchi, perla (ahimè, non rara) del ministro-cognato Lollobrigida, aspettiamo con ansia nuove illuminazioni sulla salute degli italiani. Chissà, qualcuno potrebbe venirci a decantare il ritorno dei vecchi cari rimedi della nonna, gli impacchi con la polenta, le sanguisughe, radici curative raccolte nel bosco, o altre diavolerie medievali per cui superstizione e arte di arrangiarsi – due must dei fortunatissimi poveri – fanno premio sulla ricerca e sull’assistenza. Insomma, urge nuova narrazione sull’invidiabile culo dei meno abbienti, categoria sociale in vertiginoso aumento, anche in tema di sanità, perché soldi non ce ne sono, le liste d’attesa si allungano di mesi e anni, e forse per fargli finalmente le analisi prenotate a suo tempo bisognerà riesumare il cadavere del nonno, che nel frattempo ha tolto il disturbo.
Basti pensare che nel 2022 (dati Istat) quattro milioni di italiani (il sette per cento di tutti noi) ha rinunciato alle cure o per mancanza di soldi o per difficolta di accesso al sistema sanitario, che significa che tu telefoni oggi per un appuntamento che ti fissano tra un anno e mezzo, e allora sai che c’è, vaffanculo e incrociamo le dita (un vecchio trucco dei poveri, insieme al ferro di cavallo e al cornetto portafortuna).
Va detto che la narrazione sulla sanità a uso e consumo dei meno abbienti ha radici storiche, e ancora si ricordano le leggende di una decina di anni fa (governo Renzi) che narravano di troppi esami richiesti dai pazienti – avidi di prelievi – con conseguente stretta sugli esami passati dal SSN. Insomma, pur di tagliare si accusava la popolazione di essere ipocondriaca, e i medici di essere di manica larga. A proposito di medici e infermieri, tra l’altro, segnalerei a tutte le categorie professionali italiane di tenersi alla larga dai complimenti e dagli osanna dei media. Gli operatori della sanità che per un annetto e più sono stati “eroi”, “santi”, “angeli”, passata l’emergenza stanno nella merda come e più di prima, tanto che dalla sanità pubblica c’è un fuggi fuggi generale: nel biennio 2021-2022, tra medici e infermieri, quelli che sono scappati prima del tempo sono aumentati del 120 per cento, senza contare quelli che espatriano perché all’estero li pagano meglio, o che si mettono a lavorare a cottimo per tappare i buchi.
Dopo aver sbandierato al mondo che qui il Pil andava come un treno, che crescevamo alla grande, che c’era una specie di boom economico, anche la sora Meloni e il suo variegato staff di parenti sta aprendo un po’ gli occhi, e magari si accorgerà che i medici italiani chiedono il nuovo contratto (2022-2024) che costerebbe 2,7 miliardi, ma ancora non ci sono i fondi per rispettare il contratto del triennio precedente, e aggiungerei che quasi il 90 per cento delle strutture sanitarie italiane usa macchine diagnostiche obsolete, che andrebbero rinnovate. La spesa a carico dei cittadini in materia di sanità aumenta vertiginosamente: il 41,8 per cento dichiara di aver pagato di tasca propria per visite specialistiche (nel 2022), il 27,6 (stesso anno) di averlo fatto per accertamenti diagnostici.
Insomma, si paga, e chi non può pagare, in molti casi rinuncia a curarsi. Chissà, forse affidandosi a vecchi rimedi, e comunque consolandosi al pensiero che compriamo carri armati per miliardi di euro e aumentiamo la spesa in armamenti, in modo di avere sì una visita oncologica tra due anni, però abbastanza sicuri di non essere invasi da nessuno.
 Le notizie dalla guerra sono frammentarie, occupano le pagine per qualche ora, o giorno, sull’onda dell’emozione, poi spariscono di nuovo fino al prossimo attacco e ai prossimi morti. La guerra del lavoro, intendo. Quella che fa ogni anno in Italia oltre mille morti, tre al giorno, più o meno, e alcune centinaia di migliaia di feriti, senza che nessuno vada in tivù quotidianamente a dare il bollettino, a fare una conferenza stampa con statistiche, dati, cause, nomi dei defunti, patologie o condizioni dei feriti. E soprattutto responsabili.
Le notizie dalla guerra sono frammentarie, occupano le pagine per qualche ora, o giorno, sull’onda dell’emozione, poi spariscono di nuovo fino al prossimo attacco e ai prossimi morti. La guerra del lavoro, intendo. Quella che fa ogni anno in Italia oltre mille morti, tre al giorno, più o meno, e alcune centinaia di migliaia di feriti, senza che nessuno vada in tivù quotidianamente a dare il bollettino, a fare una conferenza stampa con statistiche, dati, cause, nomi dei defunti, patologie o condizioni dei feriti. E soprattutto responsabili.
La tragedia di Brandizzo, per restare alla cronaca, rivela ad ogni ora che passa anomalie, dolo, stratagemmi produttivi, cose che non si possono fare (ad esempio stare sui binari finché passano i treni) ma che si fanno lo stesso, perché i tempi sono stretti, se non si lavora in fretta si erode il profitto, la ditta appaltatrice subappalta a un’altra, che subappalta a un’altra ancora, e via così a cascata, cosa che nell’edilizia, per esempio, è una prassi consolidata. In Piemonte, sempre per restare in zona, la probabilità che un’azienda subisca un controllo dell’Ispettorato del Lavoro è di una visita ogni vent’anni, perché le aziende sono tante e i controllori pochi, pochissimi. La più giovane delle vittime di Brandizzo, Kevin Laganà, 22 anni, era assunto a tempo determinato, prendeva ottocento euro al mese, era insomma, una recluta mandata al fronte. Un fronte – quello del lavoro – dove la sicurezza dei soldati è considerata un costo, un rallentamento, una rottura di palle, una seccatura.
Luana D’Orazio, 22 anni, venne risucchiata dall’orditoio su cui lavorava (era il 2021), in un’azienda tessile di Montemurlo (Prato), perché alla macchina era stata tolta una griglia di protezione che rallentava la produzione – si disse in sede di indagini – dell’otto per cento. Dunque la vita di una ragazza di ventidue anni è perfettamente calcolabile in una frazione del fatturato e del conseguente profitto, che è considerato variabile indipendente, mentre tutto il resto – dalla qualità della vita di chi contribuisce a produrlo, alla sua salute, alla sua sicurezza – è considerato variabile dipendente, cioè sacrificabile a piacere.
Se la metafora della guerra non vi piace – lo capisco – aggiungerò questo, come nelle guerre è l’obiettivo che conta, e l’obiettivo è il famoso Pil, territorio da aumentare e conquistare, consolidare, allargare, e se per farlo servono sacrifici umani e perdite, beh, pazienza. Se la tensione securitaria –
lo scandalo e la paura per la piccola delinquenza, per lo scippo, per l’aggressione – che ogni giorno leggiamo sui media si contagiasse al mondo del lavoro, alle vittime che cadono su quel fronte, non ci basterebbe la carta da stampare, e quindi pare un’autodifesa della società considerare le morti sul lavoro come tragiche fatalità, incidenti, disgrazie senza veri colpevoli, tipo il tamponamento in autostrada. Un costo accettabile, insomma. Con il vantaggio, che risparmiare sulle norme di sicurezza aiuta quasi sempre il profitto privato, mentre il costo sociale (comprese le cure del Servizio Sanitario Nazionale per centinaia di migliaia di feriti) pesa su tutta la comunità, un’altra clamorosa conferma della prassi nazionale: i profitti sono privati e le perdite sono di tutti. Se le aziende che producono morti e feriti dovessero, una volta accertate le responsabilità, pagare le spese sanitarie e iscriverle a bilancio, la sicurezza diventerebbe – allora sì – una priorità. E avremmo meno morti sul fronte del lavoro.
 Per un normale istinto di prudenza, per evitare il baratro più pericoloso, che è sempre quello del ridicolo, e per altri millemila motivi, vorrei mettere in guardia vip, sottovip, famosetti generici per un quarto d’ora e altri esseri umani, dalla tentazione irresistibile del paragone storico. Il trucchetto è noto e, purtroppo, assai diffuso anche ai livelli più alti, cioè quelli della similitudine geopolitica, della metafora che si aggrappa al passato con un certo stato confusionale. Il triste caso Putin, per citare il più recente, ne ha dato plastica rappresentazione. E’ Hitler, no, è Stalin, no, è lo zar, come se tutto fosse uguale, ribollente nello stesso calderone, e come se – per inciso – uno non potesse essere un fior di farabutto in piena autonomia, senza scomodare farabutti più antichi e famosi.
Per un normale istinto di prudenza, per evitare il baratro più pericoloso, che è sempre quello del ridicolo, e per altri millemila motivi, vorrei mettere in guardia vip, sottovip, famosetti generici per un quarto d’ora e altri esseri umani, dalla tentazione irresistibile del paragone storico. Il trucchetto è noto e, purtroppo, assai diffuso anche ai livelli più alti, cioè quelli della similitudine geopolitica, della metafora che si aggrappa al passato con un certo stato confusionale. Il triste caso Putin, per citare il più recente, ne ha dato plastica rappresentazione. E’ Hitler, no, è Stalin, no, è lo zar, come se tutto fosse uguale, ribollente nello stesso calderone, e come se – per inciso – uno non potesse essere un fior di farabutto in piena autonomia, senza scomodare farabutti più antichi e famosi.
Ancor più ridicolo il paragone, diciamo così, autoinferto, cioè quando il parallelo con qualche personaggio storico è condotto in prima persona. Il caso di Marcello De Angelis, portavoce della Regione Lazio, è ancora fresco fresco. Dopo aver detto le sue fregnacce sulla strage di Bologna (i camerati stragisti sarebbero innocenti perché “lo sanno tutti”) non ha esitato a scivolare dalla padella alla brace, anzi direttamente alla pira fiammante: “Sulla strage di Bologna io al rogo come Giordano Bruno, pagherò con orgoglio”. Niente male, considerato che poi non c’è stato nessun rogo, nemmeno un licenziamento, nemmeno una condanna univoca, nemmeno un buffetto, e quanto all’orgoglio lascerei perdere: i soliti umilianti balbettii della retromarcia.
Il povero Giordano Bruno, se potesse, dovrebbe querelare, e De Angelis non è il solo aspirante ustionato. E’ seguito a ruota, infatti, il volitivo generale Vannacci, quello dei libretto nero. Anche lui intriso di paragoni storici, e anche lui avvicinato a Giordano Bruno, ovvio, con la differenza che mentre quello l’hanno bruciato su un rogo, lui l’hanno semplicemente sospeso da un confortevole ufficio, e non è detto che la punizione sia definitiva: dal rogo non si torna, all’ufficetto sì.
Si esagera, insomma. Ma si esagera in modo così grottescamente smaccato e risibile che tutto piomba immediatamente nella farsa, una specie di pochade, un cinepanettone, anzi un fasciopanettone che fa solo un po’ ridere a denti stretti. Aggrava la faccenda il fatto che il generale citi tra i suoi ispiratori anche Giulio Cesare, il che denota un’assoluta mancanza di ironia, perché nelle barzellette chi si paragona a Giulio Cesare finisce solitamente nella stessa stanza (imbottita) di chi si crede Napoleone. Alla fine, il meccanismo è chiaro: si dice una cretinata – più grande è e più ci si aggrappa alla metafora storica – e quando molti si alzano a dire che è una cretinata, scatta il paragone: “Ecco: sono come Giordano Bruno!”.
La moda prende piede. Et voilà Roberto Mancini, neo-commissario tecnico della nazionale Saudita, che frigna seduto su una montagna di milioni: “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze!”, per dire che qualcuno lo ha contestato, e lui c’è rimasto maluccio. Ecco, bisogna ringraziare che, per una volta, si sia lasciato in pace Giordano Bruno buonanima, o Galileo Galilei, o Giovanna d’Arco, a vantaggio di un paragone più pop, ma ugualmente storico. Certo, uno ci rimane male, se si considera paragonato a un tizio che ammazzava la gente e la faceva a pezzetti, c’è da capirlo. Ma è anche vero che il mostro di Firenze, con tutte le cose bruttissime che ha fatto, non è mai stato eliminato dalla Macedonia del Nord. Una prece.
 Abituato a decenni, secoli, millenni di scazzi a sinistra, assistere finalmente a un mirabolante scazzo nella destra post-non-post fascista mette di buon umore. E – mi perdonerete un piccolo “io l’avevo detto” – non si fa, non è elegante, pazienza – perché tre anni fa di questi tempi in questa piccola rubrica, mi ero permesso di far notare che le fila di Fratelli d’Italia erano piene di gente usa a salutare romanamente, a vestirsi da nazista, a celebrare pubblicamente criminali genocidi come il generale Graziani e via elencando varie nefandezze in orbace. Saltò su come un tappo l’allora non onorevole, e non ministro, Guido Crosetto che mi additò in un tweet ai seguaci (da cui minacce varie). L’accusa era, più o meno, che io “vedevo fascisti dappertutto”. Che visionario, eh? Arrivò di rinforzo Carlo Calenda, ribadendo il concetto e flirtando con Crosetto su “quel deficiente di Robecchi”. Modestamente. Ora che Guido Crosetto è ministro della difesa (dopo essere stato presidente dei produttori di armi, un conflitto d’interessi che noterebbe anche un cieco) e ha criticato le parole del generale Vannacci, diverte vederlo attaccato da destra, accusato di moderazione da quegli stessi arditi che glorificano Graziani, gli otto milioni di baionette, spezzeremo le reni alla Grecia, e attaccato pure da quel sottosegretario (Galeazzo Bignami) di cui girano foto “goliardiche” con l’uniforme delle SS. Ho letto anche un “Crosetto comunista”, che ritengo sublime. Chiusa questa piccola madeleine personale, non vorrei che ora qualcuno si alzasse a dire a Crosetto che vede fascisti dappertutto, che visionario, eh?
Abituato a decenni, secoli, millenni di scazzi a sinistra, assistere finalmente a un mirabolante scazzo nella destra post-non-post fascista mette di buon umore. E – mi perdonerete un piccolo “io l’avevo detto” – non si fa, non è elegante, pazienza – perché tre anni fa di questi tempi in questa piccola rubrica, mi ero permesso di far notare che le fila di Fratelli d’Italia erano piene di gente usa a salutare romanamente, a vestirsi da nazista, a celebrare pubblicamente criminali genocidi come il generale Graziani e via elencando varie nefandezze in orbace. Saltò su come un tappo l’allora non onorevole, e non ministro, Guido Crosetto che mi additò in un tweet ai seguaci (da cui minacce varie). L’accusa era, più o meno, che io “vedevo fascisti dappertutto”. Che visionario, eh? Arrivò di rinforzo Carlo Calenda, ribadendo il concetto e flirtando con Crosetto su “quel deficiente di Robecchi”. Modestamente. Ora che Guido Crosetto è ministro della difesa (dopo essere stato presidente dei produttori di armi, un conflitto d’interessi che noterebbe anche un cieco) e ha criticato le parole del generale Vannacci, diverte vederlo attaccato da destra, accusato di moderazione da quegli stessi arditi che glorificano Graziani, gli otto milioni di baionette, spezzeremo le reni alla Grecia, e attaccato pure da quel sottosegretario (Galeazzo Bignami) di cui girano foto “goliardiche” con l’uniforme delle SS. Ho letto anche un “Crosetto comunista”, che ritengo sublime. Chiusa questa piccola madeleine personale, non vorrei che ora qualcuno si alzasse a dire a Crosetto che vede fascisti dappertutto, che visionario, eh?
Resta il problemino per solutori più che abili (quindi escludo Calenda): dentro il partito di governo (e dentro il governo) resta un’ampia corrente di pensiero dichiaratamente e orgogliosamente fascista. E questo è un primo dato. Il secondo dato è che rimangono tutti al loro posto: il portavoce della regione Lazio che sfida le sentenze definitive sulla strage di Bologna per difendere i camerati, il viceministro vestito da Nazi, il ministro-cognato che di Graziani disse “è un punto di riferimento”, il generale vanesio che rivendica l’odio per le minoranze. Si fa un po’ di polvere e poi si perdona, si zittisce, si dimentica, il che suona alle orecchie degli arditi come una silente rivendicazione. Dalla signora premier, infatti, silenzio, nemmeno un fiato. E c’è da capirla. Intanto perché viene da lì, da quella cultura di estrema destra che osanna Almirante – razzista convinto e certificato fucilatore di partigiani – e poi perché per anni, nella sua resistibile ascesa, si è sempre rivolta a quegli ambienti con i toni volitivi che conosciamo, un piede nelle istituzioni (fu ministra a trent’anni, altro che underdog!) e uno nel furore della militanza post(?)fascista, basti pensare al comizio davanti ai camerati di Vox, in Spagna o alle frasette – sì, anche lei, non solo il cognato – sulla “sostituzione etnica”.
Ce ne sarebbe abbastanza per pregare la destra “liberale”, come ama definirsi chi al governo non pratica il passo dell’oca, di battere un colpo, di dire qualcosa su questi suoi camerati di strada, un po’ scomodi in società ma anche molto funzionali. Insomma, l’album di famiglia non è per niente archiviato, anzi è in grande spolvero, alza la voce, minaccia e mugugna. Forse è troppo dire che i post-fascisti hanno un problemino coi fascisti, ma certo risulta che l’operazione di nasconderli sotto il tappeto fa acqua da tutte le parti, o servirà un tappeto molto grande.
Intervista al Fatto Quotidiano. Grazie a Alessandro Ferrucci che ha saputo condensare così bene una lunga chiacchierata su tutto, romanzi, personaggio, satira e tutto il resto. Grazie grazie
 Dei tanti nomi che si può dare alla barbarie, eccone uno nuovo, Ascension Island. Se prendete in mano una mappa farete fatica a trovarla, perché è un puntino minuscolo nell’oceano Atlantico, tra l’Africa (andate a Est e nuotate per milletrecento chilometri) e l’America del Sud (andate a Ovest e nuotate per 2.300 chilometri). Fa parte dell’amministrazione britannica di Sant’Elena (Napoleone vi dice qualcosa?), ci abitano 800 persone, ha una base aerea britannico-americana ed è grande 88 chilometri quadrati, la metà di Milano. Secondo una recente proposta del governo britannico, è lì che si potrebbero deportare i migranti in attesa di asilo attualmente sul suolo inglese.
Dei tanti nomi che si può dare alla barbarie, eccone uno nuovo, Ascension Island. Se prendete in mano una mappa farete fatica a trovarla, perché è un puntino minuscolo nell’oceano Atlantico, tra l’Africa (andate a Est e nuotate per milletrecento chilometri) e l’America del Sud (andate a Ovest e nuotate per 2.300 chilometri). Fa parte dell’amministrazione britannica di Sant’Elena (Napoleone vi dice qualcosa?), ci abitano 800 persone, ha una base aerea britannico-americana ed è grande 88 chilometri quadrati, la metà di Milano. Secondo una recente proposta del governo britannico, è lì che si potrebbero deportare i migranti in attesa di asilo attualmente sul suolo inglese.
Mi spiego meglio: se ti strappano le palle in Iran, o ti fanno morire di fame in Niger, o ti violentano in Libia, o ti trattano maluccio in Afghanistan, e tu riesci, rischiando la pelle e tutti i soldi della tua famiglia, ad approdare sulle coste della grande potenza occidentale che fece tremare il mondo, culla della democrazia e del beat, quelli ti prendono e ti portano alle pendici un vulcano in mezzo all’Atlantico. La proposta precedente – suggellata addirittura da un accordo da milioni di sterline – era di portarli in Ruanda, proposta ancora in piedi, peraltro.
Insomma, duecentoquindici anni dopo l’abolizione dello schiavismo nel Regno Unito (1807) assisteremo forse a un flusso inverso: gli schiavi sono una bella rottura di coglioni e si allestiranno delle belle navi per (de)portarli via. Navi che peraltro funzionano alla grande già ora, anche se sono, diciamo così, stanziali, come la Bibby Stockholm, una mega-chiatta adattata a prigione, lunga cento metri, dove la Gran Bretagna ospita migranti richiedenti asilo, al largo delle sue coste. Interessante la storia della compagnia armatrice, la Bibby Line Group Limited, che John Bibby fondò proprio nel 1807. Trasportare schiavi di qua e di là diventava illegale e il vecchio John si metteva in regola, anche se i soldi li aveva fatti anche con quel commercio di braccia dall’africa alle colonie. SlaveVoyages, un prezioso database che raccoglie i dati delle rotte schiaviste, registra almeno tre trasporti: il veliero Harmonie che portò 250 schiavi angolani alla Guiana Britannica, il Sally (250 nigeriani alle Barbados) e l’Eagle (237 camerunesi in Jamaica). Insomma, ieri schiavisti, poi riciclati in armatori, e oggi fornitori di questa feroce nave prigione per gente (i richiedenti asilo) che in prigione non ci dovrebbe stare.
Dunque è uno strano concetto di “aiutiamoli a casa loro”, un refrain delle democrazie occidentali, compresa la nostra, che per “aiutarli a casa loro” mise in campo i decreti Minniti (governo Gentiloni), poi regalò motovedette alla guardia costiera Libica – più volte accertata complice dei trafficanti di esseri umani – esternalizzando la prigionia in lager che fingiamo di non vedere. Oppure (governo Meloni) promettendo mari e monti (di euro) al governo tunisino “per non farli partire”, con il risultato che quelli – essendo disperati e non avendo scelta – partono lo stesso (cinque volte in più dell’anno scorso dalla Tunisia, il doppio in totale).
Il tutto mentre di Africa si discute molto per il golpe in Niger, dove quei cattivoni cambiano padrone, si affidano ai russi, invece di apprezzare e ringraziare il vecchio padrone francese che li ha depredati per secoli, come farà del resto il padrone nuovo. E così ecco noi bravi occidentali, così umani e disinteressati, gridare agli orrori del colonialismo. Che spettacolo!
 Riassumiamo per i non udenti, i non vedenti, gli ignari, i patrioti e quelli che guardano il Tg1: Il Pil cala di brutto, siamo gli ultimi in Europa, anche se la sora Meloni attraversa il globo terracqueo per dire che c’è “un piccolo miracolo economico italiano” (sic). L’inflazione è la più alta d’Europa, sei per cento, ma se andate a fare la spesa la trovate al dieci e passa. La benzina sfiora i due euro al litro, aumentano le rate dei mutui, nel caso vi venisse la balzana idea di andare in vacanza troverete alberghi più cari e voli carissimi. Centosessantanovemila famiglie in bilico tra povertà e disastro hanno ricevuto un sms con scritto “cazzi vostri”, altre ottantamila lo riceveranno a breve, sono quelli che la retorica congiunta di destra, di centro, di finta sinistra e di tutti i giornali hanno additato per anni come “fannulloni sul divano” e che ora – uh, che spavento! – si alzeranno forse dal divano e faranno un casino del diavolo, cioè, si spera. Per quelli che lavorano, invece, gli stipendi sono fermi, il salario minimo non è bello – turba l’ordine sacro del mercato e dello sfruttamento – e alla Caritas c’è gente che si mette in fila quando stacca dal lavoro sottopagato.
Riassumiamo per i non udenti, i non vedenti, gli ignari, i patrioti e quelli che guardano il Tg1: Il Pil cala di brutto, siamo gli ultimi in Europa, anche se la sora Meloni attraversa il globo terracqueo per dire che c’è “un piccolo miracolo economico italiano” (sic). L’inflazione è la più alta d’Europa, sei per cento, ma se andate a fare la spesa la trovate al dieci e passa. La benzina sfiora i due euro al litro, aumentano le rate dei mutui, nel caso vi venisse la balzana idea di andare in vacanza troverete alberghi più cari e voli carissimi. Centosessantanovemila famiglie in bilico tra povertà e disastro hanno ricevuto un sms con scritto “cazzi vostri”, altre ottantamila lo riceveranno a breve, sono quelli che la retorica congiunta di destra, di centro, di finta sinistra e di tutti i giornali hanno additato per anni come “fannulloni sul divano” e che ora – uh, che spavento! – si alzeranno forse dal divano e faranno un casino del diavolo, cioè, si spera. Per quelli che lavorano, invece, gli stipendi sono fermi, il salario minimo non è bello – turba l’ordine sacro del mercato e dello sfruttamento – e alla Caritas c’è gente che si mette in fila quando stacca dal lavoro sottopagato.
Nel frattempo, abbondano i regali per i ceti alti, gli evasori avranno nuovi sconti e agevolazioni, i parlamentari si riprendono i loro vitalizi con gli arretrati. Certo, anche i ricchi hanno i loro problemi: non potranno comprare una Lamborghini perché fino alla fine del 2024 gli ordini sono al completo, ed è un problema trovare un tavolo al Twiga: l’ultimo l’hanno occupato quelli di Italia Viva per il loro sushi party garantista dove si festeggiava una che non pagava dipendenti e fornitori e che fa il ministro del turismo.
Potrei continuare, e anzi ognuno lo faccia per quel che lo riguarda, ma un dato è certo: mai come ora, estate 2023, la distanza tra due Italie è parsa così siderale e incolmabile, la società così vergognosamente scollata tra chi ce la fa agevolmente e chi arranca. Anche le politiche economiche dissennate, tutte foriere di diseguaglianze, degli ultimi trent’anni mostrano il loro fallimento: si pensava che fosse tutto ceto medio, qui, con una piccola parte fisiologica di molto poveri. E invece i molto poveri sono aumentati e il ceto medio teme – ha il terrore – di scivolare là sotto pure lui. Ciò crea una piccola borghesia spaventata, ben addestrata a indicare come nemico chi sta peggio e a non vedere – anzi a invidiare – i privilegi vergognosi di chi sta troppo meglio. Il tutto mentre una classe dirigente messa su in fretta e furia, ripescata dalle sedi del Msi, raschiata via dal fondo culturale del barile, si affanna nella sua unica riforma riuscita: chiamare Nazione un Paese sfibrato.
Questo è lo stato dell’arte, che evidenzia clamorosamente gli errori di quella che si è un po’ arditamente definita “sinistra” negli ultimi trent’anni, dal pacchetto Treu che apriva il vaso di Pandora del lavoro precario (1997), alla mitologica agenda Draghi (2022), con in mezzo incalcolabili nefandezze a punizione dei ceti più deboli. Lo stesso identico meccanismo per cui ci mancano i Canadair ma compriamo carri armati; o per cui pur dopo una pandemia e con budget illimitato, si continua a tagliare la sanità pubblica a vantaggio delle spese militari. Urge, se non per giustizia almeno per calcolo politico, qualcuno che ricominci a parlare di lotta di classe, che non è scomparsa, anzi è più viva che mai, e al momento la sta vincendo, a man bassa, la signora Santanché.
 In estate fa piuttosto caldo, in inverno fa decisamente freddino, piovere è sempre piovuto e la grandine c’era pure prima. Ecco riassunto in due righe il contributo al dibattito sul clima di quelli che negano il cambiamento climatico. Faccio una doverosa premessa: ognuno e chiunque ha il diritto di confondere il clima con il meteo, non si possono regolamentare per legge le stupidaggini ed esiste in qualche modo il diritto alla cazzata. Quindi di fronte a ricerche scientifiche, enti di ricerca, università, Onu, Nasa, scienziati, dati, statistiche, rilevazioni ed evidenze, uno può anche credere a Vittorio Feltri, perché no, tutti abbiamo amato Linus che credeva nel Grande Cocomero.
In estate fa piuttosto caldo, in inverno fa decisamente freddino, piovere è sempre piovuto e la grandine c’era pure prima. Ecco riassunto in due righe il contributo al dibattito sul clima di quelli che negano il cambiamento climatico. Faccio una doverosa premessa: ognuno e chiunque ha il diritto di confondere il clima con il meteo, non si possono regolamentare per legge le stupidaggini ed esiste in qualche modo il diritto alla cazzata. Quindi di fronte a ricerche scientifiche, enti di ricerca, università, Onu, Nasa, scienziati, dati, statistiche, rilevazioni ed evidenze, uno può anche credere a Vittorio Feltri, perché no, tutti abbiamo amato Linus che credeva nel Grande Cocomero.
Naturalmente non mi occuperò né del clima né del meteo, cose per cui serve una competenza scientifica che non maneggio adeguatamente, ma della narrazione che ne sgorga, torbida e abbondante. In primis, notando come persino una cosa evidente e gigantesca come il cambiamento delle nostre abitudini di fronte al clima stia diventando una questione di fazioni contrapposte. Più i climatologi lanciano l’allarme e più balzano su come pupazzetti a molla certi pensatori a dire che faceva caldo anche nel 1843, il discorso finisce in vacca, si formano due partiti, si comincia a picchiarsi sui denti, e del clima non frega più niente a nessuno. Aggiunge ridicolo il fatto che ormai si è sedimentata la certezza che chi pensa all’emergenza sia “di sinistra” (una delle cose più generiche dopo “mammifero”, peraltro), e chi invece irride le paure e i timori sia “di destra”, pronto a sudorazioni improvvise non per il caldo afoso, ma perché vede minacciata la sua libertà di parola. Un delirio.
Quindi si rischia una paralisi nel dibattito sul clima, con forze equamente distribuite: i negazionisti hanno mezzi d’informazione, giornali agguerriti, trasmissioni televisive, come quella del compagno della presidentessa Meloni, che zittisce la sua inviata mentre fornisce dati scientifici per dare la parola al primo trombone che passa. E’ una comprensibile – psicologicamente comprensibile – reazione a certi millenarismi estremisti che dipingono la questione del clima come l’anticamera della morte collettiva: è scientificamente provato che di fronte a chi annuncia sventure si alzi qualcuno a dire che va tutto benissimo.
Quel che stupisce è la tigna ideologica, un meccanismo che sposta il discorso da quel che esiste e da quel che si potrebbe eventualmente fare, a una specie di impostazione dogmatica. Se dici che sarebbe meglio evitare voli privati dove arriva il treno sei “comunista” (ahah), se dici che l’aria condizionata nelle stanze d’albergo andrebbe settata in modo meno delirante, senza che si affacci un pinguino da sotto il letto, sei “contro la libertà individuale”. Insomma, ogni anche minuscolo accorgimento per arginare il delirio è contrastato non in termini di effettiva utilità – giusto, sbagliato, efficace, non efficace, come si converrebbe a un dibattito tra esseri senzienti – ma di impostazione ideologica: facciamo il cazzo che vogliamo e il problema non esiste, siete voi che fate tutto ‘sto casino per impedirci di tenere il riscaldamento a ottanta gradi, l’aria condizionata a meno dodici, che sono nostri inalienabili diritti. E’ in questo modo che il dibattito diventa non solo inutile, ma anche un po’ grottesco, come se davanti a un frontale in autostrada non si parlasse di chi ha ragione o ha torto, o di come soccorrere i feriti, ma si negasse l’incidente: dai, guarda come sta bene il morto!
 Comincio a diventare un estimatore di questo governo, perché nella vita ho visto poche cose più esilaranti del viaggio a Pompei, del treno per Pompei che parte da Roma una volta al mese – poi corretto a una volta la settimana per non farci ridere troppo – e se lo perdi ti devi rifare una vita alla stazione Termini. Più rappresentative ancora di questo governo, le foto della delegazione ai massimi livelli (il ministro della cultura e la presidentessa del Consiglio), ritratta a Pompei, con una temperatura percepita di centonove gradi, tutti in giacca a cravatta, con il portavoce Mario Sechi promosso a portaombrelli per fare ombra, la faccia di quelli che darebbero un braccio per una gazzosa, e le quattro banalità su treni, cultura e, naturalmente, Pompei. Con tutto il rispetto, nemmeno Fantozzi avrebbe fatto meglio, e confesso che davanti a quella foto – quattro o cinque capataz con la regina in mezzo, sotto il sole – mi sono figurato le allucinazioni da caldo del ragionier Filini vestito a Pompei in luglio come a un matrimonio a Cortina in dicembre, salivazione azzerata, mani: due spugne.
Comincio a diventare un estimatore di questo governo, perché nella vita ho visto poche cose più esilaranti del viaggio a Pompei, del treno per Pompei che parte da Roma una volta al mese – poi corretto a una volta la settimana per non farci ridere troppo – e se lo perdi ti devi rifare una vita alla stazione Termini. Più rappresentative ancora di questo governo, le foto della delegazione ai massimi livelli (il ministro della cultura e la presidentessa del Consiglio), ritratta a Pompei, con una temperatura percepita di centonove gradi, tutti in giacca a cravatta, con il portavoce Mario Sechi promosso a portaombrelli per fare ombra, la faccia di quelli che darebbero un braccio per una gazzosa, e le quattro banalità su treni, cultura e, naturalmente, Pompei. Con tutto il rispetto, nemmeno Fantozzi avrebbe fatto meglio, e confesso che davanti a quella foto – quattro o cinque capataz con la regina in mezzo, sotto il sole – mi sono figurato le allucinazioni da caldo del ragionier Filini vestito a Pompei in luglio come a un matrimonio a Cortina in dicembre, salivazione azzerata, mani: due spugne.
Per fortuna i giornalisti erano chiusi in un vagone piombato, che non gli venisse in mente di fare qualche domanda, mentre una domanda, francamente, ci stava: da Roma Termini si prende un treno per Napoli e poi la Circumvesuviana che ti lascia proprio davanti agli scavi: che senso ha questo circo per risparmiare meno di un quarto d’ora?
Nessuno l’ha fatta, peccato. Alla fine parevano le poderose armate del duce, che per sembrare numerose facevano cinque giri attorno all’isolato, e la gente schierata e plaudente diceva: “Ma, cazzo, Gino è già la quinta volta che passa qui davanti con la baionetta!”.
Ora, frementi e gioiosi, aspettiamo altre prove di alta propaganda, che so il treno diretto per l’Agenzia delle Entrate, con Salvini che fa il buttafuori. Non prendetelo! Non salite! Oppure un grande treno popolare per portare i possessori della nuova carta annonaria regalata ai poveri a far la spesa. Un euro al giorno per le famiglie di tre persone con cui comprare pesce fresco sì, pesce surgelato no, zucchero sì, sale no, una cosa che persino i Monty Python avrebbero detto: no, questo è troppo! E invece.
Invece bisogna imparare a considerare la propaganda come arte surrealista, prova di sublime dadaismo, come la trovata delle conferenze stampa senza domande o dei video promozionali al posto delle comunicazioni istituzionali. C’è del tiktokkismo nell’aria, dove al posto del premier abbiamo un’influencer che ai vertici internazionali si lamenta di quanto sono scomodi i tacchi e chiede affranta ai consiglieri: “Quanto manca?”. Così, sembra che ogni decisione, ogni comunicazione, sembri studiata per annullare la figuraccia precedente: il treno per Pompei era un colpo da maestro del ministro della cultura per cancellare la figura barbina allo Strega, per dire, e ora servirà un altro colpo da maestro per cancellare la figura barbina del treno per Pompei e via così, all’infinito. Divertente. Il tutto mentre compriamo otto miliardi di carri armati, perché abbiamo paura di essere invasi da qualcuno, chissà da chi, forse da quelli che aspettano il treno diretto Termini-Pompei.
Alla fine tutto è andato benissimo: nessuno è stato ricoverato per insolazione, forse grazie al mega-ombrello antisole brandito dal portavoce, i turisti in canotta e bermuda hanno goduto dello spettacolo delle istituzioni incravattate, e la cultura del Paese, pardon, della Nazione, ne è uscita rafforzata, grazie all’indomita azione del governo. Alalà.
 Fa una certa tenerezza – diciamo spaesata commozione – riguardare ora, dieci mesi dopo le elezioni, quei deliziosi manifesti elettorali con cui la destra italiana di ispirazione post-fascista (la tribù meloniana, per intenderci) si dichiarava “pronta” a governare. Per qualche settimana ci siamo beccati tutti la gragnuola volitiva del “siamo pronti”, cioè eccoci, arriviamo, finalmente, abbiamo studiato, lasciate fare a noi, siamo preparati fino al delirio. Un “siamo pronti” che suonava come la dichiarazione di fiducia dell’ultimo somaro della classe prima dell’orale alla maturità. Come ti senti, Gino? Pronto!
Fa una certa tenerezza – diciamo spaesata commozione – riguardare ora, dieci mesi dopo le elezioni, quei deliziosi manifesti elettorali con cui la destra italiana di ispirazione post-fascista (la tribù meloniana, per intenderci) si dichiarava “pronta” a governare. Per qualche settimana ci siamo beccati tutti la gragnuola volitiva del “siamo pronti”, cioè eccoci, arriviamo, finalmente, abbiamo studiato, lasciate fare a noi, siamo preparati fino al delirio. Un “siamo pronti” che suonava come la dichiarazione di fiducia dell’ultimo somaro della classe prima dell’orale alla maturità. Come ti senti, Gino? Pronto!
Quindi ci si perdonerà una certa ridarella nel guardare questi “prontissimi” inanellare una serie infinita di stupidaggini, gaffe, pensieri dal sen fuggiti, puttanate varie, scivoloni littori, amenità da sala bigliardi e altro ancora. La ministra con la Maserati che non paga i Tfr, il ministro della scuola che fa l’elogio dell’umiliazione, il ministro della cultura che si ripromette – come se fosse un compito titanico, ultra-umano – di leggere un libro al mese (ma quelli per cui vota ai premi non li legge), la fascistissima seconda carica dello Stato, collezionista di busti del duce, che “interroga il figlio” e decide che “non c’è nulla di penalmente rilevante”, la ministra della famiglia che paragona Daniela Santanché a Enzo Tortora, e altri millemila articoli del campionario, un’enciclopedia intera.
Pensa se non erano pronti!
Come spesso avviene, la teoria e la prassi fanno a cazzotti. Uno, superficialmente, sarebbe portato a pensare, trattandosi di fascisti in vario grado di colorazione orbace, a una maschia e volitiva rivendicazione, a un perenne “noi tireremo dritto” che gonfia il petto irto di medaglie. Macché, più che la marcia su Roma domina la marcia indietro, la toppa peggio del buco, il rifugio nel sempre meraviglioso “sono stato frainteso”. E dunque intenerisce la flessibilità e la tenera disponibilità all’”abbiamo scherzato”, come quando il ministro della scuola dice che sì, ha detto “umiliazione”, ma voleva dire “umiltà”; o quando il commentatore che scrive una frase schifosa e rischia con quella di giocarsi un posto annunciato in Rai dice che non abbiamo capito, non è il suo stile, siamo cattivi noi, e lui ha scritto un libro “che farà letteralmente storia”. Testuale. Il ridicolo ha rotto gli argini.
Insomma, eccoli qui, tutti quelli che erano così pronti, gente che, beccata a fare il passo dell’oca, comincia a passeggiare come un flaneur, fischiettando: chi, io? Avete capito male. Il tutto condito da revisionismi ridicoli, Storia reinventata, stupidaggini sesquipedali, errori da matita blu. E con la copertura – tipo il mantello dell’invisibilità – che nasconde all’occorrenza le vergogne. Per cui, appena gli si fa notare lo scivolone, eccoli dichiararsi “liberali” – quasi sempre liberali coi soldi di tutti, peraltro – o addirittura “radicali”. E quando molte associazioni, partiti e sindacati francesi chiedono di annullare uno spettacolo della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (“è neofascista”) tutti insorgono: uh, ma è illiberale! Gli stessi che applaudono quando si nega a qualche artista russo di esibirsi in pubblico, e lo trovano, questo, abbastanza liberale per i loro gusti. Lo spettacolo continuerà: il problema è avere una base ideologica e culturale di cui ci si vergogna un po’, farla saltar fuori a sorpresa e poi correggere il tiro, cincischiare scuse patetiche, frignare un po’. Ecco per il vittimismo sì, sono pronti.
 Chissà se un giorno potremo finalmente occuparci dei meravigliosi e popolarissimi danni operati sul tessuto culturale del Paese di un antico elettrodomestico novecentesco chiamato “televisione”, una cosa che ha prodotto alfabetizzazione e cultura, certo, ma che ha prodotto anche Sgarbi, per dirne uno, e quindi è lecito pensare che forse non tutto è andato per il verso giusto. Con grande divertimento si leggono oggi cronache e ricostruzioni e critiche sull’ultima performance del vetusto showman, liso e prevedibile come una gag dell’avanspettacolo. Chi tira di qua, chi tira di là, chi pigola un po’ ridicolo “Perché lo fai, Vittorio?” (spoiler: lo fa da trent’anni e passa), chi ne sottolinea la spudorata impunità, chi ne condanna la volgarità, come se potesse esistere uno Sgarbi senza volgarità, figurarsi.
Chissà se un giorno potremo finalmente occuparci dei meravigliosi e popolarissimi danni operati sul tessuto culturale del Paese di un antico elettrodomestico novecentesco chiamato “televisione”, una cosa che ha prodotto alfabetizzazione e cultura, certo, ma che ha prodotto anche Sgarbi, per dirne uno, e quindi è lecito pensare che forse non tutto è andato per il verso giusto. Con grande divertimento si leggono oggi cronache e ricostruzioni e critiche sull’ultima performance del vetusto showman, liso e prevedibile come una gag dell’avanspettacolo. Chi tira di qua, chi tira di là, chi pigola un po’ ridicolo “Perché lo fai, Vittorio?” (spoiler: lo fa da trent’anni e passa), chi ne sottolinea la spudorata impunità, chi ne condanna la volgarità, come se potesse esistere uno Sgarbi senza volgarità, figurarsi.
E dunque prendersela con lui non ha molto senso: costruito dalla tivù e per la tivù, Sgarbi incarna quella tendenza all’iperrealismo che serve per brillare sullo schermo: nessuna realtà è abbastanza reale, bisogna “pettinarla”, come dicono quelli del mestiere. Se hai una storia devi esagerarla, se hai un personaggio deve debordare. E dunque risultano sempre un po’ ridicole le scuse e le giustificazioni del giorno dopo: se inviti Sgarbi avrai quella cosa lì, se inviti un mangiafuoco sporcherà tutto di benzina, se inviti un gregge di pecore sai che poi dovrai spazzare per bene lo studio. E non deve ingannare che l’ultimo gettonatissimo show si sia svolto in un museo anziché in televisione: la logica è quella, e da tempo ha debordato dall’etere per tracimare nella società.
Naturalmente non si tratta di Sgarbi, che usiamo qui come esempio di scuola. Si tratta piuttosto di una costante opera di malintesa provocazione, un “épater le bourgeois”, dove “le bourgeois” non si scandalizza per niente, anzi si fa una risata, perché conosce il meccanismo, e si incantano invece le masse poco scolarizzate che apprezzano chi urla di più e chi dice “cazzo”. E in soprammercato cascano come polli nella trappola della “competenza” in altri campi. In un Paese così ricco di capolavori, per esempio, pochi sanno guardare un Caravaggio, pochi sanno vedere le magie di un Giotto, e così ecco che quando arriva uno che te li spiega (che te li spiegava) come farebbe un onesto professore di storia dell’arte, né bravo né cattivo, né più né meno, sembra che arrivi la scienza infusa.
Sgarbi dunque non è Sgarbi, sarebbe troppo semplice. Egli è piuttosto il suo posizionamento, meditato e calcolato, sulla platea pubblica: la trovata furbetta che in una discussione quasi sempre paludata e prudente, tendente al monocorde, se arriva uno che dà fuori di matto lo noteremo tutti, lo chiameranno ancora. Questo prima che la recita diventasse così scontata e già vista, prima di rivelarsi per quello che è: un semplice certificato di esistenza in vita. E la prova è che, se togli gli insulti, le diffamazioni sparse, le volgarità da bar, di quello che dice Sgarbi non si ricorda nessuno, non resta un concetto, una teoria, una tesi: quel che dice Sgarbi è l’immagine di Sgarbi, tutto lì. Non è molto.
Marketing, dunque. Posizionamento del prodotto sugli scaffali, vernicetta accattivante, confezione (che fu) innovativa, coperta e protetta però da ruoli istituzionali, sindaco di questo e di quello, sottosegretario, deputato, insomma impunito e impunibile. E superato da se stesso, perché ormai non è Sgarbi che fa ridere, ma il finto pentimento del giorno dopo: non dovevamo invitarlo. Fino alla prossima volta. Che noia.
 Sono stati giorni entusiasmanti per chi osserva (forse come me, il più delle volte basito) le dinamiche dei media, le contorsioni delle narrazioni, i testacoda della propaganda, le circonvoluzioni, gli spiegoni, i commenti in rete, sui giornali, alla tivù. Trovo meravigliosamente democratico che Farfallina71 sappia decrittare con tanta precisione i retroscena interni del Cremlino, o le mosse di Wagner; oppure che Gino-bandierina ci ammannisca la sua analisi retroscenista, che tu leggi e dici: “Minchia, Gino! Avrà le sue fonti segrete a Rostov sul Don!”, e poi scopri da altri tweet che fa l’elettrauto a Posillipo.
Sono stati giorni entusiasmanti per chi osserva (forse come me, il più delle volte basito) le dinamiche dei media, le contorsioni delle narrazioni, i testacoda della propaganda, le circonvoluzioni, gli spiegoni, i commenti in rete, sui giornali, alla tivù. Trovo meravigliosamente democratico che Farfallina71 sappia decrittare con tanta precisione i retroscena interni del Cremlino, o le mosse di Wagner; oppure che Gino-bandierina ci ammannisca la sua analisi retroscenista, che tu leggi e dici: “Minchia, Gino! Avrà le sue fonti segrete a Rostov sul Don!”, e poi scopri da altri tweet che fa l’elettrauto a Posillipo.
Putin è più debole. Putin è più forte. Non è mai stato forte. Non è mai stato debole. Ha le ore contate. Ora vanno a Mosca e gli fanno un culo a capanna, anzi no, tornano indietro, visto?, erano d’accordo. Progozhin è cattivo ma dice la verità, e questo quando la “verità” di Progozhin collima con la “verità” di CiccioPasticcio-bandierine, che vai a vedere il suo profilo e di solito si occupa di calcio e polenta taragna. Mah. Del resto, quelli che si occupano di geopolitica sui giornali e in tivù, e loro sì dovrebbero avere le loro fonti segrete a Rostov sul Don, non è che hanno prodotto di meglio, quindi…
Naturalmente non voglio occuparmi della questione in sé, della quale sappiamo poco e nulla, possiamo fare solo vaghe ipotesi, non è quello il punto. Il punto è il matrimonio ormai indissolubile tra emotività dei media e tifoserie, per cui una notizia (esempio: “Progozhin marcia verso Mosca”) diventa all’istante, dopo nemmeno due secondi, una costruzione barocca di esultanze, o panico, un arzigogolìo di teorie ultimative e definitive, di sentenze inappellabili, che saranno ovviamente riviste e limate il giorno dopo. Per un breve istante, nella notte del finto golpe, è parso che tutto fosse finito, finita la mattanza in Ucraina, finite le bombe, i morti, le avanzate, le ritirate, tutto finito, hurrà! Il pensiero debole e binario, unito all’afflato della speranza trasfigurata in certezza, unito all’ansia di dire “avevo ragione”, ha trasformato i media in una specie di calderone ribollente di cazzate. In più, ed è il dato più divertente, tutti leggono ogni avvenimento, ogni fatto di cronaca, ogni novità – non parlo solo della guerra, ma di tutto quanto – alla luce del proprio schieramento e della propria curva. Chi era cattivo diventa buono, chi era buono diventa cattivo, magari si è sostenuto A fino a ieri, ma oggi conviene dire B. Putin era un macellaio potentissimo che se non lo fermiamo “Arriverà fino a Lisbona” (cit), e oggi è debole coi i piedi di argilla; come quando la Russia doveva fare default in due settimane, ma poi no, eccetera eccetera.
E’ vero che la prima vittima della guerra è la verità, ma qui un po’ si esagera, perché la verità diventa variabile, elastica, tirata di qua e di là a seconda delle convenienze. Tutto molto ridicolo, se uno non pensasse che l’informazione è un bene primario, che serve per creare cittadini migliori, e invece al momento genera soltanto curve da stadio isteriche e mutevoli. Si legge un titolo, magari furbetto o sbagliato, lo si capisce male, ci si costruisce una tesi, si trovano dei nemici, e oplà, il gioco è fatto. Il Cai – esempio di scuola sempre di questi giorni malandati – non ha mai detto di voler togliere le croci sulle montagne, era solo un titolo di Libero. Ma ecco Farfallina71 in trance agonistica che promette di andarle a rimettere lei, più grosse di prima, sulle cime innevate. Chapeau!
 Ancora incredulo e divertito, leggo e rileggo le dichiarazioni di alcuni
Ancora incredulo e divertito, leggo e rileggo le dichiarazioni di alcuni
esponenti di sesto, settimo e ottavo piano della politica italiana – tutti
renzisti – allarmati dalle parole di Beppe Grillo. Conviene riportarle per
intero: “Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e
di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto i marciapiedi, le aiuole,
i tombini, senza dare nell’occhio, col passamontagna, fate il lavoro e
scappate!”. Testuale. Un discorsetto che per Raffaella Paita “utilizzava toni
che potrebbero istigare alla violenza sociale”. Per Lisa Noja sono “parole
eversive”. Luciano Nobili, invece, ci vede “Incitamento pubblico alla
violenza” e (tenetevi forte) “Presa a modello degli assassini che hanno
macchiato il nostro Paese di una lunga e dolorosissima scia di sangue”.
Non mi sembra di dover aggiungere altro: per non capire un testo di poche
righe serve essere molto stupidi. Per travisarlo accusando di violenza chi
incita a “mettere a posto i marciapiedi” serve molta malafede. Purtroppo, le
due cose non sono alternative: si può essere contemporaneamente stupidi e
in malafede.
Ciò non significa che non si possano contestare le parole di Grillo, anzi.
Parole che nascono probabilmente dalla vicenda di un cittadino multato
perché si è preso la briga di tappare una buca pericolosa in strada. Di sua
iniziativa, senza permessi, né controlli, né autorizzazioni. Giusta multa,
dico io, perché se tutti i pensionati si mettessero a tappare buche per strada,
non si circolerebbe. E in più, se io cado con la moto nella buca che il
Comune non ha sistemato posso far causa al Comune, mentre se cado sul
pastrocchio fatto col bitume dal primo pensionato che passa, come dire, mi
attacco.
Ma lasciamo perdere queste piccolezze tecniche e passiamo alla sostanza.
Queste famose “brigate di cittadinanza” sarebbero dunque chiamate a
lavori socialmente utili, lavori per i quali, mi risulta, un buon cittadino già
paga fior di tasse. Fare volontariato per una cosa che ti sarebbe dovuta e per
la quale hai già pagato non mi sembra una grande idea. Mi viene in mente
quando – anni fa, con i figli alle scuole dell’obbligo – assistevo basito a
brigate (ehm…) di volenterosi genitori che si dannavano l’anima per
imbiancare aule e corridoi. In pratica supplivano con tempo e denaro a un
diritto non rispettato, quello di avere aule e corridoi imbiancati a cura
dell’amministrazione. Ora, si sa che le tasse non le pagano tutti, e quindi se
di qualche brigata c’è bisogno sarebbe quella contro gli evasori. O, in
subordine, contro chi invece di destinare soldi al bene della comunità li usa
per aumentare le spese militari.
Intendiamoci, non c’è nulla di male a partecipare attivamente al
miglioramento della vita comune (magari stappando un tombino), ma non
vorrei che dopo, quando le strade si allagano e abbiamo l’acqua alle
ginocchia, saltasse su un qualche genio liberal-liberista a dire che è colpa
nostra, di noi cittadini senza senso civico che non abbiamo stappato i
tombini, o riempito le buche, o curato i giardinetti. Vista la tendenza
sempre più radicale a incolpare il cittadino di quel che non funziona, invece
della politica centrale o locale che dovrebbe farlo, mi sembra una toppa
peggio del buco, ci andrei piano, ecco. Il tombino me lo deve stappare il
Comune, creando posti di lavoro, e non il giovane volenteroso delle brigate
di cittadinanza, e se le tasse non bastano, si veda di farle pagare a chi le
evade. Questo sì, sarebbe, felicemente, eversivo.
 Sono un po’ restio ad occupare questo mio quadratino di giornale con le gesta y la historia di Silvio Berlusconi, perché già si sono spese righe per migliaia di chilometri, ed è passato sotto gli occhi di noi tutti un coccodrillo ininterrotto di ore e ore e ore a reti unificate. Coccodrillo smemorato assai, peraltro, dove la morte non è Livella, ma Grande Prescrizione, e con la salma sono arrivate le autobotti di bianchetto per cancellare le imprese più grette, le parole più sconce e feroci, i disegni eversivi. Nessun titolo sulla P2, nulla su Eluana Englaro che “ha un bell’aspetto e potrebbe anche avere un figlio”, come lo incoraggiarono a dire i suoi più schifosi consiglieri. Nulla sul precariato e la ferocia del mercato che aveva soluzione semplice: “Le consiglio di sposare un miliardario”. Questo è stato Berlusconi. E chi oggi gli riconosce di aver plasmato il Paese, di averlo sagomato e profilato, si dimentica di dire che il Paese è cambiato in peggio, modellato sul cinismo del potere e dei dané: dalle superville alle case popolari, il premio di maggioranza spetta al ricco senza limiti, capace di finanziarsi una narrazione per cui il suddito può soltanto ammirarlo.
Sono un po’ restio ad occupare questo mio quadratino di giornale con le gesta y la historia di Silvio Berlusconi, perché già si sono spese righe per migliaia di chilometri, ed è passato sotto gli occhi di noi tutti un coccodrillo ininterrotto di ore e ore e ore a reti unificate. Coccodrillo smemorato assai, peraltro, dove la morte non è Livella, ma Grande Prescrizione, e con la salma sono arrivate le autobotti di bianchetto per cancellare le imprese più grette, le parole più sconce e feroci, i disegni eversivi. Nessun titolo sulla P2, nulla su Eluana Englaro che “ha un bell’aspetto e potrebbe anche avere un figlio”, come lo incoraggiarono a dire i suoi più schifosi consiglieri. Nulla sul precariato e la ferocia del mercato che aveva soluzione semplice: “Le consiglio di sposare un miliardario”. Questo è stato Berlusconi. E chi oggi gli riconosce di aver plasmato il Paese, di averlo sagomato e profilato, si dimentica di dire che il Paese è cambiato in peggio, modellato sul cinismo del potere e dei dané: dalle superville alle case popolari, il premio di maggioranza spetta al ricco senza limiti, capace di finanziarsi una narrazione per cui il suddito può soltanto ammirarlo.
Ma non sarà la cronaca – né il ricordo a tassametro che oggi scorre come un fiume – a rendere i contorni dell’epopea. Servirebbe letteratura, racconto, implacabile autopsia di un paese e di un popolo. Non è nelle lacrime dei suoi salariati di ieri e di oggi che si ritrova Berlusconi, ma in un capolavoro di Gabriel Garcia Marquez, L’autunno del patriarca (1975), dove in un lungo canto epico si disegnano i millemila interessi, i complotti, le furbizie, le infamie, le solitudini, le astuzie dei servi e dei complici, i nemici diventati amici, gli amici per convenienza, e tutte le sconcezze di un potere senza freni, senza limiti né confini. Come scrive inarrivabile Marquez: “una tiepida e tenera brezza di morto grande e di putrefatta grandezza”.
Ed è solo l’inizio dello spettacolo, perché ora si assisterà a quello, più deprimente ancora, dello smembramento delle spoglie, della spartizione dell’eredità politica e culturale, dell’appropriazione centimetro per centimetro, frame per frame, di quella narrazione del potere feroce ma col sorriso sulle labbra, la barzelletta, il motto di spirito, l’ostentazione. Come in quei giganteschi affreschi di battaglie dove la scena è grandiosa ma l’occhio è catturato dal particolare, lo zoccolo di un cavallo, il ricciolo di una nuvola. Il dettaglio è tutto, per chi capisce che “il pullman di troie” non è freddura da bar, ma Zeitgeist, lo spirito del tempo, l’impronta ideologica e culturale.
E c’è un altro mirabile racconto di Marquez che ci parla dell’oggi, ed è Los funerales de la Mamà grande (1962), dove per Macondo passano il cordoglio universale, le lacrime vere e finte, i famigli, i miracolati, i mediocri elevati a sub-potenti, i devoti per scelta, o per conformismo, o per convenienza. Spettacolo molto “sudamericano”, da provincia dell’Impero, da populismo estremo e conclamato, che finalmente si potrà raccontare. Ancora Marquez: “….Ora che è impossibile passare da Macondo a causa delle bottiglie vuote, dei mozziconi di sigarette, degli ossi spolpati, degli stracci, degli escrementi lasciati dalla folla che ha partecipato ai funerali, ora è giunto il momento di accostare uno sgabello alla porta di strada e cominciare a raccontare dal principio i particolari di questa perturbazione nazionale, prima di dar tempo agli storici di arrivare”.
 Chiedo scusa se parlo di cose minime, ma capirete che non ci sono solo i Grandi Temi ad appassionare la gente, i Grandi Personaggi, le Grandi Idee. Andiamo, si vive anche di friabili gioie che durano lo spazio di un minuto. Per esempio: la quotidiana intervista sui giornali, o in tivù, o alla radio, a Carlo Calenda. Confesso di avere per il personaggio una speciale simpatia, allo stesso modo in cui mi sta simpatico Wile Coyote, per cui quando compare Carlo Calenda non mi chiedo – credo non lo faccia nessuno – “Ehi, sentiamo cosa ha da dirci!”, ma piuttosto “Ehi, vediamo questa volta come cade nel canyon!”.
Chiedo scusa se parlo di cose minime, ma capirete che non ci sono solo i Grandi Temi ad appassionare la gente, i Grandi Personaggi, le Grandi Idee. Andiamo, si vive anche di friabili gioie che durano lo spazio di un minuto. Per esempio: la quotidiana intervista sui giornali, o in tivù, o alla radio, a Carlo Calenda. Confesso di avere per il personaggio una speciale simpatia, allo stesso modo in cui mi sta simpatico Wile Coyote, per cui quando compare Carlo Calenda non mi chiedo – credo non lo faccia nessuno – “Ehi, sentiamo cosa ha da dirci!”, ma piuttosto “Ehi, vediamo questa volta come cade nel canyon!”.
Dunque confesso senza timore la mia debolezza, e sono felice che sia una debolezza, umana, troppo umana, incoraggiata dalla stampa nazionale, che un giorno sì e l’altro pure telefona a Calenda per avere il suo parere su tutto. Sembra di vederle, le riunioni di redazione. Qualcuno dice: “Ci sarebbe il cane che conta fino a sei!”; e un altro: “Bella, la storia del melone che sa di fragola!”. Poi prevale la tradizione, e si decide di intervistare Calenda. Ho cercato su Google “intervista a Carlo Calenda”, e mi sono usciti (giuro, provate!) 585.000 risultati, e su 585.000 volte che qualcuno ha chiesto un parere a Calenda mai, mai una volta, una sola, che io sia andato al bar e abbia sentito qualcuno dire: “Porca miseria, ma hai visto cosa ha detto Calenda? Pazzesco!”.
Insomma, credo che gran parte del fascino di questo speciale genere letterario che è l’intervista al capo di Azione dipenda esattamente dal gusto sublime dell’irrilevante. C’è da capirlo: uno sfoglia pagine e pagine di guerre, debiti, delitti, infamie, schifezze, plastica negli oceani, e poi, stanco e depresso, ha bisogno di un alleggerimento. Giusto.
In più, il genere, essendo vastissimo, ha dei gustosi sottogeneri. Il più gettonato, di questi tempi è “Calenda dà ragione al governo”, dove, fingendosi critico (lui lo avrebbe fatto meglio, ovvio), Calenda dice che Meloni ha fatto bene a… (riempire a piacere, l’ultimo caso è sulla limitazione dei poteri della Corte dei Conti). Altro sottogenere interessante dell’intervista a Calenda è quando gli chiedono cosa dovrebbero fare secondo lui Caio, o Tizio, o Sempronio. Cosa dovrebbe fare il Pd? Cosa dovrebbe fare il governo? Cosa dovrebbe fare il papa? Sono perle di saggezza che strappano inevitabilmente un sorriso, perché Calenda veleggia intorno al tre per cento, a esser buoni, e ha praticamente un piede nel gruppo misto, e in assenza di strategie sue gli si chiedono le strategie degli altri. Un po’ come se si facesse una lunga intervista all’allenatore della Vignolese, campionato di eccellenza, girone A, per chiedergli, all’apice del pathos, cosa farebbe se allenasse il Real Madrid. Mi aspetto, da affezionato lettore, che si alzi l’asticella: dove ha sbagliato Einstein? Come riscriverebbe il finale di Morte a Venezia?
Un altro grande classico del genere è Calenda che manda cose. Non c’è argomento, problema, seccatura o emergenza su cui Calenda non abbia già elaborato, e poi spedito, un suo piano, o studio, o progetto. Al governo, all’opposizione, ai Tupamaros, agli astronauti della stazione spaziale, in un angolo dell’intervista c’è sempre, immancabile, un “Io ho mandato il nostro piano…”. E qui c’è anche del mistery, un intreccio giallo: dove finiscono ‘sti piani che Calenda manda a tutti? Cosa ne fanno? Non abbiate fretta di svelare l’arcano, godetevi la suspance. Tanto domani qualcuno intervisterà Calenda, e anche venerdì, e anche sabato. Che gioia.
 Un caro pensiero va a tutti gli italiani che in questi giorni o settimane saranno sollecitati da un’associazione chiamata Agenzia delle Entrate a pagare il “pizzo di Stato”, come ha detto in un comizio a Catania il/la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un vero e accorato appello contro un’organizzazione che vessa e deruba i cittadini, cercando di far pagare le tasse o di recuperare quelle non pagate. Tasse che poi dovrebbero servire a non chiarissimi scopi come per esempio sanità, scuole, servizi, insomma tutte cose di cui potremmo fare allegramente a meno tornando a curarci con erbe e radici, oppure pagando sanità, scuole e servizi privati (cosa che peraltro facciamo sempre più spesso). Potremmo ovviare a questa richiesta estorsiva anche prendendoci a colpi di clava e facendoci giustizia da soli, invece di chiamare Carabinieri, magistrati e altri membri della stessa organizzazione che chiede il pizzo.
Un caro pensiero va a tutti gli italiani che in questi giorni o settimane saranno sollecitati da un’associazione chiamata Agenzia delle Entrate a pagare il “pizzo di Stato”, come ha detto in un comizio a Catania il/la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un vero e accorato appello contro un’organizzazione che vessa e deruba i cittadini, cercando di far pagare le tasse o di recuperare quelle non pagate. Tasse che poi dovrebbero servire a non chiarissimi scopi come per esempio sanità, scuole, servizi, insomma tutte cose di cui potremmo fare allegramente a meno tornando a curarci con erbe e radici, oppure pagando sanità, scuole e servizi privati (cosa che peraltro facciamo sempre più spesso). Potremmo ovviare a questa richiesta estorsiva anche prendendoci a colpi di clava e facendoci giustizia da soli, invece di chiamare Carabinieri, magistrati e altri membri della stessa organizzazione che chiede il pizzo.
Fa parte dell’imperdonabile distrazione di questi tempi allegri che nessuno abbia usato a proposito delle esternazioni meloniane sul “pizzo di Stato” l’abusata parola “populismo”. Davvero strano: per anni e anni si è accusato di “populismo” chiunque avesse una visione del mondo appena un po’ discosta da quella consigliata e autorizzata dall’autorità costituita. Era “populista” aiutare i poveri, per esempio, mentre invece correre in soccorso di chi non paga le tasse, perdipiù durante una campagna elettorale, colpo di scena, non è “populista”. Bizzarro.
E ancor più populista, se possibile, è l’ottima intuizione del/della Presidente del Consiglio, secondo cui la lotta all’evasione fiscale va fatta contro multinazionali e banche, e non contro il piccolo commerciante. Vero, sacrosanto, nemmeno da dire, ma anche un po’ comodo, visto che le multinazionali e le banche non votano per il sindaco di Catania, mentre invece molti piccoli commercianti sì.
A parte le considerazioni semantiche, però, c’è questo piccolo dettaglio che non è vero. Cioè, non è vero che l’evasione fiscale in Italia è in gran parte un’evasione di necessità (che pure esiste, data la crisi perenne, l’inflazione e altri doni del sistema economico vigente). Solo il venti per cento, infatti, è “evasione da versamento”, cioè dichiari le tue entrate e poi non hai i soldi per pagare il dovuto. L’80 per cento deriva invece da omesse dichiarazioni o dichiarazioni infedeli, cioè, diciamo così, da eroici resistenti al “pizzo di Stato” che si portano avanti col lavoro già in fase di dichiarazione dei redditi.
Esiste una cosa che si chiama “tax gap” e che misura la differenza tra le tasse che lo Stato si aspetta e quelle che arrivano veramente. Le cifre non sono sbandierate da picciotti con il rigonfiamento sotto la giacca, ma rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il tax gap per il 2020, per esempio, era di 89,8 miliardi. Non proprio noccioline: più di 28 miliardi di Irpef, più di 25 di Iva, 9 miliardi di Ires (questi sarebbero a carico delle imprese), oltre 5miliardi tra Imu e Tasi (questi sarebbero i proprietari di immobili), più 4 miliardi e mezzo di Irap e poi giù per li rami con cifre meno eclatanti ma che, sommate, pesano quanto peserebbero tre o quattro manovre economiche all’anno. Tutte cose che però, in un comizio per sostenere un sindaco valgono poco e niente. Meglio il messaggio squillante, diretto e cristallino: se le tasse sono un pizzo e se a richiederle è un “intollerante sistema di potere”, come ha detto Meloni, si risolve così: non pagatelo. Niente male, per non essere “populismo”.
 Ora che Tg1, Tg2, Tg3, Rete4, Tg5, Studio Aperto, Tg7 e TgSky24 ci hanno mostrato Giorgia Meloni “lontano da microfoni e telecamere”, possiamo dormire tranquilli.
Ora che Tg1, Tg2, Tg3, Rete4, Tg5, Studio Aperto, Tg7 e TgSky24 ci hanno mostrato Giorgia Meloni “lontano da microfoni e telecamere”, possiamo dormire tranquilli.
Ma intanto si registra un persistente mal di testa dato dall’inseguire voci e propagande della destra di governo, che lotta come un leone, come in un fortino assediato da comunisti e invece (ho controllato) è proprio al governo del Paese. Lo dico subito: Meloni che fa (pardon, non fa) passerella tra gli alluvionati è giusto e doveroso, cioè quello che uno si aspetta da un capo del governo. Un po’ meno edificante è la narrazione messa in piedi: lei che lascia il G7 in gramaglie, e poi la favola del “non è una passerella” con tono pre-offeso (traduzione: lo dico prima, non vi azzardate a dire che è una passerella). Insomma, è incredibile che anche in una normalissima e doverosa azione di capo del governo non si riesca a rinunciare a un ingrediente culturalmente centrale della destra italiana: il vittimismo.
In generale, spulciando qui e là tra esternazioni e commenti di questi giorni frenetici si direbbe che c’è gran confusione, è molto difficile codificare una strategia mediatica. La palma d’oro va, come spesso accade, al ministro cognato Lollobrigida, un campione. Mattarella, attraverso le celebrazioni del Manzoni, gli ha fatto pelo e contropelo con una lezioncina da maestro di sostegno su razza, etnia e Costituzione. E lui se n’è uscito con uno strepitoso: “Non credo che ce l’avesse con me”, per poi pubblicare odi ad Alessandro Manzoni. Riassumo: abbiamo un ministro dell’agricoltura che diventa raffinato esegeta manzoniano pur di fingere che gli schiaffoni non li ha presi lui (cfr, “Io mica so’ Pasquale” di Totò).
Spicca nel quadro Marcello Veneziani, da alcuni decenni candidato a tutto quello che c’è di destra, dal convegnetto di nostalgici alla spedizione spaziale. Ha esternato sulle contestazioni alla ministra Roccella accusando il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, intervenuto per mediare, di “violenza di origine anarco-comunista”. Qui siamo alla meraviglia, al vittimismo onirico, come se contestare un ministro, pratica democratica quant’altre mai, fosse la Comune di Parigi (nota mia: magari!).
Ma in generale il ricorso allo spettro del comunismo è frequente e generalizzato e fa parte del gioco fascio-vittimista: governare il Paese ma fingere di essere dissidenti braccati in Corea del Nord. Comandare su tutto, ma dare la sensazione di essere minoranza oppressa (dai “comunisti”, poi, creature ormai mitologiche).
E poi, c’è lei, Augusta Montaruli, che allo stesso Lagioia, al Salone, urlava “Vergogna, vergogna e “Con tutti i soldi che prendi!”. Ora, sommessamente, un consiglio spassionato agli anarco-casinisti della destra: se hai tra le tue fila una condannata in via definitiva per peculato, è meglio impedirle di andare in giro a parlare dei soldi degli altri, è una questione di decenza, una cosa che somiglia molto all’autogol da metà campo.
In questi giorni abbiamo dunque visto in tutta la sua sgangherata potenza una certa esuberanza mediatica. E mentre ci balocchiamo con questi proclami un po’ improvvisati, tra il patriota Manzoni e i moti insurrezionali contro la ministra Roccella (che due ore dopo la terribile censura in stile Pol Pot era in televisione a dire la sua), registriamo la pressante richiesta – degli stessi – di costruire finalmente un’egemonia culturale di destra. Oh! Basta con Bertold Brecht e Rosa Luxembourg, su, fate spazio, arriva Veneziani con la Montaruli!
 La madre di tutte le narrazioni, poveretta, è la narrazione sui soldi. Follow the money, segui i soldi, è un sistema sempre valido per stanare qualcuno, ma anche per percorrere certe curve ideologiche disegnate male, alcune a gomito, altre scivolose assai. A seconda delle angolazioni, averne troppi è una piccola trascurabile colpa, averne pochi è una colpa anche quella (molto più grave); ma averne troppi è anche motivo di ammirazione, si dimostra che uno è bravo, (ha fatto i soldi!), così quello che non li ha fatti si dimostra che non è bravo, confermando la storiella che si sente spesso tra le righe: “Insomma, ‘sti poveri si diano da fare!”.
La madre di tutte le narrazioni, poveretta, è la narrazione sui soldi. Follow the money, segui i soldi, è un sistema sempre valido per stanare qualcuno, ma anche per percorrere certe curve ideologiche disegnate male, alcune a gomito, altre scivolose assai. A seconda delle angolazioni, averne troppi è una piccola trascurabile colpa, averne pochi è una colpa anche quella (molto più grave); ma averne troppi è anche motivo di ammirazione, si dimostra che uno è bravo, (ha fatto i soldi!), così quello che non li ha fatti si dimostra che non è bravo, confermando la storiella che si sente spesso tra le righe: “Insomma, ‘sti poveri si diano da fare!”.
Tra quelli bravi, che si sono dati da fare, si mettono molto in vista alcune star di Instagram e Tik Tok. Ammetto di guardarli affascinato, diciamo che è una forma di porno-capitalismo un po’ estremo. Sono ragazzotti italiani aitanti, fanno primi piani intensi, vivono a Dubai, ci comunicano che hanno incassato ottantamila, centomila – in un giorno – mostrano orologi da trecentomila euro (300k, come dicono loro, perché la neolingua vince sempre), Ferrari e Lamborghini, piscine sull’attico. Allargano le braccia per mostrare un paradiso senza tasse e senza rotture di coglioni, dove i poveracci lavorano (suppongo che qualcuno pulisca la piscina, magari depurandola dallo champagne versato), e loro accumulano portentose ricchezze. Ah, dimenticavo: il tutto senza parlare di lavoro, mai (al massimo di “business”). Vendono manuali e corsi per insegnarvi a diventare come loro, trattatelli a metà tra il trucco commerciale e il seminario motivazionale, cose come: “Ehi, molla il tornio nella fabbrichetta del bresciano e vieni a Dubai a fare business! Tra due mesi avrai la Lambo anche tu!”.
I soldi saranno anche tanti, ma le ambizioni restano basic, la macchina, l’orologio… Non credo che ci caschino in molti (nel caso, nessuna pietà), ma resta il fatto che migliaia di persone si bevono ogni giorno, grazie al cellulare e al pollice scorrevole, questa nuova santificazione dei soldi, un po’ ridicola ma molto social, molto moderna.
E’ noto comunque che i soldi danno alla testa, soprattutto a destra. E’ bastato che gli studenti sollevassero il problema del caro-affitti per sentire allarmatissimi allarmi antibolscevichi, tipo “i comunisti” (eh?) che attaccano la proprietà privata” (eh?). Divertente. Così come divertente è la reazione di tutti (tutti!) quando qualcuno mormora la parola “patrimoniale”, che suona ormai come “esproprio”, o “rapina a mano armata”. Con lo strabiliante testacoda che anche quelli che ne beneficerebbero, che non hanno patrimoni da tassare e che anzi lavorano per mantenere e rafforzare quelli esistenti, corrono in soccorso dei privilegiati. La narrazione è più forte di tutto, il vittimismo dei ricchi commuove spesso i poveri, un caso macroscopico di tafazzismo di massa incoraggiato in coro dai media.
Intanto, il ministro Salvini ha annunciato che abolirà il superbollo, quell’odioso balzello che pesa sulla parte di popolazione indigente che possiede auto lussuose e di grossa cilindrata. Quindi un consiglio agli studenti fuorisede: basta tende, dermite in macchina! Se poi è una Bentley risparmiate sul bollo. Con lo sconto sui macchinoni, lo Stato perderà un centinaio di milioni, che sono poca cosa rispetto a quello che guadagna prendendolo ai poveri. Diciamolo: è bello pensare che qualche milione dei due miliardi e mezzo sottratti al reddito di cittadinanza coprirà lo sconto per i possessori di Porsche.
 Forse andrebbe studiata per bene – suggerisco corsi di psichiatria – la parabola ardita dell’informazione italiana su quella benedetta pioggia di manna dal cielo comunemente chiamata Pnrr. Se uno avesse la pazienza di andare un po’ indietro negli archivi, scoprirebbe che le speranze, le aspettative, le ambizioni che quella cornucopia di miliardi generò sulle prime pagine e negli osanna dei commentatori hanno oggi un sapore assai diverso. In poche parole: profumavano di progresso e ora puzzano di guerra. E’ sembrato, per un lungo momento magico, che saremmo stati sommersi di soldi. Soldi, finalmente! Era ora! Dopo gli anni dell’austerità e quelli della pandemia, ecco l’Enalotto europeo che ci avrebbe permesso, se non i rubinetti d’oro, almeno delle strutture e infrastrutture per una vita decente. Traduco in italiano: sanità, scuole, asili, riconversioni industriali in chiave ecologica e tanto altro ben di Dio per cui si aprì il libro dei sogni.
Forse andrebbe studiata per bene – suggerisco corsi di psichiatria – la parabola ardita dell’informazione italiana su quella benedetta pioggia di manna dal cielo comunemente chiamata Pnrr. Se uno avesse la pazienza di andare un po’ indietro negli archivi, scoprirebbe che le speranze, le aspettative, le ambizioni che quella cornucopia di miliardi generò sulle prime pagine e negli osanna dei commentatori hanno oggi un sapore assai diverso. In poche parole: profumavano di progresso e ora puzzano di guerra. E’ sembrato, per un lungo momento magico, che saremmo stati sommersi di soldi. Soldi, finalmente! Era ora! Dopo gli anni dell’austerità e quelli della pandemia, ecco l’Enalotto europeo che ci avrebbe permesso, se non i rubinetti d’oro, almeno delle strutture e infrastrutture per una vita decente. Traduco in italiano: sanità, scuole, asili, riconversioni industriali in chiave ecologica e tanto altro ben di Dio per cui si aprì il libro dei sogni.
Oggi – passati pochissimi anni – la riconversione c’è stata, ma non quella che ci avevano fatto credere con il famoso gioco del portafoglio col filo attaccato, quello che tu allunghi la mano e lui scappa via. No, no. Oggi un po’ di fondi del Pnrr scappano verso un mercato particolarmente fiorente, che è quello delle armi, dell’apparato industrial-militare, il cui potenziamento serve a sostenere un’escalation militare alle porte dell’Europa. Insomma, si scommette su una guerra lunga anziché su una pace veloce. Conviene di più, soprattutto al di là dell’Oceano.
E, sempre a proposito di neolingua, è bene ricordare che molti soldi (un miliardo di euro, ma previsto in aumento) vengono da un portafoglio comunitario che si chiama Fondo Europeo per la Pace. Nemmeno Orwell sarebbe stato così vergognosamente orwelliano.
Sono passati appena un paio di mesi da quando il/la presidente del Consiglio Meloni andò in tivù, dal fido Vespa, a dire che “Noi non spendiamo soldi per mandare armi agli ucraini”. Testuale: “Noi abbiamo delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare e quindi non c’è niente che stiamo togliendo agli italiani”. E sono passate soltanto un paio di settimane da quando il suo ministro Fitto ha candidamente dichiarato che i soldi del Pnrr per gli asili (“Fate più figli!”, ndr) non riusciremo a utilizzarli.
E così arriviamo a oggi: la Ue decide che parte dei famosi fondi, la manna di cui sopra, andranno a produrre munizioni, che ci servono – scusate la metafora – come il pane. Gli stati potranno decidere il come e il quanto, e già sembra l’asso di briscola per un governo che non riesce a fare asili ma è perfettamente in grado di fare missili. Si aggiungono i tristi lamenti della nostra Difesa, per cui bisogna usare un po’ di Pnrr anche per l’esercito, sia per l’addestramento sia per i poligoni che sono “troppo piccoli” (sic). Il tutto sostenuto dalla nota richiesta Nato di arrivare al due per cento del Pil per la spesa militare. Il tutto chiosato amabilmente dall’affabile Guido Crosetto – ieri presidente della Federazione dei produttori di armi e oggi ministro della Difesa, a proposito di lobby – che dice che bisogna ripristinare le nostre scorte, sistemando con poche parole le menzogne della sua premier (“Non togliamo niente agi italiani”, buona, questa). Tecnicismi? Soldi che cambiano destinazione? Capitoli di spesa nuovi a causa della nuova emergenza? La vendono così, certo, ma il risultato non cambia: volevate asili e avrete cannoni, riempire gli arsenali e svuotare i granai: masters of war.
 Chi avesse, l’altro giorno, Primo Maggio, saltabeccato un po’ tra televisone e Rete, stampa e propaganda, notizie dall’alto e cronache dal basso, avrebbe certamente colto alcune affinità e divergenze tra la Francia e noi. Differenze notevoli. Di qua un popolo stanco e senza conflitto, si direbbe quasi arreso; di là un sussulto poderoso di lotta, gigantesche manifestazioni di popolo, simbologie potenti. Il Primo Maggio, festa dei lavoratori, è stata per noi italiani la festa di una provocazione di governo, quella che ai lavoratori sottrae ancora più diritti e contrabbanda come conquista salariale una mancetta semestrale già divorata dall’inflazione. E dietro questo paravento per allocchi, niente più sostegno a migliaia di famiglie in crisi, nuove bastonate alla povertà e nuove precarizzazioni, cioè una rapina da parte di chi detiene la ricchezza ai danni di chi la ricchezza la produce con il suo lavoro (o lavoretto).
Chi avesse, l’altro giorno, Primo Maggio, saltabeccato un po’ tra televisone e Rete, stampa e propaganda, notizie dall’alto e cronache dal basso, avrebbe certamente colto alcune affinità e divergenze tra la Francia e noi. Differenze notevoli. Di qua un popolo stanco e senza conflitto, si direbbe quasi arreso; di là un sussulto poderoso di lotta, gigantesche manifestazioni di popolo, simbologie potenti. Il Primo Maggio, festa dei lavoratori, è stata per noi italiani la festa di una provocazione di governo, quella che ai lavoratori sottrae ancora più diritti e contrabbanda come conquista salariale una mancetta semestrale già divorata dall’inflazione. E dietro questo paravento per allocchi, niente più sostegno a migliaia di famiglie in crisi, nuove bastonate alla povertà e nuove precarizzazioni, cioè una rapina da parte di chi detiene la ricchezza ai danni di chi la ricchezza la produce con il suo lavoro (o lavoretto).
Prevengo le obiezioni: le due situazioni, quella italiana e quella francese, non sono direttamente sovrapponibili, perché lassù la protesta del mondo del lavoro si intreccia con la rivolta anti-macroniana sulla riforma delle pensioni, che ha contro la stragrande maggioranza della popolazione (il settanta per cento, dicono i sondaggi). Resta però, piuttosto evidente, la differenza: da dodici settimane i francesi lottano senza tregua contro un governo e un Presidente visibilmente inadeguati, mentre qui, dove le condizioni del lavoro sono ancora più deplorevoli e i salari più fermi, la massima espressione di antagonismo sembrava il gran concertone di Roma. Istituzionale, paludato, vagamente ribellista a parole, dove addirittura a un discorso contro le spese militari e i padroni della guerra (grazie a Carlo Rovelli) i conduttori si dolevano della mancanza di contraddittorio (chissà, l’anno prossimo inviteranno Crosetto, o addirittura un paio di carri armati).
Insomma, pur facendo le debite proporzioni, le differenze saltano agli occhi. Anche simbolicamente. Pensate se in Italia, a una manifestazione di lavoratori, qualcuno portasse in piazza una ghigliottina di cartone (come abbiamo visto fare a Lione, a Parigi e in altre città francesi), o bruciasse un pupazzo con le sembianze del capo del governo. Apriti cielo! E giù alti lai e frignamenti e scandalo sulla violenza, gli anni di piombo, l’estremismo, dove andremo a finire, signora mia! E questo è il frutto di anni e anni e anni in cui il conflitto sociale è stato demonizzato, escluso, insultato in lungo e in largo, criminalizzato, trasformato in reato da tutte le forze parlamentari, destra e “sinistra” unite contro ogni lotta.
Eppure qualche affinità tra Italia e Francia, a guardare la giornata di ieri si poteva cogliere. Re Macron che per muoversi per il Paese si circonda di migliaia di guardie, e quando i francesi scoprono la casserolade (manifestare con le pentole per fare rumore) arriva al grottesco di vietare per decrerto di scendere nelle strade con padelle e pignatte: il trionfo del ridicolo. Non diverso, a pensarci, dalla sora Meloni che passeggia magnificandosi per le sale di Palazzo Chigi, una piccola Versailles, prima di entrare nella grande sala del Consiglio dei ministri, dove cicisbei e lacché la aspettano per il grande gesto del lancio delle brioches, padron del cuneo fiscale, ai lavoratori. Bel video, mancavano solo le parrucche incipriate e il gran ballo di corte, ma chissà che non l’abbiano fatto dopo, a telecamere spente, per festeggiare un nuovo schiaffo ai lavoratori italiani.
 La fremente discussione sulla natalità nell’Italia degli anni Venti è sempre incinta. Non passa giorno, settimana, mese, che qualcuno non lanci l’allarme su questi debosciati (noi) che fanno pochi figli, meno di quanti ne servirebbero per la filiera agricola, per esempio, o per le fabbriche del nord-est, o per pagare i contributi un domani. Insomma, c’è grande angoscia per la futura sparizione della stirpe italica, dannazione, con grande dispiacere di tutti e di alcuni anche di più: il ministro cognato che teme la sostituzione etnica, o il ministro Giorgetti che intende fecondare molte donne per via fiscale.
La fremente discussione sulla natalità nell’Italia degli anni Venti è sempre incinta. Non passa giorno, settimana, mese, che qualcuno non lanci l’allarme su questi debosciati (noi) che fanno pochi figli, meno di quanti ne servirebbero per la filiera agricola, per esempio, o per le fabbriche del nord-est, o per pagare i contributi un domani. Insomma, c’è grande angoscia per la futura sparizione della stirpe italica, dannazione, con grande dispiacere di tutti e di alcuni anche di più: il ministro cognato che teme la sostituzione etnica, o il ministro Giorgetti che intende fecondare molte donne per via fiscale.
Parte così la girandola un po’ grottesca della ricerca delle cause, la principale delle quali è sempre quella: è colpa nostra. Un classico degli ultimi anni: era colpa nostra la pandemia – che non stavamo abbastanza distanziati e chiusi in casa – anche se si erano precedentemente tagliati più di 25.000 posti letto alla sanità pubblica e la medicina di base era scomparsa. E’ colpa nostra la siccità, che non chiudiamo il rubinetto mentre ci laviamo i denti, anche se le tubature sono un colabrodo che perde il 40 per cento dell’acqua trasportata. Ed è colpa nostra, ovvio, se non ci accoppiamo con il sacro fine di figliare, perché – in breve sintesi – siamo egoisti. Dietro ogni colpevolizzazione dei cittadini si nasconde – a volte non si nasconde nemmeno – un errore di gestione delle risorse e, insomma, della politica. Nel caso della natalità, la faccenda è così macroscopica che rende un po’ risibile l’accorato allarme.
Suggerirei, per affrontare il tema in modo almeno sensato, di incrociare alcuni indicatori sociali. Che so, gli annunci immobiliari, magari quelli che chiedono sei-settecento euro per un appartamento in condivisione, oppure mille- millecinque per un bilocale in periferia. Vale anche per i mutui. Oppure – altro indicatore che ogni tanto balza agli onori della cronaca – quegli annunci di lavoro strabilianti, dove fatto il conto delle ore e della retribuzione si scopre che lavare i vetri ai semafori è più conveniente. Mi si consenta una parentesi: anche lì è colpa nostra, non del mercato, o del capitalismo, o delle storture del sistema, ma di noi viziati, segnatamente i giovani, che non ci adeguiamo. Chiusa parentesi.
Insomma, capisco i lungimiranti governanti italiani, che devono convincere la gente a fare un figlio, vaste programme. Futuri padri e madri costretti a vivere coi genitori fino a trent’anni (media europea: 26), dove un medico di base ha più abbonati del Milan, si taglia periodicamente la sanità, si aumenta però la spesa militare, si spendono due terzi dello stipendio per avere un tetto sulla testa, un posto all’asilo costa come un’utilitaria, il diritto allo studio universitario c’è solo per il ceto medio e medio alto e il welfare lo fanno i nonni. Si calcoli tra l’altro che quando saranno nonni questi qui – ammesso che facciano un figlio e che il figlio faccia un figlio anche lui – di welfare famigliare non ce ne sarà più per esaurimento scorte. Senza contare il dato più importante: che per fare figli serve una convinzione specifica: una ragionevole fiducia che domani sarà meglio di oggi, e questa, in Italia, è merce che proprio scarseggia.
E così il Giorgetti della maternità incentivata a colpi di Irpef finirà come il Giorgetti del cuneo fiscale: tante chiacchiere e promesse e titoloni roboanti e poi… sedici euro in più al mese, con cui chi vuole potrà radicalmente cambiare la propria vita. Tanto, se non ci riesce è colpa sua.
 Dell’esilarante show andato in scena su tutte le reti, tutti i giornali, tutti i social e tutte le discussioni da bar, insomma, del grande derby tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, alla fine, resterà poco e nulla. L’effetto gag è già terminato, finito, uffa che noia, a meno che qualcuno non metta in piedi “Renzi e Calenda, il musical”, oppure commercializzi “Renzi e Calenda per PlayStation”, se ne parlerà sempre meno e tutto finirà come lacrime nella pioggia. Questo dipende essenzialmente dal fatto che la ricaduta dello spettacolino sulla vita degli italiani è pari a zero, cioè pari al peso che hanno questi due leader di due partitini sulle reali condizioni di vita della popolazione. Renzi e Calenda, come Totti e Illary, possono anche tenerci incollati alle cronache, e forse persino aumentare il consumo di popcorn, ma poi uno deve andare a lavorare, far la spesa, prendere i figli a scuola, prenotare una visita dal dottore, insomma fare la sua vita, che non cambierà una virgola chiunque trionfi o soccomba dei due statisti che si menano come fabbri.
Dell’esilarante show andato in scena su tutte le reti, tutti i giornali, tutti i social e tutte le discussioni da bar, insomma, del grande derby tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, alla fine, resterà poco e nulla. L’effetto gag è già terminato, finito, uffa che noia, a meno che qualcuno non metta in piedi “Renzi e Calenda, il musical”, oppure commercializzi “Renzi e Calenda per PlayStation”, se ne parlerà sempre meno e tutto finirà come lacrime nella pioggia. Questo dipende essenzialmente dal fatto che la ricaduta dello spettacolino sulla vita degli italiani è pari a zero, cioè pari al peso che hanno questi due leader di due partitini sulle reali condizioni di vita della popolazione. Renzi e Calenda, come Totti e Illary, possono anche tenerci incollati alle cronache, e forse persino aumentare il consumo di popcorn, ma poi uno deve andare a lavorare, far la spesa, prendere i figli a scuola, prenotare una visita dal dottore, insomma fare la sua vita, che non cambierà una virgola chiunque trionfi o soccomba dei due statisti che si menano come fabbri.
Al massimo, la vicenda potrà confermare l’esistenza di mondi paralleli, universi alternativi. Uno è quello della vita reale, e un altro è quello dei social, dove il testacoda è esilarante: le truppe di Renzology dicono a Calenda cose che nemmeno il più estremista dei grillini avrebbe mai pensato; e i calenderos rimproverano a Renzi cose che nemmeno il più efferato comunista da centro sociale avrebbe mai osato elaborare. Entrambi usano argomenti che fino al giorno prima erano considerati volgare propaganda nemica, e che ora vanno benissimo per sostenere la battaglia a seconda del campo scelto. Il wrestling nel fango, al confronto sembra danza classica.
Resta sullo sfondo, e verrebbe da dire per fortuna, quello che dovrebbe essere il nodo centrale del problema, e cioè: cosa inseguono, cosa vogliono, cosa architettano per il Paese questi due esimi pensatori che oggi si comportano come capi gang durante l’ora d’aria? Mistero.
Vagamente, dietro gli sganassoni e gli sputi che volano, echeggiano parole lontane, una “forza liberale”, un “polo dei riformisti”, eccetera eccetera, molta fuffa e alcune parole d’ordine invecchiate prima ancora di nascere, senza contare che non esiste sul pianeta una forza che non si definisca “riformista”, perché qualche riforma la vogliono fare tutti e ovviamente il giudizio lo si darà semmai su “quale” riforma, non su un generico spirito riformista. Il jobs act, per dire, era una riforma, così come lo sarebbe la reintroduzione della pena capitale, dello ius primae noctis o del voto per censo: in assenza di monarchie assolute sono tutti riformisti, è come dire “bipedi” o “mammiferi”.
Dunque abbiamo due bipedi il cui programma per il paese – annunciato in millemila interviste, comparsate, ospitate, interventi davanti a un sistema mediatico capace quasi solo di annuire – è diventare bipedi ancora più grossi. Si vagheggiava di “doppia cifra” alle elezioni, e addirittura di “primo partito” per le europee, che è un po’ come se una tribù del Borneo ambisse a conquistare il pianeta. Ma cosa poi volessero fare una volta arrivati lì non si sa, a parte un generico “noi siamo più bravi degli altri” che i fatti hanno finora sonoramente smentito. E dunque sipario. Si torna a casa dopo i titoli di coda con la netta sensazione di aver buttato del tempo, che, a parte qualche risata, lo spettacolo era scadente, non valeva il prezzo del biglietto e faceva schifo pere la claque pagata per battere le mani.
 C’è qualcosa di meravigliosamente stordente, a suo modo sublime, italianissimo e al tempo stesso satirico, però anche mistico e grandioso, nelle cronache che vengono da Trevignano Romano. La statua della Madonna che piange sangue, l’ex vescovo che la porta in chiesa, le trasmissioni televisive di gossip aumentato che danno corda alla storia, la santona che si rende irreperibile, i fedeli che ci ripensano. Un florilegio che incrocia anni Cinquanta, Totò e Peppino, speculazione edilizia, acquisto di terreni. E voi, allocchi, che credevate alle favole mistiche dell’intelligenza artificiale, ChatGPT, microchip ed elettronica ciberpunk, lo spazio, il futuro… bene, rieccovi nel Medioevo del nostro scontento.
C’è qualcosa di meravigliosamente stordente, a suo modo sublime, italianissimo e al tempo stesso satirico, però anche mistico e grandioso, nelle cronache che vengono da Trevignano Romano. La statua della Madonna che piange sangue, l’ex vescovo che la porta in chiesa, le trasmissioni televisive di gossip aumentato che danno corda alla storia, la santona che si rende irreperibile, i fedeli che ci ripensano. Un florilegio che incrocia anni Cinquanta, Totò e Peppino, speculazione edilizia, acquisto di terreni. E voi, allocchi, che credevate alle favole mistiche dell’intelligenza artificiale, ChatGPT, microchip ed elettronica ciberpunk, lo spazio, il futuro… bene, rieccovi nel Medioevo del nostro scontento.
Tutto fa ridere, tutto è amabilmente deprimente, a partire dal fatto che le statue piangenti sarebbero cinque o sei che si dividono i compiti: un paio lacrimano sangue (parrebbe di maiale, il che sarebbe ancor più miracoloso, in effetti), e le altre olio (parrebbe santo, ma vai a sapere); e dicono i testimoni che la veggente Maria Giuseppa Scarpulla, nome d’arte Gisella Cardia, prima di mostrarle si chiudeva un quarto d’ora nella stanza, da sola, lei e le statue. E intanto ampliava il terreno, raccoglieva offerte, mentre i non credenti del luogo, laicamente, deploravano la difficoltà di parcheggio causa assembramenti sacri, chissà se qualcuno pregava per trovare un posto auto libero, sarebbe consono allo spirito dei tempi. Tutto questo da anni e anni, sotto gli occhi di tutti, il 3 di ogni mese.
Quanto a miracoli, pare pochini: molte promesse ma zero risultati, non fosse per il dolore (vero) e la disperazione (vera) di alcuni che chiedevano guarigioni insperate, siamo in piena commedia all’italiana: la veggente assicurava la moltiplicazione delle focacce e degli gnocchi (giuro), che però un fedele e finanziatore della prima ora, Roberto Rossiello, dice di non aver mai visto. Dannazione.
Ma cosa veggeva la veggente? “Minacciava il papa, parlava di braccia tagliate ai sacerdoti. Ci siamo messi paura”. E te credo, ci manca solo la Madonna hater!
Insomma, come nei veri film dell’orrore si fatica a staccarsi dai racconti e dalle testimonianze, c’è una repulsione che attrae, che solletica vecchi istinti, oltre al timore di constatare che siamo ancora un po’ questa cosa qua, che c’è una (piccola, si spera) frazione del Paese che puoi convincere di ogni cosa, se gliela vendi bene, ma anche se gliela vendi male. Un’ignoranza atavica impastata con uno sconforto che è parente della resa senza condizioni. Se c’è gente che crede alle statue che piangono, figurati cosa puoi fare con un buon apparato mediatico su cose un filino più serie, le crisi, le guerre, l’ottundimento del senso critico in ogni angolo di un Paese che si favoleggia laico e moderno. Il tutto mentre alla maestra di Oristano che nelle ore di lezione ungeva i bambini con l’olio santo di Medjugorje (lei dice che ha portato l’olio, poi si ungevano loro, da soli) vengono offerti ruoli di consulente (regione Sicilia) o invitata al ministero (Sgarbi) per essere “risarcita” dopo la sospensione di venti giorni dall’incarico.
Tutti santi, tutti devoti, tutti volti all’inginocchiatoio, tranne quando il papa invita un ragazzo russo alla via Crucis, e allora apriti cielo: il mistico piace molto e non impegna, ma solo finché non dice la parola “pace”, allora si storce il naso e lo si confina nei trafiletti di dieci righe a pagina nove e nella coda dei telegiornali, ché suona fastidioso, e rovina la narrazione.
 Essendo anch’io segno zodiacale “Uomo del fare”, come Briatore Flavio, non posso che essere d’accordo con il grande cuneese che il mondo della pizza ci invidia: questo ossessivo parlare di fascismo è una perdita di tempo che sottrae energie a cose più serie, tipo il menu estivo del Twiga. E deploro anch’io – come Flavio ha detto in una bella intervista a questo giornale – che suo figlio Nathan Falco non sappia nemmeno chi è Patty Pravo e quindi cosa cazzo volete che gliene freghi di via Rasella, delle Fosse Ardeatine e di tutto il resto. Questo ci porta dritti dritti all’idea di Giorgia Meloni: serve, anzi è urgentissimo, fare un “liceo del Made in Italy”, dove si insegni per prima cosa – già nel biennio – chi è Patty Pravo, e poi, semmai, anche a riparare le caldaie italiane, che non esplodano, così che non abbiano a ripetersi tragedie come Piazza Fontana o la stazione di Bologna.
Essendo anch’io segno zodiacale “Uomo del fare”, come Briatore Flavio, non posso che essere d’accordo con il grande cuneese che il mondo della pizza ci invidia: questo ossessivo parlare di fascismo è una perdita di tempo che sottrae energie a cose più serie, tipo il menu estivo del Twiga. E deploro anch’io – come Flavio ha detto in una bella intervista a questo giornale – che suo figlio Nathan Falco non sappia nemmeno chi è Patty Pravo e quindi cosa cazzo volete che gliene freghi di via Rasella, delle Fosse Ardeatine e di tutto il resto. Questo ci porta dritti dritti all’idea di Giorgia Meloni: serve, anzi è urgentissimo, fare un “liceo del Made in Italy”, dove si insegni per prima cosa – già nel biennio – chi è Patty Pravo, e poi, semmai, anche a riparare le caldaie italiane, che non esplodano, così che non abbiano a ripetersi tragedie come Piazza Fontana o la stazione di Bologna.
Da quel che si capisce, il liceo del Made in Italy dovrebbe insegnare ai nostri ragazzi cosa è italiano e cosa no, difenderci dalle contraffazioni cinesi, assaggiare vini, stagionare il Parmigiano, servire a tavola e sorridere al momento della mancia, unico welfare rimasto.
Il dibattito è ricco e stimolante, e quindi non poteva mancare l’illuminata analisi di Daniela Santanché (donna del fare, e del fare insieme a Flavio): “In questi anni abbiamo avuto una sinistra che ha invogliato i giovani a fare il liceo”; licei peraltro moltiplicati da lady Moratti quand’era ministro dell’Istruzione di Berlusconi, e poi realizzati da Mariastella Gelmini quand’era ministro dell’Istruzione di Berlusconi. Una li ha pensati (i licei), una li ha istituiti, e poi la sinistra (intendono il Pd, roba da matti, ndr) ha invogliato la gente ad andarci. Gira la testa, eh? E questo è niente. Tenetevi forte.
Come sempre quando la questione si fa dura, più dura del comprendonio di Giorgia e Daniela, arrivano i maestri di sostegno ad aggiungere complessità. Uno è l’ideuzzologo autarchico Fabio Rampelli, con la sua nuovissima trovata – mai sentita, davvero inedita, che sorpresa! – di dare multe qua e là a chi usa parole straniere (tipo “made in Italy”, per dire, con cui hanno battezzato un ministero e vogliono creare un liceo). L’altro è il cognato dell’agricoltura, ministro di Giorgia Meloni, che sogna di mandare a zappare i giovani che prendevano il reddito di cittadinanza, e ora non lo prendono più. Insomma, l’agricoltura italiana ha bisogno di braccia, le braccia stanno attaccate a corpi posteggiati sui divani, bisogna che si alzino e vadano a raccogliere le arance, mentre gli studenti del liceo Made in Italy controllano che i divani siano veramente italiani e non, che so, costruiti in Belgio o in Albania.
Il segreto obiettivo di tutta questa frenesia riformista che la destra italiana lancia sul mercato delle scempiaggini – mercato in grande espansione – sarebbe quello di recuperare un’egemonia culturale, rispolverando tradizioni e italianità là dove ancora si possono trovare. Spezzare le reni alla farina di grilli e inchiodare sul bagnasciuga due bistecche sintetiche, magari con otto milioni di cotolette, riporterebbe in alto i cuori. Anche affollare le bidonvilles della piana di Rosarno con raccoglitori ex-fancazzisti non sarebbe male. Per non dire del ritrovato rispetto della nostra amata lingua, oggi così lordata dal “forestierismo” (sic), per cui molti giovani – sbagliando – preferiscono rifugiarsi in un “fuck you”, aglofono e globalista, invece dell’italianissimo, volitivo e maschio “vaffanculo”.
 Non è sempre facile seguire un filo, dipanare una matassa, cercare qualcosa che colleghi vari argomenti apparentemente slegati tra loro che invece, come per magia, portano allo stesso punto. Quindi eccoci, nello spazio di una settimana, a strabiliare per il puzzle che si compone, pezzettino dopo pezzettino, da Parigi a Roma, a Kiev, a Tel Aviv, e altri posti più o meno esotici, fino alla storia passata e – si teme – futura. Soltanto qualche anno fa sarebbe stato impensabile in una democrazia per un politico – un ministro, un uomo di Stato – attaccare frontalmente l’opinione pubblica. Si preferiva lisciarle il pelo, o perlomeno tenerne conto, e anche la Storia in qualche modo lo faceva: la guerra del Vietnam, per fare un esempio, fu persa in casa, in America, per la crescente ostilità degli americani a mandare i loro figli a morire in una giungla lontana.
Non è sempre facile seguire un filo, dipanare una matassa, cercare qualcosa che colleghi vari argomenti apparentemente slegati tra loro che invece, come per magia, portano allo stesso punto. Quindi eccoci, nello spazio di una settimana, a strabiliare per il puzzle che si compone, pezzettino dopo pezzettino, da Parigi a Roma, a Kiev, a Tel Aviv, e altri posti più o meno esotici, fino alla storia passata e – si teme – futura. Soltanto qualche anno fa sarebbe stato impensabile in una democrazia per un politico – un ministro, un uomo di Stato – attaccare frontalmente l’opinione pubblica. Si preferiva lisciarle il pelo, o perlomeno tenerne conto, e anche la Storia in qualche modo lo faceva: la guerra del Vietnam, per fare un esempio, fu persa in casa, in America, per la crescente ostilità degli americani a mandare i loro figli a morire in una giungla lontana.
Così si strabilia a sentire Emmanuel Macron dire che “La folla non ha legittimità di fronte al popolo che si esprime attraverso i suoi eletti”. Una nuance filosofica, molto furbetta, che serve a dividere i francesi che protestano in piazza (cattivi), dal potere, emanazione del popolo (buono). Una specie di “il popolo c’est moi” che strappa un sorriso, specie nel Paese della ghigliottina.
Non è difficile tracciare una linea dritta tra le parole di Macron e quelle del ministro dell’Interno italiano Piantedosi. Anche per lui l’opinione pubblica è un problema: quella italiana sarebbe troppo incline all’accoglienza dei migranti e questo farebbe da pull-factor per i barconi di disperati. Certo, con un popolo fatto tutto di Traini, lo stragista di Macerata che se ne andava per la città sparacchiando ai neri, forse Piantedosi avrebbe un compito più facile, ma è evidente che il suo prendersela con gli italiani –troppo buoni (mah! ndr) – non è altro che depistare l’attenzione dall’incapacità del governo.
Una cosa che fa scopa con la teoria, ben espressa da Francesca Mannocchi in tivù, che l’opinione pubblica non è lucida, mentre “i decisori” (credo si intenda i governi) sì. Quindi i lucidi decisori continuano a spedire armi sempre più letali in zona di guerra, mentre l’opinione pubblica, che lucida non è, si ostina a rimanere contraria nonostante le pressioni di chi dovrebbe informarla, e che sta al novantanove per cento dalla parte dei “lucidi”. Che frustrazione!
Purtroppo ci sono eccezioni: se a Gerusalemme e Tel Aviv grandi manifestazioni popolari evitano che il governo di Israele porti la magistratura ad obbedire alla politica, ecco i toni di trionfo, e il testacoda: lì sono “lucidi” i manifestanti, e non il governo, colpo di scena, perché preme molto dire di quanto sia democratico Israele, nonostante l’apartheid. Mentre invece per l’Ucraina si usa un altro metro: il popolo è fatto coincidere perfettamente, in scala uno a uno, con il governo, per cui Zelensky e il popolo ucraino vengono usati come sinonimi e mai, in questo anno e passa di guerra, si è sentita qualche voce dissidente, che so, qualche ucraino pacifista, o anche solo qualche lettore dei giornali chiusi dal governo, o qualche elettore dei numerosi partiti messi fuorilegge a Kiev. Dunque il popolo, l’opinione pubblica, i cittadini, sono lucidi quando si identificano con chi li governa, e sono invece poco lucidi quando non si allineano. Ed ecco così sistemate le annose questioni della democrazia, dell’opposizione e della protesta sociale: il “popolo” va bene se annuisce, ma guai se diventa “folla”, o anche solo (come qui) sondaggio.
 Ci dev’essere qualcosa di strano nell’acqua che bevono i sedicenti “riformisti” italiani, forse una pozione magica che li spinge irresistibilmente a tifare per i peggiori, a imitarli, a prenderli ad esempio, e – dannazione – a dirlo a gran voce. L’ultimo caso eclatante è quello del presidente francese Macron, con tutto il seguito di semi-leader italiani che per anni si son detti macronisti. Ora che in Francia Macron è popolare come le pulci nelle lenzuola, di macronismo si parla un po’ meno, diciamo che va meno di moda. E a dire il vero si parla con una certa superficialità anche della situazione francese, dove la riforma che alza l’età pensionabile (da 62 a 64 anni) ha creato una mobilitazione popolare di enormi dimensioni, con il paese bloccato e grandi manifestazioni, una vera rivolta. A leggere le home page di qui, sembra che ci sia qualche matto che brucia i cassonetti, e bon, finita lì. Questo è molto strano: di solito alla stampa & propaganda italiana le rivolte degli altri piacciono molto, si tifa per i manifestanti, che siano a Teheran o nelle capitali arabe, ma quando il malcontento si avvicina ai confini l’atteggiamento cambia, prevale la prudenza.
Ci dev’essere qualcosa di strano nell’acqua che bevono i sedicenti “riformisti” italiani, forse una pozione magica che li spinge irresistibilmente a tifare per i peggiori, a imitarli, a prenderli ad esempio, e – dannazione – a dirlo a gran voce. L’ultimo caso eclatante è quello del presidente francese Macron, con tutto il seguito di semi-leader italiani che per anni si son detti macronisti. Ora che in Francia Macron è popolare come le pulci nelle lenzuola, di macronismo si parla un po’ meno, diciamo che va meno di moda. E a dire il vero si parla con una certa superficialità anche della situazione francese, dove la riforma che alza l’età pensionabile (da 62 a 64 anni) ha creato una mobilitazione popolare di enormi dimensioni, con il paese bloccato e grandi manifestazioni, una vera rivolta. A leggere le home page di qui, sembra che ci sia qualche matto che brucia i cassonetti, e bon, finita lì. Questo è molto strano: di solito alla stampa & propaganda italiana le rivolte degli altri piacciono molto, si tifa per i manifestanti, che siano a Teheran o nelle capitali arabe, ma quando il malcontento si avvicina ai confini l’atteggiamento cambia, prevale la prudenza.
Macron, dunque, che solo qualche anno fa sembrava il faro dei “riformisti” (ahah, ndr) italiani, non sembra messo benissimo: fa passare la sua riforma delle pensioni senza voto parlamentare, evita di un soffio la sfiducia e ha contro – dicono i sondaggi e le piazze – due terzi abbondanti del Paese e una coalizione di sinistra (di sinistra, non una destra rosé) che alle ultime elezioni ha sfiorato per un pelo la maggioranza in Parlamento.
Si ricorda en passant che qui da noi alla riforma Fornero che alzava l’età pensionabile a 67 anni si rispose con quattro (4!) ore di sciopero. Perbacco, che resistenza!
Orbati del suo idolo di cartone Macron, i “riformisti” (ahah, ndr) italiani cercano anche di cancellare il ricordo di altri tizi idolatrati per anni, tipo mister Tony Blair, quello che fece insieme a Bush una guerra da un milione di morti, invadendo l’Iraq sulla scorta di prove (disse lui, testuale) “trovate su Internet”. Mentre il socio americano sventolava all’Onu le false prove contro Saddam, Blair diventava un faro per certi politici nostrani, quelli che amano la destra che scrive “sinistra” sul biglietto da visita. Oggi, che si celebra sottotono il ventennale di quella carneficina illegale e imperiale, di Tony si parla pochino, è passato di moda anche lui, meglio scordarselo.
Comprensibile che dopo tante delusioni, i “riformisti” italiani – piccoli fans – si guardino intorno in cerca di nuovi idoli da venerare. E si avanza la figura di Sanna Marin, premier finlandese, nuovo idolo della simil-sinistra italiana iper-atlantista. E’ giovane, dinamica e carina, allevata da due madri (come se fosse un merito politico, mah), entra nella Nato (questo piace moltissimo) e sta costruendo, con il suo governo, un massiccio muro anti-immigrati al confine con la Russia. Perché i russi nemici di Putin ci piacciono molto – e giustamente – ma se scappano qui ci piacciono meno, un po’ come gli afghani, che se sono contro i talebani sono simpatici assai, finche non vengono ad annegare a cento metri dalle nostre rive, e allora gli diciamo che dovevano restare là. In cosa il muro anti-immigrati di Sanna sia diverso dal muro anti-immigrati di Trump ce lo spiegheranno con calma, staremo ad ascoltare con pazienza, pensando sotto sotto: ma voi siete quelli di Blair e Macron, giusto? Ok, bravi, grazie di tutto.
 Correva il 23 ottobre del 2022, pochi mesi fa, e Guido Crosetto, ministro della difesa italiano, lanciava il suo allarme in un’intervista a Repubblica: “Mosca vuole colpirci con la rabbia nelle piazze”, sintetizzavano vari titoli, e il ragionamento scorreva via fluido: c’è l’inflazione, c’è il caro bollette dovuto alla guerra, si teme un’impennata di proteste e la Russia soffia sul fuoco e fomenta. Insomma, lettura facile: se la gente scendesse in piazza incazzata (cosa che finora non è successa, si vede che a Mosca dormono) sarebbe una questione di sicurezza nazionale. Traduco in italiano: non vi mandiamo la celere, vi mandiamo la Folgore.
Correva il 23 ottobre del 2022, pochi mesi fa, e Guido Crosetto, ministro della difesa italiano, lanciava il suo allarme in un’intervista a Repubblica: “Mosca vuole colpirci con la rabbia nelle piazze”, sintetizzavano vari titoli, e il ragionamento scorreva via fluido: c’è l’inflazione, c’è il caro bollette dovuto alla guerra, si teme un’impennata di proteste e la Russia soffia sul fuoco e fomenta. Insomma, lettura facile: se la gente scendesse in piazza incazzata (cosa che finora non è successa, si vede che a Mosca dormono) sarebbe una questione di sicurezza nazionale. Traduco in italiano: non vi mandiamo la celere, vi mandiamo la Folgore.
Non è mai bello quando delle piazze e della rabbia popolare (ammesso di vederla, prima o poi) si occupa il ministro della Difesa e non quello dell’Interno, ma pochi se ne accorsero o si allarmarono. Si arriva ai giorni nostri e ancora l’ineffabile Crosetto dice la sua sul fenomeno migratorio e sul grande flusso annunciato e atteso sulla rotta libica, dicendo che dietro ai migranti che arrivano (o tentano di arrivare), dietro quella disperazione dietro quelle condizioni di vita (di non vita) spaventose, ci sarebbe la brigata Wagner, molto forte in Africa e in Libia, cioè quella milizia semi-privata che fa le guerre a libro paga di Putin. Insomma, i russi. Scemi noi che chiamavamo la Guardia Costiera, mentre bisogna chiamare la Nato (la Nato va su tutto, come il beige).
Sull’analisi geopolitica di Crosetto, sull’allarme del Servizi, su quanto sia comoda e semplicistica la lettura (non siamo noi a non saper gestire un problema, sono i russi che lo creano), hanno detto con varietà e complessità di argomenti molti che si occupano in modo professionale e scientifico di flussi migratori, anche ieri e anche su questo giornale, quindi non mi addentrerò. Registro en passant un problema di traduzione della risposta del boss di Wagner Prigozhin a Crosetto: “mudak”, che Repubblica traduce “cazzone”, il Fatto con “stronzo” e La Stampa con “testa di c…” coi puntini. Urge filologo.
Più interessante mi sembra l’inesauribile e indefessa azione del governo Meloni nell’individuare colpevoli da additare ai suoi elettori e in generale all’opinione pubblica. Erano i giovani dei rave, all’esordio dell’esecutivo, e poi gli anarchici, poi (quello sempre) i fannulloni sul divano, e poi si temeva che lo zar del Cremlino portasse in piazza massaie incazzate e metalmeccanici impoveriti. E poi – davanti a una strage in mare – era colpa di quelli che scappano dall’Afghanistan (strano, li abbiamo trattati tanto bene, bombardandoli per vent’anni!), e poi gli scafisti che cercheremo per tutto il globo terracqueo, e poi il mare grosso, e poi la virata improvvisa del barcone. Insomma, sembra di capire che nel primo governo di destra-destra della storia repubblicana, che nella mitologia astrusa dell’hombre vertical dovrebbe essere volitivo e deciso, prevalga la nota sindrome del “maestra, il cane mi ha mangiato i compiti”.
Non è colpa nostra, sono gli anarchici, no, sono gli sballati dei rave, no, sono i russi, e via così, in un accavallarsi di cattivi che impediscono a Salvini, Piantedosi e Crosetto, che sono i buoni, di far funzionare decentemente le cose, di prevedere le emergenze e magari di risolverle invece di incolpare questo e quell’altro. Non resta che adeguarsi, e anzi suggerire a tutti gli italiani di trarne lezione e insegnamento: “Cara, posso spiegarti, sono stati i russi”. Coraggio, se funziona per Crosetto può funzionare anche per voi.
Come sapete, i “Cinque blues per la banda Monterossi” sono preceduti da una piccola prefazione (o introduzione, o confessione, come volete voi). Tutto Libri ne pubblica una parte. La metto qui. Ci vediamo qui e là
 Un fantasma si aggira per l’Italia, ed è il fantasma della colpa. Concetto antichissimo, praticamente un pilastro, molto gettonato dalle religioni, (quasi tutte), dalle assicurazioni auto (tutte), e da chi governa il Paese, impegnatissimo a dar la colpa alle vittime anziché a chi le ha fatte diventare tali. Caso di scuola, il naufragio di Cutro. Passate per infami e disumane le parole del ministro Piantedosi sui profughi che se la sono cercata, non hanno destato lo stesso scalpore quelle della premier Meloni: “Quelle persone non erano in condizione di essere salvate”. Cioè, tradotto in italiano, il soggetto sono “loro”: loro non erano in condizione di essere salvati, maledetti, e non noi, che non li abbiamo salvati a cento metri dalla riva. Un modo un po’ più arabescato e furbetto di dire la stessa cosa: colpa loro.
Un fantasma si aggira per l’Italia, ed è il fantasma della colpa. Concetto antichissimo, praticamente un pilastro, molto gettonato dalle religioni, (quasi tutte), dalle assicurazioni auto (tutte), e da chi governa il Paese, impegnatissimo a dar la colpa alle vittime anziché a chi le ha fatte diventare tali. Caso di scuola, il naufragio di Cutro. Passate per infami e disumane le parole del ministro Piantedosi sui profughi che se la sono cercata, non hanno destato lo stesso scalpore quelle della premier Meloni: “Quelle persone non erano in condizione di essere salvate”. Cioè, tradotto in italiano, il soggetto sono “loro”: loro non erano in condizione di essere salvati, maledetti, e non noi, che non li abbiamo salvati a cento metri dalla riva. Un modo un po’ più arabescato e furbetto di dire la stessa cosa: colpa loro.
Che oltre cinquanta di quei naufraghi venissero dall’Afghanistan non è passato inosservato, ma è stato per così dire notato a metà, la sola metà del discorso che consentisse di dare la colpa a loro e non a noi. Ancora il ministro Piantedosi, ineffabile, ha fatto notare che lui è stato educato alla responsabilità, cioè a chiedersi cosa può fare lui per il suo Paese (lo stiamo vedendo, ndr), e non cosa deve fare il suo Paese per lui. Un ragionamento che finisce per battere lì: come sono irresponsabili questi afghani, che invece di fare qualcosa per il loro Paese – che so, combattere a mani nude i talebani a cui abbiamo lasciato un patrimonio di armamenti da far spavento – decidono di partire in condizioni precarie e pericolose. Che stronzi, eh?
Faceva notizia, sui giornali di ieri, la storia della giornalista afghana Torpekai Amarkhel, quarantadue anni, morta nel naufragio insieme al marito e tre nipoti. Nelle redazioni hanno messo insieme in fretta e furia la sua storia, dimenticandosi, ahimé, la Storia, con la s maiuscola, del posto da cui veniva. In quarantadue anni di vita, un afghano (qualunque afghano, uomo, donna, giornalista e non) ha visto solo guerra: prima i russi, poi gli americani che hanno armato i mujaheddin, poi i talebani ingrassati e foraggiati in chiave anti-russi, poi la “guerra giusta” che ammazzava civili a grappoli, poi la fuga senza dignità su cui campeggiava un cartello a caratteri cubitali: “Ciao, afghani, cazzi vostri”.
Certo non sempre è facile districare le storie personali dalla Storia collettiva, ma direi che in questo caso il compito non è difficilissimo: il famoso Occidente – noi compresi – una come Torpekai Amarkhel, suo marito e i suoi nipoti, avrebbe dovuto andare a prenderla con un volo di prima classe, portarla qui servita e riverita (forse voleva andare in Olanda, dalla sorella). Invece no. Invece le ha invaso il paese, l’ha bombardato e riempito di armi per vent’anni, dicendo che lo faceva per il suo bene, ha finito per rafforzare un regime delirante e oppressivo e poi – quando lei è venuta qui – non l’ha aiutata nemmeno a non affogare, e come ultimo atto le ha detto che è stata colpa sua, che non doveva partire.
Come si vede, la questione della colpa, apparentemente complicata, è molto semplice: la colpa è dei poveracci. Che si parli di immigrati che attraversano i mari (e allora si complicano e si ostacolano i salvataggi, vedi le recenti norme sulle navi delle Ong) o di poveri italiani che “non hanno voglia di lavorare” (e allora gli si tagliano i sussidi per costringerli ad accettare offerte al ribasso), la colpa è sempre dei più deboli, che è il trucco migliore – e infallibile – per assolvere i più forti.
 Sono così pochi gli entusiasmi, in questo tempo di neolingua, dove i camerati si chiamano patrioti, la guerra si chiama pace, le armi si chiamano soluzione per finire la guerra, la richiesta di giustizia economica si chiama invidia sociale, che non vorrei smorzarli né attenuarli, insomma, non voglio essere io a portare acqua dove potrebbe vedersi finalmente qualche scintilla di cambiamento. Su Elly Schlein e sulla sua vittoria si è scritto tutto e il contrario di tutto, quindi non mi aggiungerò al coro, anche se diverte vedere il puzzle impazzito delle reazioni scomposte e disordinate. A giudicare da alcuni esilaranti isterismi, ci si aspetterebbe da un momento all’altro che Schlein proclami la distribuzione delle terre ai contadini, la dittatura del proletariato, la guerra alle armate bianche e il ritorno del culto di Stalin. Molto divertenti anche alcuni neologismi coniati per l’occasione come il “dirittismo” (non ho capito bene, ma credo sia la tendenza a difendere i diritti), o l’”abortismo sfrenato” (ma sfrenato, eh!) che si rimproverano già dagli exit poll alla nuova segretaria del Pd.
Sono così pochi gli entusiasmi, in questo tempo di neolingua, dove i camerati si chiamano patrioti, la guerra si chiama pace, le armi si chiamano soluzione per finire la guerra, la richiesta di giustizia economica si chiama invidia sociale, che non vorrei smorzarli né attenuarli, insomma, non voglio essere io a portare acqua dove potrebbe vedersi finalmente qualche scintilla di cambiamento. Su Elly Schlein e sulla sua vittoria si è scritto tutto e il contrario di tutto, quindi non mi aggiungerò al coro, anche se diverte vedere il puzzle impazzito delle reazioni scomposte e disordinate. A giudicare da alcuni esilaranti isterismi, ci si aspetterebbe da un momento all’altro che Schlein proclami la distribuzione delle terre ai contadini, la dittatura del proletariato, la guerra alle armate bianche e il ritorno del culto di Stalin. Molto divertenti anche alcuni neologismi coniati per l’occasione come il “dirittismo” (non ho capito bene, ma credo sia la tendenza a difendere i diritti), o l’”abortismo sfrenato” (ma sfrenato, eh!) che si rimproverano già dagli exit poll alla nuova segretaria del Pd.
In prima fila in questo fuggi fuggi di cellule cerebrali, i campioncini della propaganda del Terzo Polo, divisi tra chi si strappa i capelli (moriremo tutti nel gulag) e chi fa buon viso a cattivo gioco, sperando in un allargamento della destra travestita da cento-centro-centro-sinistra, cioè renzisti e calenderos. Vorrei metterli in guardia: tutte le volte che si dice “abbiamo davanti una prateria!”, ci si ritrova su un sentierino di montagna impervio e strettissimo, quindi auguri. Per ora la comunità del Pd piange l’addio di Fioroni – di cui si molto discusso, credo, nella cucina di casa Fioroni – e qualche minaccia di “Io non ci sto”, ma sinceramente si fatica a immaginare moti di piazza e masse in agitazione per trattenere nel Pd Giorgio Gori.
Siccome lo sport del momento è tirare la giacchetta di Schlein, soprattutto per raccomandarle un atlantismo cieco e assoluto, vorrei volare più basso e limitarmi alla narrazione e allo storytelling, insomma alle parole. E’ un appello che esce dal cuore: ci si eviti, per favore, quella retorica vuota e roboante che è stata per lungo tempo la poetica del Pd, i giochetti stucchevoli, le perifrasi da baci Perugina, le formulette del buon cuore che hanno negli ultimi anni lordato ogni argomento con la sola preoccupazione di apparire affidabili al mercato. Si cominci – questo sì sarebbe un elemento nuovo – ad adoperare parole vere, che esistono in natura. Lo sfruttamento, le morti sul lavoro, la depressione dei salari, la povertà, che non sono parolacce, ma che sono state fin qui edulcorate da una retorica soffice e morbidosa, deputata in gran parte a non spaventare le élite. Forse dovendo fare opposizione anziché servire l’agenda di un banchiere, l’impresa sarà più facile, ma ricominciare a chiamare le cose con il loro nome sarebbe un grande elemento di chiarezza, potrebbe diradare la nebbia e spiegare per una volta che si sta da una parte, e non da una parte “ma anche” dall’altra. La guerra è guerra, i miliardi in riarmo e cannoni sono miliardi in armi e cannoni tolti a scuole e ospedali. In attesa del recupero di un minimo sindacale di radicalità (la Spagna attuale, o la sinistra francese sono buoni esempi), si recuperi almeno la lingua, si ritrovino le parole, si esca dalla trappola del sofficismo retorico tenero, ciccioso e innocuo ,e si torni ad essere spigolosi. Senza aspettarsi chissà che, per carità, ma sarebbe un inizio.
 E’ solo un piccolo segnale, un inizio incoraggiante, non fermiamoci, ora! Avanti con la revisione politicamente corretta dei testi – classici e non – della letteratura mondiale! Hanno cominciato, com’è noto, alla Puffin Books, casa editrice inglese che ha riscritto i capolavori di Roald Dahl, cancellando parole come “grasso” e “brutto”, che non vanno bene, perché se uno è grasso o brutto si sente discriminato e smette di leggere. Giusto! E’ solo l’inizio. Vi sembra possibile che nei grandi romanzi russi dell’Ottocento siano tutti bianchi? Che assurdità! Una vera discriminazione! Ora almeno un fratello Karamazov del Congo bisognerà mettercelo, senza contare che il povero principe Myškin, che è tanto puro ma un po’ indietro di comprendonio, non potrà essere più chiamato “l’idiota”, Dostoevskij se ne faccia una ragione! Naturalmente è inaccettabile che in Via col vento i ricchi siano tutti bianchi e i neri facciano gli schiavi, si suggeriscono edizioni alternate: i bianchi fanno gli schiavi negli anni dispari, con “signorina Rossella” presa dai campi di cotone, e la sua domestica, che le stringe il busto e le porta la colazione, una bianca del Wisconsin, ma non grassa come nel romanzo, se no si ricomincia daccapo.
E’ solo un piccolo segnale, un inizio incoraggiante, non fermiamoci, ora! Avanti con la revisione politicamente corretta dei testi – classici e non – della letteratura mondiale! Hanno cominciato, com’è noto, alla Puffin Books, casa editrice inglese che ha riscritto i capolavori di Roald Dahl, cancellando parole come “grasso” e “brutto”, che non vanno bene, perché se uno è grasso o brutto si sente discriminato e smette di leggere. Giusto! E’ solo l’inizio. Vi sembra possibile che nei grandi romanzi russi dell’Ottocento siano tutti bianchi? Che assurdità! Una vera discriminazione! Ora almeno un fratello Karamazov del Congo bisognerà mettercelo, senza contare che il povero principe Myškin, che è tanto puro ma un po’ indietro di comprendonio, non potrà essere più chiamato “l’idiota”, Dostoevskij se ne faccia una ragione! Naturalmente è inaccettabile che in Via col vento i ricchi siano tutti bianchi e i neri facciano gli schiavi, si suggeriscono edizioni alternate: i bianchi fanno gli schiavi negli anni dispari, con “signorina Rossella” presa dai campi di cotone, e la sua domestica, che le stringe il busto e le porta la colazione, una bianca del Wisconsin, ma non grassa come nel romanzo, se no si ricomincia daccapo.
Possibile che nei Malavoglia siano tutti terroni? Avanti, ditelo! E I Promessi sposi allora? Con tutta quella gente che non vuole vaccinarsi, che insegnamento sarebbe per i nostri giovani?
Come può sentirsi una signora anche leggermente sovrappeso in visita a villa Borghese davanti al mirabolante sedere di Proserpina scolpita dal Bernini durante il suo rapimento? Urge marmo con almeno un pochino di cellulite. Sia chiaro che vale anche per i maschietti: gli addominali del David sono uno schiaffo a chiunque sia costretto a nutrirsi di panini e di mense aziendali, una vera discriminazione! Eppure sarebbe facile: un paio di saldature ben fatte, un piccolo rinforzo di metallo, ed ecco che i bronzi di Riace sarebbero più politicamente corretti, con la loro pancetta da birra e i bicipiti almeno un po’ flaccidi. Così noi umani potremmo andare a vederli senza sentirci proprio delle merde, discriminati, umiliati, sprofondati nella vergogna.
Certo si esagera (ma chissà, non poniamo limiti all’idiozia umana) e tutto accade nel mondo surreale della cultura woke e del revisionismo storico-artistico della società tristemente contemporanea, per cui si vorrebbero valutare cose di altre epoche alla luce delle convinzioni e dei parametri culturali dell’oggi. Nell’abbottonatissimo Ottocento, così pudico e sessuofobo, ovvio che Mozart potesse sembrare un pericoloso libertino, ma nessuno si è sognato di riscrivere il Don Giovanni, il revisionismo artistico non era arrivato a tanto nemmeno allora.
Tutto questo correggere il passato fa una certa impressione, poi, se si esce dal surreale dibattito e si fanno due passi nella società contemporanea, quella vera, e si scopre che le discriminazioni – reali, non letterarie – aumentano anziché diminuire. Che si parla di guerra con gli stessi toni garruli, disponibili e possibilisti – perché no? – del 1938, che si corre a comprare cannoni invece di ospedali, che i poveri sono più poveri, i ricchi più ricchi, i cittadini meno informati, i potenti più impuniti, le donne ammazzate di botte o a pistolettate. La sensazione è che tutta quest’ansia di cambiare il passato serva più che altro a mantenere il presente così com’è: niente più grassi e brutti nei libri, e poi, quando posi il libro, l’allegro massacro continua.
Torto marcio (Sellerio, 2017) è un romanzo a cui tengo molto. Per cui annuncio con molta gioia l’uscita in Francia, sempre per le benemerite Editions de l’Aube e la traduzione di Paolo Bellomo e Agathe Lauriot dit Prévost. Qui un paio di recensioni francesi
 Letti e compulsati i commenti del dopo-tsunami lombardo-laziale, forse bisogna ribaltare il concetto. Una cosa simile a quella famosa retorica kennedyana, sapete: non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese, eccetera eccetera. Fuffa. Ecco. Forse la domanda non è: perché la gente (sei su dieci) non è andata a votare, ma perché l’hanno fatto quelli che ci sono andati (4 su dieci, anche meno). E’ la minoranza che dovrebbe spiegare, non la maggioranza. E la maggioranza ha detto chiaro e tondo che questo modello di democrazia rappresentativa non la rappresenta, non è credibile né per proposta politica né come meccanismo. Traduco in italiano: nessuno – nemmeno quelli che sono andati a votare – crede veramente che votando Tizio piuttosto che Caio, una compagine piuttosto che un’altra, cambierà realmente qualcosa. La percezione diffusa è che la scelta sia inesistente, farlocca, questione di sfumature. Che questo sia vero o no (ci sono ovviamente centinaia di varianti, e sfumature molto brutte) non è importante, quel che conta è la percezione e la sua ricaduta sulla realtà.
Letti e compulsati i commenti del dopo-tsunami lombardo-laziale, forse bisogna ribaltare il concetto. Una cosa simile a quella famosa retorica kennedyana, sapete: non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese, eccetera eccetera. Fuffa. Ecco. Forse la domanda non è: perché la gente (sei su dieci) non è andata a votare, ma perché l’hanno fatto quelli che ci sono andati (4 su dieci, anche meno). E’ la minoranza che dovrebbe spiegare, non la maggioranza. E la maggioranza ha detto chiaro e tondo che questo modello di democrazia rappresentativa non la rappresenta, non è credibile né per proposta politica né come meccanismo. Traduco in italiano: nessuno – nemmeno quelli che sono andati a votare – crede veramente che votando Tizio piuttosto che Caio, una compagine piuttosto che un’altra, cambierà realmente qualcosa. La percezione diffusa è che la scelta sia inesistente, farlocca, questione di sfumature. Che questo sia vero o no (ci sono ovviamente centinaia di varianti, e sfumature molto brutte) non è importante, quel che conta è la percezione e la sua ricaduta sulla realtà.
Nella ridente Lombardia, da dove scrivo, locomotiva italiana e vanto dei dané, se ti serve una gastroscopia paghi sull’unghia, oppure aspetti un anno e più, e questo, nonostante le belle promesse e le belle parole, non cambierà perché lo dice un candidato o perché campeggia nei programmi distribuiti nei mercati. La parola “eccellenza” si spreca in lungo e in largo, ma se non hai soldi, o un’assicurazione che costa soldi, di eccellente non c’è niente, il tuo medico di base sembra disperso in Nepal e vai al pronto soccorso, dove ti rimbalzano, per un mal di testa.
Il Pd di Majorino – giustamente considerato più a sinistra delle fantasiose candidature Pd degli ultimi decenni – spingeva il famoso Pregliasco (non eletto), virologo à la page durante la pandemia e dirigente della sanità privata, il che non è, anche dal punto di vista dei simboli e dei segnali, il modo migliore per “rilanciare la sanità pubblica”, come si diceva a ogni passo. E in caso di vittoria, ipotesi peregrina, d’accordo, si sarebbe installato un comitato incaricato di “immaginare (sic) una buona politica per lo sviluppo della Regione”, affidato a… Carlo Cottarelli.
Poi dice che la gente non va a votare.
Sempre nella ridente Lombardia di Attilio Fontana, nei comuni martiri di Alzano Lombardo, Albino, Nembro, la coalizione della destra ha sfiorato il sessanta percento, e anche quelli scampati a una gestione delirante della pandemia, a votare non ci sono andati. Già, la pandemia, il Covid, l’emergenza, l’afflato emotivo delle “bare di Bergamo”. Non pervenuti. Il signor Gallera di Forza Italia – quello che andava in giro a dire che per prendere il Covid dovevi incontrare due positivi insieme, e che nei momenti più bui vagheggiava di diventare sindaco di Milano – pur non eletto, ha preso le sue belle preferenze, oltre cinquemila. La badante di Fontana che lo sostituì all’assessorato, Letizia Moratti, gioia dei salottini chic finto-progressisti della Milano da bere, salutata come salvatrice della Lombardia solo perché nel frattempo erano arrivati i vaccini, non entra in consiglio, naufragata come i due cabarettisti che si sono inventati la sua candidatura. Ora si dirà, come sempre, che chi non è andato a votare ha torto. Può darsi. Ma, visti i risultati, si può dire anche il contrario: è chi è andato a votare che ha torto. Questione di punti di vista.
 Tra le cose degne di nota della regione Lombardia, oltre a bellissimi laghi, montagne spettacolari e pregevoli formaggi, segnaliamo Letizia Moratti, candidata del cosiddetto Terzo Polo, che nell’imminente weekend elettorale metterà il suo nome, il suo prestigio e la sua storia al servizio del presidente uscente e rientrante Attilio Fontana, della Lega (quello dei soldi alla Bahamas, poi trasportati in Svizzera, nel caso vi foste scordati).
Tra le cose degne di nota della regione Lombardia, oltre a bellissimi laghi, montagne spettacolari e pregevoli formaggi, segnaliamo Letizia Moratti, candidata del cosiddetto Terzo Polo, che nell’imminente weekend elettorale metterà il suo nome, il suo prestigio e la sua storia al servizio del presidente uscente e rientrante Attilio Fontana, della Lega (quello dei soldi alla Bahamas, poi trasportati in Svizzera, nel caso vi foste scordati).
Moratti, per farla semplice, aiuterà la Lega, Forza Italia, parlandone da viva, e le falangi meloniane a vincere le elezioni, compiendo così la sua missione storica di sconfiggere il centrosinistra (non che si faccia fatica). I sondaggi sulle intenzioni di voto parlano abbastanza chiaro: danno Fontana intorno al 45 per cento, Majorino (Pd) dalle parti del 33, e lady Moratti sul 20 scarso. Niente male per gente – penso ai terzopolisti quando giocavano nel Pd – che ci ha sempre sfracellato gli zebedei con la tiritera del voto utile, che deve convergere sul più forte, che non va disperso, che non va frammentato. Ecco: se Attilio Fontana and his band (anche il mirabolante Gallera che per contagiarsi di Covid doveva incontrare “due positivi contemporaneamente”… poi dite che non sono talenti!) se la caverà ancora una volta conquistando la Lombardia, dovrà dire grazie a Letizia Moratti e a chi l’ha candidata, cioè il genio incompreso Carlo Calenda e quell’altro socio in ditta, quello del rinascimento saudita. Gloriosa apoteosi del voto inutile.
Facciamola breve: un romano dei piani alti e un toscano della provincia che circuiscono un’anziana signora lombarda avida di poltrone e potere, convincendola che può vincere chiedendo i voti di quegli elettori che anni fa la cacciarono dal Comune di Milano, ritenendola con molte ragioni sindaco impresentabile. Una che quando arrivò al ministero dell’Istruzione (2001, regnante il vecchio Silvio) fece il bel gesto di togliere la parola “pubblica” dalla carta intestata e che oggi, da candidata dice che la scuola è la sua priorità chiedendo voti a sinistra,.
In attesa del voto inutile per Letizia Moratti e i suoi due scudieri teorici della sconfitta, va registrato qualche smottamento. Silvio buonanima, preoccupato che Fratelli d’Italia gli mangi il partito e gli elettori, mormora (indiscrezioni giornalistiche) di preferire Letizia, ma è subito retromarcia, sennò gli alleati se lo mangiano davvero. La sua plenipotenziaria Licia Ronzulli si scaglia contro Moratti dandole della “gallina”. Lo stile è tutto, ma Moratti può contare sul voto convinto di qualche salotto (pardon, living) dove si coltiva la buona conversazione e la nostalgia del bel tempo che fu, quando la borghesia similcolta e similprogressista contava ancora qualcosa, signora mia. Al tempo stesso, la sciura Moratti, in trance agonistica, corteggia i tassisti – minoranza rumorosa considerata forza di gran capacità propagandistica – smentita dal suo stesso pigmalione Calenda, che su licenze, Uber e liberalizzazioni ha idee diverse. Interessante caso di candidata che smentisce la linea del partito che la candida, che smentisce la sua candidata. Del resto in quanto a capacità di ribellarsi ai capi, la signora non ha rivali. Chiamata in regione Lombardia per mettere fine alle performance comiche di Gallera, è diventata vice di Fontana, autocandidandosi alla presidenza per il centrodestra, poi autoescludendosi con stizza perché rifiutata, poi autoproclamatasi di sinistra, in modo così convincente da convincere Calenda e quell’altro campione, che Fontana dovrà ringraziare per il servizio reso.
 Più del fantacalcio, tragicamente imprevedibile, più del fantaSanremo, gioco di società per famiglie, impazza da mesi il fantaZelensky, incentrato sulla capacità di indovinare le richieste del presidente ucraino alla comunità internazionale, ogni giorno rinnovate, anche con una certa capacità di sorpresa. Per dire: è dell’altro ieri la strabiliante richiesta (alla Germania) di sommergibili (!), richiesta che segue la richiesta di carri armati, he segue la richiesta di caccia F-16, che segue la richiesta di missili a lunga gittata, eccetera, eccetera. Ci sveglieremo una mattina con la pressante richiesta di gas nervino? Di testate nucleari? La politica italiana, che ubbidisce agli ordini battendo i tacchi, aumenta al due per cento del Pil la spesa in armi: “Riempire gli arsenali e svuotare i granai” è la parola d’ordine, accolta con grandi applausi da parte del novanta per cento (abbondante) di giornali, tivù, e in generale degli apparati informativi del paese.
Più del fantacalcio, tragicamente imprevedibile, più del fantaSanremo, gioco di società per famiglie, impazza da mesi il fantaZelensky, incentrato sulla capacità di indovinare le richieste del presidente ucraino alla comunità internazionale, ogni giorno rinnovate, anche con una certa capacità di sorpresa. Per dire: è dell’altro ieri la strabiliante richiesta (alla Germania) di sommergibili (!), richiesta che segue la richiesta di carri armati, he segue la richiesta di caccia F-16, che segue la richiesta di missili a lunga gittata, eccetera, eccetera. Ci sveglieremo una mattina con la pressante richiesta di gas nervino? Di testate nucleari? La politica italiana, che ubbidisce agli ordini battendo i tacchi, aumenta al due per cento del Pil la spesa in armi: “Riempire gli arsenali e svuotare i granai” è la parola d’ordine, accolta con grandi applausi da parte del novanta per cento (abbondante) di giornali, tivù, e in generale degli apparati informativi del paese.
In attesa degli sviluppi militari (non entro nelle questioni belliche) e degli sviluppi della propaganda (non entro nelle polemiche sanremesi), balza agli occhi una questione generale – diciamo così strutturale della nostra democrazia – su cui vale la pena riflettere. L’opinione pubblica sembra scollata, distante, lontanissima dall’opinione dei media. Senti la gente, guardi i sondaggi e apprendi che la maggioranza degli italiani è contraria ad ulteriori invii di armi in zona di guerra; poi leggi i grandi giornali, o ascolti un qualunque telegiornale, o notiziario, e la sensazione è quella opposta: appoggio incondizionato, avanti fino alla vittoria finale, eccetera, eccetera.
Uno scollamento strabiliante, non nuovo ma mai visto in queste dimensioni, con le storture e le anomalie che ne seguono. La prima, macroscopica, infantile e un po’ miserabile, l’accusa di “stare con Putin” a chiunque immagini soluzioni diverse dalla guerra a oltranza; quindi chi pronuncia parole come “cessate il fuoco” o “trattative” diventa una specie di Rasputin assetato di sangue alle dipendenze del Cremlino. La seconda, un po’ ridicola, è la voluta confusione storica per cui la Russia (la Russia di Putin, quel mefitico concentrato di nazionalismo che ha privatizzato le ricchezze del paese) sarebbe ancora sovietica quando fa comodo, o imperiale quando fa comodo, bolscevica se serve, a piacere. Terzo elemento, piuttosto inquietante, la necessità – data dallo spirito embedded della stragrande maggioranza dei media – di nascondere accuratamente i limiti, diciamo così, della presunta democrazia ucraina. Tanto che quando Zelensky fa pulizia di alcuni politici e funzionari corrotti, pochissimi notano – e tutti tra le righe – che la giustizia in Ucraina è assoggettata al potere politico, che si sono messi fuori legge partiti, chiusi giornali, si sono unificate reti televisive e altre cosucce ancora. “L’Ue insiste da mesi che il sistema giudiziario ucraino sia reso indipendente”, scrive il Corriere della Sera come en passant, un inciso, un apostofo rosa tra le parole: stiamo riempiendo di armi un paese non Ue che non ha nemmeno lontanamente i requisiti per entrarci.
La sensazione è che ci siano due opinioni pubbliche: quella dei cittadini, oltre il 50 per cento contrari a nuovi invii di armi, che conta pochissimo, e quella dell’informazione (vorrei dire delle élite) che invece è favorevole al 98 per cento e pesa parecchio. Uno scollamento che è un dato di fatto, non positivo in una democrazia, comunque la si pensi sulla guerra, sulle armi e su Sanremo.
 Mentre il Paese si appassiona e freme per i poster nella cameretta del boss, per la mafia che non usa il telefono, per l’attesa febbrile di Zelensky a Sanremo, rischia di passare inosservata una piccola questione edilizia sulle Olimpiadi invernali del 2026. Roba banale, da carpentieri e capi-cantiere, che fa persino vergogna parlarne, Eppure bisogna.
Mentre il Paese si appassiona e freme per i poster nella cameretta del boss, per la mafia che non usa il telefono, per l’attesa febbrile di Zelensky a Sanremo, rischia di passare inosservata una piccola questione edilizia sulle Olimpiadi invernali del 2026. Roba banale, da carpentieri e capi-cantiere, che fa persino vergogna parlarne, Eppure bisogna.
Per la pista di pattinaggio veloce di Baselga di Piné (Trento) serve una copertura, cioè, così chiede la Federazione Internazionale, e fare la copertura (il tetto) costa più di 50 milioni, qualcuno dice 75, che è una bella botta, specie se si considera che il pattinaggio di velocità non è esattamente lo sport più popolare del Paese, non siamo mica in Canada, e quindi sarebbero parecchi milioni spesi non benissimo, diciamo. Si propone Torino, che ha un impianto per il pattinaggio ad alta velocità (l’Oval) avendolo costruito per altre Olimpiadi invernali, quelle del 2006; e siccome non è che in autostrada c’è la fila per andare a pattinare a duecento all’ora, ci si chiede se l’Italia sia pronta ad avere ben due piste così costose che – in assenza di Olimpiadi – servono a una dozzina di persone. Considerati i praticanti di pattinaggio veloce, insomma, si tratterebbe di stanziare un milioncino a testa, tanto vale darglielo in contanti e spedirli a pattinare in Alaska. Cosa che, tra parentesi, vale anche per la famosa pista di bob di Cortina, che costerà come una spedizione su Marte perché bisogna praticamente demolirla e ricostruirla, mentre ce n’è una seminuova a Torino, chiusa perché non la usa nessuno, e la gente che pratica il bob, in Italia, ammonta a una ventina di persone.
Nonostante tutto questo – e molte atre cose ancora – non si interrompe il mantra rassicurante che risuona ovunque (dal Coni al Cio, alla regione Veneto, alla regione Lombardia, alla ridente e innevatissima città di Milano, a Cortina, eccetera): le Olimpiadi sono un affarone, arriverà un sacco di gente, dormirà tra Cortina e Milano, spenderà dei soldi, diventeremo tutti ricchi e l’economia ne trarrà giovamento. La solita fuffa dei grandi eventi: si passano anni a decantare ipotetici guadagni (prima) e anni a leccarsi le ferite (dopo), mentre si nega di averne riportate (Expo docet), con l’aggravante che se dici qualcosa di critico passi per nemico dello sviluppo, del Paese, retrogrado e noioso.
Naturalmente tutti siamo portati all’ottimismo, specie da quando Matteo Salvini è ministro delle Infrastrutture. Perché siamo sicuri che infrastrutture decenti chissà, ma il buonumore è assicurato. “Dovremo correre come matti”, dice constatando ritardi spaventosi (il completamento di alcune opere per le Olimpiadi del 2026 è previsto nel 2027, che meraviglia!). Ma non solo, eccolo ribaltare il grande assioma del malaffare nazionale: “C’è chi pensa che la corruzione si contrasti con una lunga procedura di controlli – dice al Sole 24 Ore – io penso il contrario, con meno uffici in cui le pratiche girano ci sono meno probabilità di incontrare corrotti e corruttori”. Cioè (traduco dal salvinese all’italiano): se facciamo i lavori in fretta, senza controlli, di corsa, senza guardare chi li fa, come, con quali materiali, con quali appalti, con quali regole, corrotti e corruttori non riescono a starci dietro e tutto sarà pulito. Insomma, Salvini punta a battere la corruzione col cronometro. Quando arrivano a braccetto, corrotto e corruttore, trovano l’opera già fatta, e lui lì col cacciavite in mano e un sorriso olimpico. Ve l’ha fatta, eh! Che sagoma!
 Non cascherò nella trappola con tutte le scarpe, promesso. Non mi fingerò dantista provetto, espertone del Sommo Poeta, esegeta del pensiero guelfo, o ghibellino, e quindi non commetterò la stupidaggine di contestare con argomenti colti la stupidaggine del ministro della cultura (ossignur! ndr) Gennaro Sangiuliano su Dante Alighieri (“fondatore del pensiero di destra in Italia”… ehm… imbarazzo). Lo hanno fatto fior di pensatori, studiosi, medievalisti, dantisti e dunque mi ritiro in buon ordine nel piccolo orticello di questa rubrichetta per notare un paio di cose che sono vezzi contemporanei ben radicati e che vanno al di là delle performance critiche del fu direttore del Tg2.
Non cascherò nella trappola con tutte le scarpe, promesso. Non mi fingerò dantista provetto, espertone del Sommo Poeta, esegeta del pensiero guelfo, o ghibellino, e quindi non commetterò la stupidaggine di contestare con argomenti colti la stupidaggine del ministro della cultura (ossignur! ndr) Gennaro Sangiuliano su Dante Alighieri (“fondatore del pensiero di destra in Italia”… ehm… imbarazzo). Lo hanno fatto fior di pensatori, studiosi, medievalisti, dantisti e dunque mi ritiro in buon ordine nel piccolo orticello di questa rubrichetta per notare un paio di cose che sono vezzi contemporanei ben radicati e che vanno al di là delle performance critiche del fu direttore del Tg2.
Prima di tutto, c’è il rispetto di una regola aurea, un grande classico della retorica da marcia indietro, quando non si vuol dire apertamente “Ho detto una cazzata” e allora si butta tutto in caciara con “Ho fatto una provocazione”. Più che una deviazione in corner è un salvataggio sulla linea di porta (mi scuso per la metafora calcistica: il Pertrarca, che tifava Arezzo, mi capirà), cioè un tentativo piuttosto disperato di ribadire una cosa e darle una certa nobiltà anche dopo che tutti ti hanno riso in faccia (“provocazione”, roba da agitatore culturale, da stimolatore di dibattiti).
Lasciate Dante e Sangiuliano, questi due sommi poeti, al loro destino e fateci caso, spesso, spessissimo, quando si rivendica una “provocazione” è esattamente quello: ho detto una cosa piuttosto campata per aria e la rivendico in forma di paradosso. Purtroppo, il ministro Sangiuliano si lancia (sul Corriere) pure in digressioni colte, tira in ballo “l’idea di Nazione”, Aristotele e San Tommaso d’Acquino, forse di destra anche loro, mentre Platone era del Pdup, e qui perde un po’ colpi. Ma insomma, la sua difesa principale resta quella della “provocazione”, che è un lasciapassare insuperabile. Chi può smentire? Chi può contestare? Se io dico che un pittore amatoriale, un imbrattatele della domenica, vale Giotto o Caravaggio e tutti mi guardano come un matto, posso sempre cavarmela con la “provocazione”, questa comoda uscita di sicurezza sempre aperta, sempre disponibile.
E sia, non ci stupisce che alcuni dei più triti trucchetti della dialettica siano applicati dalla politica, mentre stupisce, invece, che qualcuno li prenda ancora sul serio. Perché è la seconda parte della difesa in due mosse del ministro che colpisce. Vediamo dall’apologia di Sangiuliano scritta da sé medesimo: “Nessuno pensa che la sua opera e le sue idee (di Dante, ndr) possano esaurirsi nello spazio di uno scritto e tantomeno di una battuta” (lui ha fatto esattamente una battuta). “E nessuno pensa che la sua opera e le sue idee possano essere trasposte, sic et simpliciter, nel mondo contemporaneo” (esattamente come ha fatto lui). Per concludere: “Ma se la provocazione che ho fatto è servita a far riprendere a qualcuno in mano i libri di Dante Alighieri, è già un buon risultato”.
Ecco fatto: la frittata è rivoltata, la magia compiuta e lo stratagemma dialettico risolto come un sudoku per principianti. In sostanza ho detto una scemenza su un argomento preciso, poi l’ho chiamata provocazione per nobilitarla, poi ho rivendicato che senza la mia provocazione voi tutti – bestie – non avreste approfondito quell’argomento preciso. Come tutti sanno Domodossola è in Bolivia. Una cazzata? Ma no, è una provocazione! E senza di me – ignoranti che non siete altro – non avreste mai ripreso in mano una cartina della Bolivia. Facile, eh!
 Quello della benzina, e di suo fratello gasolio, è un caso di scuola, una dimostrazione pratica di come la politica – sempre presentata come complicata alchimia – possa essere letta anche dalle persone più semplici, con ragionamenti lineari. Il benzinaio di Occam, insomma: la spiegazione più semplice è spesso quella più probabile.
Quello della benzina, e di suo fratello gasolio, è un caso di scuola, una dimostrazione pratica di come la politica – sempre presentata come complicata alchimia – possa essere letta anche dalle persone più semplici, con ragionamenti lineari. Il benzinaio di Occam, insomma: la spiegazione più semplice è spesso quella più probabile.
Chi fino al 25 settembre 2022, data delle elezioni, ululava più forte contro le accise sui carburanti, una volta eletto non solo non le ha ridotte, ma ha ripristinato anche quelle ridotte dal governo Draghi. Come promettere di darvi dei soldi (parliamo più o meno di un miliardo al mese) e poi fregarveli da sotto il naso: furto senza destrezza.
Sedici, diciotto, venti centesimi. Tanto dovevano aumentare i carburanti per colpa delle accise ripristinate del governo di Giorgia Meloni, quella che prima delle elezioni vibrava di indignazione contro le accise. E invece, colpo di scena, gli aumenti sono lievitati del doppio e anche di più con grande sorpresa dei governanti che hanno fatto ooohhhh!, e invocato il solito spettro della “speculazione”. Speculazione, sia detto per inciso, sempre ad opera di ignoti, che loro sarebbero pagati per combattere, invece di restare stupefatti, basiti e paralizzati dallo stupore.
Un aumento consistente dei carburanti, naturalmente, porterà ad un aumento di tutte le merci che vengono trasportate, e siccome non esiste un prodotto di consumo che arrivi a casa vostra a piedi, nel giro di qualche settimana aumenterà tutto perché – signora mia – è aumentata la benzina. E siccome non abitiamo su Alpha Centauri come alcuni dei ministri del governo italiano, sappiamo anche che i prezzi aumenteranno di qualche decina di centesimi più dell’aumento dovuto ai carburanti. Riassumendo: il governo di quella signora che in campagna elettorale si faceva filmare al distributore minacciosa e indignata contro il caro carburanti, ha rincarato i carburanti, avviando una vera e propria spirale di aumenti delle merci di consumo, una vera manovra recessiva che si aggiunge all’inflazione superiore al dieci per cento. Una dichiarazione di guerra ai cittadini, insomma, una specie di esproprio.
Per fortuna ci viene in soccorso Giovanbattista Fazzolari, che di lavoro fa il sottosegretario, oltre che il “Responsabile del programma di Fratelli d’Italia”, il quale ci spiega che i soldi che finanziavano il taglio delle accise sotto il governo Draghi oggi sono stati destinati a “misure mirate ai aiutare i più deboli”. Capito, Robin Hood Fazzolari? Voi pagate la benzina anche quaranta, cinquanta, sessanta centesimi in più al litro, e così il governo aiuta i più deboli. Non siete orgogliosi? Se poi vai a vedere chi sono ‘sti deboli che stai aiutando… mah… le partite Iva da 85 mila euro l’anno, i presidenti delle squadre di calcio, le spese per gli armamenti, e altre meritevoli debolezze. I deboli veri, ovvio, cazzi loro.
A una settimana dal consiglio dei ministri che ha ripristinato alcune tasse sui carburanti, insomma, il/la presidente del Consiglio e i suoi più ascoltati consiglieri sono costretti a riunirsi per discutere dell’aumento dei carburanti, e probabilmente a convocare un altro consiglio dei ministri per affrontare il rincaro dei carburanti. Se gli fate notare la figura da cioccolatai e la distanza lunare tra quel che dicevano prima delle elezioni e quello che fanno dopo, si metteranno a frignare e a dare la colpa ad altri (la speculazione!), perché le accise sul vittimismo dei dilettanti sono sempre altissime.
 Ci sono parole fuori posto, che piovono male, che non c’entrano niente, così estranee al contesto che sembrano appoggiate lì per caso. O per convenienza, per ridicolo calcolo, o peggio per speranza, o peggio ancora come piccola assicurazione sui fallimenti futuri: parole che mettono le mani avanti. Una di queste parole, ricorrente al punto da essere noiosa, è “ottimismo”, non a caso sbandierata fieramente dal/la signor/a Giorgia Meloni nei suoi auguri (soprattutto a se stessa e ai suoi arditi) di fine anno. “Un 2023 di orgoglio e ottimismo”, augura il/la presidente del Consiglio, che vuol “sollevare questa nazione”, “rimetterla in piedi”, “farla camminare velocemente con entusiasmo”, e, ovvio, “dobbiamo farlo insieme”. Con il che si capisce bene il sottotesto: se voi non avete entusiasmo, ottimismo e non lo farete insieme, beh, un eventuale disastro sarà colpa vostra. Un classico.
Ci sono parole fuori posto, che piovono male, che non c’entrano niente, così estranee al contesto che sembrano appoggiate lì per caso. O per convenienza, per ridicolo calcolo, o peggio per speranza, o peggio ancora come piccola assicurazione sui fallimenti futuri: parole che mettono le mani avanti. Una di queste parole, ricorrente al punto da essere noiosa, è “ottimismo”, non a caso sbandierata fieramente dal/la signor/a Giorgia Meloni nei suoi auguri (soprattutto a se stessa e ai suoi arditi) di fine anno. “Un 2023 di orgoglio e ottimismo”, augura il/la presidente del Consiglio, che vuol “sollevare questa nazione”, “rimetterla in piedi”, “farla camminare velocemente con entusiasmo”, e, ovvio, “dobbiamo farlo insieme”. Con il che si capisce bene il sottotesto: se voi non avete entusiasmo, ottimismo e non lo farete insieme, beh, un eventuale disastro sarà colpa vostra. Un classico.
Giorgia, donna, madre e cristiana, non è che inventa molto, diciamolo. Ancora ci ricordiamo quello là col sole in tasca, il Berlusca buonanima, che andava dicendo che i pessimisti si tirano addosso la sfiga da soli, e quindi non essere ottimisti non è un atteggiamento, ma un concorso attivo alla catastrofe. Vennero altri ottimismi, più organici all’ubriacatura liberale che piace tanto ai piani alti e altissimi del Paese. I primi giorni di Mario Monti fecero saltare l’ottimistometro nazionale, e pareva che fosse atterrata la Madonna in persona, il loden al posto del velo, per sistemare le cose con la sola imposizione delle mani della Fornero. Si è visto.
Altro sussulto di ottimismo sfrenato, la comparsa di Mario Draghi, quando pareva che l’Europa bussasse da ogni italiano con i contanti in mano dicendo “tenga buon uomo”, e i giornali titolavano sulla pioggia di miliardi in arrivo, praticamente già infilati nella nostra casella della posta. Si è visto anche lì, e basterebbe a mettere una moratoria di dieci anni sulla parola ottimismo, almeno in politica.
Quali motivi ci siamo oggi, essendo italiani, per essere ottimisti, è piuttosto misterioso. L’inflazione al dieci per cento, il lavoro che si precarizza sempre più, il welfare che svapora, le bollette, la guerra di altri che ci costa come se fossimo in guerra noi. Basta dare un’occhiata a ricerche e sondaggi per scoprire che il segno meno, in quanto a fiducia, domina incontrastato, e non sarà certo chiamare il Paese “Nazione” (o i camerati “patrioti”) che ci indurrà a cambiare idea. Di solito, l’ottimismo è un afflato piuttosto irrazionale (“Gli ottimisti sono la claque di Dio”, diceva mirabilmente Gesualdo Bufalino), mentre il pessimismo è mesto realismo. Una differenza che chiunque può capire se si sveglia con Giorgia ottimista, la benzina più cara, le autostrade più costose, il mutuo più stretto al collo, lo stipendio che vale meno e l’assistenza scomparsa per dare una mano ai presidenti delle squadre di calcio, i veri bisognosi del Paese.
Ma quando si invoca ottimismo – come il sor/sora Giorgia fa un po’ maldestramente, nel suo stile – si intende un’altra cosa. Si intende solitamente uno spirito collettivo, un vento che porta non solo consenso, ma convinzione, un’aria frizzante di partecipazione emotiva dei cittadini che oggi non si vede, non risulta, non c’è, e non ha motivo di essere.
Meloni faccia la sua strada in salita, non cerchi appigli, non invochi aiutini da casa come nei telequiz, non si appelli all’ottimismo della popolazione al quale ha finora contribuito soltanto bastonando i poveri e aumentando la benzina: non un grande contributo.
 Finisce il 2022, ed è probabilmente l’unica buona notizia del 2022.
Finisce il 2022, ed è probabilmente l’unica buona notizia del 2022.
Il 2023 s’avanza a lunghi passi distesi, mancano pochissimi giorni, e quindi è il momento delle previsioni, dei buoni propositi, delle necessarie illusioni e dell’”andrà tutto bene”, come dissero a Pompei guardando il primo filo di fumo del Vesuvio.
Prima regola: davanti a un anno nuovo non bisogna essere prevenuti e avere un atteggiamento negativo, no, bisogna aspettare almeno il 15 gennaio, e poi si può cominciare con il pessimismo. Un solo pensiero deve occupare la mente dell’italiano che guarda davanti a sé: cosa potrebbe andare storto? E dunque stilare un elenco infinito di cose, faccenda che potrebbe occuparlo fino alla fine dell’anno, distraendolo da disastri più o meno annunciati.
Per esempio, il congresso del Pd, che segnerà il 2023 come l’anno in cui il Pd scelse un nuovo segretario, che sarebbe il decimo in quindici anni di vita (e non conto i bis e gli interim). Forte di questa incredibile novità – un segretario nuovo di zecca che vanta nel curriculum una vittoria per un pugno di voti contro Lucia Borgonzoni, e ancora ne parla come fosse la battaglia di Okinawa – il Pd potrà affrontare il futuro con piglio deciso e autorevole insieme ai suoi duecentocinque elettori.
Purtroppo, l’asse della politica penderà ancora verso destra: Meloni, cognato, Crosetto e altri bellimbusti, più il duo comico del Terzo Polo, al momento (fine 2022) un po’ seccato perché a Palazzo Chigi non hanno ascoltato i suoi consigli. Ora, per tutto il 2023, tenteranno di compiacere Meloni in tutti i modi, un po’ per candidarsi a stampella del governo, un po’ per farsi notare. Fiume Italiana, Nizza e Savoia, magari la befana fascista o il gli esercizi ginnici il sabato: già pare di vedere Calenda che parla di “tradizioni liberali” come l’oro alla patria o le bonifiche delle paludi.
Proseguirà la riforma della giustizia con decisive novità sulle intercettazioni: saranno tutte autorizzate quelle a carico di giudici e pm, che saranno intercettati regolarmente. E finalmente ecco la separazione delle carriere: la carriera di colletto bianco, dirigente, manager, politico, separata da quella di imputato, definitiva dimostrazione che in Italia il garantismo si applica per reddito.
Continuerà, nel 2023, l’entusiasmante guerra ai poveri che tante soddisfazioni ha dato alla destra, alla sinistra (parlandone da viva), ai grandi giornali, alle televisioni, a Matteo Renzi che teorizza di educare i poveri con la sofferenza, sennò che gusto c’è. Dopo aver tolto il reddito di cittadinanza a migliaia di indigenti ribattezzandoli “occupabili”, si studierà di escludere anche quelli con una gamba sola (“saltellabili”) e a quelli senza fissa dimora (“barbonabili”). Sono allo studio misure restrittive anche per altre categorie di nullatenenti, spiantati, disperati a cui non è giusto garantire sussidi statali, almeno finché hanno ancora degli organi (“asportabili”).
Queste norme permetteranno di risparmiare alcune decine di milioni che potrebbero più proficuamente essere destinate alla ricopertura in broccato e oro delle poltroncine delle tribune vip degli stadi di calcio, un aiuto concreto a presidenti di squadre che attraversano purtroppo una drammatica crisi.
Come si vede, le sfide del 2023 saranno numerose e impegnative, ma ci tempreranno e ci renderanno migliori, più consapevoli e più generosi nei confronti di alcune categorie in sofferenza, come ad esempio i produttori di armi, a cui regaleremo un’ottantina di miliardi in più.
Auguri a tutti.
Non c’è occasione di satira, spiritosaggine, freddura, motto di spirito, battuta, più ghiotta di una legge cretina: l’emendamento di Fratelli d’Italia alla Finanziaria che riguarda l’abbattimento della fauna selvatica. Anche nelle aree protette, anche nelle aree urbane, anche nei periodi di silenzio venatorio. Insomma, per i cinghiali è la famosa tolleranza zero: pena di morte per impallinamento, ad opera di zelanti cacciatori che potranno girare tra cassonetti, giardinetti e controviali armati fino ai denti, colpo in canna, sguardo vigile, visori notturni, cani da punta, giberne piene di cartucce, stivali da palude, lasciando a casa soltanto il loro peraltro già scarso senso del ridicolo.
Scene di caccia metropolitana, con tutto quello che ne consegue: gente che gira armata, errori, abbagli, colpi che partono per fatalità e disgrazia: “Vostro onore mi sembrava che grufolasse, giuro… che c’entra che ronzava intorno a mia moglie? E’ stato un incidente!”.
Come si muoveranno i cacciatori urbani? A piedi in lunghe marce estenuanti? O in macchina, per raggiungere le zone più frequentate dagli ungulati? In questo caso, avere decine, forse centinaia di automobilisti armati tra la Salaria e la Flaminia nuova, assonnati alle prime luci dell’alba, oppure nervosi come marines in missione notturna tra la Prenestina e la Collatina, sarà un eccellente sistema per fare un po’di selezione della specie: sopravviveranno solo i più svegli. Peccato per i danni collaterali, le vittime civili, le signore che alla luce tremolante e fioca dei lampioni scendono a buttare il sacchetto nel cassonetto dell’umido, magari indossando la prima cosa che capita a tiro, ecco, eviterei le pellicce, anche sintetiche (“Vostro onore, le giuro che…”, come sopra).
Indotto economico notevolissimo: impennata delle vendite per tutti gli strumenti di protezione individuale. No, non le mascherine, ma caschi, giubbotti antiproiettile, tuniche catarifrangenti, kit di primo soccorso, corsi di aggiornamento per infermieri (“Pallini: come estrarli da gambe e braccia”), senza contare il rafforzamento del servizio ambulanze.
Insomma, c’è da far felice Crosetto: più doppiette per tutti, munizioni, sistemi d’arma, esplosivi, trappole, fucili automatici, mitragliatori. E tutto non solo nei parchi, nelle riserve naturali, nelle zone di ripopolamento dove si possono far più danni ecologici di un concerto di Jovanotti, ma anche ai margini della Cristoforo Colombo, o dell’Aurelia, a diradare il traffico a colpi di pallettoni vaganti (“Lo so che era una Ford Fiesta, vostro onore, ma le giuro che sembrava…”, come sopra).
Si potranno mangiare le vittime. No, non la signora che butta l’umido o il barbone che dorme al parco, scambiati per fauna selvatica, ma proprio i cinghiali uccisi a pallettoni, stesi sull’asfalto, dissanguati. Nasceranno così generazioni di scuoiatori, sezionatori, macellatori di prede urbane, nuove professioni, un milione di posti di lavoro, finalmente! Per i più formidabili, incredibili, demenziali anni di piombo che la storia ricordi.
 Che il Signore ci mantenga il ricordo indelebile del genio Tognazzi Ugo, e del maestro che lo diresse ne La marcia su Roma (Dino Risi, era il 1962), perché di quel personaggio – camerata Umberto Gavazza, presente! – è lastricata l’italianità grottesca dell’oggi, il melonismo del “noi tireremo dritto” e del “non ci faremo intimidire”. Figurarsi.
Che il Signore ci mantenga il ricordo indelebile del genio Tognazzi Ugo, e del maestro che lo diresse ne La marcia su Roma (Dino Risi, era il 1962), perché di quel personaggio – camerata Umberto Gavazza, presente! – è lastricata l’italianità grottesca dell’oggi, il melonismo del “noi tireremo dritto” e del “non ci faremo intimidire”. Figurarsi.
Ad ogni curva della sua marcia su Roma, il Gavazza tirava una riga su un punto del programma del fascio: via questo, via quello, e questo lo cancelliamo, e questo ce lo scordiamo, eccetera eccetera. Esattamente come fanno le truppe meloniane giorno dopo giorno nelle ore che ci separano dalla fiducia sulla famosa manovra che doveva cambiare tutto e che invece porrà qualche ritocchino qui e là – draghismo dell’obbligo – mentre le bandiere e i labari identitari tornano nel sottoscala, con la naftalina e i busti del Puzzone, chissà, ci saranno momenti migliori per tirarli fuori di nuovo. Insomma, contrordine camerati, perché il Pos torna quel che era, la pacchia (sic) non è finita, il fatto che uno possa avere in casa dei contanti per mille motivi, come disse il/la premier e che quindi possa diventare un delinquente se li spende era un tristo arrampicarsi sugli specchi insaponati e adesso, mestamente, il/la Giorgia deve fare marcia indietro. Come il sempre più smarrito e deluso camerata Umberto Gavazza, anche Giorgia tira una riga sulle sue belle teorie e punti del programma: cava di tasca il foglietto delle promesse e cancella il punto del Pos, del contante, del “li spendo come voglio”.
Peggio mi sento con le pensioni minime di Silvio buonanima. Anche lì era glorioso un “pane e figa per tutti”, le minime a mille euro, senza contare quelle (sempre a mille euro) per le “nostre mamme e le nostre nonne”, hurrà, arriva Silvio con la sua cornucopia di dané. Macché, porca miseria, Gavazza Umberto in marcia verso Roma, vestito d’orbace e stivalato a dovere, cancella anche quello. Seicento euro, ed è già cara grazia, e solo per chi ha più di 75 anni, e solo per il 2023. Cioè un bonus, alla fine, uno di quei tanti odiati bonus che il programma voleva eliminare e oplà, altra riga tirata su una voce dell’elenco, altra promessa cancellata strada facendo.
E del resto anche il/la Meloni che prometteva “mille euro agli italiani che ne hanno bisogno con una semplice domanda”, si sentirà un po’ ridicola, pensando a quella sua promessa populista, di cui circola impietoso il video in cui lei guarda dritto in camera, pancia in dentro, petto in fuori: mille euro per tutti… e lì il camerata Gavazza la riga l’aveva già tirata da un pezzo, tanto era cretina e peregrina la promessa.
E poi altra riga sulle famose multe annullate, che insomma è vero sì ed è vero no, perché decideranno i comuni e non è detto che le abbuonino, forse si limiteranno a limare gli interessi.
E poi riga definitiva, tirata forever a cancellare la famosa flat tax, che al momento è un regalo agli autonomi fino a 85.000 euro, mentre nel foglietto degli impegni solenni del gerarca bacia-salami, alla vigilia, era la madre di tutte le promesse: il 15 per cento di Irpef per tutti. Risate in sottofondo e il camerata Gavazza che ancora una volta estrae il foglietto dalla tasca e una matita dall’altra e dice: “E anche questa… cancelliamo”. Ecco, niente male per quelli che erano arrivati per fargliela vedere, ai burocrati di Bruxelles!, e che poi, andati per menare, erano stati menati loro, al grido poco littorio del “Forse che ci lasceremo intimidire?”. Risposta: sì.
 Dei diritti umani non si butta niente. Sacchi di soldi, vacanze da sogno, padri (quello della ex vicepresidente del Parlamento Europeo greca Eva Kaili) che se ne vanno alla chetichella con il trolley pieno di contanti, stati del Golfo che cacciano il grano per avere “buona stampa”, ex sindacalisti come Antonio Panzeri col malloppo in casa. Siccome succede in Belgio, ancora non si è alzato nessuno a gridare alla giustizia a orologeria, ai manettari giustizialisti, eccetera eccetera, esistono posti dove la legge è ancora uguale per tutti. Intanto, si gioca a pallone con l’aria condizionata proprio laggiù, in Qatar. Intanto, si mette su una finta indignazione che si ammorbidisce o si irrigidisce a seconda dei momenti: va a manetta se c’è lo scandalo, però vediamo la partita, però che cattivi, però che bravi… aggiungere a piacere.
Dei diritti umani non si butta niente. Sacchi di soldi, vacanze da sogno, padri (quello della ex vicepresidente del Parlamento Europeo greca Eva Kaili) che se ne vanno alla chetichella con il trolley pieno di contanti, stati del Golfo che cacciano il grano per avere “buona stampa”, ex sindacalisti come Antonio Panzeri col malloppo in casa. Siccome succede in Belgio, ancora non si è alzato nessuno a gridare alla giustizia a orologeria, ai manettari giustizialisti, eccetera eccetera, esistono posti dove la legge è ancora uguale per tutti. Intanto, si gioca a pallone con l’aria condizionata proprio laggiù, in Qatar. Intanto, si mette su una finta indignazione che si ammorbidisce o si irrigidisce a seconda dei momenti: va a manetta se c’è lo scandalo, però vediamo la partita, però che cattivi, però che bravi… aggiungere a piacere.
Dei lavoratori morti a migliaia per costruire gli stadi in Qatar hanno parlato in pochi, e del resto soltanto qualche mese fa un senatore italiano andava in uno degli stati del Golfo, l’Arabia Saudita, a invidiare il locale costo del lavoro (la semi-schiavitù) debitamente retribuito – ma con regolare fattura – per le sue consulenze. Tutto legale, per carità, l’etica si paga a parte.
Il campo dei diritti umani è, insomma, il camposanto della più fervida ipocrisia, della morale elastica, doppia, tripla, quadrupla.
Se si volta pagina, dopo le cronache di quelli che pigliavano soldi per dire bravo al Qatar, troviamo i torturati della nave Humanity 1, arrivata a Bari col suo carico di umani senza diritti, molti torturati, le donne violentate, mutilate, i segni delle sevizie ricevute in Libia. Si sa, si legge, lo dice il telegiornale, così come dice che noi con la Libia abbiamo accordi – chiedere a Minniti – gli regaliamo motovedette con cui questi torturati qui, se li intercettavano, li riportavano indietro per torturarli di nuovo.
Sembra di sognare: c’è un’indignazione quasi di prammatica, obbligatoria (gente che fugge da quelli che persino il papa chiama “lager”), e poi la serena consapevolezza, che noi – noi Italia – quei lager li finanziamo. Una specie di alternanza emotiva: sì, certo, li torturano. Ma anche: sì, certo, i torturatori sono nostri amici, li finanziamo.
Schizofrenia di alta scuola, strabismo prodigioso: ci spiace per le vittime (forse) ma i nostri governi sostengono i carnefici (sicuro).
Ovvia, scontata, sacrosantissima, la solidarietà al popolo iraniano in rivolta, alle donne, prima di tutto, perché si parla di loro e dei loro corpi e dei loro capelli. E su questo c’è una commovente unanimità. Balzano in prima pagina le schifezze del regime, ci si strabilia per la stupefacente punizione all’atleta Elnaz Rekabi, campionessa di climbing “colpevole” di aver gareggiato alle olimpiadi senza velo: il regime le ha raso al suolo la casa, che infamia. Prassi che da decenni usa l’esercito israeliano nei confronti dei palestinesi, anche soltanto sospettati, senza che nessuno meni scandalo per questo, o anche soltanto lo scriva. Sacrilegio. Come si diceva, doppia morale, tripla, quadrupla. Si vede che i diritti umani dipendono anche dalla latitudine.
Tutti siamo a fianco del popolo iraniano in piazza, ma il rapporto annuale di Human Right Monitorsull’Iran dice che le armi che sparano sui manifestanti sono (anche) italiane, precisamente fucili Benelli M2 e M4, e ci sono sospetti anche su cartucce a pallini Cheddite made in Livorno. Chissà, forse con la solidarietà agli iraniani in rivolta si può fare qualcosa di meglio.
 L’iter della legge finanziaria è sempre un toboga gibboso irto di curve, ostacoli, rallentamenti, testacoda e assurdità. Il tema, in definitiva, è quello di cavare sangue dalle rape, trovar soldi dove non ce ne sono, tirare di qua e di là una coperta sempre troppo corta e mettere in atto i ghirigori ideologici di chi tiene il timone. Sempre pronto, tra l’altro, a battersi il petto come un eroe, a dire “non mi importa di essere impopolare!”, che se ci fate caso è la prima cosa che dicono quelli che venderebbero la madre per essere il più popolari possibile. Così, infatti, Giorgia Meloni è andata a parlare agli industriali veneti, assicurando che il governo sta con le imprese, ci mancherebbe, i suoi regali vanno valutati in cinque anni, non nella prima legge di bilancio e che già in quella, comunque, c’è l’assicurazione sulle mani libere dell’impresa. Non verrete ostacolati: andate e sfruttateli tutti. Amen.
L’iter della legge finanziaria è sempre un toboga gibboso irto di curve, ostacoli, rallentamenti, testacoda e assurdità. Il tema, in definitiva, è quello di cavare sangue dalle rape, trovar soldi dove non ce ne sono, tirare di qua e di là una coperta sempre troppo corta e mettere in atto i ghirigori ideologici di chi tiene il timone. Sempre pronto, tra l’altro, a battersi il petto come un eroe, a dire “non mi importa di essere impopolare!”, che se ci fate caso è la prima cosa che dicono quelli che venderebbero la madre per essere il più popolari possibile. Così, infatti, Giorgia Meloni è andata a parlare agli industriali veneti, assicurando che il governo sta con le imprese, ci mancherebbe, i suoi regali vanno valutati in cinque anni, non nella prima legge di bilancio e che già in quella, comunque, c’è l’assicurazione sulle mani libere dell’impresa. Non verrete ostacolati: andate e sfruttateli tutti. Amen.
Resta, come sempre e più di sempre, la sensazione della spremitura delle olive, a volte fino al ridicolo, livello a cui è giunta la famosa “Opzione donna”, cioè la norma che doveva permettere alle donne che lo volessero di andare in pensione un po’ prima. Puoi farlo, ok, ma devi avere un figlio (le non mamme cazzi loro), anzi meglio due, ma non basta. Devi avere un parente infermo e fargli da badante. Oppure (meglio) essere inferma tu, invalida più del 74 per cento. Donne! E’ arrivato l’arrotino! Potete andare in pensione venti minuti prima ma solo con otto figli, una gamba sola e il vecchio padre infermo appeso al collo. I giornali, seriosissimi, titolano trattenendo le risate: “Opzione donna, si riduce la platea”.
Sono gli stessi giornali che fino a due mesi fa ci descrivevano i percettori di reddito di cittadinanza come pascià sul divano, il narghilé in una mano, il telecomando nell’altra, sghignazzanti davanti ai poveri lavoratori madidi di sudore; e che ora scoprono che questi qui, i famosi fancazzisti da divano, non sanno quasi leggere né scrivere, che non sono occupabili, che non si sa cosa fargli fare, né dove, né come. Pazienza.
A proposito di essere più o meno popolari, bisogna in qualche modo ringraziare quel ventre molle del Paese (pardon, Nazione) che ha sostenuto la narrazione tossica dei cattivoni sul divano. Piccoli commercianti, piccoli artigiani, corporazioni pronte alla battaglia, potentati titolari di licenze, insomma tutti quelli che fare un po’ di nero non gli dispiace, ed ecco le norme sul Pos che si alzano e si abbassano come le paratie del Mose. Trenta euro, no, sessanta euro, ma in attesa di sentire cosa dice l’Europa. Insomma, signora mia, si prepara la festa nazionale del “caccia il contante”, con tanto di sghignazzamenti e sberleffi: “Mi volevi dare la carta? Marameo!”. Un paese moderno (pardon, Nazione), non c’è che dire.
Dove vadano poi tutti ‘sti soldi tagliati qui e là, ritagliati con le forbicine da rammendo o rapinati ai poveri, o sottratti al fisco, non è difficile da capire. Un’aliquota fissa al 15 per cento fino a 85.000 euro è un lusso da texani, finanziato coi soldi degli indigenti e dei poveracci. E in più – tradizione delle tradizioni – c’è il munifico regalo alla scuola privata: 70 milioni di euro in più nel 2023, elargiti con gesto elegante. “Ecco, qualche soldo per i chierici, su, su, prendete” dice il ministro, mentre alla cena di corte – che nemmeno si accorge della vergogna – discetta, con la parrucca incipriata, con l’ossequioso Bruno Vespa su come punire i discoli e gli indisciplinati. Ah, signora mia, che tempi!
 Volendo esagerare, tirare un po’ la corda, fantasticare un po’ insieme all’onorevole Domenico Furgiuele (Lega), si può ipotizzare uno scambio di prigionieri: italiani poveri contro bomboniere. Il governo post-fascista che taglia sussidi a chi non ce la fa, e la proposta di finanziare i matrimoni in chiesa – era la prima idea di Furgiuele – locomotivamente fischiata (cit. Marinetti), tanto da allargare subito la profferta di benefit a tutti gli sposalizi italiani, che l’importante è soccorrere il comparto del wedding, signora mia.
Volendo esagerare, tirare un po’ la corda, fantasticare un po’ insieme all’onorevole Domenico Furgiuele (Lega), si può ipotizzare uno scambio di prigionieri: italiani poveri contro bomboniere. Il governo post-fascista che taglia sussidi a chi non ce la fa, e la proposta di finanziare i matrimoni in chiesa – era la prima idea di Furgiuele – locomotivamente fischiata (cit. Marinetti), tanto da allargare subito la profferta di benefit a tutti gli sposalizi italiani, che l’importante è soccorrere il comparto del wedding, signora mia.
Basterebbe questo, per dire delle componenti da operetta e delle priorità dei puffi del governo Meloni, dettagli, spigolature che emergono, chissà quanto involontariamente dalle cronache, a contrastare invece la narrazione ufficiale: una Meloni corrucciata e responsabile, che studia, che pare serissima, china e concentrata sulle carte. Ma sapete com’è, in quei contesti di orgoglio mascelluti, è un attimo che si cade nel Federale con Tognazzi, nella parodia, nel gorgo del ridicolo. Ed ecco infatti il ministro dell’Istruzione (e del merito! ahahah!) buttare subito lì nuove fantasiose repressioni, i lavori “socialmente utili”, da usarsi contro violenti e indisciplinati e anche – maddài! – in occasione delle occupazioni scolastiche. Una cosa che fa scopa con il pasticcio dei rave party: più di cinquanta e fa sei anni di galera, oppure tutti a imbiancare il liceo. Quanto a rifare i tetti dello stesso liceo, che cadono spesso e volentieri in testa agli alunni, il ministro non dice, non fiata, non argomenta, essendo un lavoro socialmente utile che spetterebbe a lui.
E sia, seguiamo le cronache dei nostri eroi. Mentre ministri e sottoministri si arrovellano per cercare nuove soluzioni ad antichi problemi (“i telefonini fuori dalla classe”, i “tutor per affiancare i docenti”, “buca”, “buca con acqua”, eccetera, eccetera), nel cuore del potere meloniano c’è qualche timore nuovo. “L’impatto di cancellare di botto il reddito di cittadinanza è devastante”, dice la ministra del Lavoro, riportata con virgolette qui e là. Tradotto in italiano, significa quel che molti dicono da sempre: che il reddito è un argine, una diga che protegge chi non ce la fa, e toglierlo di botto in un anno di recessione sarebbe come accendere una miccia. Cioè il contrario della vulgata retorica delle destre più estreme ed ottuse, Italia Viva, Lega e Fratelli d’Italia, sempre concentrate a dire cretinate sui divani, i fannulloni e varianti più o meno offensive. Cazzate: di quei 660 mila a cui verrà tolto ossigeno tra qualche mese, pochissimi potranno trovare un lavoro. Bassa scolarità, nessuna formazione, soggetti deboli: cancellare il reddito significa consegnarli alla disperazione o alla manovalanza della criminalità, oppure, nel migliore dei casi (speriamo) al conflitto sociale.
Dopo aver sbraitato per anni, ora se ne accorgono pure al Consiglio dei Ministri, ma è tardi per tornare indietro, quindi niente, pochi mesi e poi smantellamento dell’unica legge che abbia aiutato, negli ultimi anni, le fasce più disagiate della società.
La legge finanziaria – la stessa che ci dice che un professionista da 85.000 euro l’anno pagherà le tasse di un dipendente che ne prende 30.000 – è dunque una netta e precisa (in qualche caso rivendicata) ricerca dello scontro. Davanti al timore di ampi disagi sociali si scelgono deliberatamente il conflitto e la contrapposizione, le mani sui fianchi e la mascella volitiva: la dichiarazione di guerra è stata consegnata nelle mani dei poveri.
 Chissà com’è la vera carta intestata di Matteo Salvini. Sì, è possibile che ci sia scritto “Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici”, ma poi c’è dell’altro. “Ministero dell’interno in pectore, ma purtroppo ho dovuto metterci una controfigura”, per esempio. E anche “Ministero dell’Economia che però, mannaggia, lo fa Giorgetti”. Insomma, Matteo Salvini fa il ministro di quello che gli pare a seconda di come si sveglia la mattina. Un giorno di alza e fa incazzare Macron, un altro abolisce a parole il canone Rai, un altro ancora ridisegna il sistema pensionistico con la sola imposizione delle mani ancora unte di maionese. Va bene, dicono che nei sondaggi questo iperattivismo paghi, e gli facciamo molti auguri. Tanto più che non si sentiva da parecchio tempo – forse da mai – che una delle condizioni geopolitiche fondamentali per impedire a due paesi confinanti di prendersi a schiaffoni (Italia e Francia) sia far tacere Salvini. Insomma, Mattarella telefona, Marcron risponde, le diplomazie facciano il loro corso, ma soprattutto – s’il vous plaît – fate tacere il mangiatore di salami col rosario, che ad ogni esternazione rischia di scatenare il putiferio.
Chissà com’è la vera carta intestata di Matteo Salvini. Sì, è possibile che ci sia scritto “Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici”, ma poi c’è dell’altro. “Ministero dell’interno in pectore, ma purtroppo ho dovuto metterci una controfigura”, per esempio. E anche “Ministero dell’Economia che però, mannaggia, lo fa Giorgetti”. Insomma, Matteo Salvini fa il ministro di quello che gli pare a seconda di come si sveglia la mattina. Un giorno di alza e fa incazzare Macron, un altro abolisce a parole il canone Rai, un altro ancora ridisegna il sistema pensionistico con la sola imposizione delle mani ancora unte di maionese. Va bene, dicono che nei sondaggi questo iperattivismo paghi, e gli facciamo molti auguri. Tanto più che non si sentiva da parecchio tempo – forse da mai – che una delle condizioni geopolitiche fondamentali per impedire a due paesi confinanti di prendersi a schiaffoni (Italia e Francia) sia far tacere Salvini. Insomma, Mattarella telefona, Marcron risponde, le diplomazie facciano il loro corso, ma soprattutto – s’il vous plaît – fate tacere il mangiatore di salami col rosario, che ad ogni esternazione rischia di scatenare il putiferio.
Tutte le cronache della signora presidenta del Consiglio Giorgia Meloni in trasferta a Bali parlano di quello: di come far tacere Salvini per non irritare i francesi e il mondo intero. E già questo dettaglio fornisce una divertente lettura della diplomazia italiana, che può anche essere (mah, chissà) un consesso di astutissime feluche, ma poi basta un rutto dal leader leghista-formaggista per rovinare tutto.
Non vorrei però che il Salvini selvatico diventasse un po’ una specie di capro espiatorio. Cioè, ormai sappiamo chi è, ne conosciamo le intemperanze, la tentazione di attribuire a lui ogni sbandamento, ogni estremismo nella gestione dei flussi migratori è forte, eppure fanno la loro parte anche gli altri estremisti del governo. Sembrerebbero seri e responsabili – un travestimento – finché, come accaduto al ministro della Difesa Crosetto, gli parte un colpo. Ecco quindi le OnG “ideologiche”, che sono “Centri sociali del mare”. Insomma, è Salvini che traccia il solco, ma poi è il governo che lo difende (scusate la rozza metafora, ma magari così capiscono anche loro).
E dunque, conclamata l’incapacità di gestire la questione migranti secondo regole, leggi e trattati internazionali, ecco la falange governativa, pancia in dentro, petto in fuori, prendersela con le OnG, esattamente come aveva fatto Salvini. Si agisce su più fronti, ovviamente, e si medita di tagliare fuori dalla questione le Procure della Repubblica per incoronare i prefetti. Niente più magistrati in mezzo alle palle – traduco – e più poliziotti a sequestrare navi e navigli.
Chi negli ultimi anni non viveva su Saturno. riconoscerà il tocco, la mano, lo stile inconfondibile della peggior destra europea. Viktor Orban partì da lì con la sua escalation, da una guerra serrata contro le Ong, da leggi (contestate dalla Ue) che ne limitano l’azione, criminalizzazioni e servizi segreti. E anche in Polonia, molto del lavoro oscurantista partì dall’attacco alle associazioni e alle organizzazioni indipendenti, specie quelle sui diritti delle donne. Insomma, viene il sospetto che dare tutte le colpe a Salvini sia un giochetto di società facile facile, e mentre tutti sono distratti dal mangiasalami intemperante, gli arditi fanno il loro sporco lavoro per non avere testimoni, né operatori indipendenti, né ostacoli al massacro nel Mediterraneo.
 Finalmente scrivere da Milano non è periferia, finalmente non siamo ai margini dell’Impero, quassù sulle palafitte, dove la cosa più bella “è il treno per Roma”, e altre amenità e sciocchezze.
Finalmente scrivere da Milano non è periferia, finalmente non siamo ai margini dell’Impero, quassù sulle palafitte, dove la cosa più bella “è il treno per Roma”, e altre amenità e sciocchezze.
Finalmente anche qui si freme, si registrano languori preorgasmici delle sciurette in total Prada – uh, le scalmane! – e i brividi di eccitazione dei maschi alfa da consiglio di amministrazione, quelli trascinati alla Scala una volta l’anno perché si deve, perché si fa. Scala dove – manco a dirlo – lei svettava in total black Armani (cito i classici).
Ma come lei chi? Lei Moratti Letizia, che provenendo da un casato Bricchetto Arnaboldi (guai a voi se ci aggiungete Serbelloni-Mazzanti-Viendalmare, stronzi!) dà quelle garanzie di schietta aristocrazia di cui tutti abbiamo bisogno, in primis la società lombarda il cui problemi, si sa, sono i salotti innoiositi e le false borse Vuitton. Lei. Una che sa usare il coltello da pesce, sa come si mettono i bicchieri, come ci si siede alle riunioni di bilancio, una che possiede quel pragmatismo acuminato, che sarebbe una specie di realismo magico dei dané; una che voleva far vaccinare la gente in base al Pil – prima i lombardi che ci mantengono tutti! – e che si prestava al post-Gallera, ultimo comico della tradizione milanese, come badante del presidente Fontana.
Insomma, a un certo punto, a quella Milano dipinta a olio, quella dei salottini dove ancora si gioca la pantomima del potere – i dané, la finanza, la fabbrichetta, che oggi è la start-up del figliuolo, di ville! di villule! di villoni ripieni, di villette isolate… Gadda dove sei? – ecco, in quella Milano lì, dove la rendita si spaccia per merito, è comparsa la Madonna rivelata, la sciura delle sciure. Nostra signora dei salotti ma anche della finanza, una specie di icona benedetta, ultrasettantenne, ma ancora giovanile, piacente, dinamica; insomma a misura di come le sciurette del circuito via Spiga-Montenapo-Sant’Andrea vorrebbero essere, povere stelle.
Perché si parla un po’ troppo di politica, nell’affaire Moratti, candidata alla Presidenza della Lombardia dai Bibì e Bibò forestieri (uno toscano, l’altro di Roma, figurarsi), la cui finalità è far vincere il leghista Fontana dando la colpa al Pd che non ha seguito “la visione”.
Macchè, quello è il contorno, e il piatto forte della questione è invece social-antropologico, dove una città in cui i ricchi sono asserragliati in due-tre quartieri, con le loro tessitrici di elogi, maestre di eleganza e di “costume” (il costume dei signori), e fremono di giubilo e tripudio potendo finalmente dire di essere un po’ di destra anche loro. Ma non la destra burina dei leghisti di provincia (quel Fontana, un varesotto, ossignùr, quelli delle valli, buoni solo se ti portano il taleggio fresco). E nemmeno di quei destri parvenu, fasci ripuliti che in un salotto, sotto un Sironi, sotto un Balla ben appeso alla tappezzeria buona non ci saprebbero stare, volgari come un centrotavola della Santanché, signora mia.
Insomma Lady Letizia è la quadratura del cerchio: consente alla borghesia-wannabe-aristocrazia milanese di fingere di restare “progressista” pur votando – finalmente! – a destra. E’ lei che fa il favore di slittare un po’ a gauche, come quando si aggiunge un ospite e le nobildonne – aiutate dalla servitù – spostano un po’ le sedie per fargli spazio.
Grazie, Letizia di fornire questo brivido prenatalizio alla nomenklatura del panetùn, anche questa è un’opera caritatevole che la sinistra – coi suoi pregiudizi, cattiva – non ti perdonerà.
 Il pendolo di Giorgia, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, un sorrisino per i poteri forti, rassicurante, da statista; un ghigno per il mercato interno, quando si ricorda di avere un elettorato (e un percorso personale) un po’ littorio. Legge e ordine – per non farsi fregare da Salvini, dicono alcuni – ma anche per mantenere le tradizioni, mossa identitaria: chi ci guida e ci conduce?
Il pendolo di Giorgia, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, un sorrisino per i poteri forti, rassicurante, da statista; un ghigno per il mercato interno, quando si ricorda di avere un elettorato (e un percorso personale) un po’ littorio. Legge e ordine – per non farsi fregare da Salvini, dicono alcuni – ma anche per mantenere le tradizioni, mossa identitaria: chi ci guida e ci conduce?
Lei che sa mentire così bene: “Le leggi razziali gradino più basso…”, eccetera eccetera, molto compunta e contrita, ma tutta una vita a celebrare Giorgio Almirante, segretario di redazione de La difesa della razza, bel curriculum. Lui (1942): “Il razzismo nostro deve essere quello del sangue (…) Altrimenti finiremo per fare il gioco dei meticci e degli ebrei”.
Lei (2020): “Onestà, coerenza e coraggio sono valori che ci ha trasmesso (…) Un grande uomo che non dimenticheremo mai”.
Basterebbe questo, ma si vede che non basta.
Grande fu lo sconcerto, il rigurgito nazionalista e il brividino sciovinista che prese il Paese (pardon, la Nazione) quando la ministra francese per gli affari europei Laurence Boone disse “Vigileremo sull’Italia”. Uh! Apriti cielo: il/la presidente Meloni tuonò contro l’ingerenza straniera, Sergio Mattarella disse che “L’Italia sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”, bene! E ora che vediamo le foto di un viceministro (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia) vestito da nazista, con la svastica al braccio e il sorriso tutt’altro che intelligente, è lecito il dubbio: mah, “Badare a se stessa”, parole grosse. Facciamo a fidarci, era un addio al celibato. Chi di voi non si è mai vestito da ufficiale delle SS durante l’addio al celibato? A me pare un’aggravante.
Il pendolo di Giorgia ora vira verso l’Europa. Vedrà Ursula Von Der Leyen per perorare la causa del cambio di destinazione di un po’ di soldi del mitologico Pnrr, che li possiamo usare – noialtri che sappiamo badare a noi stessi – per pagarci un po’ di gas. Pare già di vedere le cronache: l’autorevole leader che, pancia in dentro, petto in fuori, va a far valere gli interessi nazionali. Questo agli esteri. Agli interni, intanto, da tre a sei anni per il reato di rave party, poco meno di quello che si rischia per il reato di banda armata. “Invasione compiuta da più di 50 persone di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, il che vuol dire che si parte da un capannone di Modena – dove nessuno limitava la libertà di nessuno – per arrivare potenzialmente ovunque, all’occupazione della scuola, o della fabbrica, o a qualunque “adunata” di protesta che preveda l’occupazione “di terreni”: cioè basterà essere per la strada.
Legge e ordine, specificamente indirizzate verso che si radunerà per protesta, una norma che verrà buona quando l’inflazione a due cifre morderà di brutto, i salari saranno fermi, gli aiuti al reddito verranno cancellati. Insomma, quando il/la presidente del Consiglio si vedrà un po’ alle strette, accorgendosi che i milioni di poveri italiani non sono tutti “fannulloni che vogliono stare sul divano”, ma gente che potrebbe anche incazzarsi. E allora il pendolo di Giorgia si apprezzerà meglio, le parole magiche “da tre a sei anni” avranno un altro suono. Lo stesso suono dei manganelli già risuonati sugli studenti della Sapienza, ma non sulle capocce dei nazi-ultras di San Siro – lo stadio – o degli adoratori del Puzzone Buonanima di Predappio. Perché lì “E’ tradizione”, dice il ministro competente
 Rimbalza come d’abitudine nel flipper del nuovo governo – tra lingue mulinanti di apprezzamenti, piaggerie da mantenimento del posto, riposizionamenti studiati da mesi – la pallina solita del “non siamo ideologici”, sbandierata qui e là da questo o quel membro del nuovo esecutivo. Ultimo a pronunciarla in un’intervista (“non abbiamo mai avuto preclusioni ideologiche”), il ministro cognato dell’agricoltura (e sovranità alimentare! Wow!) Francesco Lollobrigida, che lo dice a proposito della consulenza di Roberto Cingolani. Ministro prima, consulente oggi, un uomo per tutte le stagioni: non si capisce quale preclusione ideologica si possa avere con uno che si adatta così facilmente.
Rimbalza come d’abitudine nel flipper del nuovo governo – tra lingue mulinanti di apprezzamenti, piaggerie da mantenimento del posto, riposizionamenti studiati da mesi – la pallina solita del “non siamo ideologici”, sbandierata qui e là da questo o quel membro del nuovo esecutivo. Ultimo a pronunciarla in un’intervista (“non abbiamo mai avuto preclusioni ideologiche”), il ministro cognato dell’agricoltura (e sovranità alimentare! Wow!) Francesco Lollobrigida, che lo dice a proposito della consulenza di Roberto Cingolani. Ministro prima, consulente oggi, un uomo per tutte le stagioni: non si capisce quale preclusione ideologica si possa avere con uno che si adatta così facilmente.
Ma sia: quella dell’allontanare da sé i sospetti è una preoccupazione molto in voga e la presidente del Consiglio ci sta molto attenta, non vuole passare per figlia della lupa, così come alcuni dei suoi giannizzeri indossano la maschera dei moderati, ragionevoli, neo-atlantisti, pacati, guarda che bravi. Magari giocando facile nel ridurre a macchietta i piccoli reducismi balilla di un La Russa e camerati: folklore, collezionismo, uffa che barba, mentre loro pensano al bene della Nazione.
Ed eccola lì. L’ideologia cacciata dalla porta a parole, rientra dalla finestra proprio con le parole. E’ un profluvio di “Nazione”, che sostituisce “Paese” (brutto, di sinistra), così come “patrioti” ha sostituito l’impresentabile “camerati”. Camouflage. Mimetismo.
Il cambio di nome di alcuni ministeri, di cui si è molto parlato, denuncia – sempre le parole, maledette! – una densa sostanza ideologica, proprio quella che si vuol negare. Si è detto della natalità, della sovranità alimentare, del ministero del mare (a cui manca colpevolmente “Nostrum”, ma serviva per fregare a Salvini i porti, cosa che non sembra riuscita, per ora). E potentemente si infila – ideologia canaglia – nella carta intestata del nuovo ministero dell’Istruzione, che diventa anche “del merito”, quel glorioso trucchetto delle classi dominanti e dei nati meritati per difendere all’infinito privilegi e diseguaglianze. Esattamente – in barba a tutti i “non saremo ideologici” di questo mondo – un manifesto ideologico di classismo (infatti piace tanto a Calenda). Anche il ministero “delle imprese e del made in Italy” gronda ideologia già nell’enunciato, e manifesta che l’economia del Paese (pardon, Nazione) sono le imprese. Non i lavoratori, le forze produttive, l’insieme di, no, le imprese. Bon. E quel che fa bene alle imprese fa bene alla Nazione, antico refrain oggi benedetto anche dal nome.
Ma se siete in cerca di ideologie a casa di quelli che “non saremo ideologici” (ahah), la lezione migliore viene da Guido Crosetto, tradizionalmente presentato come “moderato”, vezzeggiato e corteggiato dai media, dietro la cui maschera di buono si nasconde il vero tratto ideologico della destra vincente. Ed è un tratto minaccioso assai: Crosetto ammette che “C’è un rischio fortissimo di povertà e disoccupazione. Dunque, di rabbia…”. Ma poi, ecco la sostanza ideologica: “La rabbia cerca sempre colpevoli e le piazze arrabbiate non fanno male ai governi. Ma alle nazioni”. Et voilà, esplicitato per bene per chi ancora non lo vedesse: la piazza, la rabbia, la mobilitazione (eterodiretta, magari da Putin, lascia intendere Crosetto) non è antigovernativa, ma antinazionale. Governo e Stato, governo e Nazione, di fronte a un’eventuale opposizione di piazza, coincidono. La summa, spiegata bene, dell’ideologia sovranista, nazionalista (e un po’ fascista) che si tenta di negare a parole.
 Brutta roba, i numeri. Dovrebbero spiegare, e invece rendono tutto freddo, algido, tecnico, tutto algebricamente smerigliato. Così dal rapporto Caritas pubblicato ieri da tutta la stampa nazionale – dopo lo sfoglio sul totoministri, Silvio a Canossa, Giorgia statista e altre amenità per chi ci casca – non è facile estrarre il succo di vite in bilico, di paure per domani che mordono già oggi, di umiliazione per le code, dell’indecenza dell’indigenza nazionale.
Brutta roba, i numeri. Dovrebbero spiegare, e invece rendono tutto freddo, algido, tecnico, tutto algebricamente smerigliato. Così dal rapporto Caritas pubblicato ieri da tutta la stampa nazionale – dopo lo sfoglio sul totoministri, Silvio a Canossa, Giorgia statista e altre amenità per chi ci casca – non è facile estrarre il succo di vite in bilico, di paure per domani che mordono già oggi, di umiliazione per le code, dell’indecenza dell’indigenza nazionale.
Non so se è il caso di ripetere qui lo stillicidio: 5,6 milioni di poveri assoluti, altri 15 milioni a rischio di diventarlo, sul crinale, un piede di qua, un piede di là, un italiano su quattro, impaurito se va bene, praticamente sicuro che domani sarà peggio di oggi, che già è una discreta merda.
Niente retorica, per carità, non serve, non aiuta. Ma in queste settimane di passaggio, in cui esperti e osservatori ci spiegano le dinamiche del voto, le scelte del Paese (pardon… ora bisogna dire Nazione, secondo la riforma semantica dei camerati… ops, patrioti), sarebbe forse il caso di chiedersi da dove vengono questi numeri freddi, la genesi, il percorso, che strada hanno fatto questi fottuti poveri per triplicare in quindici anni. Erano – sempre fonte Istat – un milione e ottocentomila quindici anni fa, e oggi sono 5,6 milioni, il che vuol dire che sono cresciuti di tre volte, che dove ce n’era uno ora ce ne sono tre. Quindici anni, non una vita, ma un tempo abbastanza lungo per capire chi, come, perché, per valutare politiche e strategie. Quindici anni fa, regnava un Silvio vorace, non il fantasma gaffeur di oggi, che ci portava in quel baratro di spread che fece tremare tutti. E per “salvarci” – cominciava il carosello dei Salvatori – arrivava Monti, e poi altri governi di emergenza e decoro economico, tutti o quasi a massiccia presenza progressista e democratica, che sciccheria.
La cavalleria leggera (leggerissima) del “Siamo tutti sulla stessa barca”, aiutiamoci, facciamo qualche sacrificio. E piovevano soldi sulle aziende, sui datori di lavoro, decontribuzioni, e insieme contratti leggeri, corti, cortissimi. Il pensiero debole (debolissimo) che se aiuti chi produce – le aziende, gli imprenditori – andrà poi bene anche a chi lavora, in una cascatella di redistribuzione che dalle tavole imbandite lascia cadere qualche briciola. Ora si vede che non era vero: c’è povertà assoluta nel 7 per cento delle famiglie con occupati, cioè tra quelli che un lavoro che l’hanno. Ed è più del doppio rispetto al 2011 (erano il 3,1), quando arrivava Mario Monti con il loden, accolto come Mosé con le tavole, che ci salvava lui, ci pensava lui, meno male che c’è lui… e tutti gli altri salvatori in fila, fino a Mario Draghi, altro Salvatore da cosa non si sa. Non si capisce che salvezza, infatti, se anche tra chi lavora la povertà è raddoppiata.
E tutti, in questi quindici anni di arretramento e di impoverimento, con il chiodo fisso e il nemico comune, perennemente additato: niente conflitto, niente battaglia, niente casino, non sporcare, non urlare, non baccagliare per il reddito, o per i diritti. Zitti e buoni, che sennò i mercati… che sennò l’Europa… e alla fine il bilancio di quindici anni di politiche “virtuose”, senza conflitto, senza lotta, è che a milioni non mettono insieme il pranzo con la cena, il triplo di prima. Un po’ di lotte, forse servivano, un po’ di conflitto, forse, li avrebbe difesi meglio, ‘sti poveri moltiplicati per tre in quindici anni, mentre invece si beccano solo l’eterno “colpa loro”.
 Il 17 ottobre 2022, al Teatro Parenti di Milano, per iniziativa di qualche amico, compagno di strada, lettore, fans, le figlie, e altri complici, ma
Il 17 ottobre 2022, al Teatro Parenti di Milano, per iniziativa di qualche amico, compagno di strada, lettore, fans, le figlie, e altri complici, ma soprattutto con la tigna di Giorgio Terruzzi e Paolo Maggioni, si è ricordato Beppe Viola a 40 anni dalla morte. Metto qui il mio intervento di quella serata.
soprattutto con la tigna di Giorgio Terruzzi e Paolo Maggioni, si è ricordato Beppe Viola a 40 anni dalla morte. Metto qui il mio intervento di quella serata.
Ciao.
Non mi piacciono quelle cose “Io c’ero-io c’ero-io c’ero”.
Soprattutto perché io non c’ero.
Io avevo un anno, sul confine Villapizzone-Bovisa, quando Beppe Viola entrava alla Rai rispondendo “No” alla domanda “Lei è comunista?”.
E poi ne avevo 22 quando incautamente mi davano una tessera da giornalista professionista, e lui moriva proprio quell’anno lì.
Non mi piacciono neanche quelle cose è vivo è vivo, è qui con noi.
Mi viene in mente il mio papà che un po’ incredulo al funerale di un famoso mi disse: “Ghe baten i man perché l’è mort?”
Non è vero che è qui con noi… siamo noi che siamo qui con noi.
E siamo qui con noi perché gli volevamo bene.
Chi lo ha conosciuto, vabbé, per forza.
E chi lo ha conosciuto dopo, leggendo, perché ha imparato qualcosa.
Quindi qui faccio l’elenco di quello che ho imparato dal Beppe Viola.
Che le parole c’hanno un senso loro, come il pallone per Trapattoni, che sembra rotondo, ma delle volte c’è dentro un coniglio.
E che ridere non vuol mica dire essere scemi, anzi serve a capire chi sono quelli scemi che non ridono.
E che essere leggeri non è il contrario di essere pesanti, ma è il rovescio di essere dei pirla che si credono stocazzo.
Ma poi, dopo, quando il mio mestiere è diventato suo malgrado quella cosa che chiamano carriera, non lo so perché, forse è una roba di ore di volo… Dopo, dico, la vicinanza al Beppe Viola è diventata un’altra cosa, una gloriosa specializzazione nell’accumularsi delle rogne.
Perché nella mia immaginazione, il Beppe era anche quello che capitava a me, che bisogna andare in redazione.
Ma anche consegnare la rubrica…
o finire la canzone,
magari sei lì che devi chiudere il pezzo e ti viene un’idea più bella,
oppure un’ora da spendere meglio,un dialogo da ridere,
 poi c’è una roba che hai letto che ti torna su, come i peperoni, dai, cazzo, rileggila..
poi c’è una roba che hai letto che ti torna su, come i peperoni, dai, cazzo, rileggila..
o un amico che ha bisogno…
E resti indietro con le cose
…e allora ne inizi altre due, poi ti capita anche di finirne qualcuna e viene bene, o male, o così così
… e dai che ne scrivo un’altra…
Una cosa che ho imparato da Beppe Viola, una delle…
Non è che c’è la vita. e poi c’è quella roba lì,
è che c’è la vita CHE E’ quella roba lì.
E questo per me, da quarant’anni di lui ce non c’è più, e di mestiere mio che c’è – guarda le coincidenze – è una vicinanza da amici e fratelli.
Che lavoro fai?
Boh !
Poi, siccome anche un po’da balordi, ma i compiti bisogna farli, mi son messo a cercare una roba di Beppe che c’avevo in testa da sempre, così in testa che ho anche smesso di cercarla, perché la so a memoria e dice così:
C’ho via una gamba da quando ho fermato il tram in viale Porpora.
Il pallone però l’ho salvato anche se adesso non mi serve.
Ecco, sembrano due righe perché in effetti sono due righe.
E in due righe c’è dentro tutto, il ridere, il piangere, il tram in viale Porpora che non è l’Abu Dhabi di vetro di chi ce l’ha più alto, ridateci le Varesine, bastardi.
Sono due righe di verità vera, perché col cazzo che va tutto bene, ma noi ridiamo lo stesso.
Che è come tirare i sassi.
 Se non fosse largamente prevedibile, già visto, già sentito, già millemila volte esplorato, il dibattito sull’essere più o meno pacifisti o più o meno bellicisti, sul fatto che l’unica cosa da dire quando si spara è “smettetela di sparare”, sarebbe certamente utile e fecondo. Temo che non sia così nemmeno questa volta e quindi, come dire, esco con le mani alzate, anche per esperienza personale. Ho abbastanza primavere sul groppone per essermi preso dell’”amico di Saddam” quando dicevo che si stavano massacrando civili a Baghdad con la scusa delle armi di distruzione di massa. Applaudito da moltissimi – dagli stessi che oggi pontificano contro ogni iniziativa pacifista o richiesta di trattativa – Colin Powell agitava all’Onu la sua bustina di finto-antrace, e Tony Blair confessava di aver trovato le prove contro Saddam “su Internet”. Pagliacci. Sia loro che quelli che gli gridavano “bravo-bravo”, gli atlantisti al fulmicotone che stanno ancora in giro e ancora oggi si spellano le mani. Mentre io, piccolo insignificante democratico italiano, venivo etichettato come “Ah, allora stai con Saddam! Vuoi gasare i curdi con le armi chimiche!”, detto da chi ora i curdi aiuta a venderli a Erdogan in cambio di biglietti di ingresso nella Nato.
Se non fosse largamente prevedibile, già visto, già sentito, già millemila volte esplorato, il dibattito sull’essere più o meno pacifisti o più o meno bellicisti, sul fatto che l’unica cosa da dire quando si spara è “smettetela di sparare”, sarebbe certamente utile e fecondo. Temo che non sia così nemmeno questa volta e quindi, come dire, esco con le mani alzate, anche per esperienza personale. Ho abbastanza primavere sul groppone per essermi preso dell’”amico di Saddam” quando dicevo che si stavano massacrando civili a Baghdad con la scusa delle armi di distruzione di massa. Applaudito da moltissimi – dagli stessi che oggi pontificano contro ogni iniziativa pacifista o richiesta di trattativa – Colin Powell agitava all’Onu la sua bustina di finto-antrace, e Tony Blair confessava di aver trovato le prove contro Saddam “su Internet”. Pagliacci. Sia loro che quelli che gli gridavano “bravo-bravo”, gli atlantisti al fulmicotone che stanno ancora in giro e ancora oggi si spellano le mani. Mentre io, piccolo insignificante democratico italiano, venivo etichettato come “Ah, allora stai con Saddam! Vuoi gasare i curdi con le armi chimiche!”, detto da chi ora i curdi aiuta a venderli a Erdogan in cambio di biglietti di ingresso nella Nato.
Insomma, come si vede non ho gran fiducia, non tanto nel dibattito, ma nella sua pulizia, nell’assenza di scorie. Contiene merda e malafede, come tutto ciò che viene dalla guerra, contiene coscienze embedded e cervelli all’ammasso.
E naturalmente non mi sono fatto mancare niente, compreso “sei amico dei talebani”, detto sia vent’anni fa – quando, guarda un po’, ero contrario alla più stupida e sanguinosa guerra mai vista, quella in Afghanistan – e ancora detto e ripetuto l’anno scorso. La grottesca e precipitosa fuga di chi aveva portato morte e distruzione per vent’anni chiamandola “missione umanitaria”, lasciava il popolo afghano nella più nera disperazione, ma se provavi a dire “complimenti, bella figura, gli esportatori di democrazia!”, eccoti di nuovo “amico dei talebani”, incredibile. Il tutto mentre occhiuti commentatori, corsivisti più che abili, guru iperatlantisti in servizio permanente effettivo, applaudivano la “ritirata umanitaria” allo stesso modo in cui avevano applaudito l’”invasione umanitaria” vent’anni prima. Complici e cantori di un massacro spaventoso, ma pronti allo sport sempre ben remunerato del “dagli al pacifista!”. Senza vergogna.
E ora, eccoli, sempre loro – chi più, chi meno, ma insomma – a dire che se chiedi che si smetta di sparare in Ucraina, che si smetta di foraggiare massicciamente un’escalation militare che potrebbe far male e malissimo a tutti, ecco, allora “stai con Putin”. La logica binaria di chi la guerra la ama profondamente. Dimenticando che mentre io, “amico di Saddam”, ai tempi, con Saddam regnante, in Iraq sarei stato di certo in galera, loro no. Avrebbero fatto da coretto al regime, finché vincente. E che coi talebani anche, io che ero “amico dei talebani” non me la sarei passata bene di certo. E che anche con Putin, sotto Putin, nell’impero di Putin, starei tra i dissidenti, mentre loro, questi nemici del “pacifista”, questi che dicono che chiedere la pace è “cedere”, è da “rammolliti”, sarebbero probabilmente a fare quel che fanno qui: i cantori del consenso alla guerra, serviti e riveriti. Quindi capirete – e mi scuso – il dibattito non mi entusiasma: chi insulta i pacifisti oggi sono gli stessi che li insultavano ieri. Non conta quale guerra, conta proprio che gli piace la guerra.
 Ci piacciono tanto le rivolte degli altri, le sommosse, le proteste, le primavere qui e là per il mondo, purché avvengano – appunto – da un’altra parte, un po’ esotiche, insomma. Ci piacciono meno – molto meno – le rivolte che avvengono qua, che sono sempre raccontate sottotono, sminuite, ridotte a piccoli episodi semi-folkloristici, trovatine mediatiche. Così anche i cortei e le manifestazioni in cui in parecchie piazze italiane si sono simbolicamente bruciate le bollette del gas e della luce, giunte a livelli insostenibili per molte famiglie, sono archiviate con piccole fotonotizie. Uff, i soliti estremisti.
Ci piacciono tanto le rivolte degli altri, le sommosse, le proteste, le primavere qui e là per il mondo, purché avvengano – appunto – da un’altra parte, un po’ esotiche, insomma. Ci piacciono meno – molto meno – le rivolte che avvengono qua, che sono sempre raccontate sottotono, sminuite, ridotte a piccoli episodi semi-folkloristici, trovatine mediatiche. Così anche i cortei e le manifestazioni in cui in parecchie piazze italiane si sono simbolicamente bruciate le bollette del gas e della luce, giunte a livelli insostenibili per molte famiglie, sono archiviate con piccole fotonotizie. Uff, i soliti estremisti.
Eppure la simbologia è abbastanza potente, e non si tratta di esagerazioni, visto che anche i grandi giornali, la stampa ufficiale, comincia a dar consigli su come fare se ti staccano il gas, come farselo riallacciare, come chiedere rateazioni, come gestire i ritardi nei pagamenti, eccetera eccetera. Insomma, la questione energetica ha avuto una sua istruttiva parabola. Prima un trattamento soltanto geopolitico for dummies (Putin bastardo, non ti compriamo più il gas, prima; Putin bastardo non ce lo manda più, dopo), poi una più seria riflessione economica su stoccaggi e prezzi di mercato accompagnata dai consigli della nonna. Vedrete che con un grado in meno si risolve… vedrete che mettendo il coperchio alla pentola si risolve… vedrete che con le docce più brevi… Fuffa, insomma.
Poi, piano piano, ecco che dalle nebbie dell’informazione – un po’ divisa tra l’allarme e l’opera di tranquillizzazione – è emerso qualcosa di simile alla verità: il prezzo del gas che tanti danni fa e farà alle nostre economie, alle nostre aziende, e Pil, e famiglie, non è per niente colpa di questo o quel dittatore, o di questa o quella guerra. Non c’è poco gas nel mondo (lo dice, tra gli altri, un rapporto Eni del luglio scorso), ma c’è – e parecchia – speculazione sul suo mercato. Al punto che il cruccio di mezza Europa, tra cui il ministro Cingolani, e il magico Mario Draghi, e di vari pensatori dell’economia globale, è proprio come fermare, o arginare, questa speculazione che gira intorno (ma non solo) alla famigerata Borsa olandese il Title Transfer Facility (TTF) dove si scambiano i futuressul gas e dove si decidono, in definitiva, le nostre bollette.
Traduco in italiano: si chiama libero mercato, cioè libertà di speculazione, di fissare un prezzo non in base all’effettiva disponibilità della merce, ma alle previsioni – più o meno interessate, più o meno sballate – che si fanno sulla disponibilità futura di quella merce. Fu un trattato europeo (Cardiff, 1996), a decidere che i prezzi delle materie prime del settore energetico non sarebbero più stati regolamentati: ci avrebbe pensato il mercato, la libera concorrenza, insomma, quella magica manina che sistema tutto lei, come piace pensare ai liberisti di ogni latitudine. Al punto che oggi (ieri sul Corriere della Sera) leggiamo accorati appelli di due commissari europei (Breton e Gentiloni) perché l’Europa faccia un debito condiviso in difesa di “beni pubblici”. Beni pubblici, che, appunto, pubblici non sono per niente, visto che si gonfiano e si sgonfiano a piacere e beneficio di “speculatori” che rimangono – tra l’altro – impuniti e sconosciuti. L’emergenza è emergenza da mesi, la speculazione è additata da mesi come responsabile, ma la soluzione non c’è, non si trova, nemmeno al più alto livello politico. Se si trovasse, confliggerebbe con il famoso “libero mercato”, libera volpe in libero pollaio.
 Insomma eccoci. “Todos populistas”, come dice Calenda Carlo, del Sesto Polo, battuto anche dal Berlusconi ceramicato di Tik Tok, ma sempre avvolto, lui che è sèrio, dal cappottino di saliva dei media. Si è letto di tutto, e ancora si leggerà, ma insomma, di colpo l’agenda Draghi è diventata di piombo, ed è caduta sui piedi di chi la sventolava come un feticcio, ferendolo a morte. Chi l’ha sempre combattuta dall’opposizione (Meloni) ha vinto in carrozza, si sapeva; chi se ne è dissociato chiedendo correzioni e revisioni (Conte) ha fatto una discreta rimonta (dal 7-8 per cento di luglio al 15). Gli altri nisba, compresi i due noti caratteristi che candidavano “Supermario” a Palazzo Chigi senza dirglielo e contro la sua volontà.
Insomma eccoci. “Todos populistas”, come dice Calenda Carlo, del Sesto Polo, battuto anche dal Berlusconi ceramicato di Tik Tok, ma sempre avvolto, lui che è sèrio, dal cappottino di saliva dei media. Si è letto di tutto, e ancora si leggerà, ma insomma, di colpo l’agenda Draghi è diventata di piombo, ed è caduta sui piedi di chi la sventolava come un feticcio, ferendolo a morte. Chi l’ha sempre combattuta dall’opposizione (Meloni) ha vinto in carrozza, si sapeva; chi se ne è dissociato chiedendo correzioni e revisioni (Conte) ha fatto una discreta rimonta (dal 7-8 per cento di luglio al 15). Gli altri nisba, compresi i due noti caratteristi che candidavano “Supermario” a Palazzo Chigi senza dirglielo e contro la sua volontà.
Ci sarà tempo di parlare di politica, anzi speriamo che si ricominci a farlo. Ci si chiede però – in questa rubrichina su narratori & narrazioni – se non sia ragionevole anche occuparsi un po’ del sistema della comunicazione, che per quasi due anni ci ha presentato Mario Draghi come un tabù intoccabile, qualcosa tipo Maradona+Gesù Cristo+Einstein, che chi si permetteva di contrastare, o anche solo di arginare o criticare, veniva colto da anatema e malocchio. Come osi? Come ti permetti? Sei stato a Princeton, tu? Sei stato ad Harvard? E ancora conservo con gioia un meraviglioso ritaglio d’agenzia (Adnkronos, luglio 2022), con il senzatetto Emanuele che ai cronisti diceva “Mario Draghi ha fatto molto per noi clochard”, giuro. Mirabile sintesi di quel che era diventato a un certo punto il Paese: un altarino dedicato al culto draghista, all’osanna perpetuo per l’Intoccabile e Incriticabile. E credo che anche a Draghi questo culto draghista abbia dato a un certo punto un po’ fastidio, cioè, speriamo.
In ogni caso, poi, all’apparir del vero, tutti quelli che non sono stati a Princeton, né ad Harvard, né seduti ai desk di giornali e televisioni dove si decidono titoli e ospiti, hanno detto la loro, votando. E si è scoperto che quella narrazione era altamente farlocca, molto sovradimensionata, addirittura caricaturale. Da qualunque parte la si guardi, la capacità dei grandi media di descrivere il Paese, di sentirne il polso, di auscultarne battiti e pulsioni, ha fallito miseramente, in modo – visto oggi – che sfiora il ridicolo. Da una parte, un tecnico mandato dalla Provvidenza, incriticabile per definizione e dogma, dall’altra astruse forme di vita senza arte né parte, populisti quando va bene, “scappati di casa”, insulto di moda presso quelli che si credono “competenti”. E si è visto, porelli.
Insomma, delle due una: o si dà ragione a Calenda, e sono tutti populisti tranne lui e grandissima parte dell’informazione; oppure bisogna fare una riflessione sui media tutti, e dire che i sapienti osservatori della realtà hanno osservato un po’ a cazzo, con le loro lenti deformanti, che la realtà era diversa e non l’hanno vista: per cecità, o convenienza, o ordini dall’alto. Con coerenza, tra l’altro, perché l’osanna al potere tecnico ed elitario veniva da un altro potere tecnico ed elitario, che si sente moralmente migliore, culturalmente più attrezzato e in definitiva buono, mentre tutti gli altri sono brutti, sporchi e cattivi. E populisti. Ora, poverini, gli toccherà riposizionarsi, ma non mi farei grandi illusioni: non c’è niente come gli adoratori di élite – che si sentono essi stessi élite – per creare nuove élite a cui ubbidire. Aspettiamo “Meloni ha fatto molto per noi clochard”, o varianti consimili. Questione di tempo.
 Coraggio, ancora qualche giorno, poi una notte di passione, poi potremo tirare un po’ le somme e dare i voti ai maghi del marketing che hanno condotto la più bislacca campagna elettorale dai tempi di Numa Pompilio. Una campagna elettorale condotta tutta “contro” e non “pro”, come lamentano (uff!) alcuni commentatori con toni da “Signora mia, che degrado”.
Coraggio, ancora qualche giorno, poi una notte di passione, poi potremo tirare un po’ le somme e dare i voti ai maghi del marketing che hanno condotto la più bislacca campagna elettorale dai tempi di Numa Pompilio. Una campagna elettorale condotta tutta “contro” e non “pro”, come lamentano (uff!) alcuni commentatori con toni da “Signora mia, che degrado”.
Ecco, proprio il contrario. Nel senso che visioni del mondo pochine, e differenze pochine anche quelle. Piuttosto, se si vanno a leggere i giornali di due mesi fa, quando iniziò la rumba, certe differenze si vedono eccome, e non tra schieramenti avversari, ma nelle stesse forze politiche. Chi era partito in un modo è arrivato in un altro, molte visioni sono cambiate in corsa, molti aggiustamenti sono stati fatti strada facendo. E questo proprio perché quella che dovrebbe essere una battaglia politica si è trasformata in marketing, studi di posizionamento, calcoli sulla collocazione degli avversari, e quindi minuscoli scarti di lato sulla griglia delle convenienze. Non “come possiamo convincere i cittadini con le nostre idee”, ma “come possiamo fregare i voti a Tizio o Caio comunicando meglio le loro”? Sembra di vederle, le riunioni di profilazione e le discussioni sul target, eterne repliche dei brain storming sul packaging di merci quasi identiche (il fustino del detersivo, cilindrco o parallelepipedo? Ah, saperlo!).
La burbanzosa energia salviniana, per dirne una, quella guapperia da ministro dell’Interno in pectore che “quando c’era lui la Digos arrivava in orario” (a identificare gli avversari) si è un po’ sciolta sotto il timore della vittoria schiacciante di Giorgia e sotto il fuoco incrociato dei suoi stessi colonnelli, tanto che oggi Salvini è unanimemente considerato in discesa libera. Il Pd, partito lancia in resta con l’agenda Draghi sotto il braccio, ha visto quell’agenda assottigliarsi giorno dopo giorno, poi diventare quattro foglietti sparsi, poi sparire, tanto che di Draghi non parla più. Era partito sull’onda dell’emozione, strillando alti lai contro chi poneva questioni e problemi al governo più bello del mondo – mai più coi 5stelle, traditori di Supermario! – e arriva a pochi giorni dal voto ad augurarsi (a volte esplicitamente, come in Puglia e in Sicilia) che i vituperati 5stelle facciano un buon risultato. Un testacoda, insomma.
Per non dire dei due caratteristi del Quarto Polo, detto Terzo, che, dopo averci sfiancato per due mesi sul prossimo governo a guida Draghi, incassano da Draghi un “no” secco e definitivo, ma si consolano con il forte argomento: “Beh, ma cosa poteva dire?”. Surrealismo puro. Il tutto mentre Giorgia modula la terapia a seconda della platea e del contesto: europeista dopo colazione, ringhiosa sovranista dopo pranzo, di nuovo simil-ragionevole al talk show serale. E Silvio che fa ridere tutti, as usual. Tutto come previsto, quindi, anzi forse no. Perché negli ultimi giorni – sorpresa – si fa strada l’assurdo timore che tutto il circo non si rivolga più solo e soltanto a un indistinto “certo medio”, ma che siano della partita anche i ceti popolari e meno favoriti, quei “descamisados” (milioni) che faticano ad arrivare alla fine del mese, quelli che fino a ieri “tanto non votano”, e forse invece oggi si scopre che sì, potrebbero votare anche loro, dannazione. Gente semplice, che non capisce le raffinatezze del marketing, che se ne sbatte della forma del fustino, e pensa più se quello che c’è dentro può servire a campare un po’ meglio. Maledizione, il marketing non l’aveva previsto.
 Piano piano, in punta di piedi, senza clamore, senza grossi traumi, la questione della lotta alle diseguaglianze ha abbandonato la campagna elettorale, rifugiandosi in un luogo nascosto e ombroso dove non darà fastidio a nessuno, un po’ polemica strumentale e un po’ manuale di conversazione. Come capita sovente, non è il problema che scompare (anzi!), ma la sua utilità nel dibattito, quindi via, via, archiviare. Restano in campo, vagamente collegate all’argomento, le polemiche funzionali ai vari schieramenti, per esempio sul reddito di cittadinanza: chi lo vuole abolire, chi lo vuole mantenere (e per questo è addirittura accusato di voto di scambio, divertente paradosso per cui se fai qualcosa in difesa dei cittadini e loro ti votano per quello, non va bene); chi insiste sulle truffe (un po’ come se si abolissero le pensioni perché c’è chi si frega quella della nonna defunta e congelata), chi si arrampica un po’ sugli specchi. Qualche sondaggio, ad esempio, deve aver acceso un faro sull’impopolarità dell’abolizione secca, visto che anche le forze fino a ieri contrarissime al reddito, virano oggi verso una più moderata “modifica”. E’ il caso, per esempio, di Azione, che se la cava con quella formuletta facile del “superamento” e della “revisione”, dimenticando che solo fino a qualche giorno fa uno dei due soci in ditta annunciava la raccolta di firme e un referendum per cancellarla per sempre. Imbarazzo comprensibile tra i fans azionisti quando glielo ricordi.
Piano piano, in punta di piedi, senza clamore, senza grossi traumi, la questione della lotta alle diseguaglianze ha abbandonato la campagna elettorale, rifugiandosi in un luogo nascosto e ombroso dove non darà fastidio a nessuno, un po’ polemica strumentale e un po’ manuale di conversazione. Come capita sovente, non è il problema che scompare (anzi!), ma la sua utilità nel dibattito, quindi via, via, archiviare. Restano in campo, vagamente collegate all’argomento, le polemiche funzionali ai vari schieramenti, per esempio sul reddito di cittadinanza: chi lo vuole abolire, chi lo vuole mantenere (e per questo è addirittura accusato di voto di scambio, divertente paradosso per cui se fai qualcosa in difesa dei cittadini e loro ti votano per quello, non va bene); chi insiste sulle truffe (un po’ come se si abolissero le pensioni perché c’è chi si frega quella della nonna defunta e congelata), chi si arrampica un po’ sugli specchi. Qualche sondaggio, ad esempio, deve aver acceso un faro sull’impopolarità dell’abolizione secca, visto che anche le forze fino a ieri contrarissime al reddito, virano oggi verso una più moderata “modifica”. E’ il caso, per esempio, di Azione, che se la cava con quella formuletta facile del “superamento” e della “revisione”, dimenticando che solo fino a qualche giorno fa uno dei due soci in ditta annunciava la raccolta di firme e un referendum per cancellarla per sempre. Imbarazzo comprensibile tra i fans azionisti quando glielo ricordi.
Insomma, espulsa dalle politiche sociali e dalle proposte strutturali, la povertà è tornata ad essere un incidente quasi inevitabile, buona sì per qualche sussulto di indignazione passeggero – un po’ di retorica – ma troppo complicata per essere al centro della discussione politica. Con qualche risvolto grottesco, anche, come il surreale dibattito sul grado in meno dei caloriferi per ripararci dal caro-bollette, senza mai dire che gli italiani che hanno abbassato il riscaldamento di un grado, anche due, anche cinque, anche del tutto, sono sempre di più, e non da oggi. E’ come se ci fosse un vizio atavico e irrisolvibile, per cui quando si parla delle spese “degli italiani” (tutti uguali, tutti sommabili in una massa indistinta non troppo diseguale) ci si riferisse solo e soltanto a una specie di generalista “ceto medio”: la larga fetta di popolazione scivolata alle soglie della povertà non è contemplata. Da qui, una sorta di incoraggiamento da rotocalco al risparmio “glamour” e modaiolo (Uh, i mercatini dell’usato, che sciccheria! Uh, la doccia fredda, quanto fa bene!). Insomma si piega la questione della povertà, e della neo-povertà, a una specie di gioco di società, con conseguente passaggio dalle pagine dell’economia, o della politica, a quella degli “stili di vita”.
Persino di quella spaventosa tabella Osce che ci ricorda il disastro salariale italiano negli ultimi trent’anni non si parla quasi più, se non per una specie di scambio di prigionieri: un pochettino più di salario (forse), e un po’ meno tasse per gli imprenditori (di sicuro) che va sotto il nome di cuneo fiscale. A parte minuscole e lodevoli eccezioni, insomma, l’impoverimento della società italiana non è stato al centro del dibattito elettorale, se non per qualche benemerita uscita ideologica à la Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro” (sic), o il vecchio refrain liberal-liberista sulla piaga dell’”invidia sociale”, che rende i poveri e gli impoveriti non solo colpevoli della loro povertà, ma pure cattivi e invidiosi. Ecco fatto.
 L’idea che con le mie bollette del gas e della luce io contribuisca a pagare profitti mostruosi a qualche migliaio di aziende che vendono gas e luce mi entusiasma e mi riempie di spirito patriottico. Così si fa! Bravi! Cos’è la sopravvivenza del cittadino, della sua aziendina, del suo negozio, della sua officina, di fronte alle leggi naturali del libero mercato? Non la conoscete la storia della manina del mercato che sistema tutto lei, senza regole e senza affanni? Magari chiedete al Foglio, quelli che non volevano il prezzo calmierato delle mascherine per evitare l’accaparramento da parte dei poveri. Che poi, sono sempre i poveri a rompere i coglioni, diciamolo, non ce ne libereremo mai, e d’altronde è giusto: è l’abbondanza di poveri a garantire l’esistenza dei ricchi (sempre la manina santa del mercato).
L’idea che con le mie bollette del gas e della luce io contribuisca a pagare profitti mostruosi a qualche migliaio di aziende che vendono gas e luce mi entusiasma e mi riempie di spirito patriottico. Così si fa! Bravi! Cos’è la sopravvivenza del cittadino, della sua aziendina, del suo negozio, della sua officina, di fronte alle leggi naturali del libero mercato? Non la conoscete la storia della manina del mercato che sistema tutto lei, senza regole e senza affanni? Magari chiedete al Foglio, quelli che non volevano il prezzo calmierato delle mascherine per evitare l’accaparramento da parte dei poveri. Che poi, sono sempre i poveri a rompere i coglioni, diciamolo, non ce ne libereremo mai, e d’altronde è giusto: è l’abbondanza di poveri a garantire l’esistenza dei ricchi (sempre la manina santa del mercato).
Ma insomma, da qualunque parte la si guardi, questa faccenda degli extra-profitti sull’energia è una divertente favola con la morale, tipo Esopo, dove superior stabat il profitto e il panettiere cazzi suoi. Restando all’esempio delle mascherine, è come se tre anni fa le farmacie avessero messo ogni ffp2 a 172 euro l’una e, richieste di una tassazione che colpisse quegli extra-profitti, avessero fatto marameo. Ecco. Lo stesso marameo che fanno oggi le grandi aziende energetiche al fu governo Draghi e a tutti noi. Una tassa del 25 per cento, da cui dovevano arrivare dieci miliardi, subito un anticipo del 40 per cento, che farebbe quattro miliardi, e ne è arrivato uno, perché molte aziende che hanno scritto nella tabella “profitti” un bel più seicento, più settecento per cento (e anche molto oltre), si rifiutano di pagare. Una “rivolta tra gli operatori” (Sole 24 Ore), una “rivolta fiscale” (Repubblica), insomma, il più strepitoso caso di evasione fiscale mai visto in un singolo colpo. Ora la palla passerà al Tar del Lazio e forse poi alla Corte Costituzionale che, apprendiamo con sgomento, dirà la sua nel giro di un anno e mezzo, quando il panettiere di cui sopra si sarà già dato alle rapine a mano armata o alle truffe agli anziani, avviando nel contempo i figli alla prostituzione minorile.
In un simile contesto, si affacciano le “ragioni” di chi dovrebbe pagare e non paga: dicono che la norma sulla tassazione al 25 per cento di utili extra (fino al mille per cento, in certi casi) è scritta male, che non sta in piedi tecnicamente, che colpisce il fatturato, o le dichiarazioni Iva, e non i profitti, che si presta a una grandinata di ricorsi, con il che i soldi incassati adesso (poco e male) tornerebbero a casa dopo raffiche di sentenze. Insomma, sarebbe incostituzionale.
In alto i cuori: non è commovente vedere un così sincero e disinteressato rispetto della nostra Costituzione da parte di gente che vendeva il gas a cento e ora lo vende a cinquecento? Il risultato è che tutti si sbracciano perché Draghi faccia qualcosa. Il problema è che prima dovrebbe ammettere di aver scritto una norma “senza discernimento”, come disse lui (testuale) nella replica al Senato a proposito di norme scritte da altri (i 5stelle sul bonus 110 per cento). Non lo farà. Insomma con le mie bollette pago gli extraprofitti dei miei fornitori di gas e luce, ma non solo. Pago (caro) anche il dogma dell’infallibilità di Draghi, insieme ad altri dogmi molto gettonati (il default della Russia in due settimane, le sanzioni che uccideranno Putin, eccetera eccetera). Insomma, niente di male: pago per avere la moraletta finale nella fiaba di Mario Esopo, il Migliore di tutti noi.
 Non si vive di sola campagna elettorale, e del resto non è solo da lì che vengono certi geyser di nonsense nel discorso pubblico, certe fiammate che consentono un’indignazione facile e prêt-à-porter, roba da manuale di conversazione in società. Insomma, chiedo scusa se parlo di Sanna Marin, la premier finlandese, e del suo ballo, di cui sarebbe lecito disinteressarsi forever, ma che è diventato un racconto centrale nell’Italia di questi giorni (e per questo ce ne occupiamo). La storia la sapete: la prima ministra finlandese, che è giovane (36) e bella, (per questo tutti pubblicano volentieri una sua foto, e le battute da camionisti si sprecano) è andata a una festa privata. Ha ballato, ha bevuto, poi è uscito un video di quella festa ed ecco la fremente polemica: basta attacchi! Sanna ha tutto il diritto di ballare! Siete contro la felicità! E’ tutta invidia!
Non si vive di sola campagna elettorale, e del resto non è solo da lì che vengono certi geyser di nonsense nel discorso pubblico, certe fiammate che consentono un’indignazione facile e prêt-à-porter, roba da manuale di conversazione in società. Insomma, chiedo scusa se parlo di Sanna Marin, la premier finlandese, e del suo ballo, di cui sarebbe lecito disinteressarsi forever, ma che è diventato un racconto centrale nell’Italia di questi giorni (e per questo ce ne occupiamo). La storia la sapete: la prima ministra finlandese, che è giovane (36) e bella, (per questo tutti pubblicano volentieri una sua foto, e le battute da camionisti si sprecano) è andata a una festa privata. Ha ballato, ha bevuto, poi è uscito un video di quella festa ed ecco la fremente polemica: basta attacchi! Sanna ha tutto il diritto di ballare! Siete contro la felicità! E’ tutta invidia!
Ok, perfetto. Fin qui sono d’accordo su tutto: non mi sembra un reato federale che una vada a ballare e quindi, diciamo, archivierei sotto la soave voce “cazzi suoi”. Eppure…
Eppure, la veemenza della difesa – anche simil-colta, anche un po’ filosofia for dummies – lasciava un po’ perplessi. Come mai tutta questa energia? Chi ha insultato la povera Sanna o le ha chiesto di non ballare in modo così feroce e paranazista da mobilitare firme famose, corsivi corrucciati sulla gioventù negata, servizi di telegiornale, verbose lezioni sulla felicità repressa? Chi è stato, il cattivo? Ecco: non si capisce.
In tutti i servizi e pezzi e articoli e titoli usciti sul tema (parecchi, un coro) si parla sempre di avvoltoi generici, “nella bufera”, “i feroci attacchi”, “l’occhio del ciclone social e mediatico”. Ma insomma, esattamente da chi si sta difendendo con così poderose armi la premier che va a ballare? Un paio di nomi li ho trovati, a dire il vero: Mikko Kärnä, deputato finlandese del Partito di Centro, e la leader dell’opposizione (finlandese) Riikka Purra. E volendo completare l’elenco dei cattivi, mettiamoci pure il tabloid (finlandese) che ha diffuso il video, che si chiama Iltalehti. Che si siano aggiunti qualche Farfallina76 e Gino-bandierina-sovranista sul web, fa parte della solita solfa (web cattivo, commentatori buoni), ma niente di rilevante.
Insomma, l’indignatissimo e predicante coro tutto italiano in difesa di Sanna Marin sta rispondendo, a colpi di Dante e Tommaso D’Aquino, di battaglia di genere, di difesa della gioventù dall’invidia dei vecchi, a una polemica tutta interna alla politica finlandese. Con tanto di pista spionistica (sono stati i russi), sospetti di discriminazione di genere (Ecco! Lo fanno perché è stata allevata da due madri!), o semplicemente accusa di machismo spicciolo (solo perché è carina). Viene in mente quel fortunato slogan: “Ti piace vincere facile”. Ecco, qui sta lo stridore: una polemica di facile presa – uh, il video, uh, le foto – che permette di sfoderare uno spirito libertario (la felicità! Hurrà! Balliamo!) che sta bene su tutto e non impegna, che taccia altri di oscurantismo e invidia, ma gli altri chi, poi, non si capisce. Molto woke, come dicono quelli bravi, oppure “panna montata, ma che piace a tutti”, come diceva un mio vecchio caporedattore, che sicuramente avrebbe aggiunto: “E’ agosto, vai, vai, paginone!”.
Naturalmente – lo dico anche per prevenire accuse di invidia – Sanna Marin vada a ballare quando, come e con chi vuole. Nessuno si farà male, a parte noi, qui, costretti dalle polemiche interne (finlandesi) alle lezioni dei nouveau-banal-philosophes.
 Il concetto di “meno peggio” aleggia sulle elezioni di settembre come un solitario condor che cerca conigli nella pianura. L’esercizio può essere infinito: preferite esser chiuso in una stanza con una decina di vespe o con un giaguaro affamato? Scegliere il meno peggio vi sarà agevole, così come, alla lunga, tra mangiare male e non mangiare per niente, uno sarà costretto a scegliere la soluzione meno dannosa. Nella politica italiana la cosa funziona da secoli, la usò Silvio quando c’erano da fermare “i comunisti” (che vedeva solo lui), prima ancora la Dc a metà dei Settanta quando c’era da evitare il sorpasso del Pci, e va molto di moda oggi in cui si consigliano caldamente mollette per il naso a chi dovrebbe votare senza entusiasmi, ma con l’onorevole missione di scegliere il male minore.
Il concetto di “meno peggio” aleggia sulle elezioni di settembre come un solitario condor che cerca conigli nella pianura. L’esercizio può essere infinito: preferite esser chiuso in una stanza con una decina di vespe o con un giaguaro affamato? Scegliere il meno peggio vi sarà agevole, così come, alla lunga, tra mangiare male e non mangiare per niente, uno sarà costretto a scegliere la soluzione meno dannosa. Nella politica italiana la cosa funziona da secoli, la usò Silvio quando c’erano da fermare “i comunisti” (che vedeva solo lui), prima ancora la Dc a metà dei Settanta quando c’era da evitare il sorpasso del Pci, e va molto di moda oggi in cui si consigliano caldamente mollette per il naso a chi dovrebbe votare senza entusiasmi, ma con l’onorevole missione di scegliere il male minore.
Sembrerebbe una questione di logica ferrea, difficile da attaccare e in molti casi usata per forzare e stirare situazioni un po’ estreme: l’idea è che io – faccio un esempio da Milano – debba votare Cottarelli per fermare Giorgetti, o che – dico uno di Bologna – debba votare Casini per fermare Berlusconi (e tutti per fermare io sono Giorgia). Suggestivo.
L’antico trucchetto funziona un po’ meno a questo giro: la polarizzazione del voto non è pienamente conclusa, perché i poli da polarizzare non sono due, c’è una terza forza non trascurabile, i Cinque stelle, accreditati sopra o attorno al dieci per cento, poi i guastatori del quarto polo, che parlano di sé come terzo polo, che veleggiano nei sondaggi intorno al cinque e che al momento hanno sicuramente più righe sui giornali che elettori. Poi, piccole formazioni che meriterebbero almeno una seggiola.
Quanto al meno peggio, mi sia concesso di dubitare dell’efficacia del concetto. Alle politiche del 2013 Giorgia Meloni prese il 2 per cento, a quei tempi il peggio erano ancora Silvio buonanima e la Lega. Nel 2018 prese il 4,3, cioè raddoppiò i voti. Dal governo Monti in poi o con dentro tutti a battere le mani, o con governi a guida Pd (Letta, Renzi, Gentiloni, Conte2, poi Draghi, con un anno di Conte1 in mezzo), il peggio che si voleva combattere con il metodo del “meno peggio” è lievitato come un panettone, la Meloni veleggia attorno al 25, e gli altri (un peggio con cui peraltro si è governato) si ringalluzziscono dietro a lei. Un elettore su due a votare non ci va, forse perché vede il confine tra peggio e meno peggio un po’ labile e affievolito.
E’ una cosa che si è vista recentemente in Francia, tra l’altro: Macron vince le presidenziali compattando il fronte anti- LePen, e alle presidenziali successive LePen risulta cresciuta, non sminuita, al punto che moltiplica per otto i suoi in Parlamento. Pare abbastanza conclamato che il meno peggio rischia spesso di portare al peggio.
Non è una cosa nuova, anzi. Tanto che ce la spiegò in modo cristallino Antonio Gramsci nei “Quaderni dal carcere”, ricordando anche un detto popolare: “Peggio non è mai morto”. E anche: “La formula del male minore, del meno peggio, non è altro dunque che la forma che assume il processo di adattamento a un movimento storicamente regressivo, movimento di cui una forza audacemente efficiente guida lo svolgimento, mentre le forze antagonistiche (o meglio i capi di esse) sono decise a capitolare progressivamente, a piccole tappe e non di un solo colpo”. La rana di Chomsky, insomma. Non si pretende certo che qualcuno che sta battendosi a mani nude con il Rosatellum vada a rileggersi Gramsci, però magari, vai a sapere, alla lunga può aiutare.
 Come vengo a sapere male le cose! Apprendo quasi per caso, nello sfoglio distratto dei giornali, che Claudio Signorile (eh?) che possiede un suo movimento dal pittoresco nome di “Mezzogiorno Federato” (eh?) lancia accorati appelli perché Renzi e Calenda si uniscano per il bene del Paese. E questo proprio nello stesso giorno in cui apprendo – capirete lo sconcerto – che Luigi Di Maio intensifica i contatti per allearsi con il Partito Animalista, della cui esistenza non erano a conoscenza nemmeno gli animali. La nazione freme per sapere se si farà o no il matrimonio tra Italia Viva, parlandone da viva, e Azione, sposalizio in pompa magna dove uno dovrebbe portare le firme e l’altro i voti (ahah), sennò uno affonderà miseramente e l’altro annasperà fino al primo scoglio, naufrago, però “sèrio”. Tutti si dicono convinti e fiduciosi, ma hanno il terrore negli occhi: seggi sicuri a Bolzano per la fatina delle riforme non ce ne sono più, e se ci fossero andrebbero a qualcun altro. Spiace.
Come vengo a sapere male le cose! Apprendo quasi per caso, nello sfoglio distratto dei giornali, che Claudio Signorile (eh?) che possiede un suo movimento dal pittoresco nome di “Mezzogiorno Federato” (eh?) lancia accorati appelli perché Renzi e Calenda si uniscano per il bene del Paese. E questo proprio nello stesso giorno in cui apprendo – capirete lo sconcerto – che Luigi Di Maio intensifica i contatti per allearsi con il Partito Animalista, della cui esistenza non erano a conoscenza nemmeno gli animali. La nazione freme per sapere se si farà o no il matrimonio tra Italia Viva, parlandone da viva, e Azione, sposalizio in pompa magna dove uno dovrebbe portare le firme e l’altro i voti (ahah), sennò uno affonderà miseramente e l’altro annasperà fino al primo scoglio, naufrago, però “sèrio”. Tutti si dicono convinti e fiduciosi, ma hanno il terrore negli occhi: seggi sicuri a Bolzano per la fatina delle riforme non ce ne sono più, e se ci fossero andrebbero a qualcun altro. Spiace.
Ora, cercate di capirmi, è sgradevole mettere in campo questioni personali mentre si dibatte del futuro di sessanta milioni di persone, ma credo sia il momento di chiedere al direttore un indennizzo per il disagio psicologico di dover leggere così tante puttanate in poche ore, compreso naturalmente il rally di Carletto nostro adorato, che ora “accelera” e ora “frena”, ora “spinge” e ora “rallenta”, come su una strada di montagna con tornanti e saliscendi senza guard rail: che brivido.
Il tutto mentre dall’altra parte, cioè dalla stessa parte – a destra – si lancia la meravigliosa riffa della flat tax, Silvio la vuole al 23, Salvini al 15, stupisce che non si alzi nessuno a dire 11, 7, 4, anzi ti diamo noi dei soldi. Poi c’è tutta la pattuglia di quelli che “andremo orgogliosamente da soli”, che sono gli stessi che sei minuti prima si dicevano “orgogliosi di questa alleanza”; oltre a quelli che vogliono sconfiggere il fascismo, a mani nude, magari con una ferma dichiarazione di Debora Serracchiani, e che riscoprono lavoratori, giovani e precari a cinque settimane dalle elezioni dopo averli bastonati per dieci anni, partecipando attivamente a sei governi su sette da Mario Monti in poi.
In più c’è l’agenda Draghi che non si sa bene chi che l’ha, si parla di un ritrovamento a Pompei, anzi di un caveau di Confindustria, anzi me ne hanno offerta una, sottovoce, furtivi, fuori da un autogrill: “Dottò, la vuole un’agenda Draghi? Solo venti euro, ma se ne prende due gliele do per trenta”.
Questo è niente. Tra pochi giorni, che sembreranno rapidi e infiniti, comincerà l’ordalia sanguinosa delle candidature, con trecento posti in meno da distribuire tra Camera e Senato, e dunque uno strabiliante stillicidio di sacrifici umani, rabbie, ripicche, tensioni, amicizie secolari che si incrinano, e la spaventosa incertezza sulla sorte di Ettore Rosato, che diede il suo nome a una legge elettorale a cui non sarebbero arrivati nemmeno i Jefferson Airplane dopo aver ingerito due chili di Lsd. Legge che fu concepita per far perdere i 5stelle, che infatti vinsero.
Il quadro, come si dice, è complesso, anche se qualche lume viene dalla ricerca di un’università americana, secondo la quale se intervisti una scimmia bonobo tutti i giorni per un anno su tutti i giornali e le televisioni, questa tenderà a salire nei sondaggi, salvo poi incontrare la dura realtà della giungla, e cioè che gli italiani saranno anche scemi, ma un pochino meno di chi si sbraccia per rappresentarli in modo “sèrio”.
 Come vengo a sapere male le cose! Apprendo quasi per caso, nello sfoglio distratto dei giornali, che Claudio Signorile (eh?) che possiede un suo movimento dal pittoresco nome di “Mezzogiorno Federato” (eh?) lancia accorati appelli perché Renzi e Calenda si uniscano per il bene del Paese. E questo proprio nello stesso giorno in cui apprendo – capirete lo sconcerto – che Luigi Di Maio intensifica i contatti per allearsi con il Partito Animalista, della cui esistenza non erano a conoscenza nemmeno gli animali. La nazione freme per sapere se si farà o no il matrimonio tra Italia Viva, parlandone da viva, e Azione, sposalizio in pompa magna dove uno dovrebbe portare le firme e l’altro i voti (ahah), sennò uno affonderà miseramente e l’altro annasperà fino al primo scoglio, naufrago, però “sèrio”. Tutti si dicono convinti e fiduciosi, ma hanno il terrore negli occhi: seggi sicuri a Bolzano per la fatina delle riforme non ce ne sono più, e se ci fossero andrebbero a qualcun altro. Spiace.
Come vengo a sapere male le cose! Apprendo quasi per caso, nello sfoglio distratto dei giornali, che Claudio Signorile (eh?) che possiede un suo movimento dal pittoresco nome di “Mezzogiorno Federato” (eh?) lancia accorati appelli perché Renzi e Calenda si uniscano per il bene del Paese. E questo proprio nello stesso giorno in cui apprendo – capirete lo sconcerto – che Luigi Di Maio intensifica i contatti per allearsi con il Partito Animalista, della cui esistenza non erano a conoscenza nemmeno gli animali. La nazione freme per sapere se si farà o no il matrimonio tra Italia Viva, parlandone da viva, e Azione, sposalizio in pompa magna dove uno dovrebbe portare le firme e l’altro i voti (ahah), sennò uno affonderà miseramente e l’altro annasperà fino al primo scoglio, naufrago, però “sèrio”. Tutti si dicono convinti e fiduciosi, ma hanno il terrore negli occhi: seggi sicuri a Bolzano per la fatina delle riforme non ce ne sono più, e se ci fossero andrebbero a qualcun altro. Spiace.
Ora, cercate di capirmi, è sgradevole mettere in campo questioni personali mentre si dibatte del futuro di sessanta milioni di persone, ma credo sia il momento di chiedere al direttore un indennizzo per il disagio psicologico di dover leggere così tante puttanate in poche ore, compreso naturalmente il rally di Carletto nostro adorato, che ora “accelera” e ora “frena”, ora “spinge” e ora “rallenta”, come su una strada di montagna con tornanti e saliscendi senza guard rail: che brivido.
Il tutto mentre dall’altra parte, cioè dalla stessa parte – a destra – si lancia la meravigliosa riffa della flat tax, Silvio la vuole al 23, Salvini al 15, stupisce che non si alzi nessuno a dire 11, 7, 4, anzi ti diamo noi dei soldi. Poi c’è tutta la pattuglia di quelli che “andremo orgogliosamente da soli”, che sono gli stessi che sei minuti prima si dicevano “orgogliosi di questa alleanza”; oltre a quelli che vogliono sconfiggere il fascismo, a mani nude, magari con una ferma dichiarazione di Debora Serracchiani, e che riscoprono lavoratori, giovani e precari a cinque settimane dalle elezioni dopo averli bastonati per dieci anni, partecipando attivamente a sei governi su sette da Mario Monti in poi.
In più c’è l’agenda Draghi che non si sa bene chi che l’ha, si parla di un ritrovamento a Pompei, anzi di un caveau di Confindustria, anzi me ne hanno offerta una, sottovoce, furtivi, fuori da un autogrill: “Dottò, la vuole un’agenda Draghi? Solo venti euro, ma se ne prende due gliele do per trenta”.
Questo è niente. Tra pochi giorni, che sembreranno rapidi e infiniti, comincerà l’ordalia sanguinosa delle candidature, con trecento posti in meno da distribuire tra Camera e Senato, e dunque uno strabiliante stillicidio di sacrifici umani, rabbie, ripicche, tensioni, amicizie secolari che si incrinano, e la spaventosa incertezza sulla sorte di Ettore Rosato, che diede il suo nome a una legge elettorale a cui non sarebbero arrivati nemmeno i Jefferson Airplane dopo aver ingerito due chili di Lsd. Legge che fu concepita per far perdere i 5stelle, che infatti vinsero.
Il quadro, come si dice, è complesso, anche se qualche lume viene dalla ricerca di un’università americana, secondo la quale se intervisti una scimmia bonobo tutti i giorni per un anno su tutti i giornali e le televisioni, questa tenderà a salire nei sondaggi, salvo poi incontrare la dura realtà della giungla, e cioè che gli italiani saranno anche scemi, ma un pochino meno di chi si sbraccia per rappresentarli in modo “sèrio”.
 Quella cosa delle pulci con la tosse non è del tutto sbagliata, e la spiega molto bene Matteo Renzi: “Se pensano di poterci abbindolare con due seggi non ci conoscono”.
Quella cosa delle pulci con la tosse non è del tutto sbagliata, e la spiega molto bene Matteo Renzi: “Se pensano di poterci abbindolare con due seggi non ci conoscono”.
Tranquillo, vi conoscono, ma già siamo alla battaglia per i posti (pochi), e sempre
meno blindati (traduco: niente seggi sicuri a Bolzano), quindi a breve assisteremo a
spettacolini poco decorosi in cui si sommeranno preghiere e minacce per salire sul
pittoresco carro di Enrico Letta. Secondo altri, addirittura, sul carro dovrebbe salire
lui. Dice Calenda che il suo programma è quello lì, se il Pd ci sta bene, sennò farà da
solo (cioè, con Bonino, cioè da solo). E’ uno strano modo di condurre una trattativa,
un po’ come andare a comprare una Porsche con trentacinque euro e, incredibilmente,
trovare un concessionario che dice, va bene, qua la mano. Misteri che la direzione del
Pd di ieri non ha del tutto chiarito, e non era possibile, anche perché non si sa dove
mettere nel mazzo né alcuni centristi un po’ imbarazzanti (chiedere ai propri militanti
di votare Brunetta, specie se sono dipendenti pubblici insultati per anni, non sarà uno
scherzetto), né chi si definisce orgogliosamente “a sinistra del Pd” e che poi vota
come il Pd, torna a casa Lassie.
Ma sia, la cronaca la conosciamo, da qui alla formazione delle liste, in confronto, la
corte dei Borgia sembrerà la famigliola del Mulino Bianco. E questo è il prima, lo
stupefacente “qui e ora”, che già scoraggia un bel po’. E poi, per scoraggiarsi
definitivamente, ci sarebbe “il dopo”. Nell’ipotesi, al momento improbabile, che i
“democratici e progressisti” riescano a resistere alla destra, si troverebbero dentro un
po’ di tutto, il bar di guerre stellari. Non so, Gelmini e Fratoianni, per dire, magari
con un peone alla Camera di nome Renzi, un Calenda che detta le tavole della legge,
tutti a sventolare l’agenda Draghi. Dove, faccio notare, alcune cose sono scritte
sempre al futuro, lo ius scholae si farà, il salario minimo si farà, l’agenda sociale si
farà, vedremo, forse. Nel programma di Calenda, per dire, c’è che bisogna
“militarizzare” (testuale) i siti dove si prevedono inceneritori o rigassificatori, e non
so se un governo di “democratici e progressisti” possa veramente usare l’esercito
così, a capocchia di Calenda. O la detassazione totale per le assunzioni di under 25,
che sarebbe un altro regalo sontuoso ai datori di lavoro.
Non se ne esce, a meno che non ci venga in aiuto la scienza. Una pillola che fa
dimenticare sarebbe l’ideale, una specie di amnesia universale, un vuoto di memoria
che consenta all’elettore di scordarsi tutto. Credere a un’ipotetica “agenda sociale”
promessa da tutti quelli che hanno votato il Job act o il decreto Poletti è possibile
soltanto in caso di grave ottundimento. Lo spettacolo di una classe politica che ha
governato per dieci anni negli ultimi undici e che ora dice di voler fare l’esatto
contrario non è tollerabile, a meno, appunto, di procurarsi una forte amnesia, di
svegliarsi dopo un coma decennale e ritrovarsi in un mondo fatato dove il Pd parla di
salari e di precarietà. Per ora la precarietà che si sta sistemando è quella dei disperati
sotto il tre per cento che si presentano minacciosi ma col cappello in mano.
Una sedazione di massa sarebbe invero utile. Potrebbe riportarci alla fine del governo
Monti, quando si dicevano dell’”agenda Monti” le stesse cose che si dicono ora.
 Perdonerete il tono affettuoso, ma a Berlusconi che “scende in campo” non si può
Perdonerete il tono affettuoso, ma a Berlusconi che “scende in campo” non si può
negare un minimo sindacale di tenerezza. Il suo mangiarsi le parole, i lievi
appisolamenti, il gesticolare fuori sincrono, rendono in modo feroce il passare del
tempo, ma hanno il pregio dell’aria famigliare, da consigli per gli acquisti, da vecchio
Carosello. E’ un modo morbido di entrare nel nostro eterno giorno della marmotta,
ieri come oggi, oggi come domani, domani come l’altro ieri.
Un programma “avveniristico”, promette Silvio, e sgancia i suoi gavettoni sui
bagnanti. Otto punti, per ora un po’ misteriosi, di cui si conosce il primo: pensioni a
mille euro. Basterebbe così, ma si parla al settore “cuore d’oro” dell’opinione
pubblica – più gli utenti di Rete4 – e quindi sotto di mamme, le nostre mamme, che
hanno lavorato anche i sabati e le domeniche. Giusto, sacrosanto. Pensioni a mille
euro per tutti. Minimo. Ci mancherebbe. Peccato che l’aveva già detto. Nel lontano
2001, per cominciare (la pensione minima a un milione!), poi mantenne la promessa
per una platea ristrettissima, tipo gli zoppi con l’occhio di vetro, ma solo il sinistro).
Si era adeguato all’euro, Silvio nostro buonanima, un po’ in ritardo, così aveva
aspettato le elezioni del 2008 per sparare le sue pensioni a 1000 euro, ripescate poi
nella campagna elettorale del 2013, e in seguito nel maggio del 2017 e lo ridisse in
novembre, e poi ancora nel 2019, e poi ancora oggi. Se le promesse pensionistiche di
Berlusconi fossero cumulabili avremmo tanti pensionati-Briatore senza problemi, in
barca a Portofino. E invece.
Siccome ci sono un paio di mesi di calvario in vista, è comprensibile che Silvio si
tenga da parte altri palloncini per stupire le platee. Per ora si mantiene sulla
precisissima vaghezza dei suoi programmi di sempre, avveniristici o no. “Meno
tasse”, maddai? Meno burocrazia (dove si scrive “burocrazia” ma si legge
“controlli”), meno processi, più sicurezza. E così ecco sistemati quattro punti
cardine, con la deliziosa svisa melodica dei “meno processi, più sicurezza”, che
tradotto vuoi dire più processi ai poveracci e meno a quelli come lui, un classico.
Divertenti gli altri punti che per ora sono ampiamente illustrati così: “Per i
giovani, per gli anziani e per la nostra politica estera”, sulla quale ci piacerebbe
sorvolare. Quando si dice un programma dettagliato.
Ma poi: il colpo da maestro: un milione di posti da albero ogni anno. Proprio
così, il Berlusconi green, uno che tra macchine, aerei, barche, ville, ha l’impronta
ecologica di una centrale a carbone medio-grande, si riscopre giardiniere, green,
ecologista e verde. Un milione di alberi all’anno è un bel traguardo, chissà che
non verrà fuori, un domani, in qualche remoto processo, che gli serviva
ripiantumare i viali d’accesso.
Ma si sa che il diavolo è nei dettagli: la millemillesima discesa in campo di mister
B non può far storcere troppo il naso a tutti quelli (tutti, dai sumeri alla Meloni,
dal Pd agli stropicciati centrini, Lega, liberal, radicali, persino i 5stelle nel
governo Draghi) che hanno governato con lui, che gli hanno perdonato tutto, che
l’hanno blandito e incensato quando i suoi votavano le “utili” fiducie del
menopeggio del nostro scontento. Silvio era lì. E ora è ancora lì, perché non c’è
come il menopeggio per coltivare il peggio eterno.
 Coraggio, smettetela coi cardiotonici e le cure per l’ansia, oggi sapremo. In questa gloriosa giornata di luglio, infine, si spera, conosceremo la nostra sorte: se potremo continuare a vantarci di essere la Superpotenza che conosciamo, quella con Brunetta ministro, oppure se sprofonderemo nel baratro dei popoli tristi e imbelli che – con grande spregio della democrazia – si avviano alle elezioni dopo una crisi di governo innestata dalle dimissioni di un capo di governo con fiducia abbondante e maggioranza parlamentare sicura. Ma intanto, godiamoci la festa di popolo in sostegno di Mario Draghi: manifestazioni oceaniche in tutta Italia, da Roma a Milano, poderose e immense, alcune in grado di occupare addirittura due panchine, e il resto in piedi, fino a quarantadue persone (ventotto secondo la questura).
Coraggio, smettetela coi cardiotonici e le cure per l’ansia, oggi sapremo. In questa gloriosa giornata di luglio, infine, si spera, conosceremo la nostra sorte: se potremo continuare a vantarci di essere la Superpotenza che conosciamo, quella con Brunetta ministro, oppure se sprofonderemo nel baratro dei popoli tristi e imbelli che – con grande spregio della democrazia – si avviano alle elezioni dopo una crisi di governo innestata dalle dimissioni di un capo di governo con fiducia abbondante e maggioranza parlamentare sicura. Ma intanto, godiamoci la festa di popolo in sostegno di Mario Draghi: manifestazioni oceaniche in tutta Italia, da Roma a Milano, poderose e immense, alcune in grado di occupare addirittura due panchine, e il resto in piedi, fino a quarantadue persone (ventotto secondo la questura).
Dunque siamo ancora – fino alle comunicazioni alle Camere di oggi – con un piede nella Gloria e uno nella Disgrazia, per metà illuminati dal faro della Saggezza e per l’altra metà avvolti dal buio delle Tenebre. Speriamo bene, sarebbe un delitto perdere il “Bonus zanzariere e tende da sole” (detrazione Irpef 50 per cento fino a 60.000 euro nel 2022) o il “Bonus condizionatori” (detrazione Irpef 50 per cento fino a 10.000 euro), il Paese non se lo può permettere. In più c’è la guerra, quindi niente crisi (come in Gran Bretagna, barbari) e niente elezioni (come in Francia, dilettanti).
Ma portiamoci avanti col lavoro: cosa resterà di questi giorni furenti e spaventosi? Forse l’appello di Emanuele, senzatetto romano, che confermando la sua presenza alla manifestazione con decine e decine di persone assicura (virgolette a cura di Adnkronos) che “Mario Draghi ha fatto molto per noi clochard”.
Per fortuna oggi sapremo, meno male. Così ci evitiamo il nuovo strabiliante ritrovamento delle mirabili iscrizioni di Pompei: “Mane nobiscum, heroicum Mario”, nella ritrovata villa sede della Confmiliardari distrutta dal Vesuvio. E forse ci risparmieremo anche il misterioso suono captato dalle profondità dello spazio – pare venga dalla Ztl della galassia di Andromeda – un ipnotico ripetersi di impulsi che ha viaggiato nel buio stellato per dodici miliardi di anni e che ora, tradotto, suona così: “Resta, Mario Draghi, unico terrestre competente”.
Ancora due giorni di thrilling e le avremmo avute sicuramente, forse insieme alle accorate preghiere delle poche categorie che mancano all’appello dei firmatari di appelli: “Rapinatori di banche per Draghi”, “Sgusciatori di ostriche per Draghi”, “Ausiliari della sosta per Draghi”, mai visto un popolo più compatto dietro alla sua punta di diamante.
Forse servirà un po’ di distanza per apprezzare le impennate popolari di questi giorni, il fremito democratico, la rabbia di quella decina di milioni di italiani che non vogliono perdere il privilegio dei loro mille euro lordi al mese ottenuti dopo otto ore e più di lavoro svolto con la gioia di chi sa di essere utile al Paese. E si capisce che nei sogni della parte sinistra del draghismo-dadaismo si faccia strada il sogno definitivo di una grande manifestazione, immensa e infinita, dei “Lavoratori poveri per Draghi”, aperta da un enorme striscione: “Grazie di tutto”. Sogni, appunto, che svaniranno oggi, quando sapremo se i nostri appelli hanno funzionato, e se quella firma finale (cfr: Massimo Troisi e Roberto Benigni nella lettera a Savonarola), “Noi ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo”, avrà raggiunto il suo obiettivo.
 E’ un uno-due che abbatterebbe un toro, il rapido susseguirsi di studi su quanto e come siamo un popolo povero, molto povero. Prima il rapporto Istat, poi il rapporto Inps, due sberle potenti e sonorissime. E poi via, di nuovo sull’ottovolante della politica del Palazzo, i buoni propositi, i roboanti annunci, i bonus, le esternazioni, gli ultimatum, gli anatemi, il solito spettacolino. Ma i numeri sono più forti: 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta, nove milioni in povertà relativa, 4,3 milioni di italiani che guadagnano meno di 780 euro al mese (senza stare “seduti sul divano”), un lavoratore su tre che guadagna meno di mille euro al mese, lordi, 4,2 milioni di lavoratori precari (il 22 per cento del totale). Lavoratori poveri con un futuro da pensionati poveri, a combattere con le mani legate, e un’inflazione che galoppa dalle parti dell’8 per cento, cioè si mangia anche (soprattutto) i salari da fame.
E’ un uno-due che abbatterebbe un toro, il rapido susseguirsi di studi su quanto e come siamo un popolo povero, molto povero. Prima il rapporto Istat, poi il rapporto Inps, due sberle potenti e sonorissime. E poi via, di nuovo sull’ottovolante della politica del Palazzo, i buoni propositi, i roboanti annunci, i bonus, le esternazioni, gli ultimatum, gli anatemi, il solito spettacolino. Ma i numeri sono più forti: 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta, nove milioni in povertà relativa, 4,3 milioni di italiani che guadagnano meno di 780 euro al mese (senza stare “seduti sul divano”), un lavoratore su tre che guadagna meno di mille euro al mese, lordi, 4,2 milioni di lavoratori precari (il 22 per cento del totale). Lavoratori poveri con un futuro da pensionati poveri, a combattere con le mani legate, e un’inflazione che galoppa dalle parti dell’8 per cento, cioè si mangia anche (soprattutto) i salari da fame.
La sensazione è quella di essere seduti su una polveriera, e il primo pensiero va proprio alla politica: da dove sgorga questo disastro? Quanti anni bisogna andare indietro per dire: ecco chi ha governato il mercato del lavoro? Sappiamo le risposte. Sì, ma il Covid, sì ma la guerra… un po’ deboli, perché tutto questo nasce molto prima, quando il Covid non esisteva e la guerra non c’era, e viene alla mente quella famosa tabella brutta e cattiva (fonte: Osce): mentre a partire dal 1990 in tutti i paesi europei sono aumentati i salari (dal più 6,20 della Spagna, l’incremento più basso, al più 33,70 della Germania), da noi sono calati (meno 2,9 per cento). Insomma, si vede a occhio nudo: la minaccia feroce che “Sennò arriva la Troika” non dovrebbe fare molta paura, dato che la Troika è arrivata da un pezzo.
Ora si assiste a un frenetico arrampicarsi sugli specchi insaponati: bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, si studiano bonus, correzioni di rotta, si annunciano impegni solenni. Si tenta di chiudere la stalla, insomma, con i buoi già scappati che fanno marameo dall’orizzonte. Si dirà: bene essersene accorti (alla buon’ora), e ora basta fare leggi che penalizzano i lavoratori! Urca!
E però, basta guardarsi un po’ intorno per capire che no, invece, che le leggi contro i lavoratori continuano a nascere senza che quasi nessuno se ne accorga. Ultimo caso, il pasticciaccio brutto della logistica, una modifica al Codice Civile contenuta (si può dire nascosta?) nel Decreto Pnrr2. Si tratta di una cosa piuttosto semplice: non c’è più la responsabilità del committente se una ditta fornitrice non paga i suoi dipendenti. Cioè io consegno merci per un grande distributore di commercio online, ma se non mi pagano, o ho un incidente, non posso più rivalermi sul committente, come potevo fare prima. Ad essere responsabili in solido saranno le migliaia e migliaia di aziendine, spesso cooperative, che ti mettono in regola per quattro ore anche se ne lavori dodici (il resto in nero), che muoiono spesso, chiudono, spariscono al primo problema, e i lavoratori sempre più ricattabili – scusate il francesismo – cazzi loro. Una sberla secca ai lavoratori di un settore, la logistica, già considerati tra i più disastrati, circa un milione di sberle, votate da tutti (fiducia il 28 giugno, 419 favorevoli, 50 contrari). L’emendamento è stato inserito nel decreto dall’onorevole Nazario Pagano (Forza Italia). Assologistica ha ringraziato con un comunicato: lui e i ministri Cartabia e Giorgetti. Un milione di lavoratori hanno meno garanzie e più paura. Grazie. Prego.
E’ consigliata l’autofustigazione, possibilmente in pubblico, l’autodafé, l’espiazione solenne e silenziosa. Insomma, porca miseria, pentitevi, ognuno scelga la sua modalità (frustate sulle piante dei piedi, pinze e tenaglie, digiuni e penitenze) perché quel che emerge dal disastro della Marmolada è che “siamo tutti colpevoli”, anzi “è colpa nostra”, anzi “questo è ciò che stiamo facendo al pianeta”, eccetera eccetera. C’è del vero, ovviamente: se gran parte del riscaldamento globale dipende dall’Uomo (inteso come umanità, ma anche come guidatore di automobile, consumatore di risorse, utilizzatore di aria condizionata), la colpa sarà anche nostra, certo, e ben vengano appelli e preghiere a comportamenti più responsabili, ovvio. Eppure non se ne va la sensazione che la colpevolizzazione del cittadino, l’appello alla sua moderazione, faccia velo all’inanità della classe dirigente (quella che dirige, che decide). Per chiarire: siamo chiamati a riflettere sulle nostre colpe e a correggere i nostri comportamenti, a sentirci in colpa, giusto, ma questo avviene proprio mentre la politica mondiale riscopre il carbone, rinvia sine die la ricerca di nuovi modelli di sviluppo, moltiplica le spese in armamenti, si riunisce in enormi assise che decidono poco o niente (e questo al netto dei deficienti negazionisti che in gennaio titolano: “Riscaldamento globale? Ma se fa freddo!”). Insomma, è colpa nostra, ma le politiche del clima non le facciamo noi. E c’è anche una sindrome da spiazzamento costante: mentre a pagina sei si legge, contriti e pentiti, che non si può andare avanti così, a pagina otto ci si stracciano le vesti perché le immatricolazioni di auto rallentano, o perché l’industria ha fame di energia e in assenza di gas, vabbé, le daremo da mangiare carbone, che sarà mai.
Come si sa, si procede per emergenze, e in ogni emergenza si chiama a corresponsabile il cittadino, in molti casi additandolo come il vero colpevole del disastro corrente. Dopo il Covid, è diventato un classico: la sanità barcollava, i vaccini non c’erano ancora, la medicina di base agonizzava, i posti letto negli ospedali calavano (25.000 in meno negli ultimi dieci anni), ma si applaudiva l’elicottero dei Caramba che inseguiva un podista solitario sulla spiaggia, in diretta tv. Traduco: l’autorità non si discute (sacrilegio!), è il singolo che è stronzo.
La siccità ci offre un esempio illuminante in proposito. Non piove, non nevica d’inverno, i fiumi sono vuoti, gli invasi calano, i sindaci si scervellano per inventare soluzioni, razionamenti, regole. Di colpo si discute animatamente sull’uso che facciamo dell’acqua. Trenta litri per lavarsi i denti? Pazzesco. Cento per lavare la macchina? Cinquanta per farsi una doccia, ma siamo matti? E questa è una parte del problema, su cui molti riflettono. Poi c’è l’altra parte: su dieci litri d’acqua che entrano nella nostra rete di distribuzione, quattro vanno persi, oltre il quaranta per cento, perché la rete è un colabrodo, gli investimenti non si sono fatti, l’acqua piovana non viene sfruttata, gli sprechi sono enormi, la politica non fa il suo mestiere. Insomma, lo dico male: può risultare irritante l’accorato appello al risparmio e alla frugalità liquida se chi dovrebbe garantire l’approvvigionamento se ne fotte alla grande, non investe, non decide nuovi invasi, non sistema le condutture. E’ come se l’idraulico, chiamato per una perdita, invece che aggiustare il tubo logoro, ti dicesse: “Anche lei, però! Eccheccazo, si lavi un po’ meno!”.
Siccome viviamo in un Paese dove uno di Cuneo che vive a Montecarlo spiega cos’è la pizza ai napoletani, possiamo partire dal presupposto che vale tutto, che si può dire ogni cosa e che nessuno ne chiederà conto. Per tradizione nazionale, il punto più alto di questa grandinata di parole si ha nei giorni a cavallo delle elezioni, e peggio ancora questa volta, perché si leggono elezioni locali, tarocchi e fondi di caffè, per capire cosa succederà in Italia tra qualche mese, alle politiche. In certi passaggi – anche divertenti, va detto – è come se una tornata elettorale, anche parzialissima come quella appena finita, azzerasse tutto quanto per tutti i decenni e i secoli passati. Sembra un remake di Eraserhead, la mente che cancella.
Così ecco il ministro del Lavoro Andrea Orlando che, richiesto di rivelare come diavolo si farà a comporre lo strano puzzle che mette insieme in un unico disegno da Conte a Renzi, da Di Maio a Calenda, risponde che “vicinanze e distanze del cosiddetto campo largo si misureranno su salari, lotta alla precarietà, attenzione alla sanità e alla scuola pubblica”. Insomma eccolo, sbarcato da Marte, invocare attenzione per quei temi su cui il suo partito ha contribuito massicciamente, negli ultimi dieci anni, a fare un deserto. Bisogna misurare “vicinanze e distanze”, bene, bella frase, ma le distanze sono già ben delineate: il primo decreto del governo Renzi fu il decreto Poletti, che di fatto rendeva più meno eterno il precariato, e poi venne il Jobs act, e poi (e prima) tutte le leggi sul lavoro (e contro i lavoratori) che conosciamo. Per misurare “vicinanze e distanze”, insomma, il primo atto sarebbe un’inversione a U: ripudiare tutto quello che negli ultimi decenni è stato fatto sul lavoro, abolirlo e rifarlo daccapo, o anche tornare alla legislazione precedente (articolo 18, statuto dei lavoratori, divieto di demansionamenti, eccetera eccetera, tutte cosette che Orlando votò). Lo stesso vale per la sanità, sempre sbandierata come frontiera di divisione tra destra e sinistra, ma dove il confine non è chiaro: 25.000 letti in meno negli ospedali italiani negli ultimi dieci anni, per esempio, e – persino con una pandemia, budget potenzialmente illimitato e un ministro della sanità “di sinistra” – già si parla di altri tagli. La scuola pubblica, poi, peggio mi sento: anche lì sono attesi nuovi tagli, a dispetto della tanto decantata grandinata di miliardi in arrivo.. Questo per dire che le chiacchiere sono gradevoli, ma i fatti incombono e non vanno nella stessa direzione. Diciamo che le “vicinanze” alle esigenze del Paese (salari, sanità, scuola) sono forti a parole, mentre le “distanze” sono evidenti nei fatti.
Gioca col nonsense anche il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano, che dice: “Per noi le larghe intese sono un’esperienza irripetibile”. Il che è bizzarro, perché dopo aver fatto parte del governo Monti (larghe intese) e del governo Draghi (larghissime intese), dire che il governo con dentro tutti è “un’esperienza irripetibile” lascia qualche perplessità nei potenziali clienti: se uno ti ha già venduto due catorci, non è scontato che la terza macchina la comprerai da lui, il che spiega come mai 6 italiani su 10 si tengono lontani dal concessionario e piuttosto che farsi truffare di nuovo, preferiscono andare a piedi. Non so le vicinanze, ma le distanze (tra elettori e urne) sono piuttosto grandi, probabilmente incolmabili in pochi mesi, a causa del vecchio vizio (populista?) di guardare più ai fatti che alle parole.
 Bevete molta acqua, mangiate la frutta e si vince al centro. L’antica saggezza ci colpisce ogni minuto, è una specie di ritornello che echeggia ovunque, un’esortazione, quasi un ordine. E’ un po’ come lo sport, o il sesso, che più se ne parla e meno se ne fa: se il famoso centro avesse un voto ogni volta che sui giornali si legge “si vince al centro”, avrebbe il 110 per cento. Diciamolo: è un argomento in cui sarebbe ora di mettere un po’ d’ordine, perché ormai sappiamo che una iattura del Paese (una delle) è l’affollamento di volenterosi costruttori di centri, che nelle intenzioni dovrebbero essere più centrali dei centri esistenti, che già sono parecchi. Gli ultimi boatos riguardano un ipotetico centro dal fantasioso nome “L’Italia c’è” (Matteo, sei tu?), che dovrebbe contenere i soliti noti e meno noti, cioè Calenda Carlo e la pattuglia di Più Europa (e alé, una cabina del telefono l’abbiamo riempita), con la leadership affidata al sindaco di Milano Beppe Sala.
Bevete molta acqua, mangiate la frutta e si vince al centro. L’antica saggezza ci colpisce ogni minuto, è una specie di ritornello che echeggia ovunque, un’esortazione, quasi un ordine. E’ un po’ come lo sport, o il sesso, che più se ne parla e meno se ne fa: se il famoso centro avesse un voto ogni volta che sui giornali si legge “si vince al centro”, avrebbe il 110 per cento. Diciamolo: è un argomento in cui sarebbe ora di mettere un po’ d’ordine, perché ormai sappiamo che una iattura del Paese (una delle) è l’affollamento di volenterosi costruttori di centri, che nelle intenzioni dovrebbero essere più centrali dei centri esistenti, che già sono parecchi. Gli ultimi boatos riguardano un ipotetico centro dal fantasioso nome “L’Italia c’è” (Matteo, sei tu?), che dovrebbe contenere i soliti noti e meno noti, cioè Calenda Carlo e la pattuglia di Più Europa (e alé, una cabina del telefono l’abbiamo riempita), con la leadership affidata al sindaco di Milano Beppe Sala.
L’altro grande costruttore di centri, Renzi Matteo, si sbraccia per un centro più tecnocratico ed elitario che lui chiama “Area Draghi”, cioè tutti quelli che ci sono nel governo Draghi tranne quelli che stanno nel governo Draghi ma non piacciono a lui, e che forse interpreta come l’unica maniera per avere un seggio da qualche parte. Poi c’è un ancora più grande centro, detto Campo largo, ambizione di Letta Enrico, che vorrebbe in qualche modo federare intorno al Pd – grande forza di centro – tutti gli altri fabbri e carpentieri dei centri in costruzione, più forse qualcuno che sta più a sinistra, ma che poi, tranquilli, quando si vota in Parlamento (che so, per le armi) vota come il centro.
Per lisergico paradosso, la formula “si vince al centro” ha avuto sulla stampa italiana una discreta impennata proprio mentre in Francia il centro macroniano prendeva una sberla solenne, anzi due: una da destra e una da sinistra, e se si hanno sotto gli occhi i risultati francesi, la frase “Si vince al centro” sembra un commento sarcastico-perculante. Coerentemente, tutto il centro possibile e immaginabile italiano, non ha quasi commentato le elezioni francesi e tutti i titoli sono per Le Pen trionfante e per il Napoleone centrista acciaccato. Se si parla di una sinistra unita e plurale, che ha ottenuto un risultato storico, e che è la prima forza d’opposizione in Francia, si scartabella nel tradizionale armamentario dialettico centrista: Mélenchon e i suoi sono populisti, anti-sistema, il Chavez francese, estremisti, anti-atlantici e aggiungere insulti a piacere.
Naturalmente non dovete pensare al centro come a un puntino statico, ma a una sostanza collosa che si muove nel tempo e nello spazio. Oggi in Italia le disavventure del marketing fanno in modo che ci sia una certa confusione: la più grande e magmatica forza di centro, il famoso Campo largo, si ostina a dirsi “sinistra”, che è un po’ come quelle fighettissime botteghe milanesi che vendono aperitivi a venti euro ma mantengono l’antica insegna novecentesca: fabbro, o lavanderia. E poi c’è pure la questione geografica, perché membri illustri del famoso centrissimo twittano sentite felicitazioni alla sinistra che vince in Colombia (la Colombia è lontana), ma zero commenti sulla sinistra francese resuscitata (anzi è una bella seccatura). Resta l’impareggiabile spettacolo di arte varia di tutti quegli omini, operosi e intervistati ogni giorno, che si affannano a costruire centro in un posto dove, se ti guardi in giro, non c’è altro che centro.
 Dopo la pizza e la pastasciutta, si conferma grande tradizione italiana il dibattito sui referendum, specie dopo il fatale mancamento di quorum. Insomma, quasi ogni volta che si viene chiamati a votare Sì o No, vincono quelli che non vanno a votare né Sì né No, che è il modo migliore per votare No, come si è visto anche l’altro giorno (fanno eccezione i referendum costituzionali, dove invece la gente va volentieri a votare No, e poi festeggia, ottimo). Ed ecco: dalle maggiori testate italiane all’ultimo giornaletto di provincia fioriscono gli spiegoni per dire che l’istituto referendario ha perso il suo potere, che va riformato, che non è più come una volta, il divorzio, l’aborto, quanto ci manca Marco Pannella, eccetera eccetera. È come se davanti a un fuciliere che sbaglia mira di qualche decina di metri si riflettesse argutamente sulla riforma del fucile. Le proposte su come cambiare l’istituto del referendum si somigliano un po’ tutte e dicono sostanzialmente due cose: alzare il numero delle firme necessarie per chiederlo e abbassare il quorum per vincerlo, che è un po’ come dire al fuciliere di cui sopra: “Senti, amico, col fucile sei negato, prova con questo cannone, vedrai che ci riesci”.
Dopo la pizza e la pastasciutta, si conferma grande tradizione italiana il dibattito sui referendum, specie dopo il fatale mancamento di quorum. Insomma, quasi ogni volta che si viene chiamati a votare Sì o No, vincono quelli che non vanno a votare né Sì né No, che è il modo migliore per votare No, come si è visto anche l’altro giorno (fanno eccezione i referendum costituzionali, dove invece la gente va volentieri a votare No, e poi festeggia, ottimo). Ed ecco: dalle maggiori testate italiane all’ultimo giornaletto di provincia fioriscono gli spiegoni per dire che l’istituto referendario ha perso il suo potere, che va riformato, che non è più come una volta, il divorzio, l’aborto, quanto ci manca Marco Pannella, eccetera eccetera. È come se davanti a un fuciliere che sbaglia mira di qualche decina di metri si riflettesse argutamente sulla riforma del fucile. Le proposte su come cambiare l’istituto del referendum si somigliano un po’ tutte e dicono sostanzialmente due cose: alzare il numero delle firme necessarie per chiederlo e abbassare il quorum per vincerlo, che è un po’ come dire al fuciliere di cui sopra: “Senti, amico, col fucile sei negato, prova con questo cannone, vedrai che ci riesci”.
I cinque referendum defunti domenica scorsa, il cui esito era largamente prevedibile e previsto – tanto che anche i sostenitori (Lega e Renzi in primo luogo) hanno quasi fatto finta che li avesse proposti un lontano cugino, per fingere di non prendere l’ennesima facciata – sono un caso di scuola. Chiedere al famoso popolo di esprimersi, che so, sulla composizione dei Consigli giudiziari, sembra un po’ azzardato. Ammesso che sappiano cosa sono, risulta che la composizione dei Consigli giudiziari, nelle priorità degli italiani, stia al milletrecentonovantaseiesimo posto, molto dopo il prezzo delle capesante gratinate e appena prima del sesso degli angeli (che sarebbe più interessante, tra l’altro). Dunque, cos’è che provoca negli elettori questa fuga dal prezioso istituto del referendum? Facciamo qualche ipotesi.
La prima è che viene da ridere. A chiedere di abolire la legge Severino, per dirne una, sono stati tre leader sotto processo (Salvini, Renzi, Berlusconi). Cioè: tre leader che temono una condanna, tentano di abolire la legge che gli impedirebbe di sedere in Parlamento in caso di condanna, non fa una piega. Poi, c’è il fatto che due referendum che sarebbero stati molto popolari (la liberalizzazione della cannabis e il diritto a una morte decente), che nascevano da varie mobilitazioni e raccolta di milion
i di firme, sono stati bocciati con bislacchi cavilli, mentre i referendum proposti da cinque consigli regionali (cioè dalla classe politica) sono stati ammessi, una cosa piuttosto irritante. Ci metterei anche – sono andato a scartabellare – che sul declino dello strumento del referendum abrogativo si parlò a lungo nel 1996 (26 anni fa) e anche nel 1999 (23 anni fa), quando i Radicali di Pannella (allora impegnato in una lista Sgarbi-Pannella, ahahah) li proponevano a mazzetti di dieci o venti, come gli asparagi. In più, alcuni referendum che raggiunsero il quorum e dove vinsero i Sì, sono spariti nel cyberspazio (acqua pubblica, 2011, o privatizzazione della Rai, 1995). Dovrebbe bastare, forse, per dire che il limite del referendum non sta nelle firme necessarie, e nemmeno nel quorum, ma nell’uso belluino che se ne fa, e comunque alla fine si dà la colpa al famoso popolo che – cretino – non capisce. Mentre invece, si è visto domenica, capisce benissimo.
 Mozzarella, pomodori, lo yogurt, mezzo chilo di pane, due etti di prosciutto, uova, pancetta e un po’ di frutta, vedi tu cosa trovi. Ah, è finito il sale, mi raccomando, e già che ci sei, i cereali per la colazione. Questa è la lista che il Copasir mi ha lasciato attaccata al frigorifero, e poi se n’è andato a lavorare. Fa un lavoraccio, poverino, passa il suo tempo a smentire di aver compilato tutte le liste attribuite al Capasir che girano – in primis quella dei putiniani. Molto stressante.
Mozzarella, pomodori, lo yogurt, mezzo chilo di pane, due etti di prosciutto, uova, pancetta e un po’ di frutta, vedi tu cosa trovi. Ah, è finito il sale, mi raccomando, e già che ci sei, i cereali per la colazione. Questa è la lista che il Copasir mi ha lasciato attaccata al frigorifero, e poi se n’è andato a lavorare. Fa un lavoraccio, poverino, passa il suo tempo a smentire di aver compilato tutte le liste attribuite al Capasir che girano – in primis quella dei putiniani. Molto stressante.
La lista comunque è incompleta (quella dei putiniani, non quella sul frigo). Manca Putin, per esempio, che non è un dettaglio, manca il papa, e siccome dai sondaggi continua a risultare che il 50-60 per cento degli italiani è contrario all’invio di armi all’Ucraina (il che equivale ovviamente ad essere putiniani), mancano più o meno una ventina di milioni di nomi. Compreso (lo dico, me ne assumo la responsabilità) il signor Fernando del terzo piano, che ha espresso le sue perplessità sul Donbass mentre aspettava l’ascensore, che tra l’altro lascia spesso aperto al suo piano (maledetto), per cui è già in due liste: quella dei putiniani d’Italia e quella degli stronzi che bloccano l’ascensore.
Può anche darsi che la pubblicazione di liste di proscrizione sia un buon metodo per superare la crisi dei giornali in Italia: pubblicando molte liste di personaggi sgraditi, e facendole sempre più lunghe, chiunque vorrà controllare la presenza di amici e parenti. “Ehi, Gino, ho visto che sei nella lista dei manciniani d’Italia, che sostengono il ct della Nazionale”. “Dannazione, – risponde Gino – come l’avranno saputo!”.
Attenzione, la cosa potrebbe prenderci la mano. Sempre leggendo i giornali, si potrebbe stilare una lista di quelli favorevoli alle liste, oppure una lista di quelli contrari alle liste, o ancora comporre liste con il famoso metodo “a cazzo”, da pubblicare quando c’è carenza di liste: la lista dei celiaci, la lista dei pescatori di frodo, la lista di chi possiede animali a pelo lungo (notoriamente sostenuta dalla lobby di produttori di spazzole). A questo punto – suggerimento al direttore, mi permetto – non ha senso combattere l’uso e abuso degli elenchi di persone da cacciare dal consesso civile e dalla tivù, meglio passare al contrattacco. Per esempio, compilare e pubblicare la lista di deputati e senatori che hanno votato il Jobs act, oppure la lista degli evasori fiscali, o addirittura la lista dei domestici di Gianluca Vacchi che non tengono il tempo nei suoi balletti su Tik Tok. Pensiamoci, aumenterebbe l’occupazione, perché il Copasir dovrebbe assumere migliaia e migliaia di compilatori di liste: “Lista di quelli che ieri non avevano la bicicletta e oggi ce l’hanno. L’avranno rubata? Nel dubbio, ecco i loro volti”. E’ anche possibile pensare a un sistema di incentivi: se nella stessa settimana uno compare in tre liste distinte (che so, putiniani, possessori di auto Gpl e tiratori con l’arco), potrà godere di un piccolo sussidio sotto la voce “sostegno all’editoria”.
Tutto questo in attesa della pubblicazione (sarebbe l’ora!) di un elenco piuttosto corposo: la lista di quelli che guadagnano tre euro l’ora, che conterrebbe milioni di nomi e facce di gente che delle liste di putiniani non sa che farsene, se ne sbatte allegramente, non capisce nemmeno di cosa cazzo state parlando, perché troppo impegnata a mettere insieme il pranzo con la cena e a tirare l’anima coi denti. Bon pazienza, basterà raccontargli che è colpa di Putin e andrà tutto benissimo.
 Segnatevi queste parole: “Il nostro Paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con una flessibilizzazione del costo del lavoro, ma questa strategia non ha funzionato”. Siccome non sta parlando Bakunin, e nemmeno qualche economista neo-marxista, o il compagno Landini, ma il ministro del Lavoro in persona (Andrea Orlando, ieri su La Stampa), il salto sulla sedia è legittimo. Molto nasce da un grafico (fonte: Osce) che gira da tempo, rilanciato negli ultimi giorni, che rappresenta in modo limpido e feroce la situazione italiana. In tutta Europa negli ultimi trent’anni i salari sono aumentati, adeguandosi al costo della vita. Naturalmente è improprio il raffronto con i paesi dell’est (Estonia, Lettonia, Lituania, tutte sopra il duecento per cento di aumento), ma è praticabile quello con gli europei a noi più vicini e dalle economie simili alla nostra: Germania (più 33,70 per cento), Francia (più 31,10), per dirne soltanto due, anche se cogliere fior da fiore sarebbe facile e un po’ umiliante per noi.
Segnatevi queste parole: “Il nostro Paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con una flessibilizzazione del costo del lavoro, ma questa strategia non ha funzionato”. Siccome non sta parlando Bakunin, e nemmeno qualche economista neo-marxista, o il compagno Landini, ma il ministro del Lavoro in persona (Andrea Orlando, ieri su La Stampa), il salto sulla sedia è legittimo. Molto nasce da un grafico (fonte: Osce) che gira da tempo, rilanciato negli ultimi giorni, che rappresenta in modo limpido e feroce la situazione italiana. In tutta Europa negli ultimi trent’anni i salari sono aumentati, adeguandosi al costo della vita. Naturalmente è improprio il raffronto con i paesi dell’est (Estonia, Lettonia, Lituania, tutte sopra il duecento per cento di aumento), ma è praticabile quello con gli europei a noi più vicini e dalle economie simili alla nostra: Germania (più 33,70 per cento), Francia (più 31,10), per dirne soltanto due, anche se cogliere fior da fiore sarebbe facile e un po’ umiliante per noi.
Ma facciamola breve: Italia, meno 2,90 per cento. Cioè negli ultimi trent’anni siamo l’unico Paese in cui i salari sono calati invece di crescere. Insomma, prima che lo dicesse Orlando, lo dicono (da anni) i numeri, e il ministro ci mette il timbro: “Questa strategia non ha funzionato”. Una pietra tombale.
Ora si sa che la famosa “questione salariale” su cui per trent’anni ha regnato il silenzio, farà parte integrante della campagna elettorale, e ce lo ha ricordato tra gli altri Tommaso Nannicini (senatore Pd, già consulente economico del governo Renzi) con un tweet di quelli a ditino alzato. “Tra meno di un anno si vota. Possiamo decidere se occuparci di discussioni sterili, piantare bandierine, oppure occuparci della carne viva del Paese. Come della questione salariale” (anche lui allega il famoso grafico). Insomma si vota, e “la carne viva del Paese” (wow!) ridiventa di moda. Bene, c’è da rallegrarsi.
Le cose si complicano un po’ se, dopo aver parlato di salari, tuonando così landinianamente, si passa a parlare di politica. Perché è giusto sottolineare che la strategia di flessibilizzare sempre più lavoratori non ha funzionato, ma sarebbe anche gradita una ricostruzione dei fatti. Chi ha sbagliato strategia? Chi da decenni sostiene con fatti, parole e opere quella flessibilizzazione, i millemila contrattini, l’erosione dei diritti, le narrazioni tossiche sul lavoro? Negli ultimi dieci anni (quasi dodici, a guardar bene) il Pd ha fatto parte di tutti i governi, con la breve eccezione del Conte Uno, con fattivo sostegno a Monti e a Draghi, esprimendo il Presidente del Consiglio per tre volte (Letta, Renzi, Gentiloni), e insomma non stiamo parlando di gente che stava all’opposizione, o in prima fila nelle battaglie per il reddito dei lavoratori, ma di quelli che hanno fatto e votato il Jobs Act, discendenti in qualche modo di quelli che avevano fatto e votato il “pacchetto Treu”.
Insomma, fa piacere quel “la strategia non ha funzionato”, ma forse bisognerebbe aggiungere nomi e cognomi di chi l’ha propugnata e condotta a diventare leggi dello Stato. In poche parole il dibattito sui salari (che avrà un suo peso in campagna elettorale) è abbastanza monco, manca la parte sui responsabili. E’ come se i passeggeri del Titanic, chiamati a votare, confermassero il vecchio capitano, anche se la sua strategia non ha funzionato. Sennò (lo sentirete dire milioni di volte) arriva un capitano di destra che magari ci fa affondare.
 Per una volta almeno darei ragione al vecchio Charles Bukowski: “I soldi hanno solo due cose che non vanno: o sono troppi o sono troppo pochi”. Il rapporto che Oxfam ha sventolato di fronte ai potenti (e ricchi) del mondo l’altro giorno a Davos è una fotografia perfetta, piuttosto spaventosa, della polarizzazione estrema tra ricchezza e povertà, o meglio la certificazione che stiamo seduti su un mondo solo, ma i mondi sono almeno due. Aumentano i miliardari, 573 in più, in totale sono 2.668. Aumentano i poveri, 263 milioni in un solo anno. Naturalmente si possono fare tanti giochetti con le cifre, ma insomma, alcune sono impressionanti comunque la pensiate: la ricchezza di tutti i miliardari messi insieme nel 2000 valeva il 4,4 per cento del Pil mondiale, e oggi, vent’anni dopo, il 13,9. Sembrerebbe che l’intera economia mondiale si sia messa al lavoro per arricchire un paio di migliaia di tizi che erano già ricchi. E tra l’altro, se avessimo tutti in tasca un dollaro per ogni volta che abbiamo sentito parlare di “lotta alle diseguaglianze”, saremmo miliardari anche noi.
Per una volta almeno darei ragione al vecchio Charles Bukowski: “I soldi hanno solo due cose che non vanno: o sono troppi o sono troppo pochi”. Il rapporto che Oxfam ha sventolato di fronte ai potenti (e ricchi) del mondo l’altro giorno a Davos è una fotografia perfetta, piuttosto spaventosa, della polarizzazione estrema tra ricchezza e povertà, o meglio la certificazione che stiamo seduti su un mondo solo, ma i mondi sono almeno due. Aumentano i miliardari, 573 in più, in totale sono 2.668. Aumentano i poveri, 263 milioni in un solo anno. Naturalmente si possono fare tanti giochetti con le cifre, ma insomma, alcune sono impressionanti comunque la pensiate: la ricchezza di tutti i miliardari messi insieme nel 2000 valeva il 4,4 per cento del Pil mondiale, e oggi, vent’anni dopo, il 13,9. Sembrerebbe che l’intera economia mondiale si sia messa al lavoro per arricchire un paio di migliaia di tizi che erano già ricchi. E tra l’altro, se avessimo tutti in tasca un dollaro per ogni volta che abbiamo sentito parlare di “lotta alle diseguaglianze”, saremmo miliardari anche noi.
A proposito di casa nostra, da marzo 2020 a novembre 2021 (pandemia, vi dice qualcosa?) i miliardari sono aumentati di 13 unità (auguri! Champagne!). In Italia, una quarantina di persone detengono la stessa ricchezza del 30 per cento degli italiani più poveri (calcolati in 18 milioni di persone adulte), un milione e quattrocentomila famiglie sono scese sotto la soglia di povertà durante il periodo del Covid.
Insomma, abbiamo un problema, cioè, ne abbiamo tanti. Uno è, se si può dire, semi-letterario. Questi leader del “miliardariesimo”, nuova religione mondiale, capita che sclerino, che diventino delle straordinarie auto-caricature, macchiette. Uno va su Marte, quell’altro mi diventa guru della sanità planetaria. I listini di Borsa sono la loro sala giochi, trattano coi governi, alla pari e in qualche caso in condizione di vantaggio, graduano alla bisogna la libertà d’espressione, pagano tasse percentualmente inferiori a quelle che paga un ragioniere di Vimodrone.
La “diseguaglianza”, insomma, è così plateale da risultare grottesca. Non solo per questioni di giustizia (già mi vedo arrivare quelli dell’”invidia sociale”, porelli, così ansiosi che dalla tavola imbandita cada qualche briciola per loro), ma proprio per questioni sistemiche e strutturali. Non è pensabile che la forbice si allarghi ancora. Anche perché è una forbice che non riguarda solo poveri e miliardari, ma un ritorno palpabile, visibile nelle nostre città, a una netta divisione per classi sociali, un proletariato sempre più compresso (e l’inflazione al sei per cento, poi…), con diritti un po’ evaporati, a cui nessuno sembra in grado di dare aperta rappresentanza politica. Insomma, aumentano i ricchi, a decine, e aumentano i poveri, a centinaia di migliaia, e questo in un Paese dove ogni giorno si sente il mantra della “lotta alle diseguaglianze”. Lo stesso Paese dove il solo pronunciare la parola “patrimoniale” genera svenimenti e crisi di panico alla classe dirigente, lamenti infiniti e repentine marce indietro, grida di allarme perché una tassa sui grandi patrimoni sarebbe indizio e sintomo di “socialismo” (ahahah, ndr). Non se ne esce. L’unica è aspettare il prossimo rapporto Oxam che dirà di un altro aumento di miliardari (non sarà la pandemia, sarà la guerra), e noi saremo qui a dire le stesse cose, e nel frattempo avremo sentito un migliaio di volte che si sta facendo una strenua lotta alle diseguaglianze.
 Eroe del giorno, lo stagista ignoto. Anzi ignota, perché è una ragazza quella che a Tirrenia, vicino a Pisa, ha reagito con “lancio di oggetti”, segnatamente “portaceneri”, contro le pareti di un bar “danneggiandole”. Ira funesta. Ha scoperto l’ultimo giorno dietro il bancone (lo riportano piccole, timide cronache) che il suo “stage lavorativo” non sarebbe stato pagato. Niente. Zero. Nemmeno un euro. Insomma ha lavorato gratis, l’ha saputo a lavoro fatto, e non l’ha presa bene, giusto, vorrei vedere voi. Ecco che l’Italia degli stagisti, dei sottopagati, degli stagionali, dei tirocinanti, dei lavoratori a chiamata, degli eterni precari, ha la sua Spartacus. Solidarietà.
Eroe del giorno, lo stagista ignoto. Anzi ignota, perché è una ragazza quella che a Tirrenia, vicino a Pisa, ha reagito con “lancio di oggetti”, segnatamente “portaceneri”, contro le pareti di un bar “danneggiandole”. Ira funesta. Ha scoperto l’ultimo giorno dietro il bancone (lo riportano piccole, timide cronache) che il suo “stage lavorativo” non sarebbe stato pagato. Niente. Zero. Nemmeno un euro. Insomma ha lavorato gratis, l’ha saputo a lavoro fatto, e non l’ha presa bene, giusto, vorrei vedere voi. Ecco che l’Italia degli stagisti, dei sottopagati, degli stagionali, dei tirocinanti, dei lavoratori a chiamata, degli eterni precari, ha la sua Spartacus. Solidarietà.
Il fatto è che la nostra stagista ignota ha soltanto arricchito per un giorno con una minuscola, quasi invisibile sfumatura, le appassionanti cronache sul mercato del lavoro nazionale, cronache che sono state invece occupate dalle esternazioni del ministro del turismo Garavaglia, preoccupato per la stagione, la ripresa, la prima gloriosa estate post-covid, alla quale mancano tra i 300 e i 350 mila lavoratori stagionali pagati solitamente come Spartacus (gli detraggono le catene). La proposta del ministro, in soldoni, è quella di prorogare il decreto flussi per gli immigrati, cioè permettere l’arrivo di più stranieri che facciano quei lavori per cui non si trova mano d’opera, per esempio gli stagionali in bar e cucine della Penisola. Mancano cuochi, sguatteri, lavapiatti, realizzatori di cappuccini, servitori di gelati.
Le storie italiane sul lavoro parlano di contratti poveri o poverissimi, di accordi sulla parola (retribuzione un po’ regolare e un po’ no), di durate risibili, trucchi, orari pazzeschi, il tutto coperto da quella deliziosa coltre di vergogna rappresentata dalla vulgata briatoresca che “i giovani non hanno voglia di lavorare”, mentre se hai voglia diventi milionario e ti compri la Bentley.
E siamo ancora lì (uff), al famoso reddito di cittadinanza che impedirebbe il corretto sviluppo della dinamica tra domanda (ti domando di lavorare dodici ore a due euro l’ora) e offerta (col cazzo). Insomma, non so se amate l’implacabile dispiegamento della legge del contrappasso, ma vedere un leghista che chiede più stranieri per fare lavori sottopagati ha un suo fascino. Il famoso “prima gli italiani” va letto dunque come “prima gli imprenditori italiani”, e per i lavoratori invece non ci sono preferenze etniche: va bene chiunque accetti condizioni semi-schiavistiche e non faccia mancare braccia all’estate. Arriva subito – ma ti pareva – l’artiglieria di rinforzo: non solo il tweet di Matteo Renzi (e vabbé) che dice “il reddito di cittadinanza è follia”, ma anche tutta quella corrente letteraria di baristi, ristoratori, albergatori che si sbraccia: li paghiamo bene! Benissimo! Un florilegio. Offro mille! Offro duemila! E poi, appena si va a leggere sotto il titolo a effetto, ecco che quei mille euro sono spalmati su centinaia di ore, festivi, notturni, niente permessi, sabati e domeniche, soprusi, angherie. E idee belluine, come quella di un ristoratore di Genova che ha buttato lì la sua proposta: “Mancia obbligatoria per legge, così avremo più dipendenti”. Ecco fatto, da reddito a mancia, che ci voleva? Resta da cambiare un articoletto della Costituzione, il primo: una Repubblica basata sulla mancia. Diciamolo, è ben trovata, ma siccome la realtà impone di guardare avanti, già me la vedo applicata alla sanità: “Non ci deve niente, signora, ma dia la mancia al chirurgo”.
L’intervista di Gabriele Micciché su Milano, il noir, Monterossi e altro, pubblicata sul Magazine del Touring Club Italiano (maggio 2022). Le foto sono di Marco Garofalo (clicca per leggere)
 Onestamente, non guardo i talk show da quando ho scoperto che sugli altri canali c’è il wrestling, o addirittura, le sere fortunate, il catch nel fango, posti dove la dialettica mi sembra più avanzata. Non che non mi interessi l’entusiasmante sviluppo di idee che si genera quando qualcuno è chiamato a intervenire sulle sorti del mondo in ventitré secondi netti, che poi c’è la pubblicità; anzi, a volte, visti certi ospiti, ventitré secondi mi sembrano pure troppi. Certo, ci sono anche aspetti positivi, cioè, uno si sente ringiovanire se accende la tivù e si imbatte in un Luttwak, per esempio, che dice le cose che diceva – nello stesso posto, alla stessa ora, con le stesse parole – una ventina d’anni fa (Iraq, Afghanistan…), anche quando aggiunge che lui ha fatto tre guerre, si è trovato benissimo e ci consiglia l’esperienza.
Onestamente, non guardo i talk show da quando ho scoperto che sugli altri canali c’è il wrestling, o addirittura, le sere fortunate, il catch nel fango, posti dove la dialettica mi sembra più avanzata. Non che non mi interessi l’entusiasmante sviluppo di idee che si genera quando qualcuno è chiamato a intervenire sulle sorti del mondo in ventitré secondi netti, che poi c’è la pubblicità; anzi, a volte, visti certi ospiti, ventitré secondi mi sembrano pure troppi. Certo, ci sono anche aspetti positivi, cioè, uno si sente ringiovanire se accende la tivù e si imbatte in un Luttwak, per esempio, che dice le cose che diceva – nello stesso posto, alla stessa ora, con le stesse parole – una ventina d’anni fa (Iraq, Afghanistan…), anche quando aggiunge che lui ha fatto tre guerre, si è trovato benissimo e ci consiglia l’esperienza.
Ora apprendo che il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) manderà qualcuno con gli occhiali neri e l’auricolare a fare il buttafuori negli studi televisivi, perché si teme che tra quelli che urlano “Io non l’ho interrotta!” e “Mi lasci parlare!”, si annidino spie russe che possono fregare micidiali segreti bellici, tipo un microfono, o un tubetto di eyeliner in sala trucco. Non credo che la nostra democrazia reggerebbe il colpo, facciamo bene a difenderci.
In sostanza va ripensata la formula dei talk show, adeguandoli al mondo nuovo, che sembrerebbe un posto dove siamo in guerra anche se la guerra la fanno altri. Spese militari di guerra, discorsi di guerra, economia di guerra, bollette di guerra, ovvio che ci vogliono anche talk show di guerra, dove al massimo sia concesso dissentire su come si scavano le trincee o come si carica un lanciarazzi, ma le divergenze devono finire lì. Porca miseria: pensa se eravamo in guerra! Del resto, si sa che la guerra si fa in due, ma guai ad essere in due a discuterne: quando mai avete visto un irakeno in un talk show? E un afghano? E un siriano?
Anche l’uso dei sondaggi nei talk show andrebbe regolamentato, possibilmente con una legge di un solo articolo: si possono pubblicare sondaggi solo se in linea con la sicurezza della Repubblica. Il fatto che la maggioranza degli italiani risulti contraria all’invio di armi in Ucraina (per tutti gli istituti di ricerca, con percentuali che vanno dal 48 al 60 e passa) è di per sé strumentale e fuorviante: che cazzo vogliono gli italiani, eh! Chi si credono di essere? Ma ‘sta legge ancora non c’è, e allora ci si adatta, spesso piegando la statistica a domande carpiate con doppio avvitamento: “Lei è d’accordo con chi è contrario all’invio di armi?”. Ben pensata: la percentuale rimane alta, ma almeno davanti al numero c’è scritto “sì”, è tutto bellissimo.
Naturalmente il Copasir ha poteri limitati, non può nulla contro le dinamiche televisive, o gli ego debordanti o le sceneggiate concordate in camerino. Peccato, perché se la sicurezza della Repubblica fosse veramente tutelata – anche dal ridicolo – avrebbe impedito gli scontri fisici e le urla belluine, per esempio tra Sgarbi e Mughini. Però bisogna anche tenere conto dell’opinione di quelli che difendono la formula talk show: avrà i suoi limiti ma gli italiani imparano qualcosa e si interrogano sulle questioni più disparate e spinose. Per esempio, quello che si sono chiesti tutti: “Urca, ma ancora sta in giro Mughini?”, oppure “Toh, ma ancora invitano Sgarbi?”. Insomma, vedete? Si fa anche informazione. Però mi raccomando: al Copasir, a scegliere gli ospiti, metteteci uno più bravo.
Qui alcune recensioni uscite sul Web: Gas, Milano Nera, Contorni di noir, Quotidiano Nazionale, SoiloLibri. Grazie grazie (cliccare per leggere)
 Il Ruanda è bello ma non ci vivrei, però se sei un immigrato irregolare in Gran Bretagna potrà capitarti. Boris Johnson ha annunciato qualche settimana fa in pompa magna l’intenzione di trasferire i migranti che la Gran Bretagna non vuole accogliere, nel ridente (?) paese africano, descritto dallo stesso Johnson come una specie di Bengodi, con il pil che cresce, e insomma, una terra delle opportunità dove gli immigrati potranno “far parte di un nuovo Rinascimento” (giuro, ha detto così, sta cosa del Rinascimento è sfuggita di mano, diciamo). E così il migrante che voleva andare a Londra si troverà benissimo alla periferia di Kigali, toh, che sciccheria!
Il Ruanda è bello ma non ci vivrei, però se sei un immigrato irregolare in Gran Bretagna potrà capitarti. Boris Johnson ha annunciato qualche settimana fa in pompa magna l’intenzione di trasferire i migranti che la Gran Bretagna non vuole accogliere, nel ridente (?) paese africano, descritto dallo stesso Johnson come una specie di Bengodi, con il pil che cresce, e insomma, una terra delle opportunità dove gli immigrati potranno “far parte di un nuovo Rinascimento” (giuro, ha detto così, sta cosa del Rinascimento è sfuggita di mano, diciamo). E così il migrante che voleva andare a Londra si troverà benissimo alla periferia di Kigali, toh, che sciccheria!
E’ probabile che ci siano parole più gentili, ma “deportazione” è quella che mi viene in mente ora. A leggere le cronache e le dichiarazioni, la cosa sarebbe semplice: se ritieni di fare richiesta d’asilo in Gran Bretagna e i tempi si fanno lunghi, vieni trasportato in Ruanda, dove aspetti il disbrigo della tua pratica. Se la domanda viene accolta, hurrà!, puoi farti una vita tua (in Ruanda, però, mica a Londra) e se invece viene respinta, il Ruanda ci pensa lui a espellerti (magari rimandandoti nel posto da cui stai scappando). La proposta è abbastanza articolata e potrebbe entrare in vigore presto.
Questa dell’esportazione di disperati sembrerebbe diventare una tendenza in tutta Europa. La Danimarca, per dirne una, i suoi migranti che abbiano commesso un reato su suolo danese, li manderà in galera, sì, ma in Kosovo. Accordo firmato, praticamente operativo. Una colonia penale nei Balcani è quello che ci vuole, dannazione, come non averci pensato prima? Il Kosovo, per cinque anni a partire dal 2023, incasserà quindici milioni all’anno per tenere in cella un po’ di delinquenti arrestati a Copenaghen. Anche la Danimarca, comunque sta studiando la pratica Ruanda, dove potrebbe esternalizzare, come la Gran Bretagna, le richieste di asilo. Il Ruanda, insomma diventerebbe una specie di campo profughi per gente che voleva andare a vivere in Europa, e che invece no, non c’è posto, spiace.
Non risultano grandi indignazioni, forse eventi più terribili e scenografici ci distraggono, ma insomma non si sono sentite in questi giorni di orgoglio europeo voci scandalizzate per la delocalizzazione della sfiga, dall’Europa al Centrafrica.
Eppure in tempi in cui si sprecano (spesso a vanvera) i paralleli storici, si potrebbe ricordare che spostare popolazioni e creare enclave non è una buona politica, in prospettiva. Stalin aveva questo vizietto, per dire: i tatari li mettiamo qui, gli osseti li mettiamo là, e poi ci sono guerre che durano cinquant’anni.
Per indignarsi, però, servirebbe una coscienza pulita, cosa che scarseggia, visto che sempre la famosa Europa dei diritti e dell’accoglienza paga soldoni sonanti a Erdogan per fare argine alle ondate migratorie da sud-est. Oppure che le autorità polacche ancora lasciano a dormire nei boschi, in una terra di nessuno, i migranti non ucraini che vengono da Oriente. Oppure che l’Italia paga profumatamente una specie di guardia costiera libica incaricata di riportare i migranti in fuga nei “lager” (cfr. papa Francesco) in Libia. Insomma il nuovo business europeo diventerà presto l’esportazione del povero, del fuggiasco, del nullatenente, il che fa un po’ a pugni con la retorica dell’accoglienza di questi giorni e con l’orgoglio democratico di un continente intero. E’ l’Europa, bellezza, oggettivamente uno dei posti dove si vive meglio nel mondo. E quindi, Benvenuti in Ruanda.
 Problemi con le bollette? L’inflazione vi morsica? Il potere d’acquisto vi sfugge di mano? Il vostro stipendiuccio si accorcia ogni anno del 6-8 per cento? Non disperate amici, c’è sempre una via d’uscita. Comprate armi! Cioè, almeno, comprate azioni di aziende che inventano, producono, vendono armi, un affare che non conosce crisi, anzi cresce ininterrottamente da sette anni, pandemia o non pandemia. Per la prima volta nella storia la spesa militare globale ha superato i 2.000 miliardi di dollari (vediamo se così si capisce meglio: 2.000.000.000.000 dollari), una cifra che fa sembrare Elon Musk un barbone che dorme sotto i ponti, figuratevi noi.
Problemi con le bollette? L’inflazione vi morsica? Il potere d’acquisto vi sfugge di mano? Il vostro stipendiuccio si accorcia ogni anno del 6-8 per cento? Non disperate amici, c’è sempre una via d’uscita. Comprate armi! Cioè, almeno, comprate azioni di aziende che inventano, producono, vendono armi, un affare che non conosce crisi, anzi cresce ininterrottamente da sette anni, pandemia o non pandemia. Per la prima volta nella storia la spesa militare globale ha superato i 2.000 miliardi di dollari (vediamo se così si capisce meglio: 2.000.000.000.000 dollari), una cifra che fa sembrare Elon Musk un barbone che dorme sotto i ponti, figuratevi noi.
E’ il mercato, bellezza. Se si sommano i fatturati dei primi venticinque gruppi che producono armi, l’incremento (dati 2019, Stockholm International Peace Research Institute, Sipri) è di 631 miliardi, più o meno l’8,5 per cento. Coraggio, nessun fondo di investimento, assicurazione, o portafoglio di obbligazioni, vi darà lo stesso risultato. Pensateci!
Come per tutte le merci hi-tech – l’irresistibile fascino dell’ultimo modello – domina la componente “sexy” dei prodottini elencati nei siti dei principali produttori, con qualche comprensibile paraculata di marketing. Per esempio, la prima azienda produttrice di armi nel mondo, la Lockheed Martin, apre la sua home page con una bellissima spianata di pannelli solari. Uh, che bello, energia pulita, ecologia, tutto verde, verrebbe da compiacersi, ma è un trucchetto per i gonzi, perché poi si scopre che il fatturato del comparto armamenti dell’azienda rappresenta l’89 del business, più di 50 miliardi di dollari (all’anno) di fatturato. E infatti basta scendere un po’ nella home page e si comincia a ragionare: missili, cacciabombardieri, elicotteri, blindati collegati tra loro con il 5g e via elencando. Quanto basta per far dire ai governi di mezzo mondo: “Oh no! Abbiamo il modello vecchio!”.
Lo stesso vale più o meno per le altre aziende della top ten, un catalogo di fantascienza già disponibile, come dice un bello slogan sul sito del Northrop Grumman (86 per cento del fatturato in armamenti, pari a quasi 30 miliardi di dollari): “Per qualcuno la parola ‘impossibile’ chiude le discussioni. Per noi è un punto di partenza”. Bene, mi sento più tranquillo, anche voi, vero. amici?
La Rayteon Technologies, invece (87 per cento del fatturato in armamenti, oltre 25 miliardi) apre la sua home page con una bella immagine di foresta vergine attraversata da un fiume azzurrissimo e il titolo: “Gente, pianeta e principi”, video che si alterna con immagine di eliche, motori. Anche qui per capire che si vendono armi micidiali bisogna scarrellare un po’ con il mouse. E anche qui, però, la guerra non si vede mai: niente corpi smembrati, niente case distrutte, nessuna immagine “brutta”, solo satelliti, spazio profondo, sistemi radar, impiegati sorridenti davanti a schermi avveniristici. Insomma, tra i primi dieci produttori mondiali, cinque sono americani, il sesto è cinese, Avic (affari di armi per 22 miliardi e mezzo, 34 per cento del fatturato), seguono un’azienda britannica (Bae Systems), altre due cinesi e un’americana a chiudere la top ten.
Noi, poverini, giochiamo a mezza classifica, dodicesimi con Leonardo, poco più di 11 miliardi di fatturato negli armamenti (il 72 per cento del fatturato del gruppo). Dannazione, ma si può fare di meglio, e ci è stato spiegato recentemente che la spesa militare è un volano per l’economia. E voi, amici, volete la pace o il volano acceso?
 Domenica si vota in Francia, si decide se tenersi l’usato sicuro di Macron o gettarsi dalla rupe verso madame Le Pen, una specie di Meloni francese ma meno corteggiata dai media. Cinque anni fa i francesi si trovarono di fronte allo stesso identico dilemma: votare Macron sennò arriva Le Pen, quando si dice la continuità. Insomma, turatevi il naso e votate Macron, non so se vi ricorda qualcosa.
Domenica si vota in Francia, si decide se tenersi l’usato sicuro di Macron o gettarsi dalla rupe verso madame Le Pen, una specie di Meloni francese ma meno corteggiata dai media. Cinque anni fa i francesi si trovarono di fronte allo stesso identico dilemma: votare Macron sennò arriva Le Pen, quando si dice la continuità. Insomma, turatevi il naso e votate Macron, non so se vi ricorda qualcosa.
Assiste basito allo scontro un popolo intero, gli elettori di sinistra, quelli della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Avrebbero potuto andare al ballottaggio se altre tribù di sinistra li avessero seguiti: trotzkisti, socialisti, comunisti. Diciamo tanto della nostra, ma anche la sinistra francese sembra il bar di Guerre Stellari.
Dunque lo scenario che si apre è il seguente. Vince Macron, tutto bene, per circa sessanta secondi la Francia liberale si mostrerà riconoscente agli elettori di sinistra, – bravi, responsabili! – e poi tornerà al lavoro come prima. Oppure vince Le Pen, e allora la sinistra si prenderà la colpa, brutti stronzi che preferite la signora fascista a Macron, non vi vergognate? Uccidete l’Europa, eccetera, eccetera.
Il modello francese differisce per molti piccoli particolari da quello italiano. Intanto là si tratta del 22 per cento dei votanti, non poco. Un francese su cinque è disposto ad ascoltare con attenzione (fino a votarlo alle presidenziali) un discorso che cambia i parametri, una sinistra popolare abbastanza radicale, di classe, quella che qui da noi quasi non esiste e viene chiamata con disprezzo sinistra-sinistra, sbertucciata in ogni modo, cosa che non stupisce in un clima di rivalutazione della svastica.
Non è un caso che Mélenchon passi qui, sui titoloni dei giornali, come il “Populista”, o addirittura l’“Antisistema”; cioè si gioca la solita carta della delegittimazione, mettendo insieme al tradizionale derby destra-sinistra (uff!) un altro più attuale scontro di civiltà: i futili sognatori-guastatori e i professionisti competenti (?). Segno dei tempi, ma, a conferma, basta fare la prova infallibile dell’insulto. Nel secolo scorso, se dicevi “Ehi, al posto delle armi, spendiamo quei soldi in case popolari!”, eri un fesso comunista. Se lo dici oggi sei un fesso populista. Ne abbiamo fatta di strada, eh!
La lezioncina francese non servirà a niente. Ed è destinata a riproporsi qui, sempre nelle dimensioni della piccola farsa locale, quindi una specie di caricatura. I contorni sono più sfumati, anche perché qui una sinistra-sinistra o non c’è o è microscopica, e c’è invece abbondanza di sinistra-destra, quella che segue Draghi senza se e senza ma, e vota in Parlamento con Brunetta e Giorgetti.
Chi lo sa se esiste anche qui, come al di là delle Alpi, un’area culturale e politica che vagamente guarderebbe a un cambio di sistema, a un ribaltamento dei parametri sociali. Si direbbe di no, a giudicare dai sondaggi. Ma si direbbe anche di sì, se si pensa che almeno quattro italiani su dieci non votano, un po’ disgustati. Il voto di questi disperati è già oggetto di scandalo: si piegheranno verso le destre, la sora Le Pen nostrana e il baciatore di salami, oppure verso i sostenitori del draghismo illimitato? Avvertenza: chi si metta in testa di rispettare una sana pregiudiziale antifascista (quindi no Meloni), ma anche di non votare chi abbia sostenuto il governo Draghi, si metterà un po’ nei pasticci. Non è un paese per giovani, né per vecchi, né per donne, né per bambini, né per non allineati, che fa brutto e poi ti dicono “populista”.
Qui l’intervista a Maremosso, il magazine online di Feltrinelli (video)
 Mi sembra di capire una cosa, nel rumore di fondo: che le parole sono un po’, vagamente, lontanamente, di sinistra; e poi le cose, le azioni, sono di destra, mi scuso per la semplificazione, ma andiamo con disordine. Si è già detto della neolingua orwelliana che pervade il Paese, dove per dire che si arma una guerra si parla di pace e di condizionatori d’aria, ché non è bello dire “burro o cannoni?”, è sempre meglio dire “miele o marmellata?”, anche se poi si fa casino e non si capisce più niente. Quiproquò che nasce da un’equazione data per scontata (più armi a loro e più spese militari a noi uguale pace. Mah, spero sia lecito dubitare). Ma qui non parliamo di politica, ci limitiamo alle parole e in particolare alle parole coprenti come il minio antiruggine, le parole che dicono il contrario di quello che si fa.
Mi sembra di capire una cosa, nel rumore di fondo: che le parole sono un po’, vagamente, lontanamente, di sinistra; e poi le cose, le azioni, sono di destra, mi scuso per la semplificazione, ma andiamo con disordine. Si è già detto della neolingua orwelliana che pervade il Paese, dove per dire che si arma una guerra si parla di pace e di condizionatori d’aria, ché non è bello dire “burro o cannoni?”, è sempre meglio dire “miele o marmellata?”, anche se poi si fa casino e non si capisce più niente. Quiproquò che nasce da un’equazione data per scontata (più armi a loro e più spese militari a noi uguale pace. Mah, spero sia lecito dubitare). Ma qui non parliamo di politica, ci limitiamo alle parole e in particolare alle parole coprenti come il minio antiruggine, le parole che dicono il contrario di quello che si fa.
Per esempio sentire Enrico Letta, segretario del Pd, citare con ammirazione Alexander Langer, grande intellettuale pacifista troppo presto scomparso, è una cosa che fa piacere. Però ti chiedi anche: come è possibile che il segretario di un partito che ha votato un aumento spaventevole delle spese militari non più tardi di qualche giorno fa, aderisca idealmente al quel pensiero? E’ come se il generale Patton leggesse Bertold Brecht prima dell’assalto alla trincea nemica. Paradosso esagerato, ok, cambio: è come quando Salvini dice che gli piace De André; che non potendo pensare che si sia sbagliato De André, tocca pensare che si sbaglia Salvini.
Ripeto che non voglio qui affrontare la questione politica, ma soltanto quello stridore, tipo unghie sulla lavagna, che provocano certe distonie. Tutti hanno lodato la bella intervista al Papa di Fabio Fazio. Intervista in cui il papa chiamava “lager” i centri di detenzione libici, poi vai a vedere quelli che applaudono (bravo Papa!) e scopri che hanno votato i decreti Minniti, i trattati con le tribù, le motovedette alla guardia costiera libica. (Tranquilli, la settimana dopo il Papa era già diventato filo-Putin, devozioni che vanno e vengono, insomma).
C’è come una copertura mimetica a certi comportamenti, un maquillage fatto, appunto, di parole, di buoni propositi, di citazioni progressiste, cui seguono comportamenti che smentiscono tutto. Tipo “Uh, che brava Rosa Parks!”, e poi quando (Macerata) c’è una tentata strage di neri, si sconsigliano manifestazioni perché “non è il momento”. Insomma, un gran progressismo, anche burbanzoso e vibrante d’orgoglio, sempre pronto a spolverare eroi e miti, principi inviolabili e valori, e poi, colpo di scena, si fa l’esatto contrario. Lo stesso, immancabile testacoda, quando si parla di lavoro, e senti esponenti della sinistra, ragionevoli e convincenti, auspicare più diritti e protezioni per i lavoratori. Poi vai a vedere e hanno votato il Jobs act. Oppure si sentono (rarissimamente) parole sensate sulle morti sul lavoro, e poi gli stessi che le pronunciano hanno fatto parte di governi che hanno allentato i controlli, reso più difficili le ispezioni, oppure votano, in questo governo, insieme a un ministro (Brunetta) che dice che le aziende saranno avvisate prima di eventuali controlli. Dire cose di sinistra pare insomma abbastanza facile, fa chic e non impegna. Anzi, a volte, per paradosso, l’uso di un linguaggio progressista avvalora comportamenti di segno opposto. Una cosa come: se citi Gandhi puoi comprare più cannoni. Se citi Di Vittorio puoi scrivere le leggi con Confindustria. Un vortice, un lessico della sinistra che copre il contrario di quel che si dice.
 “Non c’è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro”, scriveva Kurt Vonnegut (Mattatoio n. 5). Aveva ragione, niente pare doloroso e prevedibile come il fiume di parole che insegue in questi giorni i poveri fantasmi di Bucha, civili innocenti ammazzati con le mani legate, o torturati, o fucilati e lasciati lì, un po’ per monito e un po’ per mettere un timbro sull’impunità di chi fa a guerra. E già ticchetta l’osceno ping pong dei paragoni, un chiedersi attonito se Bucha valga My Lai, o l’Iraq, o Srebrenica, o Aleppo, perché una barbarie, poi, pare un po’ meno barbara se la metti vicino ad altre barbarie, se in qualche modo l’archivi; come se storicizzare fosse un po’ cauterizzare le ferite, e – alla fine – farsene una ragione.
“Non c’è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro”, scriveva Kurt Vonnegut (Mattatoio n. 5). Aveva ragione, niente pare doloroso e prevedibile come il fiume di parole che insegue in questi giorni i poveri fantasmi di Bucha, civili innocenti ammazzati con le mani legate, o torturati, o fucilati e lasciati lì, un po’ per monito e un po’ per mettere un timbro sull’impunità di chi fa a guerra. E già ticchetta l’osceno ping pong dei paragoni, un chiedersi attonito se Bucha valga My Lai, o l’Iraq, o Srebrenica, o Aleppo, perché una barbarie, poi, pare un po’ meno barbara se la metti vicino ad altre barbarie, se in qualche modo l’archivi; come se storicizzare fosse un po’ cauterizzare le ferite, e – alla fine – farsene una ragione.
La guerra è una faccenda che appartiene alla Storia, e si cristallizza lì, senza insegnare a nessuno il modo di non fare altre guerre, peraltro. Ma la guerra è anche una faccenda terribilmente personale, se finisci morto o torturato in una strada del tuo paese. Tra questi due estremi – tra il cinismo del Grande Disegno Geopolitico Globale e il terrore gelato dell’attesa di un colpo in testa, le mani legate dietro la schiena – lì, nel mezzo, sta tutta l’irredimibile merda della guerra. Meccanismo poderoso, che muove strategie e imperi, e interessi, e miliardi di tonnellate di gas, o petrolio, o armi, o soldi, dollari, euro, rubli – e dove poi rimane stritolato un innocente da qualche parte, magari faceva il panettiere, o la moglie, o il figlio, o gente che scappava.
Nell’orribile caleidoscopio di immagini che scorre in questi giorni, ci sono stati mostrati anche i presunti colpevoli, chi lo sa se poi sono loro, ma insomma, dei ragazzotti siberiani dell’unità 51460, facce da liceali ripetenti, militari della Jacuzia, lassù, lontanissima da Kiev. Chissà se si riuscirà ad accertare le responsabilità vere, personali, in quei solenni teatri che sono le aule della Corte Penale Internazionale dell’Aja sui crimini di guerra (della quale peraltro Russia, Cina e Stati Uniti, non hanno mai voluto aderire, o non hanno ratificato i trattati). E non dovremo stupirci se poi, a un certo punto, sentiremo rimbalzare una delle frasi simbolo del Novecento, la più schifosa: “Ho solo eseguito degli ordini”. E dunque tutto pare già scritto e già tutto sfuma nelle nebbie delle propagande incrociate, nell’ostensione dei martiri in prima pagina, che mischia un doveroso “è giusto sapere” a un nuovo terrificante uso di quei morti: più armi! Più missili! Più carrarmati! Insomma, “più guerra” – è la risposta – non “meno guerra”; e quindi più barbarie.
Così succede che la guerra infetta ogni cosa. In guerra fanno carriera i peggiori, gli istinti più orribili vengono premiati, incoraggiati, l’assenza di pietà è un notevole valore, come si è visto in ogni posto dove sia passata. E dietro, nelle retrovie – anche questo si sa da sempre – fanno affari i più cinici, quelli che scommettono sul prolungarsi del conflitto, che cementano nazionalismi, che soffiano sul fuoco, che vendono armi, eccetera eccetera. Tutte cose che si sanno, ed eccoci, oplà, ricaduti nel grande gioco della Storia, in cui le vite dei caduti civili e innocenti scompaiono di nuovo, smettono di essere vite reali, storie personali, e diventano statistiche, casi di scuola da rimbalzarsi addosso per sostenere tesi, o teorie, o ricostruzioni, e ognuno avrà il suo massacro di riferimento, che coi poveri massacrati non c’entra più quasi niente, anche se la guerra sono loro.
Qui un paio di articoli sul nuovo romanzo. La Libertà di Piacenza e una bella recensione di Alessandro Marongiu sul La Nuova Sardegna
Qui ci sono l’intervista di Alessandra Tedesco a Il Cacciatore di Libri su Radio 24 e la bella recensione di Antonella Lattanzi su La lettura
 Niente, mannaggia, niente da fare. Gli italiani in stragrande maggioranza restano contrari all’aumento delle spese militari fino al due per cento del Pil, cioè un po’ restii a spendere 13 miliardi in più (ogni anno!) in sistemi d’arma, gerarchie militari, missili e quant’altro. Resistono, insomma, all’offensiva dei corsivisti-generali più accreditati dai media, dai giornali e dai talk show, quasi tutti maschi, quasi tutti anziani, boomer burbanzosi e predicanti, autori di sermoni edificanti e patriottici, disposti a chiudere un occhio persino sui nazisti in campo. Fedeli insomma, al vecchio adagio americano applicato a dittatori, macellai e golpisti vari: “E’ un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana”.
Niente, mannaggia, niente da fare. Gli italiani in stragrande maggioranza restano contrari all’aumento delle spese militari fino al due per cento del Pil, cioè un po’ restii a spendere 13 miliardi in più (ogni anno!) in sistemi d’arma, gerarchie militari, missili e quant’altro. Resistono, insomma, all’offensiva dei corsivisti-generali più accreditati dai media, dai giornali e dai talk show, quasi tutti maschi, quasi tutti anziani, boomer burbanzosi e predicanti, autori di sermoni edificanti e patriottici, disposti a chiudere un occhio persino sui nazisti in campo. Fedeli insomma, al vecchio adagio americano applicato a dittatori, macellai e golpisti vari: “E’ un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana”.
Il sondaggio è canaglia, insomma, e un po’ canaglia anche chi lo disegna. Non ci eravamo ancora ripresi dal grafico diffuso da Agorà (Rai3), dove nella torta colorata i contrari all’invio di armi all’Ucraina sembravano meno della metà pur essendo il 55 per cento, che ecco un altro strabiliante sondaggio, questa volta Swg per il Tg de La7. Capolavoro, perché il titolo in maiuscolo dice “L’aumento delle spese militari” e sotto con tanto di colonne colorate dice “D’accordo” 54 per cento. Urca! Poi, uno pignolo va a leggere la domanda fatta al campione rilevato , e trasecola: “Lei è d’accordo con la seguente affermazione: Non è giusto che l’Italia aumenti le spese militari…”. E’ la prima volta che si vede un sondaggio con la negazione incorporata. E’ d’accordo che non sia giusto… davvero bizzarro. Forse chiedere direttamente “Secondo lei è giusto?” esponeva a qualche rischio in più. Trucchetti.
Qualcuno – temerario – spiega che questo benedetto aumento delle spese militari non c’entra nulla con l’invasione russa dell’Ucraina, che se ne parla da tempo, che gli americani ce lo chiedono da anni, ed ora – vedi a volte le coincidenze – è venuto il momento. Per inciso, i dati Sipri (Stockholm International Peace Research Institute, uno degli osservatori più qualificati sul mercato degli armamenti) dicono che la Nato spende ogni anno circa 17 volte quello che spende la Russia, e anche togliendo le cifre spaventose degli Stati Uniti, calcolando soltanto le spese militari attuali di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, si ha quasi il triplo della spesa militare russa. Pare che non basti.
Non è detto che gli italiani che rispondono ai sondaggi conoscano queste cifre (anche perché nessuno gliele dice), eppure si registra una resistenza ultra-maggioritaria nel voler spendere 13 miliardi in più all’anno in cannoni. C’è da capirli. Forse ricordano le solenni parole di Mario Draghi pronunciate quasi un anno fa: “Non è il momento di prendere soldi ai cittadini, ma di darli”. Bel programma. Peccato che in questi undici mesi (Draghi lo disse nel maggio del 2021 con grande plauso di tutti) non risulti agli italiani di aver migliorato sensibilmente le proprie condizioni di vita: tra inflazione al cinque per cento coi salari fermi, le bollette, la benzina e gli alimentari che aumentano. Ora si vedrà dove prendere tutti questi soldi, ma sotto sotto la notizia è buona: dopo anni passati a dire che “non ci sono i soldi” per scuole, sanità, servizi, oplà, ecco 13 miliardi che escono dal cilindro, magia e mesmerismo. Urge nuovo sondaggio: “Lei è d’accordo con la seguente affermazione: non è giusto dire che non è giusto rifare i tetti delle scuole o i prontosoccorso invece di comprare missili? E’ giusto dire che è sbagliato?”. Vediamo come disegnano il grafico.
 Come ogni avvenimento che colpisce nel profondo, anche la guerra sta lentamente formando il suo Lessico Nazionale Bellico, un impasto di parole, immagini, composizione formale e commento, fotogramma simbolico e didascalia. A volte pietoso, a volte porno-war, riflessivo raramente, emotivo quasi sempre. L’affresco della guerra, insomma, come si dice per dire di una rappresentazione complicata, densa, piena di dettagli che alla fine danno un quadro d’insieme. In questo marasma di segni si ritrovano vizi antichi e anche recenti. Antichi come sono quelli delle propagande incrociate, che debordano ogni tanto nel ridicolo, ma che a guardarle rivelano molto di noi. Caso di scuola: il teatro di Mariupol, usato dai civili ucraini come rifugio, bombardato dai russi. Grandi grida di strage e poi grande sollievo perché miracolosamente non ci è rimasto sotto nessuno e sono tutti vivi. Mi sembrerebbe questa la notizia: tutti salvi, meno male. Invece si è cominciato a litigare tra chi aveva dato tanto spazio alla strage, e poi niente allo scampato pericolo, e viceversa, come se rallegrarsi per una mancata strage possa considerarsi intelligenza col nemico. Premesso, ovviamente, che non si bombardano i teatri né, possibilmente, nessun’atra cosa.
Come ogni avvenimento che colpisce nel profondo, anche la guerra sta lentamente formando il suo Lessico Nazionale Bellico, un impasto di parole, immagini, composizione formale e commento, fotogramma simbolico e didascalia. A volte pietoso, a volte porno-war, riflessivo raramente, emotivo quasi sempre. L’affresco della guerra, insomma, come si dice per dire di una rappresentazione complicata, densa, piena di dettagli che alla fine danno un quadro d’insieme. In questo marasma di segni si ritrovano vizi antichi e anche recenti. Antichi come sono quelli delle propagande incrociate, che debordano ogni tanto nel ridicolo, ma che a guardarle rivelano molto di noi. Caso di scuola: il teatro di Mariupol, usato dai civili ucraini come rifugio, bombardato dai russi. Grandi grida di strage e poi grande sollievo perché miracolosamente non ci è rimasto sotto nessuno e sono tutti vivi. Mi sembrerebbe questa la notizia: tutti salvi, meno male. Invece si è cominciato a litigare tra chi aveva dato tanto spazio alla strage, e poi niente allo scampato pericolo, e viceversa, come se rallegrarsi per una mancata strage possa considerarsi intelligenza col nemico. Premesso, ovviamente, che non si bombardano i teatri né, possibilmente, nessun’atra cosa.
Fa parte del Lessico Nazionale Bellico, a pieno titolo, appunto, la premessa salvavita che conosciamo da decenni. Chiunque voglia avanzare anche soltanto una piccola critica o distinguo, o per esempio considerare un po’ avventato l’invio di armi in zona di guerra, farà bene a munirsi delle prime due righe di ogni discorso: “Premesso che non sto con Putin…”. Già visto. Non c’era discorso nei primi anni Ottanta che non iniziasse con “Premesso che sono contro il terrorismo…”, poi venne, “Ovvio che non sto con Bin Laden…”, poi: “Lo dico da vaccinato…”; insomma, quando il gioco si fa duro è necessario chiarire. E questa è una faccenda piuttosto divertente perché spesso si chiede questa condanna ovvia e preventiva a chi il nemico l’ha sempre schifato (anch’io avevo una maglietta russa, ma sopra c’era Anna Politkovskaja), mentre si continua a dare credito e spazio a chi col nemico divideva ideologie, faceva affari, gli vendeva armi. Mah, sarà uno strabismo di guerra.
Incredibile a dirsi, ma anche la formula “Terza Guerra Mondiale” è rispuntata fuori dalla sua coltre di paradosso ed enormità, dov’era stata confinata per anni. Usata come metafora di un disastro senza appello, la Terza guerra mondiale se ne stava nascosta nei nostri discorsi come una piccola innocua battuta, “Eh, che sarà mai, mica è la Terza guerra mondiale!”. E ora, eccoci. Non solo se ne parla come opzione e rischio, ma la si evoca come non così peregrina, la vicepremier ucraina dice che è già in corso, alcuni analisti del fronte interventista dicono che se non è ora sarà domani, quando Putin attaccherà di qua e di là. Insomma c’è sottotraccia, nel nostro linguaggio quotidiano sulla guerra, l’impossibile che diventa possibile, l’impensabile che viene – con discreta leggerezza – pensato. E già ci si diletta, su qualche giornale, a calcolare raggi e diametri di ipotetiche bombe atomiche che potrebbero cascare qui e là, una specie di gioco di società (“Uh, guarda, con centottanta megatoni in corso Como a Milano, se abiti a Sondrio te la cavi!”). E così, piano piano, si comincia a pensare l’impensabile, e la guerra arriva anche se non arriva davvero, cioè ne arrivano schegge e frattaglie. La guerra un po’ ridicola, un po’ teorica, non falsa e non vera.
Qui ci sono due piccole e preziose recensioni (uscite su L’Adige e Il Centro), e un’intervista di Francesco Mannoni uscita su Il Giornale di Brescia
Una piccola questione di cuore è partito, ora, come dire, fatene quel che volete. Metto qui un paio di uscite stampa, l’intervista all’Ansa (grazie a Mauretta Capuano) e una piccola recensione del Fatto Quotidiano (Fabrizio D’Esposito)
 Come tutti, oscillo. La guerra non mi è mai sembrata così vicina, e al tempo stesso così surreale. Quando ero giovane e studiavo, mi sono sempre immaginato i dibattiti interventisti/non interventisti come una faccenda alta, magari non colta, ma insomma, di un certo spessore e vigore. Forse non era così, e certo non è così oggi: la maggior parte delle analisi non mi sembrano all’altezza del momento e dei rischi. Alla lunga non ascolti più, ed è una fortuna.
Come tutti, oscillo. La guerra non mi è mai sembrata così vicina, e al tempo stesso così surreale. Quando ero giovane e studiavo, mi sono sempre immaginato i dibattiti interventisti/non interventisti come una faccenda alta, magari non colta, ma insomma, di un certo spessore e vigore. Forse non era così, e certo non è così oggi: la maggior parte delle analisi non mi sembrano all’altezza del momento e dei rischi. Alla lunga non ascolti più, ed è una fortuna.
Ogni tanto ascolti, a tuo rischio, esponendoti a un helzapoppin’ quotidiano. Ammirevole la copertina di Di Più che ci dice che Putin “Da bambino era un teppista”, decisivo contributo all’analisi geopolitica sull’aggressione, ma vabbé, fa pure un po’ ridere. Metteteci l’uso indiscriminatissimo di bambini, anche in posa (la Lolita di Kiev è ad oggi l’esempio più famoso, solidarietà alla ragazzina) e alcune retoriche un po’ risibili, Liala (avercene!) e petto in fuori. Troppo pop per essere vere, troppo caricaturali, al limite dell’autolesionismo semantico, dove il ridicolo sommerge il messaggio. Non accade solo da noi: vedere Macron, l’uomo più incravattato del mondo, indossare una felpa da parà strappa il sorriso: c’è una salvinizzazione del pianeta, non credo potrebbe andare peggio.
Di nostro specifico, pare notarsi un uso disinvolto della Storia, diciamo così teneramente spannometrico, che viene da pensare all’esame all’università: “Ma guardi che io un 18 non posso darglielo, perché non torna il mese prossimo? Ha qualche guaio in famiglia?”. Perdoniamo per pietà l’uso del termine “sovietico” che ormai è usato come sinonimo di russo. Un Putin talmente “sovietico”, tra l’altro, che ha dichiarato una guerra parlando male per mezz’ora di Lenin (cosa che quando lui lavorava nel Kgb l’avrebbe portato dritto in Siberia). Ci dice il Tg1 che “Nel 1905 a Odessa il popolo ucraino si ribellò ai bolscevichi”, con tanto di fotogrammi di Ėjzenštejn. E’ come Napoleone che vince a Waterloo. Irresistibile, viene in mente il John Belushi di Animal House, genio premonitore, e la sua grandiosa battuta: “Siamo forse stati con le mani in mano quando i tedeschi bombardarono Pearl Harbour?”.
La neolingua di Orwell vive il suo grande momento, il mezzo miliardo di euro (in aumento) che l’Ue spenderà per armare l’Ucraina, viene da un Fondo europeo che si chiama “Fondo per la pace”, European Peace Facility. Così è un po’ troppo, anche come neolingua, e anche come metafora; mi chiedo: costava troppo cambiare la carta intestata?
Non arriva fino a qui la propaganda russa, questo è male, perché sarà ridicola tanto quanto, risibile nei ragionamenti binari, minacciosa e stupida. E anche lei molto esperta di neolingua, dato che proibisce alla stampa di pronunciare e scrivere la parola “guerra”, proprio mentre cominciano a tornare a casa i corpi di ragazzini di leva morti in guerra. Vertigine.
Alla fine, con il combinato disposto di titolazione shock, piccole furbizie ideologiche, aperti schieramenti, brandelli sparsi di porno-war, chiacchiere da bar e paralleli storici campati per aria, la guerra si sfuoca, là in fondo. Un po’ intrattenimento, un po’ indignazione, un po’ abitudine, un po’ bolletta del gas. La guerra vera, quella che ammazza i corpi, svapora, diventa una paura vera e una visione vaga dietro una cortina densa fatta di bugie, paura e qualche compassione. C’è un verso di Gregory Corso che lo dice molto bene: “La pietà si appoggia al suo bombardamento preferito / e perdona la bomba”. Come al solito, sono meglio i poeti.
Se dobbiamo dare un nome alle assurdità che una guerra si porta appresso, sceglierei senza dubbio quello di Alexander Gronsky, la cui storia è rimbalzata sui giornali in questi giorni. Bravissimo fotografo, invitato a una prestigiosa mostra in Italia (a Reggio Emilia) e prontamente rimbalzato in quanto russo. Poi, quando hanno tentato di dirglielo – che non lo vogliamo perché è russo – hanno scoperto che era stato fermato dalla polizia (russa) perché manifestava contro Putin. In pratica, abbiamo applicato le sanzioni a un nostro amico. Non mi addentrerò nelle recenti rappresaglie contro la cultura russa, si è già sfiorato il ridicolo (per parlare di Dostoevskij dovresti parlare anche di scrittori ucraini – non che ne manchino – per una specie di par condicio letteraria). Più strabiliante l’annuncio della Siae di “sospendere i pagamenti alle società d’autore russe”, cioè di non pagare gli artisti russi che vendono qualche libro qui, o dirigono opere, o le cantano, o fanno qualunque altro lavoro che meriti la tutela della loro opera. In pratica si penalizza una categoria, quella della produzione culturale, che già viene bastonata in patria, tra censure, divieti, pressioni, media soffocati, persino parole vietate (“guerra”). Il poeta russo non prende i suoi cento euro dall’Italia, sai Putin quanto soffre.
Ora che in tivù sono tutti strateghi geopolitici-militari-campioni-di-Risiko, sarebbe bello che qualcuno indicasse un altro fronte, quello interno russo, quella che una volta si chiamava “la dissidenza”, e che oggi dimostra una notevole determinazione (manifestare contro la guerra a Mosca, o a San Pietroburgo, richiede abbastanza coraggio). Ed è anche innegabile che le due cartine non corrispondano, perché ora ci sono Europa e Russia divise da una guerra, ma se si guarda la mappa della letteratura europea, per dire, o della musica, sfido chiunque a tenere fuori i russi, e gli ucraini, impossibile. Forse dovremmo, invece che dire “russo, stai a casa tua”, offrirgli di venire qui, a dipingere o scrivere o cantare l’opera o fotografare. Cioè, se come si sostiene con molte ragioni, la guerra è una guerra imperiale di Putin, che porterà gravissimi danni anche al suo popolo, allora qui servono più russi, non meno russi; e il corso su Dostoevskij dovrebbe farlo RaiUno, per tutti.
Non è una cosa che riguarda solo il mondo culturale, ovvio. Qui ci aiuterebbe addirittura Brecht, a ricordarci che le guerre le perde sempre la povera gente, anche quando le vince.
Nel dibattito interno, invece, siamo al paradosso: chi parla di Putin come di un tiranno da anni, da decenni (la Cecenia, Anna Politkovskaja, il polonio nella minestra) viene ora accusato di intelligenza col nemico, pacifista malpancista, imbelle e altri epiteti da anni ‘20; mentre chi indossa l’elmetto più prontamente, governa insieme a chi amico di Putin lo è stato davvero, e vi risparmio la passerella polacca di Salvini, dimostrazione lampante che la guerra stermina tutto ma non il ridicolo. In più, se si fa la guerra ai russi (addirittura ai russi nati duecento anni fa) si alimenta la convinzione che si sia in guerra con un popolo, e non con il suo zar aggressore, e questo aumenterà le tensioni, non le appianerà di certo. Si sa che la guerra, per sua stessa natura, genera miopie varie, istinti di semplificazione, schieramenti netti, e del resto si tratta di un sistema piuttosto primitivo a cui media e comunicazione si accodano volentieri.
Usciti malconci dal pensiero unico sanitario, dove ogni accenno critico alla gestione della pandemia veniva interpretato come segnale di mattana pazzariella, terrapiattismo e magia nera, eccoci travasati direttamente nella mentalità bellica o-di-qua-o-di-là. Dunque lo dico subito: di qua. Il popolo ucraino non merita né i missili sulla testa né le mire imperiali dello zar. E casomai strabilia, dopo secoli, che siamo qui ancora a parlare di imperi e imperatori.
Ognuno metterà in atto un suo speciale atteggiamento rispetto alla guerra, chi non occupandosene, chi seguendo mosse e sviluppi minuto per minuto, chi improvvisando soluzioni geopolitiche elaborate su due piedi: tutti strateghi-generali, come prima erano tutti primari di infettivologia. Personalmente suggerirei qualche cauta resistenza, perché saranno anche passati duemilacinquecento anni, ma quel che diceva Eschilo è sempre vero, la prima vittima della guerra è la verità, e noi ci troveremo ad ondeggiare tra propagande contrapposte, notizie inventate, indiscrezioni, testimonianze, ricostruzioni che non saranno descrizione della battaglia, ma in molti casi la battaglia stessa. Già il tasso di testosterone è alto, l’elmetto è calcato sulla testa, l’unanimismo fortemente consigliato. Se ti permetti di dire che mandare armi in una zona di guerra è una cosa che ha sempre creato discreti casini, eccoti arruolato con Putin. Uguale se discetti delle cause e della storia pregressa: ti si colloca col nemico, come anche se citi di otto anni di guerra in Dombass. Eppure qui che Putin è un nemico lo si sa da sempre, e anzi c’è una data precisa che lo certifica, ed è il 7 ottobre 2006, quando spararono ad Anna Politkovskaja, la giornalista colpevole di informare su un’altra guerra dello zar, quella in Cecenia.
Ora dovrebbe esserci una sola parola ovunque, per la precisione “Cessate il fuoco”, ed è comprensibile che nessun pensiero complesso possa funzionare mentre c’è gente che spara ad altra gente. Purtroppo questa parola si sente poco, per ora prevale qualche isteria sparsa, e molte contraddizioni. Ad esempio, commentatori iperatlantici che hanno sempre irriso “i pacifisti”, quegli imbelli fancazzisti, e che ora li invocano alzando il ditino: “Dove sono i pacifisti? Eh?”. Poi i pacifisti arrivano, in tutta Europa, ma non sono più tanto graditi, perché si fa spazio la logica muscolare, pancia in dentro, petto in fuori, ci siamo rammolliti, presentat-arm! Nota in margine: sotto le bandiere della pace sfilano anche quelli che più di altri hanno inforcato la baionetta. Dunque si può chiedere pace votando in Parlamento per spedire missili, allo stesso modo in cui qualche settimana fa si poteva applaudire il papa sui lager libici pur avendo votato i decreti Minniti e gli accordi con la guardia costiera libica. Miracoli della guerra, accodarsi al “tacciano tutte le armi”, ma spingere per spedirne altre (peraltro ne abbiamo vendute parecchie ai russi almeno fino al 2014).
Insomma, consiglio di resistere, alle narrazioni di guerra che sono sempre tossiche, come sono tossiche le conseguenze: festeggiano i produttori di armamenti (guardate i segni più a doppia cifra nei listini di Borsa), riavremo le centrali a carbone e un nuovo stato d’emergenza. Non è difficile capire chi resterà schiacciato: per dirla con Brecht, “la povera gente”, di qua e di là, e questa è la guerra, sempre. Mentre qui ne faremo un uso interno, tra furbizie tattiche e simil-pacifisti con l’elmetto che fa molto “armiamoci e partite”.
 Siccome ci travolge l’infinitamente grande, la guerra eccetera, occupiamoci dell’infinitamente piccolo: un euro, un euro e mezzo. Lo so, è volgare parlare di soldi, e questa è una cosa che dicono soprattutto quelli che i soldi ce li hanno. Ma approfittiamo per una volta del fatto che la politica – cioè, pardon, i partiti – avranno a che fare con gli spiccioli, contanti, calcolati al millimetro, insomma con la vita reale della gente misurata in termini di budget di sopravvivenza. Non si parla, per una volta, dei millemila miliardi luccicanti che dovrebbero pioverci addosso secondo la narrazione corrente, ma della differenza tra 9 euro lordi all’ora (proposta del ddl Catalfo) e le offerte “a scendere” delle forze politiche, tutte o quasi, con emendamenti molto somiglianti che puntano a togliere dalla legge una piccola frasetta, questa: “E comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”. Lega, Forza Italia e Pd uniti nella lotta. In poche parole si vuole togliere il cartellino del prezzo. Si accetta l’idea che finalmente anche in Italia, come quasi ovunque, non si possa guadagnare meno di una certa cifra, e il problema – ovvio – diventa la cifra.
Siccome ci travolge l’infinitamente grande, la guerra eccetera, occupiamoci dell’infinitamente piccolo: un euro, un euro e mezzo. Lo so, è volgare parlare di soldi, e questa è una cosa che dicono soprattutto quelli che i soldi ce li hanno. Ma approfittiamo per una volta del fatto che la politica – cioè, pardon, i partiti – avranno a che fare con gli spiccioli, contanti, calcolati al millimetro, insomma con la vita reale della gente misurata in termini di budget di sopravvivenza. Non si parla, per una volta, dei millemila miliardi luccicanti che dovrebbero pioverci addosso secondo la narrazione corrente, ma della differenza tra 9 euro lordi all’ora (proposta del ddl Catalfo) e le offerte “a scendere” delle forze politiche, tutte o quasi, con emendamenti molto somiglianti che puntano a togliere dalla legge una piccola frasetta, questa: “E comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali”. Lega, Forza Italia e Pd uniti nella lotta. In poche parole si vuole togliere il cartellino del prezzo. Si accetta l’idea che finalmente anche in Italia, come quasi ovunque, non si possa guadagnare meno di una certa cifra, e il problema – ovvio – diventa la cifra.
Tanto per capire di quante vite si sta discutendo, ci sono almeno quattro milioni e mezzo di persone che guadagnano meno di nove euro lordi all’ora (lo dice l’Inps) e fissando quella soglia, quasi il 30 per cento dei lavoratori dovrebbe avere un aumento (questo lo dicono gli esperti del ministero del Lavoro). Segue il pianto solito di Confindustria: il salario minimo a nove euro lordi costerebbe alle imprese più di sei miliardi, tra tempi pieni, part-time, tenendo fuori il settore agricolo e quello domestico. Insomma, troppo: porterebbe il salario minimo italiano (quasi) al livello di quelli europei, appena sotto Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Chi vi credere di essere, un tedesco? Troppi soldi, sacrilegio.
Ora è probabile che si arriverà a infinite schermaglie sui centesimi, cioè i conti della serva, e la faccenda diventerà una battaglia di cifre, sistemi di calcolo, questioni politiche, mostrare muscoli ed esibire studi e grafici. Insomma, si litigherà molto su quell’euro e mezzo di differenza, perché le cifre che emergono nello stanco ribollire del dibattito politico partono da sette euro lordi l’ora fino ai nove previsti dal ddl. E’ un gioco a chi offre di meno.
Lasciamo dunque la faccenda alle schermaglie parlamentari, agli emendamenti, alle commissioni che dovrebbero riunirsi eccetera eccetera, non è difficile capire come andrà a finire: nove euro lordi l’ora verranno considerati una sciccheria, un lusso che il nostro sistema economico non può permettersi. Si parla di strumenti di verifica e controllo, di commissioni congiunte tra imprese e lavoratori (il che apre il fronte delle rappresentanze sindacali), addirittura sedute ai tavoli del Cnel, per decidere quanto vale, come minimo, un’ora di lavoro. Una cosa che rende piuttosto plastico e simbolico il vecchio detto “stare dalla parte dei lavoratori”. Di quanto? Di un euro? Due? Quanto si limerà da quei nove euro? Quanto si avrà il coraggio di dire: “No, con nove euro all’ora guadagnerebbero troppo!”. La partita è solo all’inizio, sui centesimi di lavoro, di tempo, di vite, si formeranno forse inedite maggioranze, lunghe discussioni, trappole e trucchetti. Uno spettacolo interessante per quasi cinque milioni di italiani, che poi, magari, andranno anche a votare.
 Impazza dunque la battaglia dei bonus, edilizia canaglia, delle truffe, del signor Gino con ventisei ditte di costruzioni e, per dipendenti, il cugino e il cane. Ora è in corso il tradizionale balletto, sei stato tu, no, sei stato tu, e comunque – lo dico come regola generale – se dai dei soldi a qualcuno, un sistema di controlli devi in qualche modo prevederlo. La rogna contabile (i vari bonus, anche senza truffe, succhiano oltre le aspettative e mancano soldi per coprirli) diventa subito una rogna politica. Però fatto sta: i bonus in sostegno al comparto edile fanno 38 miliardi, una bella sommetta. Siccome parlo da Milano, e qui si fa lo slalom tra cantieri, direi che la norma è stata “messa a terra” perbene, e conosco gente tutta contenta perché con la facciata rifatta il palazzo vale di più. Insomma, si vantano con me che con le mie tasse gli ho aumentato il valore della casa. Grazie. Prego. Rimane un retropensiero vergognoso e populista: ma se rifacevano le scuole, per dire, l’edilizia non si metteva in moto lo stesso? Guarda cosa vado a pensare.
Impazza dunque la battaglia dei bonus, edilizia canaglia, delle truffe, del signor Gino con ventisei ditte di costruzioni e, per dipendenti, il cugino e il cane. Ora è in corso il tradizionale balletto, sei stato tu, no, sei stato tu, e comunque – lo dico come regola generale – se dai dei soldi a qualcuno, un sistema di controlli devi in qualche modo prevederlo. La rogna contabile (i vari bonus, anche senza truffe, succhiano oltre le aspettative e mancano soldi per coprirli) diventa subito una rogna politica. Però fatto sta: i bonus in sostegno al comparto edile fanno 38 miliardi, una bella sommetta. Siccome parlo da Milano, e qui si fa lo slalom tra cantieri, direi che la norma è stata “messa a terra” perbene, e conosco gente tutta contenta perché con la facciata rifatta il palazzo vale di più. Insomma, si vantano con me che con le mie tasse gli ho aumentato il valore della casa. Grazie. Prego. Rimane un retropensiero vergognoso e populista: ma se rifacevano le scuole, per dire, l’edilizia non si metteva in moto lo stesso? Guarda cosa vado a pensare.
Ci sarebbe anche la questione della sicurezza. E qui mi illumina un tweet del ministro del lavoro Orlando che (10 febbraio) dice: “Tra le misure da adottare in tema di sicurezza sul lavoro dovremmosubordinare il rilascio del superbonus 110% e dei sostegni all’edilizia al rispetto di alcuni requisiti contrattuali”. Eh? Dovremmo? Come, dovremmo, non è già così? Cioè uno può aprire un cantiere, con o senza bonus, e avere operai arrampicati qui e là, ma senza contratto? Dovremmo subordinare… che dovendolo tradurre in italiano diremmo: cadere dal pero. Ora si tenterà con un emendamento, nel decreto correttivo al Sostegni Ter, vedremo, ma la sensazione che si chiuda la stalla quando i buoi sono già andati rimane forte e chiara.
Ma questa è cronaca di questi giorni, che ci mette un attimo a diventare chiacchiericcio, mentre la questione sostanziale, la vera questione politica, trascende il singolo bonus. E’ che da qualche anno, complice la pandemia e le falle da tappare in emergenza, la politica economica e la politica sociale sono diventate una mappa da gestire e governare a colpi di bonus. A fare l’elenco non ci si crede, e non parlo solo di quelli a sostegno delle categorie in crisi per il Covid. Bene, l’intervento dello Stato come pianificatore e regolatore economico non è niente male, non sarò certo io a lamentarmi. In più, strappa sempre un ghigno amaro vedere tutti i liberisti che allungano le mani verso i sostegni pubblici. I rischi del sistema sono però evidenti: in campo economico la scelta di quali settori favorire a colpi di bonus e quali no, è una valutazione politica, lo si vede oggi a proposito dell’edilizia, ma anche all’apparire del “bonus Terme” se ne era un po’ discusso, e in un anno elettorale rischia di diventare rissa perenne, si vedrà con il tradizionale decreto Milleproroghe. Le norme, le strettoie, le regole, insomma la curvatura di ogni bonus sarà oggetto di trattative, interessi, pressioni. Dall’altro lato – ancora più grave – c’è che la logica del bonus contagia la sfera del welfare e c’è il timore che alimentando questa logica si arriverà ad avere più bonus (da rifinanziare, rinnovare, rivotare, quindi sottoposti ai venti mutevoli della politica) che diritti (fissi e conclamati, uguali per tutti). Ecco, sommessamente suggerirei di pensare un po’ alla faccenda prima che si arrivi al “bonus elementari”, al “bonus analisi del sangue”, magari esultando per la straordinaria conquista.
 Grande Centro, ristorante pizzeria con giardino, forno a legna, matrimoni, cerimonie. Più mi addentro in questa faccenda del grande centro e meno ci capisco. Ma insomma, va molto di moda questa specie di curling politico di posizionarsi al centro, tutti al centro, in attesa di capire con quale legge si voterà, quella attuale, un proporzionale, e se sì con quale sbarramento, e insomma per ora il sistema più accreditato è il Salcazzellum, quindi la situazione è fluida.
Grande Centro, ristorante pizzeria con giardino, forno a legna, matrimoni, cerimonie. Più mi addentro in questa faccenda del grande centro e meno ci capisco. Ma insomma, va molto di moda questa specie di curling politico di posizionarsi al centro, tutti al centro, in attesa di capire con quale legge si voterà, quella attuale, un proporzionale, e se sì con quale sbarramento, e insomma per ora il sistema più accreditato è il Salcazzellum, quindi la situazione è fluida.
Il Grande Centro – vendono anche piccoli elettrodomestici – è tutto un fibrillare di sigle e di nuovi nomi, tipo Italia Viva doveva sposare Coraggio Italia e dar vita a Italia al Centro, con il che capirete che un buon copy avrebbe un futuro assicurato. Centro Centrissimo, Centro per Sempre, o anche Centro Arredo – vendono anche camerette – andrebbe bene.
Come avviene nelle grandi città, anche nel Grande Centro c’è un gran traffico, tutti incontrano tutti in appuntamenti segretissimi che il giorno dopo compaiono sui giornali. Berlusconi ha una corsia preferenziale dalla quale, di solito, “si sfila”, poi si rinfila, poi incontra Casini, poi guarda alla Lega, insomma tutte ‘ste baggianate sul Centro devono sembrargli un po’ ridicole, visto che il centro pensa di essere lui.
In tutta la faccenda, di centrista c’è solo l’egocentrismo, in effetti. Purtroppo, lo dico con la morte nel cuore, Coraggio Italia è un po’ in crisi perché il governatore della Liguria, Toti e il sindaco di Venezia, Brugnaro, hanno diverse visioni del Grande Centro, mannaggia, sai tipo Hegel e Kant, e quindi la situazione si fa drammatica. Resa incandescente dal fatto che con Brugraro si schiera Lupi, di Noi con l’Italia (giuro). Gli altri, invece, avevano adottato Mastella, perché in una banda uno col cervello ci vuole, e anche perché sennò Renzi e Toti al sud non li vota nessuno, cioè al Grande Centro vendono anche prodotti regionali dop. Per il resto: porte girevoli, cioè se ho capito bene il Grande Centro dovrebbe essere aperto ai residenti nel gruppo misto, a quelli di Forza Italia in crisi d’identità, alla pattuglia compatta di Italia Viva, ai totiani (o totici?).
Poi ci sarebbe un altro centro, che sarebbe quello di Calenda con più Europa, un grandioso polo aggregativo di idee e progetti che si attesta attualmente intorno al quattro per cento, se va bene. Qui, per non far coincidere sempre Centro e grisaglia ministeriale, si sceglie la via del punk: Calenda, “il centro mi fa schifo”. Gli sembra riduttivo, piccolo, mentre lui vuole un movimento “liberale, democratico, riformista europeista e serio”, dice che lui sarà il perno che riporterà Draghi al governo nel 2023. Ecco, bravo, faccia da perno.
Poi siccome c’è stato il festival di Sanremo e tutto il resto, ho perso un po’ di vista ‘sta cosa del Grande Centro, ma è certo che nel gioco c’è anche una corrente del Pd che esorta il segretario a “guardare al Centro” dato che nei 5 stelle prevale il cupio dissolvi. La situazione aggiornata – ma può cambiare tutto in pochi minuti – è che il Grande Centro resta una bella idea, bellissima, tranne alcuni piccoli particolari: non si sa chi lo farebbe, come, con chi, quando, perché, con quali voti, con quale legge elettorale, con quali leader e con quale programma. Dettagli. Sembrerebbe più un “che ci inventiamo adesso?”, solo che il cast è strampalato, la lite sempre in agguato, il melodrammatico “Mai con Tizio, mai con Caio” viene smentito dopo due giorni e si ricomincia da capo. Nell’indefessa costruzione del Grande Centro.
Metto qui la bella intervista che mi hanno fatto Corinne Naidet e Jacques Lerognon per la rivista francese Revue 813 (numero speciale sul polar e la musica) in occasione del festival Toulouse Polarizzatrice du Sud. Si parla di Dylan e dei romanzi e di come le due cose si sono intrecciate. Grazie grazie
 Ognuno ha le sue perversioni, ci mancherebbe. La mia, ieri, è stata bere avidamente le cronache del primo consiglio dei ministri del governo Draghi Due, che sarebbe il governo Draghi Uno dopo la scomparsa dei sogni quirinalizi del capo. Apprezzabili i toni sospesi tra l’epico e il fantasy, un po’ come se ci descrivessero una seduta della Tavola Rotonda, o una merenda dei ministri del Re Sole. Merende niente, però, lo dico subito, nemmeno il caffè, solo acqua. Poi l’applauso chiamato da Draghi per Mattarella rieletto – un bell’applauso! – poi gli sguardi bassi di chi ha qualcosa da farsi perdonare, poi piccole scaramucce (Giorgetti versus Speranza, Brunetta versus chissà chi), poi strette di mano. Poi l’orgoglioso giubilo per un Pil che veleggia verso il 6,5 per cento, cosa mai vista in tempi recenti, hurrà. Viene da chiedersi come mai Mattarella, appena rieletto dal Parlamento, abbia parlato chiaramente di “crisi economica”, forse si sbaglia lui che non vede il boom, forse si sbaglia Draghi che lo rivendica, non sottilizziamo.
Ognuno ha le sue perversioni, ci mancherebbe. La mia, ieri, è stata bere avidamente le cronache del primo consiglio dei ministri del governo Draghi Due, che sarebbe il governo Draghi Uno dopo la scomparsa dei sogni quirinalizi del capo. Apprezzabili i toni sospesi tra l’epico e il fantasy, un po’ come se ci descrivessero una seduta della Tavola Rotonda, o una merenda dei ministri del Re Sole. Merende niente, però, lo dico subito, nemmeno il caffè, solo acqua. Poi l’applauso chiamato da Draghi per Mattarella rieletto – un bell’applauso! – poi gli sguardi bassi di chi ha qualcosa da farsi perdonare, poi piccole scaramucce (Giorgetti versus Speranza, Brunetta versus chissà chi), poi strette di mano. Poi l’orgoglioso giubilo per un Pil che veleggia verso il 6,5 per cento, cosa mai vista in tempi recenti, hurrà. Viene da chiedersi come mai Mattarella, appena rieletto dal Parlamento, abbia parlato chiaramente di “crisi economica”, forse si sbaglia lui che non vede il boom, forse si sbaglia Draghi che lo rivendica, non sottilizziamo.
Insomma, come è tradizione del primo giorno di scuola, il prof non ha interrogato (interroga nel consiglio dei ministri di oggi, si dice, ndr), ma soltanto spiegato agli alunni che ora si fa sul serio, che ci sono gli esami, che non tollererà ritardi e distrazioni, eccetera eccetera. Una cosa a metà strada tra il pippone motivazionale e la faccia severa del preside. I titoli e i commenti dicono che ora Draghi è più forte; le ultime righe degli zuccherosissimi articoli – se qualcuno ci arriva senza aggravare il diabete – dicono il contrario: che in un anno pre-elettorale, con molti mal di pancia in giro, non sarà una passeggiata di salute. Va bene, non sottilizziamo (e due).
Si proroga l’obbligo di mascherine all’aperto, la stessa valenza scientifica di stringere un cornetto di corallo o di toccare ferro, e si parla di discoteche, che aprano almeno per San Valentino, l’amore è una cosa meravigliosa. Poi tutti a casa: era solo un antipasto, come un rincontrarsi dopo un lungo ponte e le festività.
Ed è qui che mi sono detto: ma guarda che fesso che sono! Perché, in effetti, nella rubrica della settimana scorsa mi ero lasciato prendere dallo sconforto, addirittura avevo teorizzato che si possa fare politica, e meglio, fuori di lì, nelle strade e nelle piazze, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Ma no, dài, avrò esagerato, mi sarò fatto prendere la mano… E allora avevo preso a coltivare l’illusione che al primo consiglio dei ministri, si parlasse di noi, del mondo qui fuori, dei comuni mortali. Chissà, immaginavo forse un piccolo capannello in cui il ministro del Lavoro chiacchiera con quello dell’Istruzione per risolvere questo fatto che un ragazzo sta in cantiere invece che in classe, e muore per una trave che gli casca in testa, cosa che peraltro succede a tre o quattro lavoratori italiani ogni giorno. Macché, niente.
Oppure che la ministra degli Interni spiegasse a tutti, con parole sue, come sia possibile che la polizia (a Torino, a Milano, a Napoli, a Roma), si metta allegramente a bastonare a sangue dei ragazzini che protestano pacificamente perché uno di loro è morto in cantiere. Magari comunicando che salta qualche prefetto, o che si prenderanno provvedimenti disciplinari. O magari che qualcuno “di sinistra” (ahah) chiedesse la benedetta riforma di mettere numeri di riconoscimento sui caschi degli agenti per contrastare abusi, come avviene in tutto il mondo… Macché, niente nemmeno lì, ma non sottilizziamo (e tre).
 Siamo appena al secondo giorno della trattativa Stato-Draghi e sono già spossato. Cioè, confesso: sarei spossato se seguissi la questione, se mi appassionassi alle varianti, alle trattative, alle ipotesi, al cabaret di basso livello dell’aula, alle battutine dei commentatori, alle dietrologie, all’eco delle parole in libertà, ai verbi tenuti al guinzaglio lasco dei condizionali. Tizio avrebbe visto Caio e forse, chissà, risposto alla telefonata di Sempronio, che avrebbe fatto il nome di Gino, gradito a Ciccio, ma fortemente inviso a Lino perché sbarrerebbe la strada del prossimo governo a Pino, che ci terrebbe tanto. Se state guardando gli speciali televisivi di questi giorni, consiglio di mettere lo schermo accanto a una finestra, e ogni tanto guardare fuori, perché la distanza tra quel che avviene attorno ai catafalchi della democrazia (mai nome fu più adatto) e il mondo reale, appare incolmabile, siderale.
Siamo appena al secondo giorno della trattativa Stato-Draghi e sono già spossato. Cioè, confesso: sarei spossato se seguissi la questione, se mi appassionassi alle varianti, alle trattative, alle ipotesi, al cabaret di basso livello dell’aula, alle battutine dei commentatori, alle dietrologie, all’eco delle parole in libertà, ai verbi tenuti al guinzaglio lasco dei condizionali. Tizio avrebbe visto Caio e forse, chissà, risposto alla telefonata di Sempronio, che avrebbe fatto il nome di Gino, gradito a Ciccio, ma fortemente inviso a Lino perché sbarrerebbe la strada del prossimo governo a Pino, che ci terrebbe tanto. Se state guardando gli speciali televisivi di questi giorni, consiglio di mettere lo schermo accanto a una finestra, e ogni tanto guardare fuori, perché la distanza tra quel che avviene attorno ai catafalchi della democrazia (mai nome fu più adatto) e il mondo reale, appare incolmabile, siderale.
Sono pronto a correre il rischio dell’insulto, perché se ti ribelli (parola grossa), o se ti mostri indifferente (ecco, più credibile) al balletto, ti becchi di solito la patente di “populista”, che è ormai l’ingiuria corrente buttata lì da chi sostiene il teatrino, o ne fa parte attiva. E riconosco che il giochetto è abbastanza facile: di qua un manipolo di strateghi da bar che muove le pedine su una scacchiera tra Governo e Quirinale, e dall’altra un Paese stanco, stufo, nervoso, incazzato come un cobra che non sa né dove né come riversare la sua rabbia. Potrei essere più preciso: da una parte i sedicenti influencer o kingmaker che sussurrano cretinate ad ogni passo (Psst! Frattini! Psst! Casellati! Psst, vedrai che vince Casini. Psst, alla fine sarà Draghi); e dall’altra un popolo (ossignùr, che parola démodé) dove un lavoratore su quattro sputa l’anima per arrivare alla fine del mese, i salari scendono anziché salire, i diritti scolorano, i ragazzini muoiono in cantiere proprio come i lavoratori veri, e i loro amici che protestano vengono manganellati, forse dalle stesse forze dell’ordine che scortavano i fascisti ad assaltare la Cgil.
Di tutto questo, del Paese reale, del suo sangue, delle sue paure, dei salti mortali e dei calcoli al centesimo davanti agli scaffali dei supermercati, non c’è nessuna, nessunissima traccia nello spettacolo indecoroso di questi giorni. Anche le parole sono lontane, lontanissime. Da “Bisogna difendere la ripresa” (eh?) a “Non possiamo permetterci di perdere Draghi” (eh?), e giù per li rami: cose che possono sembrare assurde, e sono invece semplicemente offensive.
Poi – dopo – tutti con le mani nei capelli, oh signora mia, dove andremo a finire, perché l’affluenza alle urne cala, l’astensione si impenna, la gente se ne sbatte e tenta di vivere nonostante. Il rischio – ormai conclamato – è che si dia la colpa alla politica, così, genericamente, mentre è “quella” politica che produce danni, lutti e fantasmi. E forse bisogna ricominciare a pensare che la politica si può fare senza quelli lì, senza burattini, senza pupi e pupari, senza uomini della provvidenza che “non possiamo permetterci di perdere”. Possiamo benissimo, invece, perché forse osservando un Parlamento dove sovranisti ottusi, sedicenti “di sinistra” e liberisti assistiti dallo Stato sostengono lo stesso governo, la parola “extraparlamentare” non è più così peregrina. Ricominciare a pensare che si può fare politica con le nostre vite, il nostro impegno, i nostri bisogni, fuori di lì, mi sembra, al momento, l’unica (flebile, d’accordo) speranza.
 Tra le cose che mi appassionano meno, insieme all’hokey su prato e al porno gotico giapponese, c’è la corsa al Quirinale, che sembra una partita a scacchi tra persone che non hanno mai visto una scacchiera e credono che sia una tovaglia a quadretti. Per mesi ha tenuto banco l’allarme su Silvio Buonanima al Colle, la sua foto nei tribunali (sceglierei quella dove fa le corna) e, visto che le Scuderie del Quirinale sono famose nel mondo, avrebbe nel caso bisogno di uno stalliere. Eppure – perdonate il paradosso – l’autocandidatura ora-sì e ora-no di Berlusconi contiene elementi di commedia all’italiana più che notevoli. Sgarbi telefonista che chiama in giro per trovare pesciolini da chiudere nella rete, per dire del ridicolo. O un condannato per bancarotta – Denis Verdini – che tesse la sua tela, al domicilio non ci sta, e si vede in pizzeria a Roma con peones e seconde file, con la scusa che deve andare dal dentista. Il quale (Verdini, non il dentista) è tra l’altro il quasi-genero di Salvini, amico fraterno di Renzi, insomma gli mancano solo il boia di Riga e mister Magoo e poi finisce l’album.
Tra le cose che mi appassionano meno, insieme all’hokey su prato e al porno gotico giapponese, c’è la corsa al Quirinale, che sembra una partita a scacchi tra persone che non hanno mai visto una scacchiera e credono che sia una tovaglia a quadretti. Per mesi ha tenuto banco l’allarme su Silvio Buonanima al Colle, la sua foto nei tribunali (sceglierei quella dove fa le corna) e, visto che le Scuderie del Quirinale sono famose nel mondo, avrebbe nel caso bisogno di uno stalliere. Eppure – perdonate il paradosso – l’autocandidatura ora-sì e ora-no di Berlusconi contiene elementi di commedia all’italiana più che notevoli. Sgarbi telefonista che chiama in giro per trovare pesciolini da chiudere nella rete, per dire del ridicolo. O un condannato per bancarotta – Denis Verdini – che tesse la sua tela, al domicilio non ci sta, e si vede in pizzeria a Roma con peones e seconde file, con la scusa che deve andare dal dentista. Il quale (Verdini, non il dentista) è tra l’altro il quasi-genero di Salvini, amico fraterno di Renzi, insomma gli mancano solo il boia di Riga e mister Magoo e poi finisce l’album.
“Ha messo fine alla guerra fredda”, Berlusconi. E questo l’ho letto su una pagina di giornale (suo), e in effetti anch’io avevo interpretato in quella chiave la sua storica frase da statista: “La patonza deve girare”. Chiaro obiettivo geopolitico che metterebbe fine alle dispute tra grandi potenze (oddio, dai tempi del sequestro di Elena di Troia si direbbe il contrario, ma…).
Va bene, è probabile che Silvio non ce la farà e questo apre nuove speranze, e porta nuove iatture, perché il rischio è che chiunque venga eletto Presidente, verrà salutato come “Uh, meno male che non è Silvio!”, anche se magari avrà la statura politica e morale di un cotechino senza lenticchie. E però, paradosso per paradosso, una cosa va detta. Se il Presidente deve somigliare alla classe politica del Paese – non per appartenenza partitica, ma per risultati ottenuti, dignità e visione di futuro – in fondo Silvio Nostro non è così fuori dalla realtà. Dopotutto stiamo parlando di un Paese dove nel pieno di un’esplosione spaventosa della povertà si vota allegramente per negare un contributo sulle bollette ai meno abbienti, dove il salario minimo è considerato un attentato al sacrosanto liberismo, si riducono le tasse a chi guadagna il triplo della media nazionale, dove un’eventuale patrimoniale viene letta alla stregua di un comunicato delle Br, e tutta la stampa e la propaganda in coro parlano dei poveri come di gente che si fa le pippe sul divano a spese nostre. Beh, mi fa orrore il nichilismo, ovvio, ma un Paese dove su Ponte Vecchio, patrimonio dell’Umanità, compare la scritta dello sponsor, è più culturalmente vicino a Berlusconi che a chiunque altro.
C’era un tempo (forse, ricordo vagamente) dove uno poteva “buttarsi a sinistra”, ma ora fa prima a buttarsi al fiume, visto che proprio da sinistra (oddio, il Pd…) si plaude alla “straordinaria ripresa economica”, fatta di numeretti (più sei, più sei e due, più sei e cinque…) che non finiscono però nelle tasche di cittadini e lavoratori. Intendo: non è che facendo la spesa senti gente che si rallegra di aver maggiore potere d’acquisto, e festeggia il boom economico con le lacrime agli occhi come il ministro Brunetta. Anzi. Metafora per metafora, se tra socialismo e barbarie si sceglie barbarie – da anni, con pervicacia e furore, con gusto, con sberleffo – Silvio ci sta, con tutte le scarpe, anche se ovviamente si spera di no.
 Come forse avrete sentito (ehm…), lunedì 17 esce su PrimeVideo Monterossi, la serie. Sono sei puntate da 45 minuti l’una, tre da un libro (Questa non è una canzone d’amore, Sellerio, 2014) e tre da un altro libro (Di rabbia e di vento, Sellerio 2016). La produzione è Palomar, la regia è di Roan Johnson, il protagonista, il “mio” Carlo Monterossi, è Fabrizio Bentivoglio (e quindi ora è anche il “suo”
Come forse avrete sentito (ehm…), lunedì 17 esce su PrimeVideo Monterossi, la serie. Sono sei puntate da 45 minuti l’una, tre da un libro (Questa non è una canzone d’amore, Sellerio, 2014) e tre da un altro libro (Di rabbia e di vento, Sellerio 2016). La produzione è Palomar, la regia è di Roan Johnson, il protagonista, il “mio” Carlo Monterossi, è Fabrizio Bentivoglio (e quindi ora è anche il “suo”
 Carlo Monterossi).
Carlo Monterossi).
Non la farò lunga, essendo un filino di parte, ma il risultato, a noi pochissimi che l’abbiamo visto, è piaciuto molto. Ora tocca a voi, se lo vedrete. Qui, intanto, a due giorni dalla messa in onda, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla serie. Di molti (e mi spiace) non so nemmeno i nomi.
Sono quelli che in un film fanno quei lavori che non sapete nemmeno che esistono, quelli delle macchine, dei suoni, quelli che sul set danno “tecnicamente” forma a una storia, che truccano, che arredano, che scelgono le location, che scelgono il cast. Grazie a tutti loro, non è mica una cosa facile fare una cosa del genere. In più, quando giravamo (cioè, quando giravano, perché io quando andavo sul set sembravo “Scovate l’intruso”) non si lavorava da un po’, sembrava tutto fermo, e la serie ha rimesse in moto certe cose, questo è un altro motivo di gioia.
Qui il trailer lungo (90 secondi)
Poi, ovvio, vorrei dire qualche cosa sui compagni di viaggio, che sono molto più che compagni di viaggio. Intanto Fabrizio Bentivoglio. Lui e il gioco di specchi che si è creato: io, lui, Monterossi, come un ritrovarsi tra amici. E poi Fabrizio è un grande attore. Questo lo sapevo, ovvio, dai tempi di Marrakech Express e Turné (io l’ho amato tantissimo anche ne Il capitale umano…), ma vederlo lavorare, vederlo diventare un altro restando se stesso, beh, davvero una lezione.
io, lui, Monterossi, come un ritrovarsi tra amici. E poi Fabrizio è un grande attore. Questo lo sapevo, ovvio, dai tempi di Marrakech Express e Turné (io l’ho amato tantissimo anche ne Il capitale umano…), ma vederlo lavorare, vederlo diventare un altro restando se stesso, beh, davvero una lezione.
Poi Roan Johnson, con la sua tranquillità zen (sul set) che mette tranquilli tutti, ma sempre deciso, sa cosa vuole e come lo vuole e per me che ho scritto la storia, capire che la macchina messa in un punto o in un altro può cambiare tutto è stato strabiliante. Federico Annichiarico ha diretto la fotografia, cioè la luce, cioè… insomma, molto delle atmosfere, delle situazioni, sono merito suo. Il produttore Carlo Degli Esposti (qui accanto con me e Carla Signoris) che ha fatto, con una tigna e una volontà incredibili, un lavoro pazzesco.
 Sul cast che posso dire? I “giovani” che accompagnano il Monterossi nelle sue avventure sono perfetti: Nadia (Martina Sammanco) gioca alla perfezione la sua carta di “precaria della conoscenza”, sa fare cose che noi umani… e il suo gioco di ironie e prese per il culo del “boomer” Carlo è perfetto, ed è quello che può fare solo una vera amica. Oscar Falcone (Luca Nucera) è sfuggente e misterioso, è lui il vero detective.
Sul cast che posso dire? I “giovani” che accompagnano il Monterossi nelle sue avventure sono perfetti: Nadia (Martina Sammanco) gioca alla perfezione la sua carta di “precaria della conoscenza”, sa fare cose che noi umani… e il suo gioco di ironie e prese per il culo del “boomer” Carlo è perfetto, ed è quello che può fare solo una vera amica. Oscar Falcone (Luca Nucera) è sfuggente e misterioso, è lui il vero detective.
Poi i miei due sbirri. Diego Ribon (Tarcisio Ghezzi) e Tommaso Ragno (Carella) sono loro, ma proprio sputati, incollati come sulla pagina, non avrei potuto immaginarli che così. Una brava persona, che sa meditare, che pensa, che capisce, Ghezzi, e un irruente fumantino, Carella, uno che prende le cose sul personale. In tutti, il senso di giustizia domina e comanda. “La giustizia non esiste, Monterossi”… Carla Signoris è Flora De Pisis, e chi se no? (ma vale anche l’inverso: Flora De Pisis è Carla Signoris, e chi se no?), strabiliante.
Maria Paiato, che i più fortunati hanno visto in teatro è l’agente di Carlo, Katia Sironi. Donatella Finocchiaro – che non ha bisogno di presentazioni – è Lucia, quella che nella “Canzone” si nomina solo chiamandola “Lei”, l’amore finito di Monterossi, che ancora ci pensa (e come ci pensa!). Altre ragazze di grande bravura: Marina Occhionero è l’agente Sannucci, ha con Ghezzi un gioco di complicità allieva/maestro sempre ironico. Silvia Briozzo è Caterina (Katrina, nei libri), la Mary Poppins di Carlo. Beatrice Schiros è Gregori, il capo di Ghezzi e Carella. E Mariangela Granelli è la signora Rosa.
Gli zingari (oh, i miei zingari!) sono Gianni D’Addario e Ilir Jacellari, mentre i miei due killer (oh, i miei killer!) sono Gabriele Falsetta e Maurizio Lombardi. Poi ci sono Miriam Previati (Anna) e Roxana Doran (Sarena), Bedlù Cerchiai (Meseret)… Michele Bravi fa… Michele Bravi…
Poi c’è Bob Dylan. Intendo che le canzoni sono le sue, che le canta lui, che ci sono scene in cui parte e… ma quand’è che avete sentito Dylan in una serie? Ci voleva il Monterossi, diciamo… Insomma, la pianto qui. Metto qui sotto qualche foto di scena. Il tutto accade a partire da lunedì prossimo. Insomma. Ecco. Fate sapere…
 Sono affascinato, devo ammetterlo, dal concetto di “autosorveglianza”, introdotto dall’ultimo decreto legge sul Covid. Immagino che voglia dire “arrangiatevi”, cosa che già facciamo in abbondanza e quindi bene, niente di nuovo. Non stupisce nemmeno che avvenga in ambito sanitario, in un Paese dove è più facile parlare col Papa che col medico di base, dove un tampone d’emergenza o controllo costa come una cena da Cracco, dove le regole sono interpretabili, eccetera, eccetera.
Sono affascinato, devo ammetterlo, dal concetto di “autosorveglianza”, introdotto dall’ultimo decreto legge sul Covid. Immagino che voglia dire “arrangiatevi”, cosa che già facciamo in abbondanza e quindi bene, niente di nuovo. Non stupisce nemmeno che avvenga in ambito sanitario, in un Paese dove è più facile parlare col Papa che col medico di base, dove un tampone d’emergenza o controllo costa come una cena da Cracco, dove le regole sono interpretabili, eccetera, eccetera.
Che la parola compaia in un decreto legge (col trattino in mezzo, auto-sorveglianza) inquieta un po’, questo sì.
Mettetela come volete, ma l’autosorveglianza, in generale, rischia di darci grandi soddisfazioni. Contiene una retorica densa di senso di responsabilità e ragionevolezza (“Badi, buon’uomo! Io mi autosorveglio!”), e una prateria davanti di cose che si possono autosorvegliare, anche al di fuori dell’emergenza Covid. Se la cosa prende piede, tra un po’ qualcuno chiederà l’autosorveglianza fiscale, e qualcun altro dirà beh, sai, non è una brutta idea. Sappiamo come vanno queste cose. E se cerchi “sorveglianza” in rete non ti esce subito Foucault, ma decine e decine di venditori di telecamere, sicurezza, anti-intrusioni, panoramiche del tuo salotto dal telefonino. Ecco, diciamo che sorvegliare ci piace di più che autosorvegliarci (Foucault torna sempre fuori), e prima qualche prova pratica la farei. Che so, un decreto in cui si dica: ehi, gente, niente multe per un mese, autoregolatevi il codice della strada! Un’orgia di doppie file, un’ordalia di lamiere. Oppure due turni di serie A senza arbitri, “Oh, sul fuorigioco fate un po’ voi”. Delirio.
Ma posto che “autosorveglianza” significa “non riusciamo a sorvegliarvi” – a pensarci bene è strano che non abbiano trovato una parola inglese – verrebbe da dire che è meglio così. Al netto delle regole arabescate e ghirigoreggianti, è ovvio che uno si autoregola, cioè si arrangia. Chiede in giro, si informa presso le massime autorità del ramo, tipo il dottore che sta in tivù, o la cassiera del panettiere, o addirittura ascolta quel che gli dice il medico, se riesce a trovarlo. Si fa insomma, delle sue proprie regole, accettando la sua collocazione nella complicata scala sociale sanitaria del momento. Asintomatico con booster! Guarito da 120 giorni! Hurrà!
Ci autosorvegliamo tutto il tempo, peraltro, non andiamo al centro commerciale con un fucile a pompa, non prendiamo l’autobus nudi e riusciamo persino a non tirare i piatti al televisore durante certi dibattiti o interviste. Direi che fin qui la tenuta di nervi e la capacità di autosorveglianza degli italiani è stata persino strabiliante, oltre ogni più rosea previsione. Ora cerchiamo di autosorvegliarci – inteso come stiamo calmi – anche mentre leggiamo il decreto legge e la circolare del ministero della salute, che dicono cose diverse su come devono comportarsi gli autosorvegliati. Serve il tampone, quando ti sei autosorvegliato da asintomatico per cinque giorni? Non serve? E’ argomento di grande attualità nelle file per i tamponi, che intanto fatturano come la Krupp nel ’41. E il gioco dell’anno sarà sfuggire alla sorveglianza, dribblare quarantene, sminuire contatti, mentire, in modo da non cadere nel limbo dell’autosorveglianza. Per scoraggiante coincidenza, l’appello e l’incoraggiamento a sorvegliarsi da sé coincidono con la più grande matassa di regole che si sia mai vista, il più complicato origami di articoli e commi in cui le nostre vite siano mai rimaste impigliate.
 Con il Green Pass di livello 25 – C – Rafforzato Plus puoi entrare in una sala biliardo, ma puoi giocare solo a boccette, niente stecche, per quelle serve il livello 26, che ti danno solo se fai un tampone di tipo D-14 in un aeroporto della Mongolia orientale. Occhio che c’è la fila. Ha ragione il generale Figliuolo, bisogna avere pazienza. Dai, cazzo, magari aspetti quaranta minuti dal concessionario della Porsche e non vuoi stare sei ore fuori da una farmacia?
Con il Green Pass di livello 25 – C – Rafforzato Plus puoi entrare in una sala biliardo, ma puoi giocare solo a boccette, niente stecche, per quelle serve il livello 26, che ti danno solo se fai un tampone di tipo D-14 in un aeroporto della Mongolia orientale. Occhio che c’è la fila. Ha ragione il generale Figliuolo, bisogna avere pazienza. Dai, cazzo, magari aspetti quaranta minuti dal concessionario della Porsche e non vuoi stare sei ore fuori da una farmacia?
Di tutte le categorie in crisi, la mia solidarietà di fine anno va a chi aveva in mente di scrivere un romanzo distopico, ambientato in un futuro nebuloso e incerto, su una società isterica. Ecco, mi spiace per lui, dovrà inventarsi qualcos’altro, perché ‘sta roba qua la leggiamo tutti i giorni. Seguo, per esempio, la strabiliante evoluzione tecnico-scientifica del nostro lasciapassare sanitario, quello che durava nove mesi, no dodici, no di nuovo nove, no sei.
Mostro il mio Greenpass con la scioltezza del giocoliere, potrei partecipare alle Olimpiadi nella categoria “Mostratore al volo di display”. Vado a lavorare tutti i giorni nello stesso posto, dove la stessa persona me lo chiede ogni giorno, e ormai il problema non è il Greenpass, ma inventarsi qualcosa da dire in quell’attimo di imbarazzo: lui sa che sta facendo una cosa inutile, io so che sto facendo una cosa inutile. E’ un rito scaramantico, che ha la stessa portata scientifica di stringere un cornetto di corallo. Eppure lo facciamo lo stesso. Unica soddisfazione: quando gli antropologi ci studieranno, tra una decina di secoli, e impazziranno per interpretare una cosa del genere. Giunti al punto “SuperGreenpass obbligatorio per le feste di laurea ma non per i matrimoni” si arrenderanno, spero.
Ma facciamola breve. Presto il mio Greenpass non basterà più: come per il Mac, il telefono, il tablet, la televisione, il navigatore, dovrò fare l’upgrade, aggiornare il programma. Una certa riprovazione sociale comincia a spumeggiare intorno a me: ho ancora il Green pass semplice, non mi vergogno? Non penso a mio nonno? “Io non ce l’ho il nonno!”, rispondo. Ma niente, ottengo solo un accenno di disprezzo.
Naturalmente ho prenotato la terza dose, mi daranno il Green pass rafforzato, diciamo che passo da Greenpass 2.1 a Greenpass 3.0, non male per uno che non aveva mai pensato di fare carriera nel mondo della sanità. La quarta dose viene data per certa, comunque, da quasi tutti i virologi in onda, quindi già so che è il solito giorno della marmotta, e che quello che leggiamo oggi (“cambio di passo sulle terze dosi”) potremmo leggerlo anche domani (“cambio di passo sulle quarte dosi”). Approfitto per consigliare nuove formule (che so: colpo di reni, scatto felino) perché il generale Figliuolo che dice “cambio di passo” è un classico da marzo, nove mesi fa, un po’ invecchiato come tormentone. Scatteranno le promozioni commerciali, tipo un tampone gratis se porti un amico, e ci saranno corsi di laurea dedicati ai diversi tipi di quarantena.
Intanto, le cose che si potevano fare, non sono state fatte. A parte litigare un po’ su chi controlla biglietti e/o Greenpass sugli autobus, gli autobus sono sempre quelli, le aule sono sempre quelle, le code per i tamponi sono dense di gente che bestemmia tutti i santi perché in classe di Gino o di Filippa c’era un positivo, quindi tutti a casa, madre, padre, due fratelli, stanno tutti bene, ma è il Vietnam. A ‘sto punto la coda per il tampone è una botta di vita. Il mio consiglio è scollinare Capodanno e ripresentarsi qui nell’anno nuovo, carichi di buoni propositi. Auguri a tutti.
Oggi con l’intervista doppia su La Lettura (io e Fabrizio Bentivoglio, l’intervista è di Cecilia Bressanelli) comincia ufficialmente l’avventura di Carlo Monterossi al cinema. Siccome è più di un secolo che si mettono i libri nei film, che si danno facce a personaggi, gesti, voci, insomma non cadrò nella trappola di dire le solite banalità. La produzione è Palomar, il regista è Roan Johnson, il protagonista è Fabrizio Bentivoglio, la luce è di Federico Annichiarico, la sceneggiatura è di Roan, Davide Lentieri e mia. E poi ci sono (li dico in ordine sparso, Diego Ribon, Martina Sammarco, Donatella Finocchiaro, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Marina Occhionero, Beatrice Schiros, Maria Paiato, Silvia Briozzo… vabbè li scoprirete nei vari ruoli).
Andrà in onda su Prime Video dal 17 gennaio. Sono sei episodi, tratti da due romanzi, Questa non è una canzone d’amore e Di rabbia e di vento.
 Dunque, il consiglio dei ministri deciderà il 23 dicembre (domani) come potremo/dovremo comportarci il giorno di Natale. Siamo in quella fascia di tempo in cui le rosticcerie non ti prendono nemmeno più l’ordine: “Mi spiace, signora, doveva dircelo prima”.
Dunque, il consiglio dei ministri deciderà il 23 dicembre (domani) come potremo/dovremo comportarci il giorno di Natale. Siamo in quella fascia di tempo in cui le rosticcerie non ti prendono nemmeno più l’ordine: “Mi spiace, signora, doveva dircelo prima”.
E infatti gli italiani hanno fatto prima: chi doveva disdire ha disdetto, chi poteva confermare ha confermato, un po’ di parenti staranno a casa, si mentirà su obblighi e quarantene, tutti o quasi greenpassati e tutti alle prese con quella ormai familiare frase: “Vabbé, staremo un po’ attenti”.
Ma nelle decisioni prenatalizie che ci verranno gentilmente comunicate mentre facciamo i pacchetti, c’è qualcosa in più di qualche regola; c’è in controluce la crisi di una narrazione molto molto pressante, sulla pandemia, sulla scienza, e in definitiva sulle nostre vite ai tempi del Covid.
Due unanimismi intrecciati hanno camminato di pari passo in questo anno: quello per superare la pandemia, uscirne finalmente, accettare regole e consigli a reti unificate, a volte un po’ balzani; e uno per il nuovo salvatore della politica, l’ennesima ultima spiaggia, eccetera eccetera, insomma, il draghismo semi-obbligatorio che il paese respira come un aerosol. Ecco, è possibile ora che questi unanimismi si scollino un po’, che non marcino più così uniti come qualche mese fa. Ognuno dei due ha dato qualche cenno di cedimento, non la tenuta ferrea che si credeva.
Sul lato pandemia (ma ormai bisognerebbe dire “politica pandemica”) i nuovi sviluppi ci dicono che il vaccino ci protegge dall’intubazione, ma non da tutto il resto (dall’ammalarsi alla quarantena, all’isolamento, e via elencando, e tutto magari con un greenpass valido in tasca). Ognuno fa i conti con la sua propria situazione. Personalmente sarei un eroe della AZ generation, in attesa di booster-surprise, perché non so se mi toccherà Pfizer o Moderna, può darsi che tirino a sorte. Diciamo che non mi avvicino alla terza dose con la stessa soddisfatta serenità con cui ho ricevuto la prima e la seconda.
Si parlò addirittura, qualche mese fa, di vietare i tamponi, colpevoli di disincentivare al vaccino. Si infiammò persino la polemica: io con le mie tasse ti dovrei pagare il tampone! Ver-go-nia! Si colorò insomma il dibattito tanponi sì-tanponi no con quell’atteggiamento sbirresco e discriminatorio che faceva di uno col tampone il nemico sociale del momento, il parassita buono per il dileggio popolare. I romanzi distopici di Ballard ci fanno una pippa.
Oggi invece si certifica (cioè domani, con calma) che magari in certe situazioni (stadi, grandi eventi) non basterà il vaccino, e quindi il green pass, ma ci vorrà anche un tampone, con nuovo greenpass, suppongo. E questo mentre un’altra proposta arriva alla “cabina di regia”: che per il trasporto locale non basti più il tampone, ma sia necessario il vaccino, in due dosi, meglio tre, e greenpass gold edition. Si è parlato anche (sono quei ballon d’essai lanciati per capire se c’è spazio di manovra) di greenpass più tampone per andare al cinema, o a teatro, con il che a teatro, spiace, ma non ci andrebbe più nemmeno Pirandello. Insomma, la gestione tecnico-politica della pandemia non è più il Sacro Graal, che se lo tocchi sei un cane infedele. E siccome di tutto lo sbandierato boom economico nelle tasche della gente non sta finendo niente, ecco che anche i superpoteri di Supermario si fanno meno scintillanti. Due unanimismi abbracciati, uno che regge l’altro, sembrano un po’ meno abbracciati, e anche un po’ meno unanimi.
 Nuove tendenze. Va molto di moda il licenziamento smart. Ti chiamano via Zoom, o in teleconferenza, oppure al telefono, oppure whatsapp, sms, tamburi, segnali di fumo e insomma, il cellulare fa plin e sei licenziato al volo. E’ una cosa moderna e pulita, rapida, ancora abbastanza nuova da conquistare qualche titolo sui giornali. Campione del mondo, il Ceo di Better.com, mister Vishal Garg, che ha licenziato 900 dipendenti in un collegamento via Zoom: “Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo…”. Scena lugubremente fantozziana.
Nuove tendenze. Va molto di moda il licenziamento smart. Ti chiamano via Zoom, o in teleconferenza, oppure al telefono, oppure whatsapp, sms, tamburi, segnali di fumo e insomma, il cellulare fa plin e sei licenziato al volo. E’ una cosa moderna e pulita, rapida, ancora abbastanza nuova da conquistare qualche titolo sui giornali. Campione del mondo, il Ceo di Better.com, mister Vishal Garg, che ha licenziato 900 dipendenti in un collegamento via Zoom: “Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo…”. Scena lugubremente fantozziana.
E’ un caso estremo, ma solo per entità della strage, basta cercare online licenziamenti sms, o licenziamenti whatsapp per farsi una piccola cultura in materia.
I titoli, va detto, si fanno via via ogni volta un po’ meno indignati, all’inizio era tutto un “Oh, che scandalo, licenziati via mail!”, e ora la faccenda sembra accettata con più filosofia, ci si abitua, insomma.
Ci si chiede perché non affinare nuove tecniche, sperimentare, portarsi avanti col lavoro, forse qualche ufficio studi potrebbe occuparsene. Uno sforzo, su, almeno per vedere il titolo “Sorteggio per i licenziamenti alla Pinco Pallino Laminati Industriali”. E poi si potrà migliorare ancora, fino a “Licenziati a colpi di fionda”, perché no? Un piccolo Squid Game, con i suoi eliminati dal mercato del lavoro, venti qui, trentadue là, poi ogni tanto delocalizzazioni importanti (la Gkn di Campi Bisenzio) a colpi di centinaia. Lo studio di avvocati che ha assistito l’azienda per la chiusura e l’esubero di 430 dipendenti si vanta dell’impresa e viene premiato ai Top Legal Awards. E’ una guerra piuttosto asimmetrica, diciamo.
Tra l’altro, mi si consenta l’inciso, non si legge mai “Assunti via sms!”, e in generale la parola “assunzioni” risuona assai meno della parola “licenziamenti”, cosa che andrebbe considerata di una certa stranezza, in un Paese che vanta uno strepitoso aumento del Pil. Chiusa parentesi.
Insomma, si discute un po’ sulle varie scelte etiche nelle modalità di licenziamento dei lavoratori, un dibattito tutto teorico, asettico, tecnico. E’ meglio la raccomandata? Un sms che dice: “Da domani può stare a casa”?, un algoritmo che non ti caga più, con rispetto parlando?
C’è il rischio, almeno sul piano mediatico, che il dibattito finisca per concentrarsi sui modi e non sulla sostanza. Insomma, che la modalità smart del licenziamento (quando ti dicono smart c’è la fregatura, è praticamente sicuro) attiri più attenzione del licenziamento stesso. Eppure c’è anche lì – nei modi, nei tempi, nelle frettolose arroganze aziendali, nelle righe sbrigative di liquidazione ed espulsione – una questione densa e importante, che è alla fine una questione di dignità del lavoro. Non è solo forma, insomma, o meglio si tratta di una forma che è anche sostanza: trattare in generale il lavoro come una variabile dipendente, uno strumento che oggi serve, domani no, e si dosa di conseguenza, con le modalità più funzionali alle aziende: non facciamola tanto lunga, un sms basta e avanza. Tra l’altro, ricacciando molti dei licenziati d’Italia nella morta gora dei lavoretti, del cottimo e delle coop farlocche, dove le modalità di licenziamento smart sono la prassi, dove si lavora a chiamata, a convocazione e tutti i trucchi che si sanno. Non si vede all’orizzonte un’inversione di tendenza e anzi si paventano mattanze in vari settori industriali, quindi sms, whatsapp, riunioni online, comunicazioni estemporanee tipo “Buongiorno, da domani lei non ci serve più”, arrivederci.
 Al momento in cui scrivo, i trapezisti sono stati bravi, i clown sempre perfetti e aspettiamo gli illusionisti. Quella che si chiama “Corsa al Quirinale”, una versione circense di Helzapoppin’, riserva colpacci giorno dopo giorno, numeri nuovi e sorpresone. Se ti distrai dieci minuti non capisci più chi vuole Draghi lì, chi lo vuole là, occhio che finisce né lì né là, oppure può andare là e comandare anche lì. Una trama intricatissima.
Al momento in cui scrivo, i trapezisti sono stati bravi, i clown sempre perfetti e aspettiamo gli illusionisti. Quella che si chiama “Corsa al Quirinale”, una versione circense di Helzapoppin’, riserva colpacci giorno dopo giorno, numeri nuovi e sorpresone. Se ti distrai dieci minuti non capisci più chi vuole Draghi lì, chi lo vuole là, occhio che finisce né lì né là, oppure può andare là e comandare anche lì. Una trama intricatissima.
Poi, di colpo, spunta un nuovo genere letterario: il Fantasy Costituzionale. Anche qui la trama non è semplice: un doppio incarico con un Draghi con due cappelli, uno da presidente e uno da premier? Non si può. Allora un prestanome? Un uomo di assoluta fiducia? Da qualunque parte la si guardi è un po’ imbarazzante. Il coro “Draghi stai lì” risuona in ogni dove, tutti lo vogliono al Quirinale e nessuno lo vuole al Quirinale, lui cosa vuole non lo dice. Così si favoleggia di astruse architetture costituzionali, Granducati, Superpresidenze, Imperi.
Gli attori, poi, memorabili. Di Silvio nostro si è detto in lungo e in largo, manca poco che si iscriva agli Inti-Illimani, che si mostri con l’eskimo. Dopo le aperture ai Cinquestelle (forse non ricorda “Nelle mie aziende pulirebbero i cessi”, aprile 2018) mi aspetto di trovarmelo da un momento all’altro sul pianerottolo, che tenta di vendermi Lotta Comunista. In generale gli altri si barcamenano, cercano di capire cosa succede intorno a loro, menandosi come fabbri anche se stanno nello stesso governo, votano le stesse leggi, esultano per i mirabolanti risultati raggiunti (eh?). Non mancano le note di colore locale: se Draghi andasse al Quirinale il presidente del consiglio designato sarebbe il ministro più anziano, cioè Renato Brunetta.
Nel frattempo, divampa l’incendio nel campo largo. E’ largo? Non è largo? Maria Elena Boschi lancia ultimatum: “O noi (intende i renzisti, ndr) o i Cinquestelle”. Urca. Carlo Calenda, autocandidatosi (è un vizio) per dispetto e poi autoritiratosi dalle suppletive a Roma, dice invece che ora va da Letta e gli dice serio: “O noi (intende Calenda, ndr) o i Cinquestelle”. Anche questo a suo modo è un Fantasy, con le tribù, capi e capetti, territorial pissing, offensive, colpi bassi e incantesimi.
Se si esce da questa confortevole e appassionante fiction, la situazione è un po’ più grama. Incombe uno sciopero generale, cosa che non avveniva da anni, contro un governo che – a leggere stampa e propaganda – risulta amatissimo, competentissimo, geniale. Basterebbe questo a dire di una notevole distonia tra la realtà e la sua narrazione incoraggiata: il sei e uno, sei e due, sei e tre di aumento del Pil non si vede nelle tasche del Paese, dove anzi si vede l’inflazione, che erode il potere d’acquisto ed è di fatto una flat tax che colpisce i più poveri. Mentre si assiste alle schermaglie pre o post-quirinalizie, ai tatticismi e allo spettacolino, insomma, emerge una verità. Tutti quei soldi, quegli investimenti, quel “è il momento di dare” che potevano cambiare il Paese, sono andati e stanno andando nella direzione di lasciarlo com’è. Dare qualcosa a quasi tutti, rafforzare qualche posizione cardine, smollare contentini, ma niente di strutturale, capace di cambiare in modo più egualitario il corpo sociale del paese. Un’operazione di mantenimento dell’esistente, mediocre e troppo diseguale. Il resto, quel che avviene intorno al disegno, è poco più che coreografia, un gran parlare di tattiche e strategie, mentre il gioco si fa da un’altra parte.
 Chiedo scusa se parlo di Mario Monti – un Mario Draghi di dieci anni fa – ma, occupandosi questa rubrichina di leggende, narrazioni e media, direi che la recente uscita del senatore Monti sull’informazione che va “dosata” merita qualche appunto in margine (ne ha parlato benissimo, unendo molti puntini, Tommaso Rodano, eri, su questo giornale). Dunque troppa democrazia, troppa libertà di stampa, abbiamo subìto tante restrizioni, perché non subirne un’altra? Che male c’è? “Trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione” è una frase che dovrebbe mettere qualche brivido nelle brave persone. C’è anche quell’altro verbo, “dosare”, che ribadisce bene il concetto, cioè dovrebbe esserci un rubinetto, quello dell’informazione, e il governo (secondo il senatore Monti) dovrebbe aprire e chiudere a piacere, “come nell’informazione di guerra”. Seguono precisazioni e correzioni di tiro, ma si sa, le parole dal sen fuggite sono le più sincere.
Chiedo scusa se parlo di Mario Monti – un Mario Draghi di dieci anni fa – ma, occupandosi questa rubrichina di leggende, narrazioni e media, direi che la recente uscita del senatore Monti sull’informazione che va “dosata” merita qualche appunto in margine (ne ha parlato benissimo, unendo molti puntini, Tommaso Rodano, eri, su questo giornale). Dunque troppa democrazia, troppa libertà di stampa, abbiamo subìto tante restrizioni, perché non subirne un’altra? Che male c’è? “Trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione” è una frase che dovrebbe mettere qualche brivido nelle brave persone. C’è anche quell’altro verbo, “dosare”, che ribadisce bene il concetto, cioè dovrebbe esserci un rubinetto, quello dell’informazione, e il governo (secondo il senatore Monti) dovrebbe aprire e chiudere a piacere, “come nell’informazione di guerra”. Seguono precisazioni e correzioni di tiro, ma si sa, le parole dal sen fuggite sono le più sincere.
Si lanci dunque il giusto allarme: l’informazione che si “somministra” a dosaggio merita un no fermo, sicuro, come si dice senza flessioni. Un soave “non diciamo cazzate”. Ma a parte questo, esistono già abbondanti sentori di un’informazione di guerra. Il nemico è brutto, sporco, cattivo, si macchia di orrendi delitti, si copre di ridicolo, è un cretino, è stupido, eccetera eccetera. Il nome, “no-vax” già lo descrive spregevole, e siccome l’informazione di guerra non deve guardare troppo per il sottile, diventa “no-vax” chiunque abbia una posizione anche vaghissimamente critica sulla gestione della pandemia, anche plurivaccinati convinti. Insomma, l’informazione di guerra evocata da Monti radicalizza il confronto e divide, individua il nemico e lo ridicolizza. Così abbiamo, praticamente a reti unificate, una specie di reductio a imbecillum di una parte della popolazione. Si intervista il cretino, quello che dice che il Covid è un raffreddore, quello del 5g, del complotto planetario, dell’“io mangio molta verdura”, il millenarista, lo squilibrato generico. Insomma, il catalogo è questo: sono tutti matti, e bon, ecco una perfetta – a volte un po’ ridicola – informazione di guerra, dove il filosofo critico vale il guru che si cura con il muschio, tutti nemici uguali.
Si dirà che la pandemia ha cambiato certi parametri, eccetera eccetera. Certo, come no. Ma il meccanismo dell’informazione di guerra si applica anche in altri ambiti, basti pensare alla reductio a delinquentem che si è fatta, per esempio, dei percettori di Reddito di Cittadinanza. Per loro, tutti i giorni un titolo su casi specifici di malviventi (quello con la Ferrari, quello con tre case, quello che vive ai Caraibi) e la riprovazione etica costante, il pubblico ludibrio. Le modalità si somigliano molto, in effetti, e viene da pensare che quel “dosaggio” nell’informazione evocato dal senatore Monti sia già abbondantemente in atto, non “dall’alto”, come dice e vorrebbe lui, più probabilmente da molte direzioni convergenti.
Si sa poi che un “dosaggio” tira l’altro, come le ciliegie, e quel che si applica per la pandemia (niente centro storico alle manifestazioni, per dirne una) poi si applica a tutti. La Cgil regionale dell’Emilia Romagna, per citare un caso, non potrà manifestare in piazza Maggiore a Bologna per un no della Prefettura. Non si capisce se per leso shopping o per paura di contagi, le cose si confondono, la notizia merita un trafiletto minuscolo, poche righe. Insomma, come direbbe il senatore Monti, un dosaggio minimo.
 Nell’eterno giorno della marmotta che viviamo, scandito dalle stesse parole di sempre, da “Non abbassare la guardia” (Covid) a “No allo spezzatino” (Tim), la battaglia per il Quirinale porta una ventata di spumeggiante novità, che metterà d’accordo fini scacchisti e rudi amanti della lotta nel fango. Insomma, c’è una scadenza, bisognerà prima o poi fare dei nomi, tessere, cucire, uscire allo scoperto, imbastire agguati nell’ombra, bruciare avversari, mentire. Che meraviglia. E poi, tutto in diretta, l’atto finale. Prepariamoci.
Nell’eterno giorno della marmotta che viviamo, scandito dalle stesse parole di sempre, da “Non abbassare la guardia” (Covid) a “No allo spezzatino” (Tim), la battaglia per il Quirinale porta una ventata di spumeggiante novità, che metterà d’accordo fini scacchisti e rudi amanti della lotta nel fango. Insomma, c’è una scadenza, bisognerà prima o poi fare dei nomi, tessere, cucire, uscire allo scoperto, imbastire agguati nell’ombra, bruciare avversari, mentire. Che meraviglia. E poi, tutto in diretta, l’atto finale. Prepariamoci.
Su tutti svetta Silvio Nostro, uno che ci crede sempre al di là della logica, che non molla nemmeno davanti all’evidenza, insomma che punta al Quirinale senza se e senza ma (e senza dirlo per scaramanzia anche se lo sanno tutti). Ha mandato, pare, una brochure a tutti parlamentari, una specie di opuscolo con le sue gesta da statista, discorsi alti, diciamo così, non le barzellette. Poi, grandiosa, l’uscita sul Reddito di Cittadinanza, che dice un po’ le cose come stanno e spezza la narrazione ossessiva del “reddito di delinquenza” (cfr. Renzi) che “diseduca alla sofferenza” (cfr, sia Renzi che Salvini), o che è “come il metadone” (cfr, Meloni). Insomma, commovente Silvio in cerca di sponde per salire al Colle, ma di una cosa bisogna dargli atto: pochi come lui sanno l’importanza del mercato interno, dello stimolo ai consumi, della necessità di avere gente felice che fa la spesa, e cinque-sette milioni di poveri non gli piacciono di certo.
Ma sia: nella partita complicatissima del Quirinale, che investe la partita complicatissima del governo, che riguarda la partita complicatissima dei futuri assetti politici, la mission di Berlusconi – portare Berlusconi a fare il Capo dello Stato – è l’unica cosa chiara. E infatti tutti hanno letto l’apertura di Silvio sul Reddito di Cittadinanza come un dar di gomito ai Cinque stelle, un’operazione simpatia, cosa che Silvio tenta in qualche modo anche con il Pd, mentre Renzi si vanta che farà tutto lui e “siamo l’ago della bilancia”, Salvini e Meloni sostengono Berlusconi, a parole e con l’atteggiamento di fare un favore al vecchio padrone.
Quel che ci si presenta davanti, insomma, è lo spettacolo d’arte varia di un uomo innamorato di sé, che vuole abbastanza incongruamente coronare il suo sogno di padre della patria. Mi aspetto da un momento all’altro Silvio at work su molti fronti, alle manifestazioni per l’acqua pubblica, o a quelle per Fiume italiana, per l’aborto, contro l’aborto, fa lo stesso, purché gli venga accreditata la patente di uomo retto e super partes. Non male per uno che ha diviso il Paese per trent’anni, e fa tenerezza sentire i giovani epigoni che tuonano da un palco contro la magistratura con gli stessi argomenti e motivazioni che usava lui, passivo-aggressivo. Il giorno della marmotta, appunto.
Il bello, deve ancora venire, questo è certo, nel vortice di nomi bruciati, candidature civetta, ballon d’essai. Non proprio uno spettacolo edificante, con minacce incrociate, anche divertenti, tipo Letta che dice a Renzi che se si schiera con le destre sul Quirinale tra loro è finita (ah, perché? Non è ancora finita? Cosa serve ancora?). In tutto il balilamme politico e para-politico che ci attende, insomma, le motivazioni di Silvio, la pura ambizione personale, un riconoscimento finale alla sua opera, un risarcimento per le ingiustizie subite (eh?) sembra la più cristallina, a suo modo epica: l’ultima battaglia di uno che sì, il Paese l’ha cambiato eccome, rendendolo, ahinoi, quello che vediamo.
Domani (il 18 novembre) esce in tutte le librerie del regno, piattaforme, ecc. ecc., la nuova antologia noir Sellerio, che si intitola Una settimana in giallo. A parte il fatto (non trascurabile) che è bello esere in buona compagnia – insomma con i migliori che potete trovare in giro a partire dalla mia beloved Alicia Giménez-Bartlett a tutti gli altri – sono onorato di presentare un nuovo racconto con il Monterossi, Falcone, la Cirrielli eccetera. L’indagine sembra semplice, ma… Insomma, si intitola Occhi. Fate sapere
 Non so se si può trarre una buona storiella o lezioncina su “media e politica” dallo scherzo di Fedez, che molti boccaloni credevano pronto alla carriera politica e invece voleva solo fare il promo del suo disco. Ora se la ride, ed è probabile che conservi ritagli e screenshot a futura memoria del livello raggiunto dal Paese. La storia è nota, lui registra un dominio apposta, fa filtrare qui e là che sarebbe pronto per le elezioni del 2023 (per magia, Fedez sarebbe l’unico sul pianeta a conoscere la data delle elezioni italiane) e molti cominciano ad agitarsi. Chi mettendosi le mani nei capelli col solito “dove siamo finiti” (di solito significa che ci siamo già finiti), chi urlando al neo-neo-neo-populismo, chi facendo i calcoli: per un noto sondaggista ecco già Fedez al dieci per cento che “ruberebbe voti ai 5s”. Intanto si riflette, giustamente, su questi nuovi conflitti di interessi, e su come calcolare il peso politico di milioni di followers. Insomma, un mondo vario, chi ci è cascato con tutte le scarpe e chi ha fatto il sorrisino del dubbio, ma c’è un dato di fatto: una settimana di chiacchiericcio ha dimostrato che non è considerata impossibile una simile opzione (Fedez che sbaraglia tutti alle urne), che è tutto sommato “plausibile”, che l’attuale classe politica è così debole, balorda, impaurita e senza strumenti che sembra temere qualsiasi concorrente. Urca, arriva Fedez! Godzilla! Si candida Amadeus! Sondaggio! La Ferragni avrebbe il 64 per cento in Molise! Un delirio.
Non so se si può trarre una buona storiella o lezioncina su “media e politica” dallo scherzo di Fedez, che molti boccaloni credevano pronto alla carriera politica e invece voleva solo fare il promo del suo disco. Ora se la ride, ed è probabile che conservi ritagli e screenshot a futura memoria del livello raggiunto dal Paese. La storia è nota, lui registra un dominio apposta, fa filtrare qui e là che sarebbe pronto per le elezioni del 2023 (per magia, Fedez sarebbe l’unico sul pianeta a conoscere la data delle elezioni italiane) e molti cominciano ad agitarsi. Chi mettendosi le mani nei capelli col solito “dove siamo finiti” (di solito significa che ci siamo già finiti), chi urlando al neo-neo-neo-populismo, chi facendo i calcoli: per un noto sondaggista ecco già Fedez al dieci per cento che “ruberebbe voti ai 5s”. Intanto si riflette, giustamente, su questi nuovi conflitti di interessi, e su come calcolare il peso politico di milioni di followers. Insomma, un mondo vario, chi ci è cascato con tutte le scarpe e chi ha fatto il sorrisino del dubbio, ma c’è un dato di fatto: una settimana di chiacchiericcio ha dimostrato che non è considerata impossibile una simile opzione (Fedez che sbaraglia tutti alle urne), che è tutto sommato “plausibile”, che l’attuale classe politica è così debole, balorda, impaurita e senza strumenti che sembra temere qualsiasi concorrente. Urca, arriva Fedez! Godzilla! Si candida Amadeus! Sondaggio! La Ferragni avrebbe il 64 per cento in Molise! Un delirio.
Di base, chi sa fare gli scherzi mi sta simpatico, mi viene sempre in mente l’immenso Ugo Tognazzi in prima pagina, catturato come capo delle Brigate Rosse su il Male. In questo caso poi, lo scherzo rivela un po’ lo stato delle cose, ha quindi un valore didattico: attenzione, quelli che stanno decidendo come spendere una valanga di miliardi possono finire ad avere paura di Fedez. Sì, fa abbastanza ridere.
Ma a uscirne malamente è anche il sistema dei media, dopotutto lo scherzo era diretto a loro. Si capisce, naturalmente, che un caporedattore stremato dalle dichiarazioni di due righe, il pastone politico, il feticismo delle cronache parlamentari, abbia bisogno di un po’ di distrazione, ed ecco la simil-notizia di Fedez che registra un sito per le elezioni, è il cielo che la manda. E così parte la giostra, prima la notizia, poi il titolone, poi il commento, poi il ditino alzato. E’ un attimo che ti scende la catena e ti ritrovi a fare un comizio. E forse è pure peggio, un gioco delle parti che lo stesso Fedez spiega bene: “Nonostante tutti fossero consci che fosse una trollata, per loro era più importante fare finta che fosse vero”.
Il giorno dopo, quando è uscito il vero promo del disco di Fedez e la faccenda è apparsa semplice, tutti se la sono cavata con una fotonotizia, bon, via, alla prossima, che è l’equivalente di andarsene fischiettando.
Alla fine, dopo qualche risata, quel che viene fuori è che il “cantante tatuato”, il “rapper con la terza media”, quello ricco, tutto griffato lui e famiglia, zuccheroso coi figli nelle storie su Instagram, sempre in mezzo a bambini, vestiti, giocattoli, ecco, quello lì che mi guarda da una vetrina di mutande con gli addominali perfetti, capisce di comunicazione più di tanti sedicenti geni messi insieme. Spin doctor, consiglieri, esperti d’immagine, strateghi della narrazione, su, su, fate largo che finalmente, dopo tanta fuffa, arriva uno che ci sa fare. E lo fa citando il caposcuola indiscusso, il padre di tutte le recite: “L’Italia è il paese che amo…”.
 Uno speciale caso di strabismo, fa in modo che ci sia una parte della società poco indagata, poco vista, poco raccontata, insomma di cui non ci si occupa, e sono quelli che fanno la guerra tutti i giorni coi prezzi, la spesa, l’affitto, e i salari da fame. E’ un fenomeno italiano piuttosto noto, quello dei lavoratori poveri, da poco certificato dalla Fondazione Di Vittorio: cinque milioni di italiani guadagnano meno di diecimila euro lordi all’anno. Il limite, insomma, a un passo dalle sabbie mobili e della soglia di povertà. E’ una popolazione che non ha narrazione, che non si vede nei telegiornali, nelle serie, non è presente nella politica. Quando si parla di poveri, in generale, è per fargli il culo, perché non corrono a lavare i piatti al mare in agosto, o perché sono assistiti, o svogliati, o fancazzisti che ai miei tempi, signora mia… Ecco.
Uno speciale caso di strabismo, fa in modo che ci sia una parte della società poco indagata, poco vista, poco raccontata, insomma di cui non ci si occupa, e sono quelli che fanno la guerra tutti i giorni coi prezzi, la spesa, l’affitto, e i salari da fame. E’ un fenomeno italiano piuttosto noto, quello dei lavoratori poveri, da poco certificato dalla Fondazione Di Vittorio: cinque milioni di italiani guadagnano meno di diecimila euro lordi all’anno. Il limite, insomma, a un passo dalle sabbie mobili e della soglia di povertà. E’ una popolazione che non ha narrazione, che non si vede nei telegiornali, nelle serie, non è presente nella politica. Quando si parla di poveri, in generale, è per fargli il culo, perché non corrono a lavare i piatti al mare in agosto, o perché sono assistiti, o svogliati, o fancazzisti che ai miei tempi, signora mia… Ecco.
Tutto il racconto del proletariato italiano sta qui, dileggio e insulto, per non dire dell’equiparazione ormai diretta tra percettore del reddito di cittadinanza e “furbetto”, un’equazione accettata dai media con soddisfatta nonchalanche, e passiamo ad altro. In generale si sentono grandi allarmi, ma non ci si muove molto. Le file, per usare una metafora nemmeno tanto metaforica, si allungano.
Non pare che nella manovra finanziaria, ci siano molte tracce di attenzione per questa numerosa genìa dannata, ma in compenso qualche briciola per chi sta meglio. Se la revisione dell’Irpef sarà quella annunciata – quella del famoso “tagliamo le tasse” che tutti sbandierano – non c’è molto da brindare: si limerà qualcosa tra i 28 e i 55 mila euro, cioè chi guadagna ventottomila euro l’anno niente, e chi si avvicina ai cinquanta risparmierà meno di 500 euro all’anno. Poco, ma soprattutto sempre lì, ai piani medio-alti dei contribuenti.
Dunque, abbiamo un problema: periodicamente si puntella un po’ la classe media, diciamo la borghesia produttiva, il lavoro garantito, e dall’altra si dimentica sistematicamente il lavoro che più si è espanso negli ultimi decennio, quello intermittente, a chiamata, casuale, a singhiozzo, insomma una massa indistinta e molto numerosa di lavoratori che di garanzie ne hanno pochissime o niente del tutto. Non è un settore in cui possa intervenire la politica fiscale, giusta obiezione, perché la platea dei lavoratori poveri non è quasi soggetta a tassazione. Ma proprio per questo la faccenda è un po’ più impegnativa: non si tratta di regalare soldi, ma di disegnare bene dei diritti, e forse proprio per questo la politica se ne sta alla larga.
La vera polarizzazione, qui e ora, è quella tra redditi accettabili e redditi troppo bassi, con buona pace delle vecchie terminologie novecentesche, e però, uh, che sorpresa: riecco la borghesia e riecco il proletariato. Non so dove possa portare questa annosa faccenda dal punto di vista politico, ma insomma, le differenze sociali troppo marcate si sa che generano insoddisfazione e incazzatura. Dunque lì, lì ai piani bassi, serve più che altro un ridisegno complessivo delle modalità di lavoro e di salario, un certificato statale che chi lavora – almeno chi lavora! – non sia povero, il che tra l’altro ripristinerebbe non solo un minimo di giustizia sociale, ma distenderebbe i nervi i tutti. Forze politiche che prendano sul serio questa battaglia e la portino al centro della scena non ce ne sono, non conviene, non fa fine, forse non sono considerati voti appetibili, non fanno opinione, non sono moderati, non hanno sotto il braccio l’agenda Draghi, quindi non vanno bene.
 E’ probabile che la politica italiana dei primi anni Venti verrà ricordata come un gigantesco gioco di ruolo dal suggestivo titolo: “Dove mettere Mario Draghi”. Certo, parlare oggi di “politica italiana” è un po’ esagerato, e uso questa figura retorica per dire dell’indefessa attività di applaudire il premier in ogni contesto e situazione. Insomma, corre il decennale dell’avvento a palazzo Chigi di Mario Monti e non si scopre niente di nuovo: l’ovazione pare obbligatoria e sembra ieri che la stampa nazionale si spellava le mani perché un tizio andava a Roma in treno, metteva il loden e mandava i lavoratori in pensione più tardi. Da allora, l’evoluzione dell’elettronica è stata poderosa, quindi non parleremo di un Mariomonti due-punto-zero, semmai di un Mariomonti a realtà aumentata. Resta il fatto che “Dove mettere Mario Draghi” è il gioco di società del momento e tocca quindi mettere in fila le ipotesi più accreditate.
E’ probabile che la politica italiana dei primi anni Venti verrà ricordata come un gigantesco gioco di ruolo dal suggestivo titolo: “Dove mettere Mario Draghi”. Certo, parlare oggi di “politica italiana” è un po’ esagerato, e uso questa figura retorica per dire dell’indefessa attività di applaudire il premier in ogni contesto e situazione. Insomma, corre il decennale dell’avvento a palazzo Chigi di Mario Monti e non si scopre niente di nuovo: l’ovazione pare obbligatoria e sembra ieri che la stampa nazionale si spellava le mani perché un tizio andava a Roma in treno, metteva il loden e mandava i lavoratori in pensione più tardi. Da allora, l’evoluzione dell’elettronica è stata poderosa, quindi non parleremo di un Mariomonti due-punto-zero, semmai di un Mariomonti a realtà aumentata. Resta il fatto che “Dove mettere Mario Draghi” è il gioco di società del momento e tocca quindi mettere in fila le ipotesi più accreditate.
Draghi a Palazzo Chigi. Molti giocatori desiderano fortemente questa ipotesi. I partiti al governo per non avere il fastidioso grattacapo di metterci uno dei loro; Silvio Berlusconi nell’astrusa speranza di finire lui al Quirinale, cosa che Salvini e Meloni cercano di fargli credere per fargli poi “marameo” all’ultimo momento. L’ipotesi si scontra con le rigidità del regolamento, cioè che nel 2023 ci saranno le elezioni, per cui si teorizza un Mario Draghi capo del governo anche dopo che si sarà votato, un piccolo azzardo. Si potrebbe però – come ha già chiesto in un editoriale il primo giornale italiano – evitare la seccatura delle votazioni, tenersi Mario Draghi a vita perché votare è ormai inutile e démodé.
Draghi al Manchester United. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha velocizzato la manovra della squadra inglese, ma il talento portoghese ha ormai una certa età e la dirigenza si sta guardando intorno per potenziare la rosa in prospettiva futura. Di Mario Draghi piace il dribbling e la visione di gioco, ma soprattutto il fatto che – come avviene nel campionato italiano – nessun arbitro si sognerebbe mai di fischiargli contro, ha tutta la grande stampa dalla sua parte e gli altri giocatori gli ubbidiscono ciecamente.
Draghi a X-Factor. Rilanciare un programma che ha avuto enorme successo, si sa, non è mai facile e i piccoli aggiustamenti spesso non bastano. Serve dunque una rivoluzione del format, con una giuria più verticistica e autorevole. Chi meglio di Mario Draghi potrebbe giudicare i concorrenti in gara? Pare già di vederlo davanti al cantante che propone di andare in pensione a 82 anni (“Per me è un sì”), o al cospetto del giovane artista che chiede il salario minimo (“Per me è un no”).
Draghi al Quirinale. E’ il sogno di molti. A chi ribatte che poi sarebbe un problema trovare un Mariomonti tre-punto-zero per Palazzo Chigi si ribatte che, una volta arrivato Draghi al Colle, il ruolo del capo del governo sarebbe una questione poco più che decorativa. Con un piccolo strappo al regolamento, insomma, si potrebbe avere un Mario Draghi al Quirinale che nomini Mario Draghi a Palazzo Chigi, nel qual caso avremmo spesso severi moniti di Draghi che ammonisce Draghi di non ricorrere troppo al voto di fiducia.
Draghi alle Olimpiadi. Qualcuno ricorda che tra pochissimo, nel 2024, si svolgeranno i Giochi Olimpici a Parigi e sarebbe folle rinunciare al fondamentale apporto che Mario Draghi ha dato ai successi italiani di Tokyo 2020. Si avanza dunque la sua candidatura in tutte le discipline, certi di un nuovo trionfo del medagliere azzurro.
Il 20 novembre al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) va in scena uno spettacolo teatrale (ma sì, diciamolo, è una commedia!) tratto da un mio vecchio racconto pubblicato nel 2011 (in Piovono Pietre, cronache marziane da un paese assurdo, Laterza Editore). Non ve la farò lunga con la retorica del teatro, su quanto è bello mettere in scena una cosa scritta, trasformare in pièce un racconto, eccetera eccetera. Però vi assicuro che è bello forte. Il titolo è Montabbano sono! (spoiler, il commissario Montalbano non c’entra) e la storia è questa, che un giorno mi suona il telefono (o era la mail?) e una signora gentile anche se molto toscana mi chiede se non ho per caso qualche idea per il teatro, e io le dico, in che senso, scusi? Poi la signora si è rivelata essere Ilaria Morandi, della compagnia teatrale I Pinguini, di Firenze, quindi non era uno scherzo, cioè, in qualche modo sì, ma insomma, che razza di scherzo.
Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) va in scena uno spettacolo teatrale (ma sì, diciamolo, è una commedia!) tratto da un mio vecchio racconto pubblicato nel 2011 (in Piovono Pietre, cronache marziane da un paese assurdo, Laterza Editore). Non ve la farò lunga con la retorica del teatro, su quanto è bello mettere in scena una cosa scritta, trasformare in pièce un racconto, eccetera eccetera. Però vi assicuro che è bello forte. Il titolo è Montabbano sono! (spoiler, il commissario Montalbano non c’entra) e la storia è questa, che un giorno mi suona il telefono (o era la mail?) e una signora gentile anche se molto toscana mi chiede se non ho per caso qualche idea per il teatro, e io le dico, in che senso, scusi? Poi la signora si è rivelata essere Ilaria Morandi, della compagnia teatrale I Pinguini, di Firenze, quindi non era uno scherzo, cioè, in qualche modo sì, ma insomma, che razza di scherzo.
Poi Luca Palli mi ha sottoposto una bozza di adattamento e io ho detto, beh, niente male, se bisogna adattare adattiamo, e così abbiamo lavorato un po’ insieme, finché una sera ci siamo visti a cena, con Luca, Ilaria e altri matti come loro, e ne abbiamo parlato ancora, finché, alla fine, è venuta fuori questa commedia, che spero faccia un po’ ridere e dica anche qualche cosa su di noi e sul conformismo generale, ma anche sui libri, gli occhiali da sole e i motivi per cui ogni tanto ci capita di sghignazzare. E se non ci capite niente, da queste righe, vuol dire che le ho scritte bene. Insomma sabato 20 novembre tutta ‘sta roba si può vedere in un teatro stando comodamente seduti, e alla fine si può decidere se battere la mani o no, che anche questa, se ci pensate, è una bella libertà.
La regia è di Andrea Bruno Savelli, in scena ci sono Pietro Vené, Aldo Innocenti, Cristina Bacci, Simone Petri, Bettina Bracciali, Paolo Gualtierotti, Ilaria Morandi e Sergio Forconi. La produzione è dei Pinguini Theater in collaborazione con la Fondazione Accademia dei Perseveranti. Lo spettacolo è sabato 20 novembre (alle 21) e domenica 21 (alle 16.30), il posto è Campi Bisenzio. Ho finito, vostro onore.
 Colpo di scena, tornano di moda i giovani. Non stupisce più di tanto, è una cosa che succede periodicamente quando si tratta di penalizzare i vecchi, e quindi si attua il facile barbatrucco di mettere generazioni contro generazioni, segnatamente quando si parla di pensioni e previdenza. Traduco: siccome le pensioni ci costano un bel po’ e data l’incapacità di chiedere qualche soldo ai nuovi ricchi (un milione e mezzo i neo-milionari italiani, cresciuti del 20 per cento durante l’età d’oro – per loro – del Covid), ecco che si indicano ai giovani i diritti dei vecchi additandoli come odiosi privilegi.
Colpo di scena, tornano di moda i giovani. Non stupisce più di tanto, è una cosa che succede periodicamente quando si tratta di penalizzare i vecchi, e quindi si attua il facile barbatrucco di mettere generazioni contro generazioni, segnatamente quando si parla di pensioni e previdenza. Traduco: siccome le pensioni ci costano un bel po’ e data l’incapacità di chiedere qualche soldo ai nuovi ricchi (un milione e mezzo i neo-milionari italiani, cresciuti del 20 per cento durante l’età d’oro – per loro – del Covid), ecco che si indicano ai giovani i diritti dei vecchi additandoli come odiosi privilegi.
E’ un trucchetto antico come il mondo, che funziona sempre e che ha come unico effetto collaterale di rivelare la statura etica, morale e politica di chi lo conduce: poca cosa. Non mi addentrerò qui nel vortice attuale dei numeri e nel gorgo che si legge in giro: quota 102, no, 104, no Fornero forever, eccetera eccetera, e mi limiterò all’uso strumentale del giovane in quanto sfigato storico di riferimento, funzionale al dibattito, feticcio utile alla causa draghian-confindustriale. Un po’ occultati e nascosti sotto il tappeto (quando non se ne parla per dire che sono tutti scemi), i famosi giovani vengono buoni adesso per dire che loro probabilmente le pensioni non le vedranno, o le avranno sotto la soglia di una decente sussistenza. E si capisce: calcolandole col contributivo secco, e avendo fino alla mezza età lavori intermittenti e stipendi da fame, dall’Inps prenderanno due cipolle e un pomodoro. Da qui, dritta come una freccia, ecco la pressione sulle trattative per la previdenza di genitori e nonni: è colpa loro e della loro avidità se chi ha vent’anni oggi farà la fame domani. E giù interviste, pareri, interventi, per dire che il sistema è iniquo e penalizza le nuove generazioni (mentre i pensionati anziani, si sa, nuotano nell’oro). Naturalmente essendo le basse paghe e il precariato ad libitum a penalizzare eventuali pensioni dei giovani, bisognerebbe intervenire su quei punti: meno contratti fantasiosi, meno stages e tirocinii, più stipendi veri, magari un salario minimo che finisca per rasentare la decenza. Invece, su quel versante, niente, mentre si spinge sul pedale della guerra tra generazioni, mettendo figli contro padri, cioè i futuri poveracci contro i “privilegiati” che dopo aver lavorato una vita prendono (addirittura!) la pensione.
Il trucchetto ha il suo fascino, e a volte funziona. A pensarci, è quello su cui basa la sua propaganda anti-immigrati Matteo Salvini che tuona “prima gli italiani”, cioè invita i penultimi (gli italiani poveri) a odiare gli ultimi (i migranti). Altro caso di scuola, la narrazione renzista che portò all’abolizione dell’articolo 18. Siccome moltissimi non l’avevano, invece di darlo anche a loro si additò chi ne usufruiva come egoista e privilegiato. Anche allora i giornali erano pieni di giovani che dicevano: io, precario, l’articolo 18 non lo avrò mai, e allora perché deve averlo un metalmeccanico? Il meccanismo culturale che sovrintende il “ridisegno” del sistema pensionistico è esattamente lo stesso: lasciare una moltitudine senza diritti e poi – fase due – additare chi i diritti ancora ce li ha come un pescecane profittatore. Questo il desolante quadro del dibattito: trasferire la guerra ai piani bassi della società, mentre ai piani alti si stappa e si festeggia la ripresa “oltre le previsioni”. Siamo sempre lì: un Monti, un Renzi, un Draghi, la stessa sostanza di cui sono fatti gli interessi dei ricchi.
 Siccome Giorgia Meloni l’altra sera aveva la stessa faccia di Paul McCartney quando si sono sciolti i Beatles, tocca segnalare che dare alla politica una svolta pop comporta qualche rischio. Giorgia era – fino a una settimana fa – enormemente trendy, vezzeggiata, “brava” – e non c’era cronaca, anche critica con Fratelli d’Italia, che non le regalasse quel personale premio di consolazione: è una vera leader. Non so se subirà il contraccolpo della sconfitta (in genere succede), ma ecco che intanto Giorgia perde qualche posizione nella top ten del pop politico italiano. Aveva da poco scalzato il campione, il suo socio Salvini, che aveva avuto estati furenti, ogni dichiarazione un titolo, ogni titolo un rimbalzo nei sondaggi. Fino al crollo perché – semplicemente – aveva rotto le palle, non piaceva più, se lo trovavi alla radio cambiavi stazione, o canale in tivù, come certe canzoncine estive che ti piacciono in agosto, in spiaggia, e trovi ripugnanti in novembre. E’ il pop, bellezza, è quel meccanismo – almeno in politica – per cui qualcuno ha molta più visibilità e successo di quel che realmente raccoglie nel Paese. A un certo punto ci si accorge che il tizio, o la tizia “tirano”, e questo garantisce loro una specie di premio di maggioranza nella copertura mediatica e nei sondaggi. La storiografia delle hit-parade del pop politico registra casi analoghi, anche più drammatici, si pensi a Renzi, che oggi per trovarlo in classifica bisogna immergersi come palombari. Ma insomma: resta il fenomeno pop, in cui il gradimento politico si mischia alle copertine, alle mattane nei talk-show, alla comunicazione social, insomma un impasto di sussulti pre e post politici in cui la politica finisce per entrare poco.
Siccome Giorgia Meloni l’altra sera aveva la stessa faccia di Paul McCartney quando si sono sciolti i Beatles, tocca segnalare che dare alla politica una svolta pop comporta qualche rischio. Giorgia era – fino a una settimana fa – enormemente trendy, vezzeggiata, “brava” – e non c’era cronaca, anche critica con Fratelli d’Italia, che non le regalasse quel personale premio di consolazione: è una vera leader. Non so se subirà il contraccolpo della sconfitta (in genere succede), ma ecco che intanto Giorgia perde qualche posizione nella top ten del pop politico italiano. Aveva da poco scalzato il campione, il suo socio Salvini, che aveva avuto estati furenti, ogni dichiarazione un titolo, ogni titolo un rimbalzo nei sondaggi. Fino al crollo perché – semplicemente – aveva rotto le palle, non piaceva più, se lo trovavi alla radio cambiavi stazione, o canale in tivù, come certe canzoncine estive che ti piacciono in agosto, in spiaggia, e trovi ripugnanti in novembre. E’ il pop, bellezza, è quel meccanismo – almeno in politica – per cui qualcuno ha molta più visibilità e successo di quel che realmente raccoglie nel Paese. A un certo punto ci si accorge che il tizio, o la tizia “tirano”, e questo garantisce loro una specie di premio di maggioranza nella copertura mediatica e nei sondaggi. La storiografia delle hit-parade del pop politico registra casi analoghi, anche più drammatici, si pensi a Renzi, che oggi per trovarlo in classifica bisogna immergersi come palombari. Ma insomma: resta il fenomeno pop, in cui il gradimento politico si mischia alle copertine, alle mattane nei talk-show, alla comunicazione social, insomma un impasto di sussulti pre e post politici in cui la politica finisce per entrare poco.
I sondaggi seguono, in parte, o fotografano, questa logica. Quando era accreditato del 34 per cento – ancora un annetto fa – Salvini raccoglieva i frutti del suo primo posto nella classifica pop. Un sondaggio di popolarità, diciamo, la cosa non è sorprendente. Ciò che stupisce, invece, è che quel numero fosse preso per buono, e Salvini andasse in giro (e si comportasse, e venisse ascoltato, e intervistato, e esposto) dicendo di essere “il primo partito in Italia”. Così come oggi (cioè, l’altro ieri) Giorgia Meloni parlava di Fratelli d’Italia come della “prima forza politica del Paese”. I sondaggi, insomma, fanno l’agenda politica, dettano spazi e protagonisti, il che, con un Parlamento semidefunto che si limita a votare fiducie e a ratificare decreti, non stupisce.
Una volta trasformati i cittadini e gli elettori in pubblico dello spettacolino pop (ci sono anche band underground che ogni tanto spuntano e scompaiono, tipo Calenda), non ci si può stupire se hanno gusti volubili, se cambiano idea spesso, se si innamorano e disamorano in fretta. Oppure se decidono – i cittadini-spettatori – all’improvviso (mica tanto, il segnale c’è da tempo) che il teatrino non gli interessa, che la top ten degli ego non risolverà i loro problemi, che la noia ha preso il sopravvento.
Non saprei dire quanta importanza abbia, ora, rimproverare di questa situazione il sistema mediatico. E’ lì, dopotutto che si compiono le grandi “operazioni simpatia”, è lì che si creano i front-men, che si gettano i semi. Gli stessi media che facevano un titolo a nove colonne per un sospiro di Matteo (dei Mattei), o per una canzoncina su Giorgia, registreranno ora un calo in classifica degli ultimi beniamini. Pazienza, arriverà qualcun altro, è il pop, bellezza, e tu non puoi farci niente.
 Coi virologi abbiamo dato, e se cominciassimo con gli storici? Intendo: se in ogni telegiornale, talk show, siparietto divertente, angolo delle interviste, documentario e Carosello, invece di un esperto di pandemie ci mettessimo qualcuno che ha studiato seriamente il famoso Ventennio? Ok, abbiamo fatto per quasi due anni una straripante, strabordante, spannometrica, lezione di virus. In tram senti signore che parlano di memoria cellulare o di affinità e divergenze tra Astra Zeneca e noi, bene. Passiamo alla nostra storia, che ne dite? Ed ecco a voi il primario di Storia Contemporanea…
Coi virologi abbiamo dato, e se cominciassimo con gli storici? Intendo: se in ogni telegiornale, talk show, siparietto divertente, angolo delle interviste, documentario e Carosello, invece di un esperto di pandemie ci mettessimo qualcuno che ha studiato seriamente il famoso Ventennio? Ok, abbiamo fatto per quasi due anni una straripante, strabordante, spannometrica, lezione di virus. In tram senti signore che parlano di memoria cellulare o di affinità e divergenze tra Astra Zeneca e noi, bene. Passiamo alla nostra storia, che ne dite? Ed ecco a voi il primario di Storia Contemporanea…
Se ci allontaniamo un po’, come prospettiva, dalla sede della Cgil di Roma (massima solidarietà) e vediamo le cose più ad ampio spettro, di lezioni di storia ne servirebbero un bel po’. Il discorso di Giorgia Meloni in Spagna, per esempio, ci rivela una folta platea sinceramente e devotamente franchista, dittatura molto amata dai fascisti nostrani della generazione Almirante, come anche i colonnelli greci (è gente che non si fa mancare niente, gli piaceva anche Pinochet). In Francia si litigano la palma di re della destra, in vista dell’Eliseo, madame Le Pen e monsieur Zemmour, come dire fascio e più fascio. Non va meglio nel resto d’Europa, sia a livello di governi (l’Ungheria di Orban e la Polonia che insegue), e non c’è paese che non abbia una formazione parafascista, fortemente nostalgica, a volte rappresentata alle elezioni; a volte dispersa in una galassia semiclandestina di gruppetti con la svastica tatuata su fronti “inutilmente spaziose”.
Se ne deduce che il “non conosco la matrice” (delle azioni squadriste di Roma, ndr) di Giorgia Meloni è un trucchetto ancor più patetico di “voglio vedere tutto il girato”. Quella matrice lì, con le croci celtiche, le svastiche, i boia chi molla e tutto il campionario, la riconosce anche un ripetente di seconda media, dunque quella della Meloni è una provocazione.
Detesto i paralleli storici, anche perché le cose non sono mai parallele, ma pensare che siamo nel 2021, cioè a un secolo esatto da fatti che somigliano a quelli di oggi, con gli arditi che attraversano indisturbati una città per andare a devastare la sede sindacale, beh, qualche brividino dovrebbe metterlo. Quindi uno storico ospite qui e là che ci dicesse come si arrivò a quella situazione, perché, come mai, quali furono le molle sociali, economiche, ideologiche, insomma, che ci faccia un ripassino, non sarebbe male. Magari che smonti il diffuso luogocomunismo fascista del “ha fatto anche cose buone”, o le agghiaccianti nostalgie repubblichine tanto in voga. Magari ci spiegherebbe – il nostro ipotetico storico diffuso – che il vittimismo era parte consistente nella costruzione del primo fascismo, e non sarebbe difficile ritrovare quel tratto nella difesa dei gerarchi di FdI e della Lega e nei titoli dei giornali della destra. Passare per vittime, insomma, è un tratto distintivo, e la vulgata di destra di questi giorni lo conferma. Non si tratta di cercare analogie, che è un giochetto facile, ma di individuare – appunto – la “matrice”, che è un imprinting ideologico. Giorgia Meloni non sa, o forse ha capito dopo, di aver dato un titolo perfetto al dibattito, e forse non troppo conveniente per lei. Perché se si cercano gli arditi, eccolì lì, già noti alle cronache, i Fiore, i Castellino, facile. Ma se si cerca davvero la matrice, la struttura ideologica, il dna storico-culturale, beh, si scopre facilmente che quello è l’album di famiglia di Giorgia, che la matrice è nota.
 Come anche ciechi e sordi hanno capito da tempo, Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di fare i conti con i cascami fascisti nel suo partito, che sono parecchi e ben radicati (d’altronde, basta guardare il simbolo per capire da dove viene, e con chi). Mi spiego, non quattro dirigenti mattacchioni – ogni tanto ne beccano uno vestito da nazista, o che saluta romanamente, o peggio – ma una vera cultura di base: la moderna FdI poggia su un irrequieto cimitero di labari e gagliardetti di cui finge ogni tanto di vergognarsi ma che non può seriamente combattere. Diciamo così: per ogni dirigente che racconta la barzelletta su Hitler ci sono dieci militanti che ridono e si danno di gomito, fingere di non vedere il problema fa parte del problema.
Come anche ciechi e sordi hanno capito da tempo, Giorgia Meloni non ha nessuna intenzione di fare i conti con i cascami fascisti nel suo partito, che sono parecchi e ben radicati (d’altronde, basta guardare il simbolo per capire da dove viene, e con chi). Mi spiego, non quattro dirigenti mattacchioni – ogni tanto ne beccano uno vestito da nazista, o che saluta romanamente, o peggio – ma una vera cultura di base: la moderna FdI poggia su un irrequieto cimitero di labari e gagliardetti di cui finge ogni tanto di vergognarsi ma che non può seriamente combattere. Diciamo così: per ogni dirigente che racconta la barzelletta su Hitler ci sono dieci militanti che ridono e si danno di gomito, fingere di non vedere il problema fa parte del problema.
Ma siccome qui si parla di comunicazione e narrazioni, rimane interessante capire come fa la leader di FdI a sfiorare ancora una volta la domanda, parlare d’altro e, in definitiva, non rispondere. Insomma, scienza e tecnica della deviazione, ché tanto i media ci cascano (e infatti: ci cascano). Il classicone intramontabile di Giorgia è la data di nascita: è nata dopo il 25 aprile del’45 (un bel po’ dopo) e quindi bon, chiuso, il fascismo non la riguarda, roba vecchia, che palle, tipo i Beatles. Una visione interessante, una specie di vertigine storica da film di fantascienza, la mente che cancella, e tutto quello che esisteva prima di te non esiste. Purtroppo il dibattito politico è fatto così, una battutina e via, e dall’altra parte (i famosi media) nessuno che incalzi sul punto, che dica: “Bella battuta, ora però parliamo seriamente”.
L’ultima trovata per non rispondere alla famosa domanda è la strabiliante richiesta di “tutto il girato” di un’inchiesta audiovideo durata tre anni ad opera dei cronisti di Fanpage. Si tratta dello stesso procedimento retorico: rispondere con una battuta o una pretesa risibile, o con qualche trucchetto per cui dici e non dici, ammicchi, giochi la carta del vittimismo e insomma, alla domanda politica non rispondi, perché non puoi farlo. Un’elusione in piena regola con aspetti divertenti, perché quel che si lascia intendere è che vedendo le altre 99 ore e passa di “girato”, chissà a quali meraviglie avremmo assistito, che so, dirigenti di FdI che portano i fiori sulla tomba di Matteotti, che festeggiano il 25 aprile, o salvano migranti in mare, vai a sapere cosa ci nascondono! Insomma è un altro trucchetto retorico, buono per il bar, per il videomessaggio sui social e per i comunicati stampa, niente di nuovo sotto il cielo di Giorgia, che promette di “torchiare” i suoi, e a noi maligni viene in mente via Tasso.
Eppure la questione politica è enorme: FdI sta per strappare lo scettro della leadership della destra al povero Salvini, decisamente rintronato, e si candida (pur incassando una bella sberla alle amministrative) a guidare il Paese, dunque la questione dell’intima anima fascista del partito andrà affrontata con argomenti un po’ più solidi. Oggi la narrazione prevalente dice di una Meloni brava, uh che brava!, e di un partito inadeguato e senza classe dirigente. E’ una narrazione un po’ comoda e semplicistica, e oltretutto non tiene conto che un politico che vuole arrivare a palazzo Chigi non può cavarsela a lungo con piccoli calembours. Oppure è tutto più semplice e cristallino: alla domanda se FdI contenga una consistente componente fascista, se siamo ancora al fascino per le puttanate in orbace, la non-risposta di Giorgia Meloni è invece una perfetta risposta. Affermativa.
 Se non si parla di politica, ma di Comédie Humaine, ci vorrebbe Balzac, per dire del caso Morisi e della Lega salviniana tutta. Una galleria di personaggi che avrebbe fatto la fortuna di un buon romanziere ottocentesco: il Rasputin dei social media, il costruttore in affari coi russi, la cascina nelle nebbie nata come enclave vip e “ora ci abitano un po’ tutti”, il capo che abbraccia e perdona, i ragazzi rumeni che se la cantano manco li avesse interrogati Philip Marlowe. E poi i commercialisti furbetti, i milioni spariti, la faccia truce del potere, un feuilleton in piena regola. Mi sembra che questo elemento, sovrastato dal clamore politico, sia passato un po’ in ombra, peccato. Anche perché, la figura di quello che predica in un modo e viene sorpreso a fare l’opposto – diciamo così, la sindrome del vescovo beccato nel bordello – ha un fascino eterno, inscalfibile. Da lì passa la lama che divide l’umorismo dalla satira, è lì che un incidente disvela il reale. E’ più di una faccenda politica, è un tratto letterario, è una caduta della maschera così clamorosa da diventare proverbiale, e quindi ci vorrebbero un Balzac, uno Zola, a dire la loro.
Se non si parla di politica, ma di Comédie Humaine, ci vorrebbe Balzac, per dire del caso Morisi e della Lega salviniana tutta. Una galleria di personaggi che avrebbe fatto la fortuna di un buon romanziere ottocentesco: il Rasputin dei social media, il costruttore in affari coi russi, la cascina nelle nebbie nata come enclave vip e “ora ci abitano un po’ tutti”, il capo che abbraccia e perdona, i ragazzi rumeni che se la cantano manco li avesse interrogati Philip Marlowe. E poi i commercialisti furbetti, i milioni spariti, la faccia truce del potere, un feuilleton in piena regola. Mi sembra che questo elemento, sovrastato dal clamore politico, sia passato un po’ in ombra, peccato. Anche perché, la figura di quello che predica in un modo e viene sorpreso a fare l’opposto – diciamo così, la sindrome del vescovo beccato nel bordello – ha un fascino eterno, inscalfibile. Da lì passa la lama che divide l’umorismo dalla satira, è lì che un incidente disvela il reale. E’ più di una faccenda politica, è un tratto letterario, è una caduta della maschera così clamorosa da diventare proverbiale, e quindi ci vorrebbero un Balzac, uno Zola, a dire la loro.
Oltretutto, mai personaggio potrebbe essere così trasparente: Morisi lo possiamo leggere parola per parola scarrellando all’indietro i social di Salvini per cinque lunghi anni, è come se un personaggio si presentasse sulla scena con il curriculum in mano, che passa dalle “risorse boldriniane” alla gastronomia popolare, dall’attacco sistematico ai più deboli, ai selfie con la figlia, al “non si usano i figli per la politica” al “no alla droga” anche (anzi, soprattutto) quando si parla di due canne. Tutto il repertorio, insomma, nero su bianco e con le fotine. Lo Zeigest morisian-salviniano è sempre stato chiaro, lampante. Il problema è che è invecchiato, non serve più. Che al momento l’ordine di scuderia è un altro: fare i responsabili incravattati al Mise, e procedere con la linea Draghi, nascondere un po’ di arditi sotto il tappeto, e sorridere alle telecamere, possibilmente senza salami in mano.
La narrazione di Salvini, tutta all’attacco, sprezzante, intimamente fascista, con il forte che picchia i deboli, aveva un’eco sistematica e costante, rimbalzava sui media ufficiali, faceva notizia, quindi suggerirei anche meno lacrime e sentimenti di facile umanità, perché Morisi non parlava solo sui social di Salvini, ma al paese intero, con tivù e giornali alla ricerca dell’ultima trovata che facesse titolo. Complice anche – segno dei tempi – una certa fascinazione tecnica, per cui di un propagandista che inquina i pozzi, avvelena le acque, sposta a destra il sentiment di un paese intero si può dire: “Però è bravo”. I numeri confermano: la Lega stava al 4 e quando è comparso lui è arrivata al 34. E anche gli avversari lo dicono come se fosse un merito e non una iattura, con un po’ di ammirazione che sottintende: avercene di Morisi!, con ciò confermando indirettamente l’attuale situazione etica della politica italiana.
Per portarsi avanti col lavoro, comunque, urge sapere se con Morisi finisce anche il morinismo, cosa non molto probabile, il Parlamento è sistematicamente sorpassato dai voti di fiducia, la barra è dritta, il sentiero tracciato, non resta, come prova di esistenza in vita per leader e capipopolo, che litigare sui social, inventare nuove formule e slogan. Ecco, un consiglio: nel caso si lanciasse una crociata contro i frutti tropicali, meglio evitare si farsi beccare in una cesta di ananassi
Come sapete (?) è uscito in Francia “Di rabbia e di vento”, sempre per le Editions de l’Aube, e sempre con la benedetta traduzione di Paolo Bellomo e di Agathe Lauriot dit Prévost (grazie, amici, come fate rimarrà per me un mistero). Qui due recensioni francesi, una di NYCTALOPES (qui) e l’altra di Le Litteraire.com (qui). Per leggere cliccare sulle immagini. Grazie grazie, merci
 A giudicare da titoli e titoloni che i giornali hanno dedicato ieri e l’altro ieri alla vittoria in tribunale dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, sembrerebbe di vivere nel paese dei Soviet. Di colpo, tutti accanto ai lavoratori licenziati, anche se il giorno prima, quando quelli (e altri) erano scesi in piazza sotto lo striscione “Insorgiamo”, avevamo letto al più qualche trafiletto, piccole fotonotizie, spigolature non più lunghe delle noterelle acchiappa-click tipo il cane che conta fino a sei e la gara di velocità per lumache. Insomma, alla buon’ora: una òla per il tribunale che dà ragione ai lavoratori (bene, benissimo), e quasi niente per le lotte degli stessi lavoratori, che minacciano un autunno caldo, e non si fa, signora mia.
A giudicare da titoli e titoloni che i giornali hanno dedicato ieri e l’altro ieri alla vittoria in tribunale dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, sembrerebbe di vivere nel paese dei Soviet. Di colpo, tutti accanto ai lavoratori licenziati, anche se il giorno prima, quando quelli (e altri) erano scesi in piazza sotto lo striscione “Insorgiamo”, avevamo letto al più qualche trafiletto, piccole fotonotizie, spigolature non più lunghe delle noterelle acchiappa-click tipo il cane che conta fino a sei e la gara di velocità per lumache. Insomma, alla buon’ora: una òla per il tribunale che dà ragione ai lavoratori (bene, benissimo), e quasi niente per le lotte degli stessi lavoratori, che minacciano un autunno caldo, e non si fa, signora mia.
Resta sul campo, la proposta di inventarsi qualcosa per rimediare all’incidente belluino delle grandi aziende che vengono qui, prendono soldi per insediarsi, incassano contributi pubblici, e poi decidono di andarsene dove i lavoratori costano meno, magari licenziando con un sms, le famose delocalizzazioni.
E qui – scusate la noia – scatta quello che potrebbe sembrare un dibattito culturale, il famoso “che fare”. Perché la proposta di penalizzare in qualche modo chi prende i soldi e scappa non piace per niente a Giorgetti (Lega), a Bonomi (Confindustria) e a Draghi (Draghi). Si era cominciato parlando di sanzioni abbastanza significative: una multa pari al due per cento del fatturato e la creazione di una black list, cioè niente contributi pubblici per qualche anno a chi ha fatto il furbo ed è finito nella lista. Apriti cielo. Da Confindustria hanno cominciato a metter mano ai fazzoletti, piangendo amare lacrime sulla “penalizzazione” delle aziende, e lo stesso ministro dello Sviluppo economico – descritto dalla stampa buontempona come il leghista che ci sta con la testa (la testa di Bonomi) – ha detto che così si scoraggia a investire in Italia. Cioè si scoraggia chi investe qui e scappa subito dopo, ma questo è un dettaglio. Insomma, la solita solfa, il chiagni e fotti che ben conosciamo.
Per fortuna ci sono le indiscrezioni dei giornali che ci illuminano su come la pensa Draghi (domani parlerà a Confindustria e forse sapremo), e cioè così: non bisogna punire i cattivi, ma premiare i buoni. Dunque, a quel che si è capito, limitare le sanzioni per chi scappa lasciando all’improvviso sul lastrico centinaia di famiglie, e dare invece incentivi a chi si comporta decentemente, cioè investe, assume, produce e guadagna. Risultato: un altro bonus per chi fa impresa, che prenderebbe così aiuti, incentivi, facilitazioni o sconti solo per il fatto di comportarsi come sarebbe giusto, normale e lecito.
Anche tendendo molto l’orecchio, a fronte di questa impostazione culturale (dare soldi a chi si comporta normalmente anziché toglierli ai manigoldi), non si colgono le grida dei liberisti, quelli contrari ai sussidi, allo Stato che mette il naso nell’economia privata, alla famigerata giungla normativa. Cioè: tutti contrari ai sussidi, a meno che i sussidi non arrivino alle imprese, nel qual caso niente da dire, anzi hurrà! Il famoso “Sussidistan” di cui parlò Bonomi riferendosi ai poveri aiutati dallo Stato, diventa di colpo una mano benedetta, un toccasana, qualcosa da applaudire con convinzione se invece va a premiare il famoso libero mercato, libero di allungare il cappello per il prossimo obolo – pardon, incentivo – che sarebbe tra l’altro l‘ultimo di una lunga, lunghissima serie per il capitalismo assistito d’Italia.
 Il reddito di cittadinanza è ormai un genere letterario, credo che dovrebbero istituire dei premi appositi. La prima cosa che si fa nei giornali quando c’è una notizia di reato (rapina in banca, furto con scasso, spaccio, sequestro di persona, furto di cavalli) è andare a controllare se il colpevole prende il reddito di cittadinanza, in modo da completare la facile equazione: delinquente uguale sussidiato. E’ solo la punta dell’iceberg, il resto è garrula narrazione diffusa: non hanno voglia di lavorare, meglio il divano, è diseducativo alla fatica (Renzi), è diseducativo alla fatica (Salvini, la ripetizione non è mia, ndr), eccetera eccetera. Come dicevo, un vero genere letterario. Lo dico subito a scanso di equivoci: chi prende il reddito di cittadinanza e non ne ha diritto va sanzionato, in primis perché magari lo toglie a chi ne ha più diritto e bisogno, e in secondo luogo perché ricorda le vecchie storie di quelli che congelano il cadavere della nonna per continuare a prendere la pensione (non è che per questo si chiede l’abolizione delle pensioni).
Il reddito di cittadinanza è ormai un genere letterario, credo che dovrebbero istituire dei premi appositi. La prima cosa che si fa nei giornali quando c’è una notizia di reato (rapina in banca, furto con scasso, spaccio, sequestro di persona, furto di cavalli) è andare a controllare se il colpevole prende il reddito di cittadinanza, in modo da completare la facile equazione: delinquente uguale sussidiato. E’ solo la punta dell’iceberg, il resto è garrula narrazione diffusa: non hanno voglia di lavorare, meglio il divano, è diseducativo alla fatica (Renzi), è diseducativo alla fatica (Salvini, la ripetizione non è mia, ndr), eccetera eccetera. Come dicevo, un vero genere letterario. Lo dico subito a scanso di equivoci: chi prende il reddito di cittadinanza e non ne ha diritto va sanzionato, in primis perché magari lo toglie a chi ne ha più diritto e bisogno, e in secondo luogo perché ricorda le vecchie storie di quelli che congelano il cadavere della nonna per continuare a prendere la pensione (non è che per questo si chiede l’abolizione delle pensioni).
C’è però un altro genere letterario che meriterebbe attenzione, e che riguarda sempre il mondo del lavoro: quello delle offerte di impiego. Basta sfogliare uno dei tanti portali di annunci per assaggiare meravigliosi stralci di prosa italiana del XXI secolo, roba che dovrebbe entrare nelle antologie. Tipo il barista per dieci ore al giorno, ma ve ne pagano quattro, il banconista a due euro l’ora, la commessa “stagista con esperienza”, eccetera eccetera. Lettura ricca di colpi di scena, per cui ognuno potrà farsi la sua top ten dell’annuncio più spericolato. Il mio preferito – me l’ero segnato a suo tempo – era un’inserzione per banconista in un negozio di autoricambi a Messina: dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana, più la mattina della domenica: totale 66 ore settimanali per 400 euro al mese (ve lo faccio io, il conto: fa 1 euro e cinquanta all’ora). Ma non voglio consigliarvi la mia playlist preferita, fatevi la vostra, tra baristi, commessi, addetti alle pulizie, eterni stagisti, avrete un campionario infinito, una specie di Spotify dello sfruttamento, un pozzo senza fondo. Trattandosi di annunci di lavoro, c’è sempre un riferimento, un contatto, un numero da chiamare o una mail a cui scrivere, e ci si chiede come mai, ogni tanto, non risponda l’ispettorato del lavoro: è lei che cerca un commesso a un euro e cinquanta l’ora? Venga con noi. Non sarebbero indagini difficili, ma non le fa nessuno, peccato (lo dico anche per i giornali, sarebbe una fonte inesauribile di spigolature divertenti).
Intanto, in Europa, ventuno paesi su ventisette hanno un salario minimo garantito. Traduco: se lavori non puoi prendere meno di una certa cifra. E sono, in certi casi, cifre da capogiro 1.555 euro mensili in Francia, 1.626 in Belgio, 1.685 in Olanda, per non dire del Lussemburgo, dove nessuno, per legge, può lavorare per meno di 2.202 euro mensili. Per chi vuole guardare oltreoceano, negli Stati Uniti siamo a 1.024 euro, niente male.
Qui no. Qui il salario minimo era in una bozza del famoso Recovery plan, che sciccheria, ma poi è sparito – puff! – quando il testo è arrivato in Parlamento. Mistero: chi sarà stato? Come mai? Come si dice in questi casi, le indagini sono ferme, si brancola nel buio, si seguono tutte le piste. C’è evidentemente un caso di sordità selettiva, perché un salario minimo, a ben vedere “ce lo chiede l’Europa”, ma da quell’orecchio, chissà perché, l’Italia non ci sente.
 Ci sono due cose che contengono l’apoteosi della tristezza: la pizza fredda e la birra calda. Sulla pizza fredda non si è ancora pronunciato nessuno (diamogli tempo), ma pare che la birra calda si affacci periodicamente come geniale soluzione al male supremo delle città, dove molti giovani passano le serate in piazza sorseggiando colpevolmente liquidi non a temperatura ambiente, il che sconcerta e crea pericolo. La triste questione della birra calda torna alla ribalta in quel girone dantesco che sono le elezioni comunali a Roma, e precisamente nel programma di Carlo Calenda per il III Municipio, con tanto di slide, in cui si parla (testuale) di “movida a basso costo”, deriva da combattere con tutti i mezzi. Uno dei quali sarebbe, appunto, staccare i frigoriferi ai minimarket che vendono bibite, anche alcoliche come la birra.
Ci sono due cose che contengono l’apoteosi della tristezza: la pizza fredda e la birra calda. Sulla pizza fredda non si è ancora pronunciato nessuno (diamogli tempo), ma pare che la birra calda si affacci periodicamente come geniale soluzione al male supremo delle città, dove molti giovani passano le serate in piazza sorseggiando colpevolmente liquidi non a temperatura ambiente, il che sconcerta e crea pericolo. La triste questione della birra calda torna alla ribalta in quel girone dantesco che sono le elezioni comunali a Roma, e precisamente nel programma di Carlo Calenda per il III Municipio, con tanto di slide, in cui si parla (testuale) di “movida a basso costo”, deriva da combattere con tutti i mezzi. Uno dei quali sarebbe, appunto, staccare i frigoriferi ai minimarket che vendono bibite, anche alcoliche come la birra.
Diciamolo subito, anche per non fare di Calenda uno strabiliante innovatore: questa faccenda di incoraggiare la vendita di birra calda ha radici antiche. Se ne trova traccia su Il Tirreno già nell’anno di grazia 2016, quando il comune di Pisa vietò la vendita di bevande fredde, sempre per contrastare la movida (allora, nei titoli, era “selvaggia”, al classismo del “basso costo” non si era ancora arrivati). Venendo ai giorni nostri, una simile ordinanza è stata adottata questa estate dal comune di Voghera (sì, quello dell’assessore leghista alla sicurezza che ha ammazzato a pistolettate un immigrato): si fa divieto ai commercianti di detenere e conservare bevande alcoliche “di qualunque genere e gradazione a temperatura inferiore di quella ambiente abbassata mediante utilizzo di sistemi e/o apparecchi di refrigerazione e raffrescamento”.
Naturalmente a tutti piace sorseggiare un gustoso Moscow Mule ghiacciato ai tavolini delle belle piazze italiane, nei privé o nei locali esclusivi, ma la birretta al volo, magari (sacrilegio!) seduti sui gradini o sulle panchine è considerato poco commendevole e foriero di disordini. Insomma, un nuovo – ennesimo – capitolo della guerra ai poveri passa questa volta per i frigoriferi, diavolerie moderne che attentano alla quiete pubblica e consentono momenti di ristoro e rinfresco alle classi meno abbienti (gente che non sa soffrire, secondo la vulgata salvinian-renzista, diseducata alla consumazione come dio comanda). La questione della birra calda nelle piazze del III Municipio di Roma è stretta parente delle ordinanze fiorentine che vietano di mangiarsi un panino in strada, cosa che dovrebbe avere il duplice scopo di aumentare il fatturato delle trattorie e di scoraggiare i visitatori poco solventi, insomma di tenere alla larga i poveracci che rovinano il paesaggio. Trattasi di lotta di classe, ininterrottamente e ferocemente condotta contro le classi meno abbienti che – dai tempi di Dickens e anche da prima – non possono frequentare taverne costose, né accasarsi in alberghi con molte stelle, né ambire all’ingresso nei bar di lusso, dove la birra fredda resterebbe naturalmente disponibile. Forse dovremmo, a questo punto, cercare una metafora o una allegoria per dire del ridicolo, e anche della violenza, di un simile disegno. Ma non è il caso di sforzarsi, è già tutto abbastanza metaforico così, e sapete tutti che, una volta toccato il fondo, si può sempre cominciare a scavare. Forse si scoprirà che le scarpe “a basso costo” rovinano i selciati delle nostre piazze, e bisognerà correre ai ripari, anche con mezzi drastici – severi ma giusti – tipo l’amputazione dei piedi ai cittadini di basso reddito.
 Se la politica è la battaglia delle idee, porca miseria, prima o poi serviranno delle idee, ma siccome chi ha delle idee viene subito bollato come “ideologico”, allora è meglio non averle, le idee, e sedersi su quelle degli altri, che idee non ne hanno nemmeno loro, ma sembra che vincano.
Se la politica è la battaglia delle idee, porca miseria, prima o poi serviranno delle idee, ma siccome chi ha delle idee viene subito bollato come “ideologico”, allora è meglio non averle, le idee, e sedersi su quelle degli altri, che idee non ne hanno nemmeno loro, ma sembra che vincano.
Ed eccoci a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, instancabile globetrotter delle idee degli altri. Ultima uscita, molto commentata, il suo elogio di Matteo Salvini, una specie di apologia di Socrate, con qualche piccola differenza: che Emiliano non è Platone, che Salvini non è Socrate e che ha mangiato e bevuto di tutto, ma non la cicuta (era mojito).
Mi rendo conto che l’argomento non è entusiasmante e che ci sarebbero mille cose più interessanti di cui parlare, dalla raccolta dei funghi al calciomercato, ma se la politica italiana offre questo, beh, tocca accontentarsi.
Dunque Emiliano.
Dice che “Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese” e che da quando c’è il governo Draghi non è più omofobo, non è più xenofobo, non è più antieuro, non è più antieuropeo, non sventola più madonne e rosari e insomma, non si sa quel che gli è capitato, ma nel volgere di pochi mesi è diventato quasi una brava persona, e magari non si chiama più nemmeno Salvini. Naturalmente Emiliano sta anche con Draghi, sta anche con Conte, starebbe con gli alieni, se sbarcassero in Puglia (“Sono molto avanti tecnologicamente”), oppure, alla bisogna, si gemellerebbe con qualche tribù antropofaga del Borneo (“Difendono le loro tradizioni”), o, se servisse, con i serpenti a sonagli (“La natura è meravigliosa”). Tra i pregi di Salvini secondo Emiliano ci sarebbe il fatto che ha lasciato la Meloni (eh?, ndr) e che ha fatto dimettere Durigon, che è un po’ come dire che i nazisti lasciarono Stalingrado perché non gli piaceva il clima. Insomma, Emiliano se la canta e se la suona, a volte con un indomito sprezzo del ridicolo, tipo dire che Fratelli d’Italia parla alla parte oscura dell’umanità, ma flirtare con il sindaco di Nardò che è un ex (?) di Casa Pound. In confronto a Emiliano, un arabesco è una linea retta. Ora, naturalmente, il problema non è il “governatore” della Puglia, per cui bisognerebbe inventare un “Emilianometro” che ne registri le oscillazioni in tempo reale, ma la cretinissima pervicacia con cui si abbraccia l’ultimo format in circolazione, l’ultima trovata, la più recente cazzata in commercio. Ancora si ride, per esempio, alle grida di giubilo provenienti dai draghisti militanti quando Salvini, nel suo discorso per la fiducia al governo, citò Parri. Urca cita Parri! E’ cambiato! E giù battimani per il nuovo Salvini (probabilmente pensava fosse una mezzala del Milan).
Ci perdoni dunque Emiliano se non consideriamo la sua svolta salviniana come una cosa seria in un posto (l’Italia) e in un tempo (gli ultimi vent’anni, più o meno) in cui di serio non c’è niente. In più, delle cose che dice ce n’è una vera, comunque, che lui “ha a cuore l’umanità”, e in effetti non c’è niente di più umano che pararsi le chiappe, tenersi buoni i futuri potenti, dire “io sono stato amico atté” quando sarà il momento. Il resto è vita, orecchiette, olio buonissimo, i tramonti meravigliosi del Salento e un’idea di politica che è stretta parente delle signorie medievali, quando uno stava un po’ col papa, un po’ con l’imperatore, un po’ col primo venuto, o con l’ultimo arrivato, purché ne venisse fuori, come da una spremuta, un qualche goccia di potere.
Oggi sul Il Fatto Quotidiano un mio raccontino, che forse non è un raccontino, ma insomma, eccolo (se cliccate, come per magia si ingrandisce)
 Chissà se è vero che tre indizi fanno una prova, forse no, forse tre indizi fanno solo tre indizi, ma sono sempre parecchi, abbastanza da creare forti sospetti. Se poi i tre indizi hanno nomi e cognomi, e hanno tutti a che fare con il governo Draghi e le nostalgie fasciste, beh, qualche pensiero ti viene, non c’è niente da fare.
Chissà se è vero che tre indizi fanno una prova, forse no, forse tre indizi fanno solo tre indizi, ma sono sempre parecchi, abbastanza da creare forti sospetti. Se poi i tre indizi hanno nomi e cognomi, e hanno tutti a che fare con il governo Draghi e le nostalgie fasciste, beh, qualche pensiero ti viene, non c’è niente da fare.
Primo nome: Mario Vattani, detto anche “Katanga”, fondatore di gruppi rock filonazisti come Intolleranza e SottoFasciaSemplice, uno che faceva il saluto romano ai concerti di Casa Pound (vi risparmio i testi perché, a leggerli, viene voglia di scappare in Svizzera vestito da tedesco e poi finire a piazzale Loreto). Dopo luminosa carriera (diplomatico figlio di diplomatico, in un paese ereditario come il nostro non è una novità), ecco ora “Katanga” ambasciatore della Repubblica Italiana a Singapore, nominato alla fine di aprile 2021 nonostante qualche flebile protesta.
Secondo nome, più noto alle cronache di questi mesi: Claudio Durigon, sottosegretario leghista del governo Draghi al ministero dell’economia. E’ quello che ha avuto la luminosa idea di proporre che un parco, a Latina, tolga la targa che lo dedica a Falcone e Borsellino e ne metta una in onore di Arnaldo Mussolini, fratellino del più noto puzzone littorio. Nonostante sulle dimissioni di Durigon ci sia forte dibattito (e forse, si vedrà, una mozione di sfiducia), il capo del governo Mario Draghi non ha detto una parola in proposito. Un silenzio davvero inquietante. E anzi, incontrando l’altroieri Salvini “per fare il punto sull’attività del governo”, non ne ha parlato nemmeno per mezzo secondo. Salvini fa sapere che Durigon è vivo e lotta insieme a lui, anzi, sta studiando la riforma delle pensioni. Andiamo bene.
Il terzo nome, meno noto, è quello di Andrea De Pasquale, nominato dal ministro Franceschini alla direzione dell’Archivio Centrale dello Stato (ne ha parlato ieri Tomaso Montanari su questo giornale). Uno che, quando dirigeva la Biblioteca Nazionale, acquisì il fondo archivistico personale di Pino Rauti, il fondatore del gruppo fascista (e stragista, come da sentenze sulle stragi di Brescia e di piazza Fontana) Ordine Nuovo, che in un comunicato pubblicato sul sito istituzionale veniva addirittura definito “statista”. Ora che (mah) si decide per la desecretazione di molte carte relative agli anni delle stragi, la nomina non sembra delle più felici, tipo mettere la volpe a guardia del pollaio. A nulla sono servite le proteste delle associazioni dei famigliari di vittime delle stragi fasciste italiane: Franceschini ha difeso la sua scelta, e da Draghi nemmeno un verbo, una parola, un sorrisino sardonico dei suoi. Silenzio granitico.
Insomma, tre casi, tre indizi, e altrettanti silenzi del premier, circonfuso da quel consenso obbligatorio che conosciamo, ma inspiegabilmente muto su tre episodi che portano nel suo governo – ciascuno a suo modo – un’ombra in orbace che confligge manifestamente con la Costituzione antifascista.
Ora aspettiamo le intemerate dei pipicchiotti candidati sindaco di Roma che ci accusano di “vedere fascisti dappertutto”, oppure dei “moderati” di Fratelli d’Italia che passano il tempo a derubricare passi dell’oca e cretini in divisa da nazista a “ragazzate”. Ma, spiace, i fatti restano questi: importanti cariche pubbliche affidate a funzionari che di antifascista hanno davvero pochino e anzi, almeno in un caso, hanno fieramente militato tra gruppi e gruppetti che meriterebbero – da leggi e Costutuzione – lo scioglimento.
 Ero tentato di scrivere al direttore per chiedergli – invece dello spazio di questa rubrichina – una pagina, o due, o tre, per elencare tutti gli insulti ricevuti negli anni da quelli, come me e molti altri, che alla guerra in Afghanistan (e in Iraq) sono sempre stati contrari. Utopisti, imbelli, amici dei talebani (qualche imbecille col botto lo ha detto anche ieri), comprese insolenze di stampo fascista (malpancisti, panciafichisti), più analisi geopolitiche dei puffi, più rapporti amorosi (ed economici) con la Cia e il Pentagono, più le accuse di tradimento dell’Occidente. Insomma, mi limito a questa minuscola sintesi delle infamie ricevute per vent’anni. Anche ieri, su Repubblica, Francesco Merlo ci ricordava che “il pacifismo assoluto è un’utopia infantile e qualche volta pericolosa”, ed ecco sistemato anche Gino Strada (ciao, Gino).
Ero tentato di scrivere al direttore per chiedergli – invece dello spazio di questa rubrichina – una pagina, o due, o tre, per elencare tutti gli insulti ricevuti negli anni da quelli, come me e molti altri, che alla guerra in Afghanistan (e in Iraq) sono sempre stati contrari. Utopisti, imbelli, amici dei talebani (qualche imbecille col botto lo ha detto anche ieri), comprese insolenze di stampo fascista (malpancisti, panciafichisti), più analisi geopolitiche dei puffi, più rapporti amorosi (ed economici) con la Cia e il Pentagono, più le accuse di tradimento dell’Occidente. Insomma, mi limito a questa minuscola sintesi delle infamie ricevute per vent’anni. Anche ieri, su Repubblica, Francesco Merlo ci ricordava che “il pacifismo assoluto è un’utopia infantile e qualche volta pericolosa”, ed ecco sistemato anche Gino Strada (ciao, Gino).
Siamo abituati agli insulti, anche se alcuni – recentissimi, di ieri – suonano davvero intollerabili (ah, sei contento che gli americani si ritirano! E le donne? E i bambini? Sei come i talebani!), argomenti di poveri disperati che preferiscono fare la figura dei coglioni piuttosto che ammettere un errore politico durato due decenni.
Paradossalmente, la vergogna non riguarda solo una guerra criminale e sbagliata, ma anche il suo grottesco epilogo. Speravano, tutti gli “armiamoci e partite”, che l’esercito del governo fantoccio resistesse almeno tre mesi. Cioè: fatevi sbudellare per permetterci di scappare con più agio. La risposta – comprensibile – è stata “col cazzo”, e mentre i militari da noi così efficacemente addestrati (ahah, ndr) si arrendevano, i loro capi, da noi così generosamente coperti di soldi, scappavano oltre confine, e chi s’è visto s’è visto.
Avendo letto qualche libro di storia, avevamo imparato che chi perde una guerra viene sostituito, cacciato, sommerso dal disprezzo, insomma, il famoso “vae victis”, guai ai vinti. E invece no. Perché i cantori della guerra persa non hanno perso per niente. Ne escono vittoriosi, più ricchi e più grassi – insieme ai feroci talebani – anche tutti gli apparati militari occidentali, che per vent’anni sono stati ricoperti d’oro per sostenere il più grande affare del mondo: la guerra al terrorismo. Tremila miliardi di dollari, è costato tutto questo scempio di vite, per lo più intascati da contractors privati, produttori di bombe, lobbisti delle armi, consulenti strategici, Pentagono, servizi segreti. Con tremila miliardi di dollari, in vent’anni, si potevano consegnare ad ogni afghano centomila dollari in contanti, trasformando quel paese in una specie di Svizzera o Lussemburgo. Invece i soldi sono passati da una tasca all’altra degli invasori – una partita di giro – e per gli afghani bombe e terrore. I “signori della guerra” (cfr, Bob Dylan, 1963) siedono a Washington e nelle cancellerie occidentali, nei giornali che hanno insultato per vent’anni (e continuano tutt’ora) i pacifisti, nelle lobby degli armamenti, tra tutti i parlamentari che per vent’anni hanno finanziato e rifinanziato le missioni armate all’estero chiamandole “missioni di pace” e “umanitarie”, e si è visto. Non si farà fatica a ricordare nomi e cognomi, da Bush a Blair giù giù fino ai pensosi corsivi di oggi che ci spiegano, in clamorosa malafede, che la guerra era giusta, peccato per come è finita. Ecco, segnarsi i nomi, almeno quello, in modo da non votarli mai più, non leggerli mai più, da confinarli nel disprezzo eterno. Non sarà un risarcimento, ma almeno un piccolo esercizio di dignità personale.
 Tomo tomo, cacchio cacchio, come direbbe Totò, il senso di realtà si insinua nelle maglie della propaganda ed erode un po’ alcune delle certezze acquisite che si direbbero più o meno obbligatorie. Le ultime giravolte sul greenpass, per dirne una, rivelano alcuni problemi, detti tra le righe e furbescamente attribuiti – per comodità e per creare un nemico – solo alle destre più stupide. E’ un buon trucco, vecchio come il mondo: se sei critico sul greenpass e avanzi qualche dubbio sulla gestione della pandemia, eccoti subito arruolato in Casa Pound, o con Salvini, e giù giù nei bassifondi della politica. “Ecco, voti come i fascisti!”, ci dissero ai tempi del referendum renzista. Il meccanismo è identico.
Tomo tomo, cacchio cacchio, come direbbe Totò, il senso di realtà si insinua nelle maglie della propaganda ed erode un po’ alcune delle certezze acquisite che si direbbero più o meno obbligatorie. Le ultime giravolte sul greenpass, per dirne una, rivelano alcuni problemi, detti tra le righe e furbescamente attribuiti – per comodità e per creare un nemico – solo alle destre più stupide. E’ un buon trucco, vecchio come il mondo: se sei critico sul greenpass e avanzi qualche dubbio sulla gestione della pandemia, eccoti subito arruolato in Casa Pound, o con Salvini, e giù giù nei bassifondi della politica. “Ecco, voti come i fascisti!”, ci dissero ai tempi del referendum renzista. Il meccanismo è identico.
Ma sia: i gestori di locali non dovranno chiedere i documenti, gli basterà vedere il greenpass (anche se è della zia). Lo ha detto chiaro, chiarissimo, il ministro dell’Interno, smentendo clamorosamente le istruzioni del governo. Non solo. Lamorgese ha detto anche che la polizia non passerà le sue giornate a controllare le pizzerie, perché – si capisce – ha altro da fare. Ci saranno “controlli a campione”, cioè degli agenti potranno entrare in un ristorante a caso e controllare i documenti degli avventori. Dunque si introduce un obbligo (che presenta oggettivamente qualche scricchiolìo costituzionale) ma lo si lascia di fatto alla responsabilità del singolo. Se funzionerà, bene, altrimenti si giocherà il gioco solito di colpevolizzare il cittadino, una cosa che funziona perfettamente da quasi due anni a questa parte.
Vedremo con il tempo se il greenpass sarà la nuova app Immuni, cioè un fallimento, oppure se porterà qualche vantaggio. Nel frattempo, mettere in discussione la gestione dell’emergenza pandemica in Italia sembra ancora un tabù, anche se le circonvoluzioni, gli arabeschi e i comma 22 si sprecano. Basta pensare all’odissea di Astra Zeneca, prima ai vecchi, poi a tutti, poi a tutti ma non alle donne incinte, poi a quelli coi baffi, poi no, solo ai biondi, poi di nuovo solo agli over-60. Insomma un circo, ma dirlo è sacrilegio e reato di leso-Draghi.
L’ultima gag è quella relativa agli studenti. Il generale Figliuolo si affanna a dire che il prossimo obiettivo sono i giovanissimi, cioè gente che – statistiche alla mano – non ha motivi di temere il virus, mentre rallenta la “caccia” agli ultracinquantenni – soggetti a rischio – che non si sono vaccinati. Riassumo: bisogna vaccinare i giovani per (motivo ossessivamente ripetuto) proteggere gli anziani, quattro milioni e mezzo dei quali non si sono vaccinati, e non si riesce a convincerli. Sui giornali, accanto alle prediche, si susseguono testimonianze e interviste, quasi tutte sul tenore “Mi vaccino perché non voglio infettare il nonno”, e nessuno che chieda mai perché il nonno – che è, lui sì, a rischio – non sia ancora vaccinato. Ancora una volta, insomma, si ribalta sulle persone la responsabilità e la soluzione del problema, mentre basterebbe una legge per imporre l’obbligo vaccinale per fasce d’età – subito tutti gli over 50, per esempio. Una responsabilità che il governo non vuole o non può prendersi, e così lo scaricabarile finisce sui cittadini: è colpa loro, punto e basta. In più, limitazioni e divieti nuovi non sembrano sostituire limitazioni e divieti vecchi. Esempio: se salgo su un treno dove è obbligatorio il greenpass devo supporre che quelli che stanno a bordo lo posseggano tutti, come me. Posso togliere la mascherina? No, eh? Che stranezza, però!
 Houston, abbiamo un problema. Cioè, come si sa, più d’uno, ma quello che è emerso nei giorni dei trionfi azzurri – calcio, atletica, coppe, medaglie – è così evidente che già è scattato il paradosso: abbiamo un problema con l’epica, la retorica, le parole per dirlo. Insomma, esageriamo un po’, ecco, niente di male, se non fosse che il linguaggio è abbastanza rivelatore, e quindi eccoci improvvisamente – a ondate – a cercare l’orgoglio nazionale dove si può e si riesce. Un oro nei cento metri piani è un vittoria pazzesca, così come un oro nel salto in alto: è comprensibile che siano medaglie che ci mettiamo un po’ tutti, e ci sentiamo migliori. Una gioia condivisa.
Houston, abbiamo un problema. Cioè, come si sa, più d’uno, ma quello che è emerso nei giorni dei trionfi azzurri – calcio, atletica, coppe, medaglie – è così evidente che già è scattato il paradosso: abbiamo un problema con l’epica, la retorica, le parole per dirlo. Insomma, esageriamo un po’, ecco, niente di male, se non fosse che il linguaggio è abbastanza rivelatore, e quindi eccoci improvvisamente – a ondate – a cercare l’orgoglio nazionale dove si può e si riesce. Un oro nei cento metri piani è un vittoria pazzesca, così come un oro nel salto in alto: è comprensibile che siano medaglie che ci mettiamo un po’ tutti, e ci sentiamo migliori. Una gioia condivisa.
Lo dico subito: sfrondiamo la faccenda dalle cretinate politiche: che le medaglie e le coppe alzate dagli azzurri siano merito di questo o di quello, del nuovo rinascimento italiano (sic), di Draghi, del Paese che rialza la testa e altre amenità, fa parte di quella propaganda un po’ ridicola che percorre come un brivido dannunziano corsivi e commenti. La riscossa, la rinascita, grazie Draghi (ma quando si allena? Di notte?). Insomma, non è solo la risibile retorica dell’omaggio al capo (vinciamo perché c’è Lui) che si commenta da sé, ma proprio una difficoltà oggettiva di trovare parole misurate e credibili. Ecco invece il profluvio: dal glorioso manipolo, alla giornata storica, dai nostri gladiatori all’osanna che coinvolge tutto: vinciamo e quindi siamo un paese vincente – finalmente! Era ora! – equazione banalotta e facile, che sembra piacere a tutti.
Può darsi, naturalmente, che i successi sportivi facciano bene a chi comanda: si ricorda il mondiale argentino del 1978, quando una delle dittature più feroci del dopoguerra si costruì la sua vetrina, e questo senza bisogno di tornare alle Olimpiadi del ’36. Insomma, non voglio esagerare nemmeno io, ma che lo sport sia motore di propaganda non è certo cosa nuova, il tentativo di saltare sul podio insieme ai campioni per prendersi dei meriti senza aver sudato nemmeno cinque minuti è un classico di ogni tempo.
Resta il fatto: ciò che rimproveriamo alla vita politica e al dibattito pubblico, cioè di essere dominati dalle tifoserie, di essere orgogliosamente anti-oggettivi, si riflette perfettamente nelle cronache sportive. Il fallo di un nostro giocatore è un fallo, quello dell’avversario è un attentato terroristico che “voleva fare male”. Gli altri vincono, noi trionfiamo. Gli altri sono bravi atleti, i nostri sono mostri, giganti, immensi gladiatori, e via così, in un’ordalia verbale in cui si sprecano parabole belliche, retoriche nazionaliste, narrazioni trionfali dove l’epica è costruita lì per lì, a volte addirittura attribuita a poteri superiori e disegni celesti. Non siamo lontani, in certe cronache che debordano dalle pagine dello sport, dal vecchio “Dio è con noi”. Corre più forte, salta più in alto, para i rigori, una specie di popolo eletto per interposto atleta.
Così si corre il rischio, sfuggendo al coro unanime, di passare per rosicatori anti-italiani se ci si colloca in un ragionevole mezzo tra la gioia collettiva per la vittoria e la retorica sul riscatto nazionale: o si accetta tutto il pacchetto (vinciamo perché siamo un paese migliore, più unito, pronto finalmente alla ripartenza) oppure si finisce nel limbo dei disfattisti, equazione irricevibile per chi ancora riesce a vedere le dimensioni delle cose. Tipo: hurrà per le medaglie, evviva, ma scambiarle per riscossa etica, morale, politica, economica, sociale, non sarà un po’ troppo?
 Se si prova ad ascoltare la gente, anziché gli arguti corsivisti del giornali – pardon del Giornale Quasi Unico che si vende, sempre meno, in Italia – si capirà senza troppo sforzo che le perplessità sul green pass obbligatorio sono articolate e numerose, non tutte campate per aria. Si può cogliere fior da fiore, naturalmente, in un esercizio che non finisce più. Si parla di green pass per i treni ad alta percorrenza (cioè quelli dove già si siede distanziati e ti regalano la mascherina) e non sui carri bestiame dei pendolari o sugli autobus in città all’ora di punta, per dirne una. O si può notare che né Germania né Gran Bretagna vaccinano i minorenni, se non in casi con patologie, mentre qui un tredicenne non vaccinato viene indicato come pericoloso terrorista che vuole ammazzare il nonno (che però dovrebbe essere vaccinato, no?). Insomma, in un dibattito libero condotto da cervelli liberi e non da tifoserie schierate a gridare “merda-merda” agli altri, gli argomenti sarebbero numerosi e la discussione persino interessante, con risvolti etici, giuridico-costituzionali, di opportunità, eccetera eccetera.
Se si prova ad ascoltare la gente, anziché gli arguti corsivisti del giornali – pardon del Giornale Quasi Unico che si vende, sempre meno, in Italia – si capirà senza troppo sforzo che le perplessità sul green pass obbligatorio sono articolate e numerose, non tutte campate per aria. Si può cogliere fior da fiore, naturalmente, in un esercizio che non finisce più. Si parla di green pass per i treni ad alta percorrenza (cioè quelli dove già si siede distanziati e ti regalano la mascherina) e non sui carri bestiame dei pendolari o sugli autobus in città all’ora di punta, per dirne una. O si può notare che né Germania né Gran Bretagna vaccinano i minorenni, se non in casi con patologie, mentre qui un tredicenne non vaccinato viene indicato come pericoloso terrorista che vuole ammazzare il nonno (che però dovrebbe essere vaccinato, no?). Insomma, in un dibattito libero condotto da cervelli liberi e non da tifoserie schierate a gridare “merda-merda” agli altri, gli argomenti sarebbero numerosi e la discussione persino interessante, con risvolti etici, giuridico-costituzionali, di opportunità, eccetera eccetera.
Si assiste invece al feroce giochetto delle criminalizzazioni, nascosto dietro la formuletta facile “no-vax”, per cui si attribuisce agli scettici (non tanto sui vaccini, ma sull’impianto generale del green pass) una specie di tendenza al nichilismo. Per dirla in parole povere, se provate a esprimere qualche perplessità (tipo quella per cui dovete avere il green pass per mangiare al ristorante, ma non per cucinare o servire ai tavoli) passate immediatamente nel mare magnum dei negazionisti, di quelli che temono il chip sottopelle, oppure dei ridicoli balilla di Forza Nuova o di Casa Pound, oppure siete amici di Salvini, e via discorrendo, in una specie di discesa negli inferi dei deficienti conclamati.
C’è dunque, diciamo così, un pensiero unico per induzione. Nessuno con la testa sulle spalle vuole essere assimilato al signor Castellino, il piccolo federale di Forza Nuova già condannato in primo grado per pestaggio, che in sprezzo a qualunque regola democratica guida i “rivoltosi” per le strade di Roma. Insomma, il dibattito è inquinato: chiunque abbia una posizione non perfettamente allineata diventa automaticamente imbecille (il G5 cinese nel sangue!) o ardito tatuato di svastiche.
La questione è molto complicata e nessuno la risolverà a breve, certo. Però viene da chiedersi (se lo chiede in Francia la sinistra, per esempio) come mai si preferisca un obbligo indotto (senza green pass le tue libertà sono limitate) a un obbligo vero, di legge. Ci sono già vaccini obbligatori, in Italia, punture che lo Stato garantisce e impone. Se si è convinti che il vaccino sia l’arma più efficace (io, per esempio, ne sono convinto) perché non imporlo? Perché lo Stato, che secondo l’articolo 32 della sua Costituzione deve garantire la salute dei cittadini, preferisce una delega di responsabilità anziché imporla? Si fosse cominciato subito con l’obbligo per gli over-60, poi per gli over-50, e così via, monitorando seriamente i numeri di ospedalizzazioni e decessi, si sarebbe fatto prima e più seriamente. Invece abbiamo centinaia di migliaia di ultasessantenni non vaccinati e grida di “vergogna-vergogna” verso i genitori dubbiosi di adolescenti. Fare lo Stato senza farlo davvero, insomma, perché colpevolizzare i cittadini pare meglio, più produttivo, che prendersi una reale responsabilità da Stato sovrano (ti vaccino e sono responsabile di quel che ti inietto).
 Mannaggia, che disdetta, il boom economico non arriva. Eppure ce l’avevano promesso in tanti, e alcuni con lo sguardo ieratico del profeta. Tipo Carlo Bononi, il boss di Confindustria: “Credo ci siano le condizioni per un piccolo miracolo economico, ma neanche troppo piccolo”, ha detto il 7 giugno scorso a Manduria (titolo del convegno “Forum in masseria”, ahahah). L’equazione era semplice: licenziamo, così potremo assumere, che è un po’ come quando buttate la macchina nel burrone così poi potrete comprarne un’altra, salvo accorgervi, guardando la carcassa, che per la macchina nuova non avete i soldi.
Mannaggia, che disdetta, il boom economico non arriva. Eppure ce l’avevano promesso in tanti, e alcuni con lo sguardo ieratico del profeta. Tipo Carlo Bononi, il boss di Confindustria: “Credo ci siano le condizioni per un piccolo miracolo economico, ma neanche troppo piccolo”, ha detto il 7 giugno scorso a Manduria (titolo del convegno “Forum in masseria”, ahahah). L’equazione era semplice: licenziamo, così potremo assumere, che è un po’ come quando buttate la macchina nel burrone così poi potrete comprarne un’altra, salvo accorgervi, guardando la carcassa, che per la macchina nuova non avete i soldi.
Intanto impariamo la geografia sulle pagine economiche dei giornali: la Timken è a Brescia (106 licenziati), la Giannetti Ruote in Brianza (152), la Gkn a Campi Bisenzio (422), la Whirlpool a Napoli (327), e non passerà giorno senza che si aggiunga alla lista qualche ridente località. Se va avanti di questo passo il miracolo economico dovrà essere strepitoso.
Intanto ferve (?) la discussione sui “nuovi ammortizzatori sociali”, il che conferma la passione della classe dirigente del Paese per l’azione coordinata in due fasi. Funziona così: prima fase, stringete la cinghia, restate senza lavoro, restate senza reddito, stringete i denti perché poi arriverà la seconda fase fatta di ammortizzatori sociali e aiuti per tutti. Bello. Solo che la prima fase viene attuata senza problemi e per la seconda fase, ehm… vediamo… pensiamoci bene… aspettiamo un po’… bisogna mettere tutti d’accordo… Insomma, mai che venga in mente di fare quel che farebbe chiunque nella sua vita: prima predisporre dei sistemi di sicurezza e poi, nel caso, procedere. E’ come se si montasse la rete sotto il tendone del circo dopo che il trapezista è caduto.
A proposito di caduti, i morti sul lavoro nel 2020 (anno in cui si è lavorato meno causa pandemia, peraltro) sono stati 799 contro i 705 del 2019 (più 13 per cento). L’Inail, che viglia o dovrebbe sulla sicurezza di chi lavora, ha controllato l’anno scorso 7.486 imprese, una goccia nel mare, perché ha pochi ispettori. Di queste sono risultate irregolari (tenetevi forte) l’86,57 per cento, praticamente nove su dieci. Non male, dài!
In sostanza, mettendo insieme i dati, aggiungendo le cifre sull’aumento delle situazioni di forte disagio economico, e rincarando la dose con l’ininterrotto attacco dei soliti noti al reddito di cittadinanza, si ha come risultato che oggi in Italia c’è almeno una cosa che ha un discreto successo: la guerra ai poveri. Guerra non solo economica, ma anche fisica (le grate di protezione rimosse dai macchinari per non rallentare la produzione, i lavoratori in sciopero investiti dai camion…), perché c’è questa convinzione che morto un lavoratore ne arriva un altro, e pazienza. Ora che sul Paese (meglio, sulle aziende) pioveranno soldi, uno si aspetterebbe che vadano soltanto a chi è in regola con le norme sulla sicurezza, ma l’argomento non pare all’odine del giorno, non se ne parla, nessuno lo solleva, sacrilegio. Naturalmente siamo qui ad aspettare a pié fermo il “piccolo miracolo economico, nemmeno troppo piccolo” che ci hanno promesso in cambio di qualche centinaio di migliaia di sacrifici umani: famiglie senza più reddito che non sanno dove sbattere la testa ma si immolano per tutti noi, che presto brinderemo a champagne per il nuovo boom. Tutti, anche a sinistra, fanno finta di crederci, rapiti dell’ideologia dominante che se aiuti i ricchi mangeranno qualcosa anche i poveri. Non funziona, mannaggia, che disdetta!
 Ci sono, sui grandi giornali, 12-13 pagine di iper-retorica sul trionfo azzurro, la rinascita, la gioia, la festa, il rinascimento tricolore, il draghismo, il mattarellismo, il mancinismo, il donnarummismo, poi si arriva – col fiatone – ai 442 di Campi Bisenzio che il rinascimento italiano l’hanno ricevuto via email: licenziati. Tutti menano scandalo sul metodo: che modo sarebbe di mettere sul lastrico intere famiglie? Che poca eleganza, che cinismo! Insomma davanti a quasi cinquecento persone che perdono il lavoro, in un momento in cui trovarne un altro è assai difficile (e trovarlo alle stesse condizioni praticamente impossibile), si stigmatizza il metodo e non il merito: viene da pensare che se i lavoratori della Gkn fossero stati licenziati con una regolare raccomandata tutto sarebbe stato accettato più facilmente. Una questione di eleganza.
Ci sono, sui grandi giornali, 12-13 pagine di iper-retorica sul trionfo azzurro, la rinascita, la gioia, la festa, il rinascimento tricolore, il draghismo, il mattarellismo, il mancinismo, il donnarummismo, poi si arriva – col fiatone – ai 442 di Campi Bisenzio che il rinascimento italiano l’hanno ricevuto via email: licenziati. Tutti menano scandalo sul metodo: che modo sarebbe di mettere sul lastrico intere famiglie? Che poca eleganza, che cinismo! Insomma davanti a quasi cinquecento persone che perdono il lavoro, in un momento in cui trovarne un altro è assai difficile (e trovarlo alle stesse condizioni praticamente impossibile), si stigmatizza il metodo e non il merito: viene da pensare che se i lavoratori della Gkn fossero stati licenziati con una regolare raccomandata tutto sarebbe stato accettato più facilmente. Una questione di eleganza.
Poi, giù a leggere dichiarazioni ed esternazioni della politica, la stessa che due settimane fa ha votato per sbloccare i licenziamenti, perché se non si licenzia non si può ripartire, logico, no? Povero governo Draghi, intendeva permettere licenziamenti di massa, sì, ma secondo il galateo, e invece…
Naturalmente nessuno ci spiega esattamente cosa vuol dire per una famiglia con un reddito di 20-30.000 euro annui perdere quel reddito. Nessun cronista sarà presente alle cene in famiglia dove si decide di rimandare questa o quella spesa, di affrontare azioni normali (un paio di scarpe per i ragazzi, un cinema, una gita fuori porta e altre cose persino più essenziali) come sforzi indicibili. Nessun politico assisterà alla frenetica compulsazione dei volantini dei discount che permetteranno (forse) di risparmiare quindici euro sulla spesa settimanale. Sarebbe retorica, sarebbe giornalismo ad effetto, sarebbe parlare “alla pancia del Paese”, uh, che brutto! Populismo! Mentre invece infiocchettare di pagine e pagine la riscossa dell’Italia sul mondo per via di rigori ben tirati e ben parati è buona prassi, ma bisogna capirli: nessuno dei prodigiosi cantori del trionfo di Wembley ha problemi a mettere insieme il pranzo con la cena.
Tra i più grotteschi interpreti di questo scandalizzarsi per il modo e non per la sostanza, c’è l’ineffabile ministro Giorgetti, il leghista buono, il leghista che non bacia i salami. Testuale: “E’ inevitabile che queste cose accadano” (intende i licenziamenti che il suo governo ha sbloccato, che poteva rendere evitabili, per l’appunto). Ma poi, sventurato, aggiunge la sua perlina alla collana di paraculismo diffuso: “Però non possono succedere in questo modo”. Il dito, la luna. E infine, ecco la ciliegina: “Noi abbiamo in mente di fare il West, non il Far West”. Costruzione semantica stretta parente dei giochetti verbali del renzismo, parlandone da vivo, calembour, formulette buone per andare sui giornali, che non dicono niente, che non hanno dietro un pensiero, che servono a fregare i gonzi. Tutti i gonzi – come volevasi dimostrare – riportano la frasetta a effetto. Prudono le mani, più che altro.
Ancora più irritanti le reazioni della politica: “Inaccettabile”, dice il ministro del lavoro, che alla fine accetterà. “Se le cose stanno così bisogna rivedere lo sblocco dei licenziamenti”, dice il segretario del Pd. E come dovevano stare, le cose? Qualcuno lamenta che non abbia funzionato a Campi Bisenzio la “moral suasion” di governo e Confindustria: licenziate pure, ma con garbo. In modo che centinaia di famiglie possano precipitare nella povertà, ma con garbo, mi raccomando, sennò fa brutto.
 Confesso di leggere le cronache politiche con la stessa attenzione e lo stesso trasporto emotivo con cui leggerei i risultati dell’hockey su prato. Con qualche eccezione, perché ci sono personaggi della comédie humaine che travalicano le pagine delle cronache del potere e diventano macchiette esilaranti, caricature. A volte le metafore sono così evidenti che chiamarle metafore diventa un’offesa: la motovedetta libica regalata ai libici dagli italiani che sperona e spara su migranti indifesi è una di quelle. E se la mettete accanto alla foto del Presidente del Consiglio che si congratula per lo spirito umanitario della guardia costiera libica, vi darà un’idea di dove siamo finiti: in un gorgo in cui la realtà non c’entra niente, quel che c’entra è il raccontino della realtà, ad uso e consumo di questo e di quello (cioè di questo, Draghi, oppure di quello, Draghi).
Confesso di leggere le cronache politiche con la stessa attenzione e lo stesso trasporto emotivo con cui leggerei i risultati dell’hockey su prato. Con qualche eccezione, perché ci sono personaggi della comédie humaine che travalicano le pagine delle cronache del potere e diventano macchiette esilaranti, caricature. A volte le metafore sono così evidenti che chiamarle metafore diventa un’offesa: la motovedetta libica regalata ai libici dagli italiani che sperona e spara su migranti indifesi è una di quelle. E se la mettete accanto alla foto del Presidente del Consiglio che si congratula per lo spirito umanitario della guardia costiera libica, vi darà un’idea di dove siamo finiti: in un gorgo in cui la realtà non c’entra niente, quel che c’entra è il raccontino della realtà, ad uso e consumo di questo e di quello (cioè di questo, Draghi, oppure di quello, Draghi).
Dunque, scorro le pagine e guardo i Tg con l’aspettativa del paradosso che esplode, è il mio Helzapoppin’ quotidiano. Sommario su Repubblica: “Letta richiama Italia Viva alla coerenza”, che è come chiedere a un lombrico di volare. Seguono righe e righe e righe di analisi (questo ovunque) in cui si spiega e analizza che forse i renzisti non sono così di centrosinistra come qualche poveretto ha creduto per anni, e ora, che sorpresa!, brigherebbero insieme a Salvini per portare al Quirinale un Presidente della destra. Minchia, che intuizione.
E poi c’è la dietrologia, chiamata così perché “davantologia” fa brutto e bisogna far finta che per vedere la realtà si è scavato a fondo, mentre invece è lì sotto gli occhi di tutti. Che esista un asse ideologico tra i naufraghi di Italia Viva e le potenze della destra rampante e populista è conclamato da anni, ma lo si presenta come “colpo di scena”, “inaudita svolta”, “perbacco”, “ma guarda un po’”. Lo spettacolo d’arte varia di vedere arguti commentatori venir giù dal pero non ha prezzo.
Insomma, c’è da pensare che nei giornali non leggano i giornali, e allora perché diavolo dovremmo leggerli noi?
L’ultimo Tetris è quello del Quirinale, per cui si interpretano le astute mosse dei filo-sauditi di Italia Viva sul ddl Zan come una cosa che non c’entra niente con il ddl Zan, ma con il futuro presidente della Repubblica, sulla cui elezione cui i 45 di Italia Viva potrebbero fare l’ago della bilancia. Eletti col Pd, speranzosi di finire in doppia cifra (in effetti, a parte la virgola, 1,5 è doppia cifra), sempre in prima linea per tentare di far vincere la destra (Scalfarotto candidato in Puglia con l’appoggio della “bracciante” Bellanova, ah, che spettacolo!), vengono intervistati come fossero Cavour redivivo, e tutto questo senza scoppiare a ridere, che sarebbe a ben vedere la reazione più sana.
Naturalmente, ogni volta che Renzi fa il suo salto della quaglia c’è chi la prende alla larga e ci spiega con il ditino alzato che ogni compromesso è un compromesso al ribasso, e che bisogna piantarla di fare gli estremisti. Sono gli oliatori, i facilitatori, gente che dalla legge sul divorzio avrebbe tolto l’articolo uno, ma anche il due, il tre, il quattro e così via, perché sono “divisivi”. Se poi alzi gli occhi dalla prima pagina pensando “ma questi sono scemi”, ti predi dell’ideologico, che secondo loro è una parolaccia tranne quando sono ideologici loro, sempre al servizio occulto di baciatori di salami e di baciatori di pantofole (principesche e saudite). Il vecchio Cuore avrebbe titolato “Hanno la faccia come il culo”, oggi non si può, sarebbe “divisivo”.
 Tra una settimana esatta, alla mezzanotte del 30 giugno, la dichiarazione di guerra (un’altra!) contro i lavoratori sarà consegnata nelle mani dei gruppi industriali italiani. Si tratta delle fine del blocco dei licenziamenti, che produrrà moltissimi nuovi poveri, privati del diritto fondamentale di cui parla l’articolo 1 della Costituzione. Le stime più ottimistiche (!) dicono di centinaia di migliaia di nuovi disoccupati – sono 56 mila soltanto quelli delle aziende che siedono ai 99 tavoli di crisi aperti al ministero – che salteranno come tappi il primo luglio. La vulgata confindustriale (appoggiata da tutta la destra, da Forza Italia a Italia Viva) è che bisogna licenziare per ripartire e assumere di nuovo, che è come dire che per bere un bicchier d’acqua è giusto prima morire di sete.
Tra una settimana esatta, alla mezzanotte del 30 giugno, la dichiarazione di guerra (un’altra!) contro i lavoratori sarà consegnata nelle mani dei gruppi industriali italiani. Si tratta delle fine del blocco dei licenziamenti, che produrrà moltissimi nuovi poveri, privati del diritto fondamentale di cui parla l’articolo 1 della Costituzione. Le stime più ottimistiche (!) dicono di centinaia di migliaia di nuovi disoccupati – sono 56 mila soltanto quelli delle aziende che siedono ai 99 tavoli di crisi aperti al ministero – che salteranno come tappi il primo luglio. La vulgata confindustriale (appoggiata da tutta la destra, da Forza Italia a Italia Viva) è che bisogna licenziare per ripartire e assumere di nuovo, che è come dire che per bere un bicchier d’acqua è giusto prima morire di sete.
La realtà è molto più semplice: l’obiettivo è quello di ridisegnare le dinamiche del lavoro salariato in modo da espellere chi ha ancora vecchi diritti e vecchie garanzie e di assumere (semmai) con diritti e garanzie minori. In sostanza, una grande ristrutturazione del Lavoro a beneficio dei profitti. Traduco: chi lavora sarà più povero e meno protetto; chi fa profitti sarà più ricco e più tutelato. La riforma degli ammortizzatori sociali, tanto sbandierata, è una faccenda di chiacchiere stantie, il salario minimo è scomparso dai radar, e vagano nell’aria tante belle dichiarazioni d’intenti e progetti luminosi che finiranno, al solito, come lacrime nella pioggia.
Nel frattempo, un’indagine dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2020) certifica che il 72 per cento delle aziende che operano nel settore della logistica presentano irregolarità. Delle famose cooperative che fanno da serbatoio di braccia (quelle che “somminstrano” il lavoro, tipo supposta, insomma), il 78 per cento è fuori legge. Settantotto per cento (lo ridico), cioè quasi otto su dieci. Domanda: quale cazzo di Stato arriva a permettere un’illegalità sul mercato del lavoro che raggiunge in certi segmenti (lo ridico) il settantotto per cento?
Il 5 può essere fisiologico, il 10 una disgrazia, il 15 un segnale inequivocabile che qualcosa non funziona. Ma per arrivare al 78 per cento significa che non stiamo parlando di un incidente o di un’anomalia, ma di una precisa volontà politica, granitica, coesa, un’intesa larghissima per cui negli ultimi vent’anni e pure di più, la guerra al mondo del lavoro è stata costante, precisa, agguerrita. In una parola: un’ideologia.
La trappola dialettica che “bisogna difendere il lavoro e non i lavoratori”, sbandierata spesso da chi freme dalla voglia di licenziare, significa alla fine che ciò che producevano in due lo produrrà uno solo, e l’altro cazzi suoi. Si riproporrà, insomma, su larga scala il cottimo e l’erosione dei diritti che vediamo oggi sui piazzali e sui camioncini della logistica.
Per vent’anni, ogni legge sul lavoro si è sovrapposta ad altre leggi sul lavoro, e poi deroghe, regali, decontribuzioni, incentivi, centinaia di contratti diversi, sempre, ad ogni passaggio, con un cedimento di posizione dei lavoratori.
Risultato: secondo la conferenza dei sindacati europei su dati Eurostat, oggi in Italia, il 12,2 della popolazione lavorativa è considerata “povera”, cioè pur lavorando resta sotto la soglia di povertà.
C’è poco da scomodare categorie storiche e apparati filosofici, la realtà è più forte delle chiacchiere: questo sistema di organizzare il lavoro in una grande democrazia che lo sbandiera come primo diritto non funziona e diventerà presto intollerabile.
Qui altre due recensioni di Flora uscite in settimana: L’Arena di Verona (Mimmo Colombo) e il Foglio (Andrea Frateff-Gianni). Grazie grazie
 C’è un nuovo format giornalistico, o se preferite una immensa onnipresente rubrica, che si potrebbe intitolare: “Ricchi che danno consigli ai poveri”. Si direbbe un argomento di gran moda, almeno a giudicare dalla pletora di imprenditori, amministratori delegati, presidenti, possidenti, rentier, che si alzano alla mattina e decidono – a volte spontaneamente, a volte interrogati – di gettare perle di saggezza a ragazzi che rischiano di guadagnare seicento euro al mese per anni, e forse per sempre. E’ come se uno, scendendo dalla Porsche, ti sgridasse col ditino alzato perché hai la bicicletta sporca di fango. La tiritera scema per cui preferisci stare sul divano invece che lavorare allo stesso prezzo (o meno) è ormai diventata una narrazione-macchietta. Sono leggende marcite in fretta, come quella del rider felice, o del precarissimo che “mi piace perché ho tanto tempo libero”. Propaganda padronale.
C’è un nuovo format giornalistico, o se preferite una immensa onnipresente rubrica, che si potrebbe intitolare: “Ricchi che danno consigli ai poveri”. Si direbbe un argomento di gran moda, almeno a giudicare dalla pletora di imprenditori, amministratori delegati, presidenti, possidenti, rentier, che si alzano alla mattina e decidono – a volte spontaneamente, a volte interrogati – di gettare perle di saggezza a ragazzi che rischiano di guadagnare seicento euro al mese per anni, e forse per sempre. E’ come se uno, scendendo dalla Porsche, ti sgridasse col ditino alzato perché hai la bicicletta sporca di fango. La tiritera scema per cui preferisci stare sul divano invece che lavorare allo stesso prezzo (o meno) è ormai diventata una narrazione-macchietta. Sono leggende marcite in fretta, come quella del rider felice, o del precarissimo che “mi piace perché ho tanto tempo libero”. Propaganda padronale.
Però, siccome le parole sono importanti, ci preme rilevare due perle di saggezza (e di linguaggio, che svela moltissimo) di un famoso imprenditore (e bravissimo, a detta di tutti) che – parole dal sen fuggite – parla davvero chiaro. Testo (e musica!) di Guido Barilla, presidente della Barilla in persona, che segue la corrente del pensiero unico imprenditoriale e poi, voilà, “Rivolgo un appello ai ragazzi”. Ecco, è il momento topico del discorso, l’accorato appello, il consiglio paterno, il Verbo: “Abbiate la forza di rinunciare ai sussidi facili e mettetevi in gioco. Entrate nel mercato del lavoro, c’è bisogno specialmente di voi”.
Vediamo se un po’ di analisi del testo ci aiuta. Come sono i sussidi? “Facili”, ovvio. Buttata lì, senza parere, si dà per scontato il fatto che ti regalano i soldi, è facile. Un presidente, figlio e nipote di presidenti, non perde nemmeno un nanosecondo per pensare che se arrivi lì, a chiedere un sussidio (facile) per mangiare o avere un tetto sulla testa, significa che c’è una difficoltà. No, “è facile”, bon, discorso chiuso.
Altra chicca: “mettetevi in gioco”, che è un po’ una frase alla Paperon dè Paperoni quando andò a cercare l’oro nel Klondike. Bello, eh, mettersi in gioco. Ai tempi de L’isola del tesoro significava imbarcarsi come mozzo su un brigantino, ottimo, molto romantico. Oppure significa: ehi, ho un milione, come lo investo? Capisco. Ma cosa ci sia da mettere in gioco nell’andare a fare turni assurdi per paghe ballerine, incerte, basse, a volte schifose e quasi sempre senza prospettive, non è dato sapere. Del resto, se le paghe fossero decenti (salario minimo, dove sei?) nessun imprenditore se la prenderebbe con i “facili sussudi”, cosa che invece accade se proponi come salario una cifra inferiore ai “facili sussidi”. Bene. Chi non “si mette in gioco” è dunque pigro, o pusillanime, o proprio una specie di fancazzista che vive alle nostre spalle, anche se manda decine di curricula e riceve in cambio offerte offensive. Questo sì, più che le avventure di Stevenson, è ottocentesco. E’ la vecchia storia della povertà come colpa, la disoccupazione come pigrizia, un sottinteso “guarda me che sono nato milionario, che ci vuole?”. E forse, letteratura per letteratura, si consigliano qui altre prose, quelle degli annunci per “mettersi in gioco”, la cui lettura spiega molto e indigna parecchio. Tipo “apprendista con tre anni di esperienza”, o “stagista con sei lauree”, o “part-time di 58 ore settimanali”, tutti ovviamente pagati tre ghiande e un bicchier d’acqua. Dài, andiamo, fidatevi, come non mettersi in gioco?
 Delle poche cose che abbiamo capito della politica italiana, una è questa: quando vedi un ministro piangere, vuol dire che si mette male (non per il ministro, ovvio). Lacrime famose: quelle di Elsa Fornero (novembre 2011) mentre sforbiciava le pensioni e creava un esercito di esodati, e quelle di Teresa Bellanova (maggio 2020), che annunciava commossa la sua legge-sanatoria per far emergere lo sfruttamento schiavistico e combattere il caporalato nei campi, e non solo.
Delle poche cose che abbiamo capito della politica italiana, una è questa: quando vedi un ministro piangere, vuol dire che si mette male (non per il ministro, ovvio). Lacrime famose: quelle di Elsa Fornero (novembre 2011) mentre sforbiciava le pensioni e creava un esercito di esodati, e quelle di Teresa Bellanova (maggio 2020), che annunciava commossa la sua legge-sanatoria per far emergere lo sfruttamento schiavistico e combattere il caporalato nei campi, e non solo.
Commozione. Storia personale. Emozione: “Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle cosìffatte cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, come badanti o come colf, non saranno più invisibili…”. La chiosa era da proclama epocale: “Gli invisibili non saranno più invisibili”. Wow! Bingo!
A risentire quelle parole, a vedere quel video dove l’allora ministra si commuoveva, a leggere le cronache politiche che si commuovevano anche loro in omaggio alla ministra commossa, il bacio della pantofola alla ministra italovivaista così vicina agli sfruttati, bisogna dirlo, sale la carogna. La legge (era l’articolo 110 bis del cosìddetto decreto rilancio) fu preceduta da un intenso tam tam giornalistico, per cui l’allarme sociale era il rischio di non trovare arance e mandarini al supermercato perché “non si trovano raccoglitori”. Insomma, nemmeno gli schiavisti trovavano più schiavi, toccava correre ai ripari.
Bene, a vedere quelle cifre un anno dopo, tremano i polsi. Non solo dall’articolo si tennero fuori due settori ad altissimo tasso di irregolarità (logistica ed edilizia), ma delle 207 mila domande presentate, ad oggi, solo il 12 per cento sono state evase. Insomma, ci sono parecchi invisibili – quasi tutti, quasi il 90 per cento delle domande – che pur chiedendo, bolli e pratiche alla mano, di diventare visibili, stanno ancora lì. Le baracche delle piane degli agrumi stanno ancora lì. Gli irregolari che non riescono ad ottenere un permesso di soggiorno nonostante le code, i documenti, le richieste, le domande, stanno ancora lì. Le badanti ricattate stanno ancora lì. Il flop era annunciato: poche domande, 207 mila, data la difficolta di convincere chi usa manodopera illegale a farla emergere. Ora che è passato un anno e i termini per le domande sono scaduti, 180 mila invisibili di quei 207 mila che hanno fatto domanda per diventare visibili sono ancora invisibili.
Non solo. Ogni giorno emergono casi grandi e piccoli di “somministrazione” (sic) di lavoro illegale, di cooperative che fungono da serbatoio di braccia, di fornitori costretti dai committenti (anche di gran nome, come Dhl, come spiega l’inchiesta della procura di Milano) a evadere contributi e Iva oppure a morire, ma chissenefrega, me arriveranno altri. Il tutto mentre si ricamano trine e merletti sulla fine del blocco dei licenziamenti, perché Confindustria – dice – vuole assumere (con nuovi contratti) e per farlo deve licenziare (i vecchi contratti, più onerosi), e si diffonde sempre più rumoroso il tam tam ideologico contro il Reddito di Cittadinanza, che rende più difficile pagare un barista per dodici ore meno di 700 euro al mese (dove andremo a finire, non si trovano gli stagionali, eccetera, eccetera).
Date retta, quando vedete un ministro piangere, resistete alla commozione e all’empatia, di solito significa che tra poco piangerà qualcun altro, ma sul serio, e non ad uso di telecamera, ma in solitudine, in disperazione. E soprattutto, sempre invisibile.
 Seguo con particolare interesse le avventure di don Matteo, inteso come Salvini, pellegrino in perenne trance mistica, che l’altro giorno, dal Portogallo, ha provveduto a pregare per gli italiani, tribù di cui, ahimè, faccio parte. Con un suo piccolo video twittato per le masse, voleva dirci che ha voluto immergersi nella serenità di quel posto (in realtà nel video si vede un immenso parcheggio deserto, tipo Ikea quando è chiusa), che pensa tanto a noi, e che ci affida alla Madonna di Fatima. Lui, i figli, la compagna, e poi tutti noi, compresi voi che leggete.
Seguo con particolare interesse le avventure di don Matteo, inteso come Salvini, pellegrino in perenne trance mistica, che l’altro giorno, dal Portogallo, ha provveduto a pregare per gli italiani, tribù di cui, ahimè, faccio parte. Con un suo piccolo video twittato per le masse, voleva dirci che ha voluto immergersi nella serenità di quel posto (in realtà nel video si vede un immenso parcheggio deserto, tipo Ikea quando è chiusa), che pensa tanto a noi, e che ci affida alla Madonna di Fatima. Lui, i figli, la compagna, e poi tutti noi, compresi voi che leggete.
Recidivo. L’aveva già fatto con la Madonna di Medjugorje, e poi aveva sventolato il rosario affidandoci al Sacro Cuore di Maria, e poi ancora si era fatto ritrarre con immagini sacre, Madonne, croci, rosari, ed è forse per mia distrazione che non l’ho mai visto con un aspersorio, o vestito da vescovo, starò più attento.
Si dirà che Salvini non era lì, a Fatima, soltanto per immergersi nella serenità, ma anche per parlare con un tale André Ventura, che di mestiere fa il sovranista in Portogallo. Ma questi sono dettagli per feticisti della politica, mentre quello che rimbalza sui media con più tenacia è l’ennesima testimonianza di fede sincera nell’uso strumentale della fede.
Naturalmente (credo che andrò da un notaio, o da un avvocato), diffido chiunque ad “affidarmi” a qualunque tipo di culto o divinità, mi affido da solo, grazie, e se devo scegliere qualcosa di mistico me lo scelgo da me. Quindi pregherei Salvini di non andare di qui e di là a pregare per conto mio, o a mio nome, o anche solo per procurarmi un qualche vantaggio.
Non voglio indagare su come e quando Salvini sia caduto preda delle sue crisi mistiche, ma risulta piuttosto evidente che il fervore della nostra Giovanna d’Arco dei salami sia una ormai conclamata ed evidente mossa politica. Identità, no immigrazione, che significa no Islam, un po’ di Vandea, molto tradizionalismo da osteria, tutte cose abbastanza evidenti, che fanno della devozione salviniana una specie di foglia di fico trasparente. Brutto spettacolo.
Ma venendo alla sostanza, sarebbe interessante sapere quanti consensi è in grado di spostare questa narrazione da chierichetto. Cioè: davvero Salvini pensa che presentarsi col rosario gli aumenti i consensi? Fare il testimonial è una cosa seria, che necessita alcune accortezze. Per esempio suona stonato che prenda un aereo e vada ad affidarci tutti quanti a questa o quella Madonna in giro per l’Europa, se poi la sua foto più famosa è quella in cui sbircia il decolté di una cubista, ebbro di mojito e pieni poteri. E non si parla qui di moralismi o di facili perbenismi, ma proprio di marketing e posizionamenti. L’iperesposizione di Salvini – con il solito suicidio assistito dell’apparire “simpatico” – lo ha reso una macchietta, popolare, sì, ma sempre una caricatura. Motivo per cui ogni volta che compare, con o senza rosario, con o senza video, con o senza alimenti a portata di mano, la prima reazione è l’ilarità. Anche per questo motivo, la destra meloniana guadagna terreno e punta alla leadership della destra. Non che dalle parti di Giorgia manchi la propaganda banalotta dell’identità nostalgica e balilla, ma lei è abbastanza abile da tenerla (per ora?) sottotraccia. Insomma, il fatto che non la vedremo baciare salami basta a molti, a destra, per farne un leader più credibile di don Matteo, da Fatima, o da Medjugorje o da dove altro gli capiterà di affidarci – senza che nessuno glielo abbia chiesto – alle cure di qualche santo.
 Non è mica facile fare un autogol battendo un rigore, però a giudicare dalle reazioni, gli sberleffi, i “no, grazie” che ha raccolto Enrico Letta con la sua proposta sulla tassa di successione da girare ai diciottenni, sembra esserci riuscito. Lo dico a mo’ di premessa solenne: tassare le eredità e le donazioni ai figli sopra i cinque milioni di euro non solo è un’idea giusta e benemerita, ma ci porterebbe un po’ più vicino alla famosa Europa di cui si chiacchiera tanto. La tassa di successione, per quelle cifre, in Germania è del 30 per cento, in Spagna del 34, in Gran Bretagna del 40 e in Francia del 45 per cento. Qui da noi, nel Paese ereditario, è del 4 per cento.
Non è mica facile fare un autogol battendo un rigore, però a giudicare dalle reazioni, gli sberleffi, i “no, grazie” che ha raccolto Enrico Letta con la sua proposta sulla tassa di successione da girare ai diciottenni, sembra esserci riuscito. Lo dico a mo’ di premessa solenne: tassare le eredità e le donazioni ai figli sopra i cinque milioni di euro non solo è un’idea giusta e benemerita, ma ci porterebbe un po’ più vicino alla famosa Europa di cui si chiacchiera tanto. La tassa di successione, per quelle cifre, in Germania è del 30 per cento, in Spagna del 34, in Gran Bretagna del 40 e in Francia del 45 per cento. Qui da noi, nel Paese ereditario, è del 4 per cento.
Dunque, l’aumento dal 4 al 20 proposto da Letta (solo per ciò che eccede i 5 milioni di euro) sarebbe ancora un brodino rispetto ad altri paesi nostri vicini che non sono né Cuba né la Corea del Nord, ma posti con solide radici liberali.
E allora, si dirà, dove sta l’autogol? Mah, forse nel comunicare una operazione di giustizia fiscale in un’intervista molto pop, con foto sbarazzine (uff!), oppure nel non averne parlato prima con nessuno, in modo da dare a Draghi l’occasione di tirare una sberla con quel “Non è il momento” che ha gelato tutti. Insomma, nel mondo fatato che mi immaginerei io, una proposta di redistribuzione di ricchezza, dai più ricchi ai più stritolati, la si fa un po’ meglio, magari lanciando un dibattito pubblico, denunciando le distanze dall’Europa, confrontando cifre. E invece, così presentata, la proposta Letta ha scatenato l’ovvio: basta tasse! Non è il momento! Bolscevichi! Attentato alla proprietà privata!, e tutte le cretinate che i finti liberali di Pavlov amano pronunciare quando si chiedono soldi a chi ne ha moltissimi. Impeccabile sintesi: siamo un Paese dove quando proponi di tassare i ricchi si incazzano anche i poveri.
Però, pochi sono andati oltre l’aspetto “prendere” della proposta e pochissimi hanno guardato al “dare”. I beneficiari del ridisegno (ripeto: sacrosanto) sarebbero più o meno la metà dei diciottenni italiani (per modulo Isee), che incasserebbero 10.000 euro di bonus.
Ed ecco la parola magica: bonus. Tutto pare risolvibile con il portentoso medicamento del bonus, tanto per dire che di diritti stabili, a lungo termine, inseriti nella dinamica sociale (tu lavori, io ti pago decentemente, hai diritto a casa, studio, salute, eccetera) non se ne parla nemmeno.
Ecco un bonus, vada buon uomo.
Il tutto – se si pensa ai diciottenni, povere bestie – in un paese dove le tasse universitarie sono tra le più alte d’Europa (aumentate anche con le Università chiuse), e per le borse di studio siamo alle ultime posizioni. Un Bonus di 10.000 euro per andare a vivere da soli è una bellissima cosa, grazie, ma a chi finisce, poi, quindi? A chi affitta stanze singole a 5-600 euro al mese come accade nella ridente città di Milano e in generale nelle sedi universitarie? Non si potrebbe, invece di un bonus, avere salari decenti, non subire anni di precariato, non accettare più stage e altre forme di sfruttamento fantasiosamente travestite? Certo, sarebbe meglio, ma servirebbe più radicalità, una politica capace di coinvolgere i cittadini, servirebbe insomma tornare a fare un discorso di classe, cosa molto demodée, che oggi nessuno sembra intenzionato a fare. Insomma tra il bonus oggi e la gallina domani si propone il bonus, perché con la gallina (una società dove non si diventi adulti a quarant’anni e dove non ci siano lavoratori poveri) sembra di chiedere troppo.
 Piano piano, torna la normalità, il mondo si riaffaccia dalla nebbia fitta, torna un po’ di luce, e si ricomincia a pensare ad altro. E’ per questo che mi faccio vanto, modestamente, di anticiparvi un tema che resterà sul girarrosto delle notizie (e commenti, corsivi, analisi, espressioni scandalizzate, signora mia dove andremo a finire) per parecchie settimane, forse mesi. E cioè i lamenti, i lai, le accuse, le perorazioni e i sermoni degli imprenditori italiani che “non trovano dipendenti”.
Piano piano, torna la normalità, il mondo si riaffaccia dalla nebbia fitta, torna un po’ di luce, e si ricomincia a pensare ad altro. E’ per questo che mi faccio vanto, modestamente, di anticiparvi un tema che resterà sul girarrosto delle notizie (e commenti, corsivi, analisi, espressioni scandalizzate, signora mia dove andremo a finire) per parecchie settimane, forse mesi. E cioè i lamenti, i lai, le accuse, le perorazioni e i sermoni degli imprenditori italiani che “non trovano dipendenti”.
E’ un classico dell’estate, come il calippo e le canzoni brutte, ma insomma preparatevi, perché verrete sommersi da storie tristi tipo il barista che cerca un garzone, ma quello niente, sta al mare a farsi le canne grazie al reddito di cittadinanza e col cazzo (monsieur!) che va a lavare le tazzine alle sei del mattino. Siccome eravamo abituati al fiorire di queste notizie in un nugolo di piccole storie tristi, bisogna anche dire che la trama è sempre la stessa, banale e prevedibile. Scena uno: l’imprenditore lamenta (sul giornale locale, o alla radio, o nel servizio tivù) che da settimane cerca un dipendente, ma non si presenta nessuno. Scena due: si scopre che l’annuncio era stato messo su Facebook, quindi girava in cerchie strettissime, oppure che si offrivano condizioni che l’Alabama dell’Ottocento sembra Hollywood, al confronto. Terzo atto della commedia, la tirata indignata su: a) i giovani che non hanno voglia di lavorare; b) gli danno settecento euro per stare sul divano (sottotesto: io gliene darei meno per farsi un culo a capanna); c) Ai miei tempi… (riempire a piacere).
Dov’è la novità, direte voi. Ecco. La novità è che a fare il coro greco sullo stagionale che non si trova, questa volta non è stato il barista Pinco o l’associazione albergatori di Qui o di Là, ma un presidente di Regione, per la precisione Vincenzo De Luca, che ha saltato i primi due atti della pièce ed è passato subito al terzo: i lavoratori stagionali mancano per colpa del Reddito di Cittadinanza, che tanti lutti e tante privazioni ha causato agli imprenditori italiani. Traduco: il reddito di cittadinanza impedisce di fare dumping sui salari, che è quel meccanismo per cui se un lavoro vale dieci cercherò di dartene otto, e se arriva uno più disperato di te a lui ne darò sei, finché mi arriva il disperato che magari ha figli, e allora a lui ne darò due (John Steimbeck, Furore, 1939).
Non è tutto qui, certo. La situazione di incertezza dovuta all’anno e mezzo da cui usciamo complica le cose. Infatti, c’è chi riesce ad aggrapparsi a welfare, ristori e sostegni, e li perderebbe volentieri per lavorare, ma che succede se tutto richiude all’improvviso? Finirebbe per perdere sia reddito che sostegni, e quindi si capisce la prudenza.
Aggiungerei un dettaglio che non è per niente un dettaglio: dal Piano nazionale di ripresa e resilienza eccetera eccetera è sparito – puff – ogni riferimento al salario minimo legale per i lavoratori. Ce lo chiede l’Europa (una direttiva Ue che la commissione Lavoro del Senato ha accolto e votato a metà marzo), ma nel piano che abbiamo spedito all’Europa non c’è. Era previsto ma non c’è. Chissà, forse adesso che cominciano i lavori stagionali sarebbe servito. Eppure, la narrazione non cambierà: tra chi offre poco per orari assurdi, chi si scorda di fare leggi che tutelino i lavoratori, e i poveri che “stanno sul divano” è più facile prendersela con questi ultimi, e – ovvio – con l’unica legge che rende più difficile pagarli due cipolle e un peperone.
 Non c’è concime migliore per l’ego dell’autobiografia del leader politico scritta in giovane età, che sarebbe il non plus ultra dell’autopromozione, un monumento a cavallo autocostruito un po’ per celebrazione di sé e un po’ impalcatura per la costruzione di glorie future. In più, ghiotta occasione di riposizionamento, il cui messaggio è: “Ecco come sono veramente”. Davvero bizzarro: gente che ha una vita pubblica piuttosto frenetica, che vive di dichiarazioni, interviste e ospitate in tivù, delle cui idee, posizioni, esternazioni sappiamo tutto, sente il bisogno di raccontarsi per “come è” invece di “come sembra”.
Non c’è concime migliore per l’ego dell’autobiografia del leader politico scritta in giovane età, che sarebbe il non plus ultra dell’autopromozione, un monumento a cavallo autocostruito un po’ per celebrazione di sé e un po’ impalcatura per la costruzione di glorie future. In più, ghiotta occasione di riposizionamento, il cui messaggio è: “Ecco come sono veramente”. Davvero bizzarro: gente che ha una vita pubblica piuttosto frenetica, che vive di dichiarazioni, interviste e ospitate in tivù, delle cui idee, posizioni, esternazioni sappiamo tutto, sente il bisogno di raccontarsi per “come è” invece di “come sembra”.
Ora è il momento editoriale di Giorgia Meloni, gratificata di interviste promozionali, soffietti adoranti e domande compiacenti, insomma per il tradizionale bacio della pantofola. Così sappiamo che Giorgia ha avuto problemi col padre, che da piccola era molto chiusa, che la sua grande paura atavica, il suo fantasma, è stato per anni il timore di annegare; brutto fantasma, non male per una che chiedeva di sparare sui barconi degli immigrati facendo annegare altri, ma pazienza.
Allo stesso modo, le sezioni missine diventano, nella ricostruzione riveduta e corretta, ameni e romantici luoghi di svago e di cultura, e nessuno si sogna di fare a Meloni qualche domanda un po’ ruvida, tipo perché non caccia dal suo partito i deficienti che si vestono da nazisti, o i governatori che in campagna elettorale andavano alle cene in onore del duce; oppure perché non condanna mai l’esuberanza dei suoi militanti che fanno il saluto romano, ricordano con nostalgia il Ventennio o inneggiano alla marcia su Roma. Insomma, l’autobiografia lava più bianco, pulisce, annulla gli angoli oscuri e rende tutto lindo e pulito.
Ci aveva provato anche Salvini, certo, con un libro che era un compitino da ripetente di terza media – un’intervista in ginocchio, quella, non una vera autobiografia – edito dalla casa editrice di Casa Pound. Lì avevamo appreso che al piccolo Matteo, all’asilo, avevano rubato il pupazzetto di Zorro, il che deve aver generato un qualche imprinting passivo-aggressivo. Poi ci sono i libri di Matteo Renzi, sempre immaginifici e lungimiranti, dai titoli evocativi (“Un’altra strada”, “La mossa del cavallo”), adatti a spiegare le nuove sfide e le prospettive. A lungo termine, si direbbe, anche lunghissimo, visto che piazzarsi sotto il due per cento nei sondaggi garantisce, diciamo così, ampi margini di miglioramento, essendo l’estinzione l’unico peggioramento possibile. Mettiamo nel mucchietto anche il libro mai uscito di Roberto Speranza, “Perché guariremo”, scritto e stampato ma mai venduto, dato che cantava vittoria sulla pandemia quando la vittoria non c’era: circola clandestino in poche copie sfuggite al macero, e anche lì il mix di retorica e autocelebrazione è piuttosto (letto ora) esilarante, mentre Rocco Casalino preferiva togliersi molti sassolini dalle scarpe, anche lì con frequenti dettagli strappalacrime.
Dunque non basta ai politici occupare tutti gli spazi, monopolizzare i tg, i talk, l’immaginario collettivo, il discorso pubblico. Viene sempre il momento – pare inevitabile – di porre in mezzo al proprio cammino la pietra miliare dell’autobiografia: confessioni di peccati innocentissimi e distratto sorvolo su errori, cretinate e misfatti reali. Intorno, il plauso dei media osannanti, che finalmente possono gioire del “lato umano” di questo o quel leader che si disvela, imperdibile occasione – un’altra! – per genuflettersi al potere.
 C’è un divertente allegato alla vicenda Fedez-Salvini-concerto del Primo maggio che vale la pena indagare. Un dettaglio, forse, ma che dice molte cose sul Paese e la sua classe politica. Lasciamo da parte il solito teatrino dell’assurdo, con i leader di qua e di là che si scagliano contro la lottizzazione e la Rai controllata dai partiti, puro cabaret, puro nonsense, come se Wile Coyote comparisse in un talk show per gridare: “Basta con questi tentativi di mangiarsi uno struzzo!”. E va bene, si è già detto; così come si è già detto quasi tutto, sulla faccenda, e forse manca solo la profezia di Fassino: “Fedez si faccia un partito e si presenti alle elezioni”. Ecco, speriamo di no.
C’è un divertente allegato alla vicenda Fedez-Salvini-concerto del Primo maggio che vale la pena indagare. Un dettaglio, forse, ma che dice molte cose sul Paese e la sua classe politica. Lasciamo da parte il solito teatrino dell’assurdo, con i leader di qua e di là che si scagliano contro la lottizzazione e la Rai controllata dai partiti, puro cabaret, puro nonsense, come se Wile Coyote comparisse in un talk show per gridare: “Basta con questi tentativi di mangiarsi uno struzzo!”. E va bene, si è già detto; così come si è già detto quasi tutto, sulla faccenda, e forse manca solo la profezia di Fassino: “Fedez si faccia un partito e si presenti alle elezioni”. Ecco, speriamo di no.
Eppure qualcosa è sfuggito alla disamina del caso (clinico), ed è l’accorato appello di Salvini a Fedez: “Sono pronto a un confronto in tivù”, dice a Barbara D’Urso, chiedendo tra le righe di organizzarlo lei. Grande idea: rapper contro baciatore di salami a casa della regina del nazional-populismo televisivo, una specie di epifania del trash. Confido che Fedez si sia fatto una risata. Anche il senatore Pillon chiede un incontro, lanciando una sua bizzarra visione del mondo: “No ai comizi, sì al confronto”. Insomma, la libertà di dire quel che si pensa (che è poi la libertà) barattata con un dibattito; la libertà di dare notizie verificate e impossibili da smentire (le frasi omofobe di alcuni esponenti leghisti) ceduta in cambio del famoso “contraddittorio”. E’ come se nel telegiornale si parlasse, che so, dei manifestanti uccisi in Birmania, e dopo il servizio, si presentasse in studio un generale golpista birmano per il contraddittorio. Un bel dibattito. Un confronto franco e sereno. Uno scambio di idee e di vedute. Mani in alto.
Si intuisce, dietro lo schiocco dello schiaffone preso da Salvini, una sorta di incredulità, il non capacitarsi che un cittadino (un artista, un cantante, uno sportivo, un attore, insomma chiunque) abbia più audience della politica, e che possa non solo permettersi di avere delle opinioni, ma di dirle in pubblico con un certo successo. Al contempo, mentre si fa fuoco e fiamme per il ceffone incassato, si chiede ospitalità a questo o quel contenitore televisivo, cioè quei posti dove già abbiamo visto ogni nefandezza, compreso un Salvini addolorato che recita l’Eterno Riposo per le vittime del Covid (sempre dalla D’Urso). In quel caso, gli ultras cattolici (e nemmeno i laici, peggio mi sento) non ebbero niente da ridire e non chiesero nessun confronto, nessun contraddittorio, nessuna riparazione.
Non è cosa che riguardi solo Salvini, intendiamoci. Alla corte della tivù si presentano tutti, prima o poi, questuanti con il cappello in mano a chiedere qualche grammo di ricostituente per i loro consensi traballanti. E questo avviene perché la politica (da tempo) non ha più parole, ed è costretta a rubare quelle di altri. Quelle della tivù popolare, per dire, o dei comici, o dei cantanti (si vedano le lodi di molta sinistra al discorso di Fedez, un discorso che dovrebbe fare lei, di più e meglio); insomma un affannato rubacchiare linguaggi e parole qui e là, in mancanza di linguaggi e parole autonome, di visioni, di strategie. Fuffa, insomma. Propaganda. E difesa di un privilegio: solo noi possiamo parlare. Salvo poi, quando parla qualcun altro, chiedere a gran voce “il confronto in tivù”, magari perché compaia a discutere “democraticamente” quello che “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno”. Segue dibattito. Ma anche – prevalga la pietà – no.
 A turbare la ola e lo scroscio di applausi che il governo Draghi si porta appresso dopo la presentazione del Recovery Plan da 248 mila milioni (ogni tanto è giusto ricordare cos’è un miliardo, anche se se ne parla come di noccioline all’happy hour) c’è una divertente guerra sotterranea tra le due destre più estreme del Paese. Mentre regna una finta concordia, guidata dalla speranza che il signor Draghi – fico com’è – ci porti fuori dal disastro annaffiando di soldi la penisola, possiamo goderci il grazioso vaudeville di Giorgia contro Salvini, Salvini contro Giorgia, e tutti e due, chi più chi meno, contro il governo (uno da dentro, l’altra da fuori). No, non intendeva questo, Draghi, quando ha detto di superare “gli interessi di parte”, ma al momento, in attesa dell’assalto alla diligenza che trasporta 248 miliardi, gli interessi di parte sembrano quelli dei due combattenti: la giovane italiana e il baciatore di salami. Meloni gode della posizione privilegiata di essere l’unica opposizione esterna, Salvini cerca di monetizzare il suo ruolo di opposizione interna: la faceva a spada tratta brandendo un mojito quando era ministro dell’Interno, figurarsi se esita a farlo oggi. E’ una guerra di dispetti, scaramucce, sgambetti. Salvini attacca Speranza? Meloni presenta una mozione di sfiducia a Speranza. Salvini attacca il coprifuoco? Meloni di più. Salvini guida falangi di ristoratori incazzati? Meloni pure, con il risultato che manifestazioni di gente che non lavora da un anno e passa, che ha parecchie ragioni per essere nervosa, finiscono per sembrare riunioni di arditi, con i pipicchiotti di Casa Pound e altri nostalgici di Kappler in prima fila. A guardare i sondaggi, Salvini ha perso in poco più di un anno quasi 15 punti percentuali, mentre la Meloni ne ha conquistati un bel po’, dimostrando la tesi dei vasi comunicanti (a destra).
A turbare la ola e lo scroscio di applausi che il governo Draghi si porta appresso dopo la presentazione del Recovery Plan da 248 mila milioni (ogni tanto è giusto ricordare cos’è un miliardo, anche se se ne parla come di noccioline all’happy hour) c’è una divertente guerra sotterranea tra le due destre più estreme del Paese. Mentre regna una finta concordia, guidata dalla speranza che il signor Draghi – fico com’è – ci porti fuori dal disastro annaffiando di soldi la penisola, possiamo goderci il grazioso vaudeville di Giorgia contro Salvini, Salvini contro Giorgia, e tutti e due, chi più chi meno, contro il governo (uno da dentro, l’altra da fuori). No, non intendeva questo, Draghi, quando ha detto di superare “gli interessi di parte”, ma al momento, in attesa dell’assalto alla diligenza che trasporta 248 miliardi, gli interessi di parte sembrano quelli dei due combattenti: la giovane italiana e il baciatore di salami. Meloni gode della posizione privilegiata di essere l’unica opposizione esterna, Salvini cerca di monetizzare il suo ruolo di opposizione interna: la faceva a spada tratta brandendo un mojito quando era ministro dell’Interno, figurarsi se esita a farlo oggi. E’ una guerra di dispetti, scaramucce, sgambetti. Salvini attacca Speranza? Meloni presenta una mozione di sfiducia a Speranza. Salvini attacca il coprifuoco? Meloni di più. Salvini guida falangi di ristoratori incazzati? Meloni pure, con il risultato che manifestazioni di gente che non lavora da un anno e passa, che ha parecchie ragioni per essere nervosa, finiscono per sembrare riunioni di arditi, con i pipicchiotti di Casa Pound e altri nostalgici di Kappler in prima fila. A guardare i sondaggi, Salvini ha perso in poco più di un anno quasi 15 punti percentuali, mentre la Meloni ne ha conquistati un bel po’, dimostrando la tesi dei vasi comunicanti (a destra).
Alla lunga, però, sarà il caso di uscire da questa partita tutta tattica – che avrà la sua gloriosa epifania al momento della scelta dei sindaci delle grandi città – e passare a qualcosa che somigli alla strategia. Dunque si porranno alcune domande che oggi sembrano peregrine, ma che tra qualche mese diventeranno più pressanti. Una tra tutte: ma siamo sicuri che lasciare alla destra tutte le battaglie sulle libertà costituzionali, alla lunga, pagherà? Se uno comincia alle nove del mattino a dire che è mezzogiorno, quando finalmente arriverà mezzogiorno canterà vittoria come se fosse merito suo, ed è proprio questo che Salvini e Meloni aspettano, in modo di intestarsi, un domani, la ripartenza, la fine dell’emergenza, e magari addirittura una decisa ripresa economica (“Io l’avevo detto” livello pro).
E del resto c’è la sgradevole sensazione che le posizioni fieramente chiusuriste della sinistra (pardon) siano più dettate dal fare argine alle intemerate dei due balilla, uno dentro e una fuori dal governo, che a una visione di prospettiva, che per ora è affidata soltanto alla pioggia di miliardi in arrivo sul primo binario. La destra law and order che si finge libertaria è un notevole testacoda, ma è un testacoda speculare a quello di una sinistra (ri-pardon) che non vede – che non sa vedere, e non da oggi – la rabbia di molti italiani, e quando la vede si rifugia dietro un comodo luogocomunismo (i ristoratori incazzati? Tutti evasori fiscali, bon, fine del discorso, facile, no?). Oggi l’emergenza copre come un sudario questa contraddizione, ma dopo, poi, si saprà in qualche modo sanarla? Cioè: si troverà un vaccino?
Sul sito di Flumeri e Giacometti, intervista su Flora, la scrittura, e molte altre cose. Mettetevi comodi
 Non è facile vivere in un Paese eternamente sospeso tra il Medioevo e la fantascienza, tra l’eterno film di Totò e Matrix, dove si sognano sviluppi incredibili e futuristici e intanto ci si dibatte con un presente che arranca. Qualcuno ricorderà l’app Immuni, per fare un esempio, che di questa sindrome dei piedi ben piantati nella palude e del dito che indica le stelle fu una metafora perfetta. La propaganda dei primi mesi di pandemia (tutti i giornali e i media, tutti i politici, tutti) tendevano a colpevolizzare i cittadini perché non installavano questa benedetta app, che ci avrebbe avvertito di contatti ravvicinati con gli infetti. Si agitò il fantasma della privacy (“Vergogna! Date i vostri dati a Facebook e poi vi allarmate per un’app che vi salva la vita!”), si accusarono gli italiani di diffidenza e di scarsa collaborazione, con un copione che la pandemia ha santificato e applicato alla lettera ogni giorno: dare la colpa ai cittadini.
Non è facile vivere in un Paese eternamente sospeso tra il Medioevo e la fantascienza, tra l’eterno film di Totò e Matrix, dove si sognano sviluppi incredibili e futuristici e intanto ci si dibatte con un presente che arranca. Qualcuno ricorderà l’app Immuni, per fare un esempio, che di questa sindrome dei piedi ben piantati nella palude e del dito che indica le stelle fu una metafora perfetta. La propaganda dei primi mesi di pandemia (tutti i giornali e i media, tutti i politici, tutti) tendevano a colpevolizzare i cittadini perché non installavano questa benedetta app, che ci avrebbe avvertito di contatti ravvicinati con gli infetti. Si agitò il fantasma della privacy (“Vergogna! Date i vostri dati a Facebook e poi vi allarmate per un’app che vi salva la vita!”), si accusarono gli italiani di diffidenza e di scarsa collaborazione, con un copione che la pandemia ha santificato e applicato alla lettera ogni giorno: dare la colpa ai cittadini.
Naturalmente la privacy non c’entrava niente, quel che fece naufragare malamente l’app immuni fu semplicemente il salto troppo lungo (da Totò a Matrix, appunto), con la pretesa che una segnalazione dell’app arrivasse alla Asl in tempo reale, e da quella partissero lancia in resta, in pochi minuti, falangi di tracciatori in grado di individuare, che so, tutti quelli seduti su un tram a una certa ora. Pura fantascienza e, com’era ovvio, non se ne parlò più.
Siccome non si impara mai veramente dalle esperienze negative (che si preferisce dimenticare, piuttosto che usarle per trarne lezione), ecco ora la favola bella del pass vaccinale. Buttato lì quasi per caso, tra le righe, dal Presidente del Consiglio Draghi, il pass vaccinale non si sa esattamente cosa sia, chi lo debba rilasciare, come funzionerà nella pratica. Il sogno, ovvio, sarebbe avere memorizzata sulla tessera sanitaria la propria situazione in relazione al Covid, se l’hai fatto, se sei vaccinato, se hai fatto un tampone di recente. In sostanza, la cosa è piuttosto facile da dire, ma piuttosto difficile da fare: fornire un documento credibile (cioè non falsificabile, emesso da qualche ente con tutti i crismi dell’ufficialità) a cinquanta milioni di italiani, e farlo entro l’estate, in meno di due mesi, è un progetto bellissimo che ha la stessa fattibilità di portare fuori il cane su Saturno.
Senza contare le ricadute sulla vita di ognuno di noi. La nonna vaccinata può viaggiare, il figlio cinquantenne aspetta il vaccino, quindi no, i nipoti sotto i diciott’anni li vaccineranno forse nel 2023, i tamponi molecolari hanno bisogno di prenotazioni, tempo e file, bisogna aspettare l’esito e partire entro 48 ore, sennò bisogna rifarlo. Aggiungete a piacere, magari immaginando una macchina che parte verso il Sud per le vacanze con a bordo, un vaccinato, due no, un ragazzino, un tamponato. Ognuno con il suo documento a portata di mano per i controlli. Senza contare i costi: se fai il tampone vai in vacanza (o al cinema? A un concerto?), altrimenti no, che è – da qualunque parte la su guardi – una discriminazione anche economica, perché il mercato dei tamponi impazza e i prezzi sono molto diversi da città a città (con Milano più cara di tutti, che ve lo dico a fare). Insomma, la soluzione è ben pensata per non essere operativa mai, oppure operativa con qualche milione di eccezioni, che è lo stesso, e ci rimarrà tra le mani la vecchia cara autocertificazione che ci facciamo noi, con le nostre manine, come ai vecchi tempi dell’app Immuni, parlandone da viva.
Il Salone del Libro di Torino mi ha fatto adottare per tre lezioni da una classe di studenti, spero che mi trattino bene. Intanto mi ha chiesto di adottare una parola, e io ho scelto “Ossessione”. Agevolo il filmato (da YouTube)
Qui sotto la bella intervista di Filippo Maria Battaglia per Incipit, la rubrica di libri di Sky Tg 24, video da YouTube
 C’è un filo sottile, sottilissimo, praticamente invisibile che separa la Realpolitik dall’ipocrisia, la pratica dai proclami, la ragion di Stato dalla faccia come il culo. Era inevitabile pensarlo vedendo salpare la fregata multiruolo Fremm, nave da guerra partita in sordina, senza la banda, senza cerimonie, su l’ancora e via. Destinazione al-Sisi, cioè l’Egitto, cioè il posto dove è stato ammazzato Giulio Regeni, dove viene tenuto ostaggio Patrick Zaki, e dove i diritti umani contano come il due di coppe quando la briscola è picche. Sì, c’è una beffarda aporia tra le piazze italiane in cui campeggiano gli striscioni gialli che chiedono “verità e giustizia” per un nostro cittadino torturato e ucciso al Cairo e le poderose forniture militari al regime che l’ha ammazzato. Due fregate vendute per 990 milioni, inizialmente destinate alla nostra Marina, a cui tra parentesi erano costate di più (1,2 miliardi). La scia bianca sulle onde ci dice una cosa: di qui le belle parole e di là i fatti. Istruzioni per l’uso (non delle fregate da guerra, ma dell’ipocrisa): allargare le braccia, scuotere la testa e dire “Che ci vuoi fare, è la Realpolitik”. Bella roba, eh!
C’è un filo sottile, sottilissimo, praticamente invisibile che separa la Realpolitik dall’ipocrisia, la pratica dai proclami, la ragion di Stato dalla faccia come il culo. Era inevitabile pensarlo vedendo salpare la fregata multiruolo Fremm, nave da guerra partita in sordina, senza la banda, senza cerimonie, su l’ancora e via. Destinazione al-Sisi, cioè l’Egitto, cioè il posto dove è stato ammazzato Giulio Regeni, dove viene tenuto ostaggio Patrick Zaki, e dove i diritti umani contano come il due di coppe quando la briscola è picche. Sì, c’è una beffarda aporia tra le piazze italiane in cui campeggiano gli striscioni gialli che chiedono “verità e giustizia” per un nostro cittadino torturato e ucciso al Cairo e le poderose forniture militari al regime che l’ha ammazzato. Due fregate vendute per 990 milioni, inizialmente destinate alla nostra Marina, a cui tra parentesi erano costate di più (1,2 miliardi). La scia bianca sulle onde ci dice una cosa: di qui le belle parole e di là i fatti. Istruzioni per l’uso (non delle fregate da guerra, ma dell’ipocrisa): allargare le braccia, scuotere la testa e dire “Che ci vuoi fare, è la Realpolitik”. Bella roba, eh!
Non solo l’Egitto, ovviamente. La recente frase di Mario Draghi su Erdogan, dittatore che però “ci serve”, chiarisce senza mezzi termini il problema, anche con la Turchia si fa la stessa cerimonia: occhi al cielo, braccia allargate in un gesto di cauta impotenza, e oplà, il venti per cento delle nostre esportazioni di armi finisce nelle mani del dittatore cattivo che però “ci fa comodo”. Che ci sia mezza Turchia in galera, tra intellettuali, oppositori vari, docenti universitari, scrittori, non deve fare velo sulle convenienze, scegliete voi se vale più la vita di qualche decina di migliaia di oppositori o il fatturato. Dài, non c’è partita, come ci insegnano alcuni geni del commercio: se non gliele vendiamo noi, le armi, gliele vende qualcun altro, e allora tanto vale… In più, paghiamo profumatamente il “dittatore utile” perché fermi qualche milione di migranti.
La sconsolata confessione del Presidente del Consiglio, quel “che ci volete fare” un po’ fatalista e un po’ furbetto sui dittatori che ci circondano e che riempiamo di armamenti sofisticati, ha poi assunto toni grotteschi con la visita in Libia e i ringraziamenti al nostro dirimpettaio mediterraneo per come “salva” i migranti. Cioè per come cattura quelli che riescono a scappare per riportarli nel lager, per rivenderli tra tribù e trafficanti, il tutto (sta diventando un classico) con motovedette gentilmente donate da noi. Non che si possa incolpare solo il governo Draghi: che le tribù libiche e i signori della guerra del deserto nordafricano fossero buoni partner lo si vide già con il ministro Minniti, quando si spiavano i giornalisti in prima linea sul fronte dell’immigrazione, con il ministro Salvini che sequestrava poveracci in mare aperto, e ora, quando si va dire “grazie, bravi!” ai rastrellatori di profughi.
Chissà se è vero che tre indizi fanno una prova, ma in ogni caso restano tre indizi: tre regimi piuttosto impresentabili e feroci che fanno allegramente affari armatissimi con l’Italia. Grazie a noi, insomma, tre regimi piuttosto feroci diventano più forti, più armati, più muscolosi, più arroganti e in definitiva più pericolosi per tutti. Resterà il dubbio, quando ci troveremo circondati da dittature ostili armate fino ai denti (manca poco), su chi premiare con il Nobel alla lungimiranza: i candidati italiani saranno numerosi.
Qui l’intervista di Alessandro Beretta sul Corriere Milano, e la bella recensione di Paolo Marcolin su Il Piccolo di Trieste (cioè, Guy Debord, Roland Barthes… non staremo esagerando?). Grazie grazie
Il servizio di Laura Longo su Petrarca, il magazine culturale di Rai Tre. Grazie grazie (via YouTube)
 Il futuro è sopravvalutato. E’ un concetto che contiene tutto: prospettive, speranze, desideri di cambiamento, annunci roboanti, promesse. Persino lo slogan appeso a balconi e finestre (un anno fa: oggi suona grottesco) era al futuro: “andrà tutto bene” (sic). Andrà quando? Dopo, un domani, o un dopodomani, o chissà. Andrà, vedremo. Così emerge un piccolo sospetto, di quelli che rodono e stanno lì in agguato come un retropensiero: che il futuro, il coniugare ogni verbo di speranza al futuro, sia solo un tentativo per spostare l’attenzione al domani, una speranzosa distrazione alla desolazione dell’oggi.
Il futuro è sopravvalutato. E’ un concetto che contiene tutto: prospettive, speranze, desideri di cambiamento, annunci roboanti, promesse. Persino lo slogan appeso a balconi e finestre (un anno fa: oggi suona grottesco) era al futuro: “andrà tutto bene” (sic). Andrà quando? Dopo, un domani, o un dopodomani, o chissà. Andrà, vedremo. Così emerge un piccolo sospetto, di quelli che rodono e stanno lì in agguato come un retropensiero: che il futuro, il coniugare ogni verbo di speranza al futuro, sia solo un tentativo per spostare l’attenzione al domani, una speranzosa distrazione alla desolazione dell’oggi.
Non passa giorno – si può dire non passa ora – che non si sentano proclami su quel che succederà. Tutti i lombardi vaccinati entro giugno (questo era Bertolaso), no, tutti quelli di Brescia vaccinati entro luglio (ancora Bertolaso, il mago Do Nascimiento era più credibile), no, tutti gli italiani entro l’estate (Speranza), no, vaccineremo mezzo milione di persone al dì (il generale Figliuolo), no, tutti gli anziani entro aprile, no, il sessanta per cento della popolazione entro settembre. Si sposta l’asticella in su e in giù, e ad ogni proclama sul luminoso futuro segue il contro-proclama a stretto giro: vi ricordate quello che si diceva ieri sul vostro futuro? Beh, non era vero. Doccia scozzese, un po’ bollente, un po’ gelata, ed è passato un altro giorno.
Ora, da qualche settimana, tiene banco la promessa più solenne, quella del generale Figliuolo, che insiste sulla sua previsione (o sarà una speranza?) di 500 mila vaccinazioni al giorno. Se arrivano i vaccini, se la macchina si metterà in moto, se tutti sapranno fare il loro, se… Insomma, si tratta di un futuro, sì, ma con molte incognite, condizioni e varianti, e già in contemporanea (non domani, ma oggi) il futuro annaspa un po’ e i titoli recitano: “Il cambio di passo slitta a maggio”. Voilà, un futuro con l’elastico.
Nel frattempo, viene accolto come un proclama di vittoria il quotidiano arrivo di fiale: oggi scaricato un milione di dosi! Oggi ne arrivano un milione e mezzo! Ma la piccola esultanza dei telegiornali, svapora poi nell’accavallarsi delle cronache, con gli ottantenni ancora in cerca di una puntura, le categorie furbette che tentano il salto della fila, i problemi logistici, le Regioni che barano, i governatori che fanno il gioco delle tre carte, il governo che fa la faccia militaresca dell’efficienza, e noi che aspettiamo ‘sto famoso futuro, sottoforma di iniezione.
Ora l’allarme è chiaro: se oltre a confondere il presente si pasticcia anche con il futuro, ogni proclama e previsione diventerà quel che è: parole al vento, rassicurazioni che non rassicurano nessuno, anzi, che finiscono col creare una diffidenza naturale, un’irritazione endemica. E se si può avere un sogno declinato al futuro, oggi, sarebbe quello di cominciare a sentir parlare al passato. Esempio: “Ehi, voi! Ieri abbiamo vaccinato mezzo milione di persone!”; oppure: “Ecco fatto! Tutti i vecchi e i deboli sono al sicuro!”. Urge una moratoria sui verbi declinati al futuro, una tassa sulle previsioni che somigliano più a un afflato della speranza che a un calcolo reale, forse addirittura serve il reato di falsa promessa sulla salute. “E’ lei che disse ad aprile tutti vaccinati? Ci segua in questura, per favore”. Non succederà, ovvio, e il balletto sul “domani” continuerà, come un enorme esperimento sociale: vediamo quanto futuro ipotetico riusciamo a darvi in cambio di un presente di merda. Domani. Vedremo. Chissà.
Qui l’intervista con Alessandra Tedesco, una chiacchierata su Flora e dintorni, a Il cacciatore di libri su Radio24. Clicca per ascoltare. Grazie grazie
 Per gli amanti dei testacoda, dei paradossi, dei ribaltamenti di senso, eccone uno straordinario: la proprietà dei mezzi di produzione – quell’antico progetto marxista – diventa un argomento attuale, che tocca quasi tutti, che ancora discrimina i cittadini del Paese. Partiamo da qui: il ministro dell’Istruzione Bianchi emanerà apposite circolari eccetera, ma l’orientamento dichiarato, manifesto e riportato da tutti i giornali è questo: si boccia anche con la Dad, la famigerata didattica a distanza. Lasciamo perdere il consueto sciame sismico: attenzione ai ricorsi… il parere dei presidi… rumore di fondo. Stringendo: anche in condizioni estreme, anche in clamorosa emergenza (migliaia di italiani sono andati a scuola per poche settimane), rimane indiscutibile il criterio del voto, della media del sei, insomma del “merito”.
Per gli amanti dei testacoda, dei paradossi, dei ribaltamenti di senso, eccone uno straordinario: la proprietà dei mezzi di produzione – quell’antico progetto marxista – diventa un argomento attuale, che tocca quasi tutti, che ancora discrimina i cittadini del Paese. Partiamo da qui: il ministro dell’Istruzione Bianchi emanerà apposite circolari eccetera, ma l’orientamento dichiarato, manifesto e riportato da tutti i giornali è questo: si boccia anche con la Dad, la famigerata didattica a distanza. Lasciamo perdere il consueto sciame sismico: attenzione ai ricorsi… il parere dei presidi… rumore di fondo. Stringendo: anche in condizioni estreme, anche in clamorosa emergenza (migliaia di italiani sono andati a scuola per poche settimane), rimane indiscutibile il criterio del voto, della media del sei, insomma del “merito”.
Tutti conoscono l’accezione contemporanea della parola-feticcio “meritocrazia”: una gara di cui si indica solo il punto d’arrivo e non il punto di partenza. In sostanza: si corrono i cento metri, uno in scintillante tenuta da sprinter, e l’altro senza una scarpa, con lo zaino pesante e le mani legate. Trionfa il merito, bravo, promosso.
La didattica a distanza ha moltiplicato quest’effetto, evidenziando senza dubbio che le differenze di classe (wow!) passano oggi (che novità!) per la proprietà dei mezzi di produzione. Un buon tablet, un collegamento in fibra, magari un buon cellulare a portata di mano, un computer che non si incanta come i vecchi grammofoni, una stanza tutta per sé. Quanti studenti italiani hanno oggi queste condizioni di partenza? Una minoranza. Perlopiù il Paese abita in un’altra galassia, quella dove è cara grazia se c’è un computer in ogni famiglia, e quando c’è bisogna fare i turni. E stabiliti i turni, la rete va e viene, magari tocca seguire una lezione in avventuroso collegamento mentre qualcuno studia, o lavora nello stesso spazio (vale anche lo smart-working, ovviamente).
Senza arrivare a Dickens (per quanto…), le condizioni di partenza in questa nobile gara per conquistare il sei e confermare le leggende su un ipotetico “merito”, sono stellarmente distanti. Chi ha di fronte una consolle superaccessoriata con potenza da spostare i satelliti e chi litiga coi parenti per l’uso di un cellulare a vapore del Settecento, corrono entrambi per lo stesso obiettivo. Che è esattamente come fare a gara per chi arriva prima in piazza del Popolo, ma uno parte con la Porsche da via del Corso e l’altro arriva a piedi da Udine, cinque, bocciato.
Ecco perché la proprietà dei mezzi di produzione diventa, come sempre è stato, il vero elemento di distacco tra classi sociali, motore di diseguaglianza. Ma capisco che tirare in ballo il vecchio Marx sia barbogio e démodé, va bene. Si vorrebbe supporre, però, che chi si occupa di scuola in Italia abbia almeno letto qualcosina di Don Milani, magari là dove dice che “Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali”. Se la scuola in presenza attenua, pur in minima parte, certe distanze sociali, la Dad no, semmai le amplifica, le ingigantisce fino al grottesco, fornendo una buona caricatura delle due, tre, quattro Italie che esistono in natura. Ai tempi di Don Milani e di Barbiana si bocciavano proletari coi piedi scalzi, il moccio al naso e le famiglie analfabete, oggi si può bocciare chi non possiede un adeguato standard tecnologico (che significa standard di reddito). Come si vede siamo sempre lì, chissà, forse per un vero salto culturale cade la linea.
La bella intervista (mi prende anche in giro perché dico “bella intervista”!) di Sara Ricotta Voza su TuttoLibri de La Stampa. Cliccare per leggere
 Nella top ten delle cose che è meglio evitare, subito sotto “fare il bagno nella vasca dell’orsa assassina”, ma sopra “guidare a fari spenti nella notte”, c’è “abitare in Lombardia”, una cosa che può diventare letale se siete – come tutti – in attesa di un vaccino. Bellissima terra, con laghi e montagne, dove il cielo “è bello quando è bello” (cit) e i cittadini sono abituati a guardare tutti gli altri italiani dall’alto al basso, perché qui c’è l’eccellenza, signora mia. Ecco, questa terra di eccellenze e primati, passata in poco più di duemila anni dalle palafitte a Bertolaso si chiede ora, con una certa apprensione, se a ben vedere non fossero meglio le palafitte. Il caparbio commissario-a-tutto aveva solennemente promesso al momento dell’insediamento (era il 2 febbraio): “Tutti i lombardi vaccinati entro giugno”, cioè dieci milioni di persone. Ricevette grandi applausi. Passa un mese e mezzo e Bertolaso, stentorea la voce e gonfio il petto, ri-dichiara volitivo (18 marzo): “Tutti i bresciani vaccinati entro luglio”, cioè duecentomila persone invece di dieci milioni, ma un mese in più.
Nella top ten delle cose che è meglio evitare, subito sotto “fare il bagno nella vasca dell’orsa assassina”, ma sopra “guidare a fari spenti nella notte”, c’è “abitare in Lombardia”, una cosa che può diventare letale se siete – come tutti – in attesa di un vaccino. Bellissima terra, con laghi e montagne, dove il cielo “è bello quando è bello” (cit) e i cittadini sono abituati a guardare tutti gli altri italiani dall’alto al basso, perché qui c’è l’eccellenza, signora mia. Ecco, questa terra di eccellenze e primati, passata in poco più di duemila anni dalle palafitte a Bertolaso si chiede ora, con una certa apprensione, se a ben vedere non fossero meglio le palafitte. Il caparbio commissario-a-tutto aveva solennemente promesso al momento dell’insediamento (era il 2 febbraio): “Tutti i lombardi vaccinati entro giugno”, cioè dieci milioni di persone. Ricevette grandi applausi. Passa un mese e mezzo e Bertolaso, stentorea la voce e gonfio il petto, ri-dichiara volitivo (18 marzo): “Tutti i bresciani vaccinati entro luglio”, cioè duecentomila persone invece di dieci milioni, ma un mese in più.
Basterebbe questo, in un paese normale (ahah, ndr) per cacciare con ignominia un simile caciarone, che nonostante il surreale dispiego di scempiaggini lamenta oggi (altra intervista, sul Corriere) di non avere abbastanza potere, di non poter spendere un euro, di non firmare niente e (ciliegina!) “Dovrei stare all’ultimo piano di palazzo Lombardia”, non si capisce bene se per fare il Presidente al posto di Fontana o per buttarsi di sotto, da lombardo temo la prima ipotesi.
Per il resto, Bertolaso a parte, la Lombardia vive un grande momento di autocombustione: tutta la sanità lombarda, dai vertici all’ultima Ast, è di nomina politica e al novanta per cento gestita da marescialli, sergenti e caporal-maggiori della Lega, tutti agli ordini di Salvini che ha tuonato per i giornali: “Chi ha sbagliato deve pagare!”, ma poi, invece di andare a costituirsi, ha fatto un po’ di tetris con le nomine, incastrando uno qua e uno là, sempre dei suoi. Le altre forze della destra fanno un po’ tenerezza, con i balilla di Fratelli d’Italia che lamentano di aver poco potere e Forza Italia che ha dovuto sacrificare il più esilarante assessore alla Sanità dai tempi dei Longobardi (il mai dimenticato Giulio Gallera) per sostituirlo con lady Moratti, mossa si dice approvata e caldeggiata da Salvini medesimo. Ora si narra di guerre intestine, ferri corti e sgambetti, con la Moratti che si installa in un altro grattacielo e si comporta da vero Presidente della Regione, mentre Fontana – di fatto commissariato – si rivela per quello che è: un signore buono a tagliar nastri e ad annuire nei convegni di Assolombarda, maldestro persino negli affarucci col cognato e ricco di soldi scudati in Svizzera. Una prece.
Quel che esce da questa eccellenza, più che una soave descrizione manzoniana, sembra un quadro di Bosch, coi vecchietti convocati a cento chilometri di distanza, a volte spediti in due posti contemporaneamente, a volte non avvertiti per niente perché la Regione non riesce a spedire i messaggi di convocazione, cosa che indigna Bertolaso: “Siamo atterrati su Marte e non riusciamo a spedire gli sms”. Bella frase, ma un po’ oscura: “siamo atterrati” chi? I lombardi? La Lega? La Moratti? Se la regione Lombardia avesse organizzato la spedizione su Marte ora saremmo qui incantati a rimirare immagini di qualche palude nel varesotto, con Fontana che dichiara: “Beh, dài, ci siamo andati vicini”.
Il 25 marzo esce Flora, il nuovo romanzo della serie con Carlo Monterossi. E’ una storia di spazzatura e poesia. Per ora accontentatevi, ne parleremo…
 Le ragazze e i ragazzi italiani che hanno dai sedici ai diciott’anni sono un milione e centomila, più o meno, il che significa – su una platea elettorale di 49 milioni di persone – appena il due per cento. Dunque se votassero (difficile) e se votassero tutti insieme per lo stesso partito (impossibile) varrebbero già più di Italia Viva, Più Europa (parlandone da viva), e altre micro-formazioni che allietano il dibattito politico italiano. Tanti, ma non così tanti da sconvolgere gli equilibri esistenti, anche perché, com’è ovvio, il loro voto si spalmerebbe su tutte le forze politiche. Eppure la proposta di Enrico Letta nel suo discorso di investitura a capo del Pd ha mosso decine e decine di commenti, controdeduzioni, critiche, applausi, rimembranze. Qualcuno ha ricordato che la cosa fu proposta a più riprese e da molti, tra cui la Lega e i 5s, e che l’argomento di abbassare l’età del voto torna periodicamente come un jolly pescato dal mazzo: sfina e non impegna. In generale, le reazioni sono di prudente attendismo o di costernata opposizione.
Le ragazze e i ragazzi italiani che hanno dai sedici ai diciott’anni sono un milione e centomila, più o meno, il che significa – su una platea elettorale di 49 milioni di persone – appena il due per cento. Dunque se votassero (difficile) e se votassero tutti insieme per lo stesso partito (impossibile) varrebbero già più di Italia Viva, Più Europa (parlandone da viva), e altre micro-formazioni che allietano il dibattito politico italiano. Tanti, ma non così tanti da sconvolgere gli equilibri esistenti, anche perché, com’è ovvio, il loro voto si spalmerebbe su tutte le forze politiche. Eppure la proposta di Enrico Letta nel suo discorso di investitura a capo del Pd ha mosso decine e decine di commenti, controdeduzioni, critiche, applausi, rimembranze. Qualcuno ha ricordato che la cosa fu proposta a più riprese e da molti, tra cui la Lega e i 5s, e che l’argomento di abbassare l’età del voto torna periodicamente come un jolly pescato dal mazzo: sfina e non impegna. In generale, le reazioni sono di prudente attendismo o di costernata opposizione.
Comprensibile sgomento: in un paese che odia i giovani, come tiene a dimostrare con fatti, parole, opere e omissioni, ecco il dibattito sui giovani, condotto da non più giovani (quasi sempre non più giovani da almeno mezzo secolo), che riflettono pensosi e assorti su quanto un sedicenne possa capire di politica e destreggiarsi nel marasma dell’offerta.
E vai con il valzer: ci vuole più maturità per votare. Ci vuole più preparazione. La scuola non aiuta. Dobbiamo formarli meglio, eccetera eccetera. Cioè, se ho capito bene, i giovani dai sedici ai diciott’anni non meriterebbero il diritto di voto perché gli adulti e gli anziani del Paese, in cinquant’anni, non sono riusciti a formarli come si deve, a fare della scuola un posto dove si costruiscono cittadini, a fermare l’impazzito oscillare tra l’insulto (sono tutti scemi) e il paternalismo (vieni qui che ti formo). Il gatto (adulto, anzi anziano) si mangia la coda, insomma. C’è anche chi teorizza – e non gli viene nemmeno da ridere – che per arrivare a quel traguardo del voto ai più giovani bisogna bocciarli di più alle scuole medie. Chapeau: è il grande ritornello paraculo della “meritocrazia”, in un Paese dove vincono a man bassa quelli nati meritati.
Ignoranti, bulletti, gente che pensa solo al telefonino, da ultimo untori cattivi che ammazzano i nonni con il contagio, con la scuola chiusa da un anno, plasmati sul mercato come se già all’asilo fossero mano d’opera da indirizzare, spediti a far fotocopie in qualche ufficio per “far dialogare la scuola col mondo del lavoro” (ahahah! ndr), casinisti, arruffapopolo, bevono, si fanno le canne.
Insomma, ribalterei il dibattito: non tanto “Siamo sicuri che sia una buona idea far votare i sedicenni?”, ma piuttosto: “Siamo sicuri che i sedicenni vogliano andare a votare per questi partiti?”, per una classe dirigente che in più di un anno non li ha fatti andare a scuola perché non è riuscita a rendere sicuri i mezzi pubblici che ce li portano? Magari a votare gente che è andata in pensione a cinquant’anni mentre loro a cinquant’anni usciranno (forse) dalla precarietà? Quanto all’appello alla “maturità” necessaria per votare, è il classico argomento boomerang, e si potrebbe obbiettare, visto un Paese che periodicamente si aggrappa a questo o quel salvatore della patria, o uomo della provvidenza, o ultima spiaggia, che anche gli adulti che votano, in quanto a maturità, non possono dare tutte queste raffinate e profonde lezioni di vita.
 Visto che le Olimpiadi di Tokyo sono in forse, il Cio ha tempo per pensarci e introdurre una nuova specialità olimpica: il salto della fila. E’ una disciplina complicata: servono colpo d’occhio e capacità di fare gruppo; è uno sport di squadra, anzi di categoria, dove vince (una dose di vaccino) chi riesce a sedersi per primo davanti a un medico offrendo il braccio per la medaglia. Saremmo in zona podio, questo è certo. Non passa giorno, infatti, che non spunti qualche categoria, associazione, confraternita, Ordine professionale, setta, tipologia commerciale, che non chieda a gran voce di esser messa in lista prima di altri. Ha inaugurato la specialità il presidente della Campania Vincenzo De Luca, vaccinato il primo giorno “per dare l’esempio” (che avrei dato volentieri anch’io, dannazione). La senatrice Binetti si scalda e invia accorate mail ai colleghi perché si provveda a vaccinare prima i senatori. I giornalisti della Campania hanno chiesto (e ottenuto, sembra) di mettersi in fila subito dopo gli ottantenni, i sindaci premono per avere una corsia preferenziale, e c’è chi si è portato avanti col lavoro, tipo il sindaco di Corleone che si è fatto siringare e poi – beccato – ha annunciato le dimissioni, e via così.
Visto che le Olimpiadi di Tokyo sono in forse, il Cio ha tempo per pensarci e introdurre una nuova specialità olimpica: il salto della fila. E’ una disciplina complicata: servono colpo d’occhio e capacità di fare gruppo; è uno sport di squadra, anzi di categoria, dove vince (una dose di vaccino) chi riesce a sedersi per primo davanti a un medico offrendo il braccio per la medaglia. Saremmo in zona podio, questo è certo. Non passa giorno, infatti, che non spunti qualche categoria, associazione, confraternita, Ordine professionale, setta, tipologia commerciale, che non chieda a gran voce di esser messa in lista prima di altri. Ha inaugurato la specialità il presidente della Campania Vincenzo De Luca, vaccinato il primo giorno “per dare l’esempio” (che avrei dato volentieri anch’io, dannazione). La senatrice Binetti si scalda e invia accorate mail ai colleghi perché si provveda a vaccinare prima i senatori. I giornalisti della Campania hanno chiesto (e ottenuto, sembra) di mettersi in fila subito dopo gli ottantenni, i sindaci premono per avere una corsia preferenziale, e c’è chi si è portato avanti col lavoro, tipo il sindaco di Corleone che si è fatto siringare e poi – beccato – ha annunciato le dimissioni, e via così.
Consci del difficile lavoro sul piano vaccinale e delle polemiche che sempre possono divampare quando si tratta di diritti (la salute) che diventano privilegi (prima io), pubblichiamo una tabella definitiva per gestire precedenze e priorità.
I possessori di Ferrari Roma V8 Turbo DCT – Ambasciatori del made in Italy e propulsori della ripresa, non è possibile che non vengano protetti dal virus il prima possibile i dinamici proprietari di questa opera d’arte contemporanea da 200.000 euro (versione base). Chiedono una corsia preferenziale, consapevoli che in caso di sommossa popolare raggiungere il confine svizzero a bordo di un missile da 600 cavalli non sarà complicato.
I vertici di Confindustria – Un accorato appello viene da Viale dell’Astronomia: come faranno gli imprenditori a guidare la riscossa industriale del Paese senza essere vaccinati prima di altri? La priorità dovrebbe andare di pari passo con l’abolizione del blocco dei licenziamenti, così anche molti lavoratori potranno stare a casa al riparo dal contagio: un gesto di generosità – come consueto – della classe imprenditoriale italiana.
I capicorrente del Pd – Non bastano i vaccini.
I croupier – Categoria trascurata dal fatto in zone arancione chiaro, arancione scuro, rosso e carminio nessuno va a giocare al Casino, i croupier reclamano la precedenza, in modo che la ripartenza delle roulette sia pronta e vivace ad emergenza finita. “E poi – dichiarano in un comunicato – siamo comunque più utili noi delle correnti del Pd”.
I proprietari di barche a vela – Impensabile che proprio mentre Luna Rossa si gioca una prestigiosa coppa, venga trascurata una categoria decisiva come i possessori di natanti dai dodici metri in su. Ferma restando la priorità per tutta la categoria, si caldeggia la precedenza per i proprietari di imbarcazioni che battono bandiera panamense, delle Bermuda o delle Isole Cayman, che non pesano – grazie, eroi – sulla macchina burocratica statale.
Le cassiere dei supermercati – Cazzi loro.
Attilio Fontana – Questo eroe della lotta alla pandemia, che ha affrontato l’emergenza a mani nude, col solo aiuto del cognato, merita senza dubbio un vaccino prima di tutti gli altri. Chiede soltanto di non prenotarlo con il sistema regionale lombardo, che lo rimanderebbe al 2089.
 Sì, capo. Certo, capo. Come no, capo. Uno dei grandi temi della politica italiana – una variante del cabaret – è quello della fedeltà, forse perché si assiste a un campionario intero di capriole, giravolte, riposizionamenti, dispiegamenti tattici. E’ la politica, bellezza, ed ogni testacoda è chiosato dai saggi con quella formuletta astuta secondo cui “solo i cretini non cambiano mai idea”. Frase interessante, che non tiene conto però di un fatto conclamato: anche i cretini possono cambiare idea (e i furbi, ovvio, che la cambiano quando serve).
Sì, capo. Certo, capo. Come no, capo. Uno dei grandi temi della politica italiana – una variante del cabaret – è quello della fedeltà, forse perché si assiste a un campionario intero di capriole, giravolte, riposizionamenti, dispiegamenti tattici. E’ la politica, bellezza, ed ogni testacoda è chiosato dai saggi con quella formuletta astuta secondo cui “solo i cretini non cambiano mai idea”. Frase interessante, che non tiene conto però di un fatto conclamato: anche i cretini possono cambiare idea (e i furbi, ovvio, che la cambiano quando serve).
Caso di scuola, le espulsioni di massa nei 5 stelle, che spingono tutti – più che giustamente – a interrogarsi sulla democrazia interna di una forza politica, sui meccanismi del dissenso, sulla possibilità di dire al capo: “Non sono d’accordo, stai sbagliando” senza essere cacciati a calci. Ma non è l’unico caso.
In questi giorni di polemiche saudite, con un senatore che si intervista da solo per dirsi “bravo”, dopo aver intervistato un feroce dittatore per dirgli “bravo”, la questione della democrazia interna dovrebbe coinvolgere anche un piccolo partito come Italia Viva. Insomma, piacerebbe a molti che qualche voce dissonante si levasse dall’interno, magari flebile, magari incerta, ma abbastanza “schiena dritta” da dissentire dal segretario. Ebbene: niente. Zero. Non una vocina, non una mano che si alzi e dica: “Ma… veramente…”.
Certo, tutti ricordano la famosa frase di Ferruccio De Bortoli in un editoriale sul Corriere (24 settembre 2014), quella su “la fedeltà che fa premio sulla preparazione”. Ma forse, e almeno sulle grandi questioni di principio (non lapidare le adultere, per dirne una; non tagliare la testa alla gente davanti a un pubblico plaudente, per dirne un’altra) ci si aspetterebbe qualcosa di più. Invece tocca sentire proprio dalla ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, che l’Arabia Saudita “Ha iniziato un primo percorso nell’allargamento dei diritti”. Cioè, non sarà il Rinascimento, ma su, dài, ci manca poco. Strabiliante.
Quanto ad altri renzianissimi, non solo non dissentono dal capo, dalle sue visite saudite e dai suoi complimenti al regime (”vi invidio il costo del lavoro”), ma lo difendono a spada tratta, con vari argomenti tra cui: siete ossessionati. Lo fanno tutti. Che male c’è. Parliamo di vaccini. Fuffa retorica, insomma, difesa d’ufficio. Eppure tra questi armigeri che corrono a difesa del capo in difficoltà, c’è anche chi non è insensibile al tema. Per esempio Ivan Scalfarotto, che nell’ottobre 2018 firmò una dura interrogazione parlamentare sul caso Kashoggi, sui diritti umani, sui bombardamenti sauditi di civili in Yemen. Scalfarotto, Paita, Giachetti: alcuni dei nomi più in vista del renzismo firmavano allora quelle parole di condanna. Luciano Nobili si spingeva fino al boicottaggio, e tuonava su twitter che non bisognava giocare una finale di Supercoppa a Riad (dicembre 2019).
Poi, due anni dopo, di colpo, silenzio. Muti, allineati e coperti. Ora verrebbe da chiedersi quando hanno cambiato idea, e se l’hanno cambiata davvero, oppure se la fedeltà, oltre che sulle competenze, fa premio anche sui certi valori (i diritti umani: ora sì, ora no, ora sì, ora no). Insomma, dato che si ironizza spesso sulle millemila correnti del Pd, o sulle consultazioni dei 5s, non è peregrino chiedersi se esista anche dentro Italia Viva una democrazia interna, o se veramente hanno tutti cambiato idea, spontaneamente, liberamente, sull’Arabia Saudita e sul suo sanguinario principe.
 La luce in fondo al tunnel, se c’è, è un lumino lontano lontano, ma come sempre nelle crisi più acute lo spirito italiano e la proverbiale arte di arrangiarsi prendono il sopravvento, e dunque ecco che nella più grande crisi dal dopoguerra spuntano nuovi lavori, occupazioni prima inesistenti che si impongono sul mercato della mano d’opera. Eccone alcuni.
La luce in fondo al tunnel, se c’è, è un lumino lontano lontano, ma come sempre nelle crisi più acute lo spirito italiano e la proverbiale arte di arrangiarsi prendono il sopravvento, e dunque ecco che nella più grande crisi dal dopoguerra spuntano nuovi lavori, occupazioni prima inesistenti che si impongono sul mercato della mano d’opera. Eccone alcuni.
Il finto rider – A leggere le cronache si direbbe una professione in grande espansione. Sono ormai decine, se non centinaia, i fattorini ricchi e felici intervistati dai giornali, con l’evidente scopo di dimostrare che i rider veri, quelli che si battono contro il cottimo, sono un po’ stronzi. C’è chi consegna pizze in Bentley, chi sventola guadagni da dirigente, e chi il dirigente l’ha fatto davvero (in un’azienda di consegne) che va in tribunale a testimoniare (da rider) che l’azienda è bella e brava, e lui campa come un re. Servono spirito d’iniziativa, qualche amico nei giornali e la faccia come il culo.
Il Bertolaso – Professione diffusa da secoli. C’è sempre, al bar, quello che lo farebbe meglio di voi, meglio di tutti, una specie di mister Wolf prosecco-munito, capace di costruire intorno a sé una piccola leggenda di efficienza e “ghe pensi mi”. E’ tutto bellissimo e edificante finché non vi viene la malaugurata idea di farglielo fare, insomma finché non ci cascate. Così, la professione è in ascesa, ma invisa alla popolazione in certe zone, tipo l’Aquila post-terremoto, o la Lombardia nel marasma sui vaccini. Non è un lavoro difficile – basta fare tanti proclami a vanvera – ed ha il vantaggio di creare altre professioni collegate, ad esempio i chiamatori di Bertolaso, cioè quelli che ci cascano.
Il mediatore di vaccini – Personaggio mascherato, sempre inquadrato di spalle, o con la voce contraffatta, o “che chiede di restare anonimo”, è la prova di due verità incontrovertibili in un colpo solo: l’emergenza sviluppa pescecani, e il mercato vince sempre, specie quello nero. Serve astuzia, diplomazia, un aplomb discreto da venditore di tappeti e, a giudicare dalle interviste rilasciate, la padronanza della lingua italiana non è richiesta. Due le caratteristiche principali: parlare per ore con la stampa riuscendo a non dire mai dove cazzo si procura i vacchini che vende al mercato nero (la prima, difficile) e convincere Zaia (la seconda, più facile).
La badante istituzionale – In questo triste momento storico, i nostri anziani rischiano l’abbandono. E nella solitudine, si sa, si prendono decisioni affrettate, o stupide, o sbagliate, o cretine, o si fanno affari con i cognati. Ecco dunque la figura della badante istituzionale, affiancata al presidente della Lombardia Attilio Fontana, Letizia Moratti, unico caso al mondo di badante più anziana del badato. Non è un lavoro per tutti: serve essere ben cementati da secoli nella classe dirigente e avere ampie conoscenze nel business della sanità privata. Ma alla fine quel che conta è saper fare meglio di Fontana, quindi se avete un gatto andrebbe bene anche lui.
Le petit Macron – Altra professione emergente, il federatore di sfigati, che si mette in testa di prendere quattro-cinque forze politiche private e farne una forza contrista tutta intera, capitanata, nel caso, da lui medesimo: il nuovo Macron. Si tratta di un secondo tentativo di piazzarsi sul mercato del lavoro, visto il precedente tentativo di fare il nuovo Blair. Lavoro dalle prospettive incerte: si consiglia di avere anche altre fonti di reddito, tipo agiografo di regimi dittatoriali.
 Il mantra distensivo e paraculo del “niente veti” che ha tenuto banco per un paio di settimane prima dell’annuncio della squadra del nuovo governo si sta pian piano sciogliendo come un ghiacciolo a ferragosto. Primo caso, lo sci e le botte da orbi sull’ordinanza che rimanda l’apertura di piste e impianti: il ministro del turismo (Lega) contro quello della Sanità, i renzisti a fare il coro, Forza Italia scontenta dei suoi ministri, il Pd indeciso e attonito, as usual. Il tutto mentre va in scena l’ordalia dei sottosegretari: duecento famigli da piazzare, l’un contro l’altro armati, in un vorticare di correnti, mulinelli, risarcimenti (il Pd e le donne), riequilibri, colpi bassi. Tutto già visto, grazie.
Il mantra distensivo e paraculo del “niente veti” che ha tenuto banco per un paio di settimane prima dell’annuncio della squadra del nuovo governo si sta pian piano sciogliendo come un ghiacciolo a ferragosto. Primo caso, lo sci e le botte da orbi sull’ordinanza che rimanda l’apertura di piste e impianti: il ministro del turismo (Lega) contro quello della Sanità, i renzisti a fare il coro, Forza Italia scontenta dei suoi ministri, il Pd indeciso e attonito, as usual. Il tutto mentre va in scena l’ordalia dei sottosegretari: duecento famigli da piazzare, l’un contro l’altro armati, in un vorticare di correnti, mulinelli, risarcimenti (il Pd e le donne), riequilibri, colpi bassi. Tutto già visto, grazie.
Di già visto, però, c’è anche un altro elemento, se possibile più divertente per noi mangiatori di popcorn che osserviamo a bordo campo: s’avanza il fantasma dell’opposizione interna. Cominciò Salvini – questo grande europeista – ai tempi del Conte Uno: si accorse che stare al calduccio nel governo era comodo, ma che fare il diavolo a quattro come il più agguerrito oppositore pagava in termini di consenso (il finto consenso dei sondaggi), e si sa come finì. Stessa cosa nel Conte Due, con protagonista Renzi: sparare sull’ambulanza pur essendo a bordo garantiva una certa visibilità (che, in mancanza di voti, è quel che brama il leader filo-saudita). In sostanza, stare tutti dentro potrebbe garantire a ognuno l’ebbrezza di stare anche un po’ fuori, tipo che alla mattina lavi i vetri del Palazzo (da dentro) e al pomeriggio li rompi a sassate (da fuori). Divertente. Aggiungete alcune scelte bislacche che certo non calmeranno le acque. Uno per tutti: Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione, dove già sedette nel 2008 insultando chiunque avesse un posto pubblico (i tornelli, i fannulloni, i lavoratori precari definiti “L’Italia peggiore”, e altre amenità). La sua riforma della PA fu un tale glorioso fallimento che oggi si avverte di nuovo il bisogno di una riforma della PA: richiamare Brunetta è come richiamare l’idraulico che già una volta ti allagò la casa.
Insomma, gli applausi scroscianti per il governo Draghi (sindrome Monti) si sono un po’ attutiti dopo la presentazione della squadra: persino gli ultras del colpo di mano speravano meglio.
Interviene a questo punto la narrazione ipergovernista secondo cui “tanto farà tutto Draghi”, e il resto è confuso dettaglio. Un po’ come se nel peggiore bar di Caracas, dove tutti si sputano e si accoltellano, ci fosse una stanzetta riservata – un privé, direbbe Briatore – dove Draghi e i suoi “tecnici” si occupano seriamente delle cose serie. Bella immagine, ma strana concezione della democrazia: i “capaci” (sempre per autodefinizione, ovvio, mica per i risultati) lavorano, e gli altri si picchiano come fabbri, cazzi loro.
Spunta dunque – spunterà – la tentazione di maggioranze variabili: chi c’è c’è, una volta si accontenterà Salvini, un’altra Zingaretti, la terza toccherà ai 5s o a Silvio Buonanima, o a qualcun altro, magari qualche boccone verrà gettato ai cespuglietti, ai renziani, o ai calenderos, o cose così. Un tentativo, nemmeno troppo nascosto, di far passare l’idea che i tecnici sono bravi ed efficienti, mentre la politica dà il suo triste spettacolo di rissosità, che al governo litigano e si tirano sonori ceffoni, mentre il capo del governo – che l’ha messo in piedi – lui si che è bravo, avercene! Bella favoletta, edificante e sontuosamente qualunquista. Che poi funzioni è tutto da vedere.
 Lasciamo da parte l’agiografia canaglia, i 768.000 compagni di scuola di Draghi già censiti dai giornali (era il più bravo), le notazioni sportive (calcio, basket, sempre insuperabile, non si hanno notizie su hockey e sci di fondo, ma arriveranno), il casale in campagna, la moglie silenziosa, il rigore morale, eccetera eccetera. Sarebbe facile farci dell’ironia, ma suonerebbe tutto già sentito, perché se c’è una stupidaggine nazionale storica è quella dell’esultanza per la scoperta geografico-politica dell’ultima spiaggia. Era “l’ultima spiaggia” Monti, era “l’ultima spiaggia Renzi”, e si è visto. Ora c’è questa nuova “ultima spiaggia”, Draghi, il che fa supporre che basta, chiuso, spiagge buone non ce n’è più, e l’alternativa è schiantarsi sugli scogli. Invidio l’abbondanza di litorali balneabili, ecco, mettiamola così.
Lasciamo da parte l’agiografia canaglia, i 768.000 compagni di scuola di Draghi già censiti dai giornali (era il più bravo), le notazioni sportive (calcio, basket, sempre insuperabile, non si hanno notizie su hockey e sci di fondo, ma arriveranno), il casale in campagna, la moglie silenziosa, il rigore morale, eccetera eccetera. Sarebbe facile farci dell’ironia, ma suonerebbe tutto già sentito, perché se c’è una stupidaggine nazionale storica è quella dell’esultanza per la scoperta geografico-politica dell’ultima spiaggia. Era “l’ultima spiaggia” Monti, era “l’ultima spiaggia Renzi”, e si è visto. Ora c’è questa nuova “ultima spiaggia”, Draghi, il che fa supporre che basta, chiuso, spiagge buone non ce n’è più, e l’alternativa è schiantarsi sugli scogli. Invidio l’abbondanza di litorali balneabili, ecco, mettiamola così.
Sistemata la questione entusiasmo, comprensibile e in qualche modo prevista, resta sospesa a mezz’aria la vecchia favola, sempre affascinante, del “governo dei migliori”. Ma per ora, non conoscendo nomi e biografie di questi migliori, si accetta che ci sia un governo del migliore – Draghi – e tutti gli altri più o meno quelli di prima, cioè i peggiori, cacciati in vari modi, sbertucciati per mesi, accusati di ogni schifezza. Avremo dunque quelli che mangiavano i bambini a Rignano insieme a quelli che rivogliono la lira, insieme a quelli che insistono per ricoprirci di soldi se stiamo sul divano a fare un cazzo, che è l’interpretazione del Reddito di Cittadinanza di quelli che non ne hanno bisogno, eccetera eccetera. E anche qui si potrebbero fare notazioni linguistiche interessanti, per esempio perché parole come “ammucchiata” o “accozzaglia”, diventino di colpo “responsabilità nazionale”. Insomma, una riforma la si è già portata a casa, quella del vocabolario, con il Mattarella-Draghi al posto del Devoto-Oli.
E’ tutto un girarci intorno, però, mentre la questione centrale resta un’altra, quella del “commissariamento della democrazia parlamentare” con tutto il contorno di commenti su una classe politica che “ha fallito”, i partiti che “sono morti”, e altre sentenze simili, per cui è ora che arrivi uno bravo e rimetta le cose a posto. Appoggiato però – Comma 22 – dalla stessa classe politica che “ha fallito” e dagli stessi partiti che “sono morti”. Mah.
Allo stesso tempo, per onestà e completezza, va detto che sì, in effetti, non è facile assolvere la politica così come la vediamo oggi. Non per nostalgia, ci mancherebbe, ma le svolte politiche appartenevano un tempo a noiose consuetudini e riti, tipo discussioni interne, votazioni, congressi (qui un po’ esagero), persino discussioni nella base (qui esagero troppo), e comunque scontri tra affinità e divergenze. Oggi – superate quelle vetuste antichità – uno va a letto sovranista amico di Orban e si sveglia europeista fan della von der Leyen, come un Gregor Samsa alla rovescia, che si corica scarafone e si sveglia persona normale.
Si ride di questa assurda metamorfosi, ma non è l’unica. C’è anche la metamorfosi di tutti quelli (tutti, quindi) che amano usare la parola “mai”, una fesseria, perché dire “mai con questo” e “mai con quello” e alla fine doverci andare a vivere per forza, non è una bella figura. Un mimetismo tattico che non incoraggia, diciamo, la rivalutazione delle forze politiche in campo (eufemismo); o meglio insegna a tutti che principi sventolati come sacri, punti fermi, valori non negoziabili, erano alla fine non troppo fermi, non troppo sacri e negoziabilissimi.
 Con i retroscena più veloci dei retroscenisti, la crisi di governo in atto, innescata dal teorico del Rinascimento Saudita, presenta aspetti interessanti in ogni campo, non escluso quello della psichiatria. Il ruolo centrale di un partito che non si è mai presentato alle elezioni, accreditato nei sondaggi del voto dei parenti stretti (non tutti, a giudicare dalle percentuali) e i cui rappresentanti sono stati eletti dal Pd (lui compreso), dimostra l’eterna validità di un assunto ormai centenario. In teatro, a chi disturbava dalla galleria, Petrolini diceva apertis verbis: “Io non ce l’ho con te ma con chi non ti butta di sotto”. Ecco, questo per dire che cedere a un ricatto è il modo migliore, praticamente sicuro, di subire il prossimo ricatto, e poi il prossimo, e poi il prossimo, eccetera eccetera. Ma veniamo al dettaglio degli avvenimenti, che si susseguono a velocità sostenuta.
Con i retroscena più veloci dei retroscenisti, la crisi di governo in atto, innescata dal teorico del Rinascimento Saudita, presenta aspetti interessanti in ogni campo, non escluso quello della psichiatria. Il ruolo centrale di un partito che non si è mai presentato alle elezioni, accreditato nei sondaggi del voto dei parenti stretti (non tutti, a giudicare dalle percentuali) e i cui rappresentanti sono stati eletti dal Pd (lui compreso), dimostra l’eterna validità di un assunto ormai centenario. In teatro, a chi disturbava dalla galleria, Petrolini diceva apertis verbis: “Io non ce l’ho con te ma con chi non ti butta di sotto”. Ecco, questo per dire che cedere a un ricatto è il modo migliore, praticamente sicuro, di subire il prossimo ricatto, e poi il prossimo, e poi il prossimo, eccetera eccetera. Ma veniamo al dettaglio degli avvenimenti, che si susseguono a velocità sostenuta.
Ore 8.15 – Renzi chiede il ministero dell’economia, quello della giustizia, trasporti e lavori pubblici; poi Inps, servizi segreti, l’abbonamento a Sky per due anni, quindici punti in più per la Fiorentina e due aeroporti a Firenze, Nord e Sud, con Nardella controllore di volo.
Ore 9.25 – “Irresponsabile chiusura dei partiti avversari”. Così Renzi commenta il titubante no alle sue richieste. In un comizio al Quirinale, ormai trasformato in Leopolda per i suoi show, aggiunge all’elenco 46.000 km quadrati in Mongolia da affidare a Rosato, la comproprietà di Cristiano Ronaldo, una Bentley decapottabile, Fiume italiana con governatore Maria Elena Boschi. Tutto naturalmente per il bene dei nostri figli, per i quali già costruì con le sue mani “mille asili in mille giorni”.
Ore 10.40 – “Sconvolto dai veti”, Matteo Renzi apre alla trattativa e concede qualcosa: i km quadrati di Mongolia per Rosato scendono a 30.000, ma è un cedimento che va bilanciato con due miniere di diamanti in Sudafrica e la reggia di Versailles in comodato d’uso per dieci anni a Teresa Bellanova, perché una che ha fatto la bracciante merita di spassarsela un po’ nel lusso, oltre alla soddisfazione di gettare qualche brioche dal balcone.
Ore 12.45 – Nuova coraggiosa proposta di Italia Viva: Scalfarotto re del Belgio.
Ore 14.50 – Le trattative proseguono a ritmo serrato. Viste le titubanze delle controparti, Renzi decide per il rilancio: il Reddito di Cittadinanza può restare in vigore, ma solo per chi ha donato qualcosa alla fondazione Open. Nell’ambito di un ridisegno della politica estera, pretende invece l’annessione di Nizza e Savoia, la Corsica, la Libia e altre nomine all’Eni, dove ha già piazzato gente che non distingue un idrocarburo da un cucciolo di koala.
Ore 16.20 – Matteo Renzi concentra la battaglia sul ministero dei Lavori Pubblici, perché le infrastrutture sono un bene inestimabile per i nostri figli e nipoti, a cui va costantemente il suo pensiero. Tra i progetti più interessanti, un’avveniristica illuminazione a led per gli ospedali e le scuole dello Yemen, in modo da permettere agli amici sauditi di bombardarle con più agio, senza sprecare preziose bombe italiane la cui fornitura è stata colpevolmente interrotta dal governo Conte.
18.15 – Inaspettato rilancio: Scalfarotto imperatore della Turingia.
20.10 – Riprendono gli incontri al Quirinale, dove Renzi si presenta con un venditore Tecnocasa e prende appunti: bisognerà abbattere dei tramezzi, rifare gli infissi e acquistare nuovi arazzi.
21.00 – Spiace ripetersi, ma tocca farlo: io non ce l’ho con te, ma con chi non ti butta di sotto.
 Bravo! Grazie! Il Nerone di Petrolini (correvano gli anni Trenta) ingrossava gli occhi a palla e fissava il pubblico col mento proteso. “Bravo! Grazie”, se lo diceva da solo, scimmiottando in modo esilarante le pose ieratiche, mascellone compreso, del Puzzone di Palazzo Venezia. Grandissimo comico, ovvio, e chissà che non sia stato lui a inventare la moda, oggi frequentatissima, di dirsi “bravo” da solo. Piccola differenza, lo faceva da un palco malmesso dell’avanspettacolo e non dai social media, come fanno certi politici di oggi, non meno divertenti né meno simpatici di Petrolini. Tipo Carlo Calenda, che sotto un suo post firmato Carlo Calenda, mette un commento twitter firmato con la faccia e il nome di Carlo Calenda che dice: “Grazie, Carlo”. Puro Petrolini.
Bravo! Grazie! Il Nerone di Petrolini (correvano gli anni Trenta) ingrossava gli occhi a palla e fissava il pubblico col mento proteso. “Bravo! Grazie”, se lo diceva da solo, scimmiottando in modo esilarante le pose ieratiche, mascellone compreso, del Puzzone di Palazzo Venezia. Grandissimo comico, ovvio, e chissà che non sia stato lui a inventare la moda, oggi frequentatissima, di dirsi “bravo” da solo. Piccola differenza, lo faceva da un palco malmesso dell’avanspettacolo e non dai social media, come fanno certi politici di oggi, non meno divertenti né meno simpatici di Petrolini. Tipo Carlo Calenda, che sotto un suo post firmato Carlo Calenda, mette un commento twitter firmato con la faccia e il nome di Carlo Calenda che dice: “Grazie, Carlo”. Puro Petrolini.
Non facciamone un caso. Come da copione, l’autocandidato sindaco di Roma incolpa il social media manager, cioè “la ragazza” che gli cura gli account. Insomma, “Grazie Carlo” doveva scriverlo qualcun altro, un Franco76 o una Giovanna 61, o altri account farlocchi deputati ai complimenti al capo, e solo un incidente di tastiera ha fatto in modo che a dire bravo al capo risultasse il capo stesso. Bravo! Grazie!
Bisognerà un giorno parlare anche di questi benedetti social media manager, la cui funzione, più che comunicare il pensiero del Principale, sembra sia fare il Malussène, il capro espiatorio, sacrificabile a ogni stupidaggine del capo. E del resto, l’inciampo mediatico di Calenda (che naturalmente ha reagito insultando i giornalisti che gli facevano notare l’assurdità) ha aperto la stura ad altri casi famosi. Il senatore Pillon che si diceva da solo “Bravo Pillon”, “Coraggio!”, “Vai avanti” e altri incoraggiamenti da Templare; oppure Marianna Madia che si diceva anche lei da sola “Brava Marianna” e via così. Decine di esempi che tirano su il morale, perché ci indicano che il grande Petrolini non è dimenticato, ma lotta e vive insieme a noi, tutti i giorni, su Twitter, Facebook, Instagram e altre reti sociali che certificano l’esistenza in vita di alcuni leader (?) moderni.
Non c’è solo l’autocomplimento, certo. C’è anche il training di gruppo, tipo corso motivazionale per il venditore dell’anno. Così ecco che, mentre infuriavano le voci di una spaccatura in Italia Viva, molti deputati e senatori renziani hanno postato la stessa foto, alla stessa ora, con più o meno lo stesso testo. Una foto di gruppo con la pattuglia parlamentare di IV sorridente e festante (anche un po’ brilla, se è consentito), a sottolineare la granitica unità del gruppo. Bene, giusto, lo spogliatoio unito attorno al mister. Ma poi, ecco l’incidente, perché il diavolo è nei dettagli. La senatrice Donatella Conzatti, giunta fino a Italia Viva dopo breve tragitto (veniva da Forza Italia), posta quella stessa foto con un volto cancellato. Mistero. Suspense. Chi sarà l’epurato dalla foto, cancellato col pennarello, tagliato via come Trotzky dai dagherrotipi con Lenin durante gli anni bui del photoshop staliniano? E’ Vito De Filippo, nel frattempo tornato nel Pd, e quindi depennato con uno scarabocchio sul volto. Instagram 2021 come Mosca 1936, si parva licet, diciamo. Niente di male, abbiamo altri problemi, com’è noto, quindi risparmio la moraletta sull’uso e abuso di propaganda che sfiora l’autogol e il ridicolo. Certo non mi spingerei fino al limite estremo “dimmi come usi i social e ti dirò chi sei”, perché ne uscirebbe un quadretto assai desolante e non c’è bisogno di ulteriore depressione. Bravo! Grazie!
 Dacci oggi il nostro veleno ideologico quotidiano, ovvero come piegare la realtà ai propri desideri e vivere felici. Chiedo scusa se dopo il solenne Giorno del Pallottoliere (ieri al Senato) mi occupo di piccole pieghe della vita reale, ma corre l’obbligo, e capirete perché. Tutto comincia la scorsa settimana, con una rubrica di Antonella Boralevi, illustre scrittrice, sull’illustre quotidiano La Stampa. Titolo: “Da commercialista a rider felice”. Storia edificante: si parla del signor Emiliano, 35 anni, che aveva uno studio di commercialista, ma “il Covid gliel’ha fatto chiudere” (sic). Lui non si è perso d’animo e ha cominciato a fare il rider, a consegnare pizze e pranzi e cene, pedalando in bicicletta per “100 km al giorno” (sic) e guadagna 2.000 euro netti al mese e in certi mesi addirittura 4.000. “Uno stipendio da manager. Ed è felice” (sic). Segue virulenta intemerata sulla dignità del lavoro, il rispetto di sé, la vergogna del Reddito di Cittadinanza elargito a due milioni e passa di persone che – manigoldi – stanno a casa a far niente, mentre potrebbero anche loro guadagnare “come un manager” consegnando pizze. Insomma una notizia, seguita dalla moraletta, la solita vecchia solfa sulla colpa dei poveri, che sono poveri e assistiti perché non muovono il culo pedalando per 100 km al dì. Troppo bello per essere vero.
Dacci oggi il nostro veleno ideologico quotidiano, ovvero come piegare la realtà ai propri desideri e vivere felici. Chiedo scusa se dopo il solenne Giorno del Pallottoliere (ieri al Senato) mi occupo di piccole pieghe della vita reale, ma corre l’obbligo, e capirete perché. Tutto comincia la scorsa settimana, con una rubrica di Antonella Boralevi, illustre scrittrice, sull’illustre quotidiano La Stampa. Titolo: “Da commercialista a rider felice”. Storia edificante: si parla del signor Emiliano, 35 anni, che aveva uno studio di commercialista, ma “il Covid gliel’ha fatto chiudere” (sic). Lui non si è perso d’animo e ha cominciato a fare il rider, a consegnare pizze e pranzi e cene, pedalando in bicicletta per “100 km al giorno” (sic) e guadagna 2.000 euro netti al mese e in certi mesi addirittura 4.000. “Uno stipendio da manager. Ed è felice” (sic). Segue virulenta intemerata sulla dignità del lavoro, il rispetto di sé, la vergogna del Reddito di Cittadinanza elargito a due milioni e passa di persone che – manigoldi – stanno a casa a far niente, mentre potrebbero anche loro guadagnare “come un manager” consegnando pizze. Insomma una notizia, seguita dalla moraletta, la solita vecchia solfa sulla colpa dei poveri, che sono poveri e assistiti perché non muovono il culo pedalando per 100 km al dì. Troppo bello per essere vero.
E infatti non è vero.
Il rider felice non si chiama Emiliano (ma Emanuele), non ha 35 anni (37), non ha mai avuto uno studio di commercialista, fa il rider dal 2018 (quindi prima del Covid), non in bicicletta (moto), non guadagna né 2.000 né 4.000 euro al mese, ma arriva a 1.600 se lavora nove ore al giorno tutti i giorni della settimana, tutte le settimane dell’anno. Ciliegina sulla torta, viene fuori che questo Emiliano/Emanuele è un grande sostenitore del cottimo, già organizzatore di un sindacato giallo messo su di concerto con qualche azienda del settore, favorevole al contratto truffa sottoscritto solo da un minuscolo sindacato di destra che tutti i rider del regno schifano e denunciano come abusivo.
Tutto benissimo: la storiella edificante che la signora Boralevi usa per insultare chi è costretto a chiedere un aiuto allo Stato è un tale concentrato di menzogne, imprecisioni e assurdità perfettamente ricamate da rasentare il falso ideologico. Qualcuno – en passant – fa notare che al regime di paghe attuale per incassare 4.000 euro netti consegnando pasti bisognerebbe correre dalle 18 alle 20 ore al giorno, sette giorni si sette, ma pazienza, basta imparare a dormire pedalando.
Naturalmente non è l’incidente giornalistico della signora Boralevi che ci preoccupa, anche se ha provocato parecchie contusioni alla realtà, alla verità e al buonsenso. La parte illuminante della storia è invece il sottotesto, antico ma mai morto: i poveri (sette milioni e passa, nel Paese) non hanno dignità né rispetto di sé, mentre il signor Emiliano/Emanuele, la cui storia (inventata) sembra alla signora Boralevi “non di ‘colore’, ma di speranza” (sic), ci dà una lezione di vita. Insomma, un esempio per tutti quegli sciagurati che stanno sul divano a far niente incassando un lauto (?) assegno mentre potrebbero fare la Milano-Sanremo carichi di pizze tutti i giorni, vivere felici, e perdipiù mostrare con il loro luminoso esempio che i poveri d’Italia, Covid o non Covid, sono gente senza dignità. Una buona dose di veleno ideologico, insomma, un po’ di sale soavemente liberista sulle ferite aperte di chi non ce la fa e chiede aiuto invece di pedalare. Che stronzi, eh?
 Non si leggeva un così intenso romanzo epistolare dai tempi de I dolori del Giovane Werther (Johann Wolfgang Goethe). Roba vecchia, démodé. Meno male che adesso tutto si ammoderna e si attualizza con il carteggio “Lettere a La Stampa” (Giorgia Meloni), scambio di missive (articolo-risposta, risposta alla risposta, risposta alla risposta alla risposta) tra la segretaria di Fratelli d’Italia e il direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini. Lui a dire che quella di Fratelli d’Italia è una destra che andrebbe un po’ ripulita, specie alla luce delle ambiguità sul tentato golpe trumpista, lei a battersi come un leone per negare. Lui a dire che la sora Meloni e il baciatore di salami Salvini giocano a fare gli “sciamani d’Italia” (come quel cretino che ha invaso il Campidoglio Usa vestito come se stesse per recarsi a Pontida), lei indignata per il paragone. Ciliegina sulla torta, un tweet della signora Meloni sui fatti di Washington, così ambiguo, ma così ambiguo, da rasentare la perfezione del paraculismo. Testuale: “Mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal presidente Trump”. Che è un po’ come dire: “Mi auguro che si spenga l’incendio nel bosco come chiesto dal piromane che l’ha appiccato”.
Non si leggeva un così intenso romanzo epistolare dai tempi de I dolori del Giovane Werther (Johann Wolfgang Goethe). Roba vecchia, démodé. Meno male che adesso tutto si ammoderna e si attualizza con il carteggio “Lettere a La Stampa” (Giorgia Meloni), scambio di missive (articolo-risposta, risposta alla risposta, risposta alla risposta alla risposta) tra la segretaria di Fratelli d’Italia e il direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini. Lui a dire che quella di Fratelli d’Italia è una destra che andrebbe un po’ ripulita, specie alla luce delle ambiguità sul tentato golpe trumpista, lei a battersi come un leone per negare. Lui a dire che la sora Meloni e il baciatore di salami Salvini giocano a fare gli “sciamani d’Italia” (come quel cretino che ha invaso il Campidoglio Usa vestito come se stesse per recarsi a Pontida), lei indignata per il paragone. Ciliegina sulla torta, un tweet della signora Meloni sui fatti di Washington, così ambiguo, ma così ambiguo, da rasentare la perfezione del paraculismo. Testuale: “Mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal presidente Trump”. Che è un po’ come dire: “Mi auguro che si spenga l’incendio nel bosco come chiesto dal piromane che l’ha appiccato”.
Un carpiato, insomma, succo concentrato di malafede. Che diventa ancor più esilarante quando si ricorda alla Meloni l’assessora umbra Clara Pastorelli, che si fa una foto agghindata come lo sciamano di Capitol Hill. Uh, che reazione: “La signora indossa un cappotto e un colbacco!”, dice la Meloni. Questa è la sua arguta difesa, come ammettere che l’assessora umbra non è riuscita a procurarsi un cappello con le corna e si è adattata, problemi di trovarobato, insomma.
Il carteggio, va detto, è sui fatti americani e alla fin fine si incentra su questa domanda: è possibile che un partito che mira a governare il Paese continui a schierarsi con un (ex, tra poco) presidente americano che incita all’insurrezione, appoggia le milizie filonaziste, blandisce e corteggia certe sette di squinternati pericolosi tipo Qanon, sostiene gente che indossa magliette che inneggiano all’Olocausto? Quesito interessante.
Ma si tratta solo di un pezzettino della questione, perché anche in Italiai dubbi su Fratelli d’Italia sono numerosi. Proprio nei giorni del carteggio, per dirne una, un’altra assessora di FdI (Regione Veneto, assessore all’istruzione, andiamo bene, Ndr), Elena Donezzan, intona Faccetta nera ai microfoni della radio di Confindustria, in un programma dove (sentito con queste orecchie) il conduttore riceve telefonate dalle ascoltatrici per capire chi offre di più per fargli un pompino (giuro). Il caso Donezzan si aggiunge ad altre decine, forse centinaia. C’è quello vestito da nazista, quello con la foto del duce, il consigliere comunale che fa il saluto romano, l’attuale “governatore” delle Marche che va a cene celebrative della marcia su Roma, col Puzzone stampato sul menu. La difesa è sempre stata ridicola: si va da “Ragazzate” a “Una mela marcia”, a “Strumentalizzazioni”. Insomma, si minimizza la prevalenza della nostalgia fascista all’interno di un partito che – ricordiamolo a Crosetto e alla sora Meloni – ha nel simbolo la fiamma del Msi, oltre a detenere il poco invidiabile record di arrestati per ‘Ndrangheta. Ora aspettiamo altre lettere, missive, carteggi e corrispondenze per negare, minimizzare, parlare d’altro o buttare la palla in tribuna. Insomma, nuovi capitoli de I dolori della giovane Giorgia, romanzo epistolare. Un po’ noioso, a dirla tutta.
Per la serie “consigli non richiesti”, ecco la recensione dei Racconti sentimentali e satirici che Michail Zoščenko ha scritto e pubblicato in patria tra il ’22 e il ’37, prima che Stalin e il suo cane da guardia Zdanov si accorgessero di lui. Si ride un bel po’. Recensione comparsa su TuttoLibri de La Stampa il 9 gennaio
 “Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”. Bello, eh? Piero Calamandrei, un padre della Patria. Giusto. Bravo. Ma quando? Si era detto, per le superiori, per esempio, il 7 gennaio, con densità del cinquanta per cento, a rotazione. Poi alcune regioni… Poi qualche partito… Poi di nuovo le regioni… Insomma facciamo l’11, o forse dopo, vediamo. Che poi dipende pure da dove abiti, quale tattica di sopravvivenza ha scelto il presidente della tua regione usando chiusure e aperture come pedine dei suoi scacchi, dagli equilibri romani di qualche palazzo o palazzetto, o segreteria, da qualche corrente, eccetera eccetera. Insomma, ‘sto fatto dei sudditi e dei cittadini sì, è bello, ma magari lo rinviamo un po’, perché qui non funzionano gli autobus.
“Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere”. Bello, eh? Piero Calamandrei, un padre della Patria. Giusto. Bravo. Ma quando? Si era detto, per le superiori, per esempio, il 7 gennaio, con densità del cinquanta per cento, a rotazione. Poi alcune regioni… Poi qualche partito… Poi di nuovo le regioni… Insomma facciamo l’11, o forse dopo, vediamo. Che poi dipende pure da dove abiti, quale tattica di sopravvivenza ha scelto il presidente della tua regione usando chiusure e aperture come pedine dei suoi scacchi, dagli equilibri romani di qualche palazzo o palazzetto, o segreteria, da qualche corrente, eccetera eccetera. Insomma, ‘sto fatto dei sudditi e dei cittadini sì, è bello, ma magari lo rinviamo un po’, perché qui non funzionano gli autobus.
Pare infatti accertato che il problema non sia la scuola, nel senso delle lezioni in presenza (bassa percentuale di contagi, secondo l’Iss), ma il modo di portarci studenti e insegnanti che affollano – maledetti – i mezzi pubblici. E’ un problema ben noto, almeno dal primo lockdown, che rimane intatto, intonso, irrisolto. Eh, che ci vuoi fare, il problema sono i mezzi pubblici. Dieci mesi dopo: Eh, che ci vuoi fare, il problema sono i mezzi pubblici. Cioè ministri, “governatori”, sindaci della settima potenza mondiale (?) in dieci mesi non sono riusciti ad architettare un modo serio e sicuro per portare la gente a scuola. Mi appello alla clemenza della Corte.
Ma poi, al di là delle tattiche e delle strategie, delle aperture annunciate e rinviate, del gioco a rimpiattino tra potere centrale e potere locale, la cosa che emerge è un pensiero di fondo, sotterraneo e, se così si può dire, trasversale, inconfessato ed evidente, un retropensiero tenace: lo studente non produce reddito, non aiuta il sacro Pil, quindi nella scala delle priorità finisce ultimo. Il divario tra narrazione e realtà è, in questo caso, clamoroso, una voragine. Da un lato il coro unanime “ragazzi studiate!”, e quando protestano o fanno un corteo “Non hanno voglia di studiare!”. E poi, nei fatti, eccoli chiusi dietro collegamenti precari, con mezzi tecnici spesso inaffidabili, quando ce li hanno, nuovo (ma prevedibilissimo) discrimine di classe che si condensa nel gap tecnologico immenso tra ricchi e poveri. Ma anche di più: sospesi in un limbo di invisibilità, circonfusi da un’aura di sospetto e di colpa imminente: “Vuoi far morire il nonno solo per seguire una lezione? Che egoismo!”.
Non si può dire quali effetti avrà questa sospensione della vita sociale e culturale di qualche generazione: per valutare le ricadute psicologiche ci vorrà tempo. Qualche conteggio più tecnico, invece si potrà fare presto, perché il calcolo della dispersione scolastica è abbastanza semplice di anno in anno. L’Italia sta messa bene, grazie, ai primi posti in Europa, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha mollato prima del diploma è del 13,5 per cento (Eurostat, 2019), e aumenterà senza dubbio. Significa decine di migliaia di italiani ogni anno destinati a lavori a bassa specializzazione, spediti ad affollare i piani bassi del mercato del lavoro, culturalmente deboli, insomma, una massa di manovra piuttosto utile. Quando saranno non più studenti, ma garzoni, precari di ogni tipo, lavoratori interinali, a intermittenza o a chiamata, allora potranno affollare i mezzi pubblici senza problemi e senza clamori per andare a lavorare. Ditelo a Calamandrei, bella quella cosa dei cittadini e dei sudditi, ma non è il momento, eh!
 Lo dico subito: anch’io voglio dare l’esempio, come il Re della Campania (basta chiamarli “governatori”!) Vincenzo De Luca. Tendere virilmente l’avambraccio a favore di ago, guardare dritto in camera e dire: “Fate come me, vaccinatevi!”. Va bene, accetto anche il “chi ti credi di essere”, giusto, ma vi assicuro che per i miei condomini, il barista, la signora della lavanderia e il panettiere, sarei un buon esempio da seguire: “Presto, vacciniamoci tutti come ha fatto quello del secondo piano!”. Forse sopravvaluto la mia popolarità nel quartiere, d’accordo, e visto che si parla dell’alta missione di dare l’esempio, cambierò esempio.
Lo dico subito: anch’io voglio dare l’esempio, come il Re della Campania (basta chiamarli “governatori”!) Vincenzo De Luca. Tendere virilmente l’avambraccio a favore di ago, guardare dritto in camera e dire: “Fate come me, vaccinatevi!”. Va bene, accetto anche il “chi ti credi di essere”, giusto, ma vi assicuro che per i miei condomini, il barista, la signora della lavanderia e il panettiere, sarei un buon esempio da seguire: “Presto, vacciniamoci tutti come ha fatto quello del secondo piano!”. Forse sopravvaluto la mia popolarità nel quartiere, d’accordo, e visto che si parla dell’alta missione di dare l’esempio, cambierò esempio.
Elvis Presley, Marylin Monroe e altri eroi del Novecento si fecero vaccinare in diretta, proprio per dare un esempio. E uno può capire un giovanotto degli anni ’50 che dice: “Faccio come Elvis!”, che è un po’ diverso dal guaglione napoletano che esulta: “Faccio come De Luca”. Insomma, la faccenda ci porta dritti alla questione del “testimonial” che si pone ogni giorno in ogni agenzia pubblicitaria in cui si decida di associare un prodotto a un volto: e se poi sta sulle balle a tutti? Ecco, De Luca a parte, visto il tasso di popolarità della classe politica nel suo complesso, la cosa potrebbe risultare rischiosa, consiglierei di scegliere altri testimonial (che so, gli astronauti, i tapparellisti, i centrocampisti del Crotone), che abbiano almeno qualche minima considerazione in più presso la popolazione.
Eppure, chiunque dia l’esempio, c’è qualcosa che stride. Cioè: si dà l’esempio per invitare chi non ha il coraggio, per stimolare gli scettici, per indicare una strada. E qui arriviamo al punto: non sarà un po’ (molto) sopravvalutata questa mirabolante falange No Vax che si sbandiera tanto? Da quel che si legge in giro abbiamo una componente cyber-dadaista (la siringa che ti inietta il chip, che ti controlla direttamente da Pechino coi soldi di Soros, il 5G, eccetera, insomma stregoneria hi-tech); poi una componente scettico-dietrologica (è tutto un trucco per arricchire le case farmaceutiche, con varianti geopolitiche a piacere); e infine una parte di comprensibile prudenza, che si sistemerà con i tempi (cioè, appena si capirà che i primi mille vaccinati non si trasformano in meduse e non muoiono sul colpo). Una percentuale minima della popolazione, insomma, mentre la stragrandissima maggioranza, pur di levarsi dalle palle gel, mascherine, lockdown, limitazioni, solitudini e isolamenti, tenderà volentieri l’avambraccio senza bisogno di tanti esempi (e in ogni caso dovrà aspettare mesi, data la sacrosanta scaletta delle priorità).
Visto da questa angolazione, il gesto di generosità di De Luca e di tutti gli aspiranti “esempi vaccinali viventi” suona un po’ come: “Fermi tutti! Mi sacrifico! Do l’esempio! Mangio io la prima fetta di torta al cioccolato!” (grazie al cazzo, ndr). Insomma, può venire il dubbio che questo cortocircuito tra nemici così residuali da sembrare immaginari, i No Vax, e l’esercito dei “datori di esempio” sia un po’ sospetto, che dia molta visibilità ai primi (che contano come il due di coppe) e procuri facile popolarità ai secondi. Mentre un esempio di buon esempio (chiedo scusa) per tutta la popolazione sarebbe che so, il ragionier Gino che una mattina prima di andare in ufficio passa alla sua Asl dopo regolare prenotazione, fa la sua puntura, ci mette un’oretta, come se fosse una cosa assolutamente normale, veloce, dignitosa, facile, gratuita e civile che protegge lui e gli altri. Fine dell’esempio.
 Che sono tempi bui lo abbiamo già detto, vero? Che non sarà il solito Natale lo abbiamo letto da qualche parte, giusto? Bene, metà del lavoro è fatto. Ora passiamo a trattare l’argomento “Feste-in-pochi-e-in-zona-rossa”, con piccoli accorgimenti e trucchi per passare in armonia i giorni più santi dell’anno, quelli in cui si celebra la gloria del bambinello. No, non quello là che pensate voi, un altro bambinello, quello di Rignano.
Che sono tempi bui lo abbiamo già detto, vero? Che non sarà il solito Natale lo abbiamo letto da qualche parte, giusto? Bene, metà del lavoro è fatto. Ora passiamo a trattare l’argomento “Feste-in-pochi-e-in-zona-rossa”, con piccoli accorgimenti e trucchi per passare in armonia i giorni più santi dell’anno, quelli in cui si celebra la gloria del bambinello. No, non quello là che pensate voi, un altro bambinello, quello di Rignano.
Le settimane della vigilia sono state agitate e ricche di discussioni. Si faceva l’albero, e lui minacciava di fare il presepe, in subordine, ok, fare l’albero ma che non sembri un cedimento! Vuole scegliere le luci, poi appendere almeno una pallina ma non si può mettere il puntale finché non c’è la Bellanova. Alla fine, dopo estenuanti tira e molla, si è fatto l’albero, lui ha messo una pallina gialla sul terzo ramo dal basso e ha rilasciato gioiose dichiarazioni in cui “Senza di me sarebbe stato un Natale senz’albero!”.
Questo il pregresso. Ma veniamo al magico giorno della festa.
Il gioco dell’oco. Non c’è gusto a fare la tombola in quattro o cinque, e anche il Mercante in Fiera perde molto del suo fascino senza il nonno rincoglionito a cui bisogna dire le cose tre volte. Quindi, un consiglio: il gioco dell’oco. Funziona sempre. Tabellone, dadi, sapienti tattiche e qualche variante nelle regole: un giocatore parte con due punti e mezzo, tira i dadi, spariglia, minaccia, piange, supera, arretra, arringa le folle, rilascia sette interviste al giorno sulle sue impareggiabili strategie, e alla fine resta… con due punti e mezzo. Non è successo niente, ma ci siamo divertiti. Lui un po’ meno, ma dice che ha vinto. Tutti allegri.
Il panettone. Altro snodo cruciale del Natale, la cerimonia del panettone. Ma attenzione, c’è un commensale deciso a sollevare qualche problema. Non vuole i canditi, come ha dichiarato al Corrieredue settimane fa. Non vuole l’uvetta come ha rivelato in un retroscena già all’inizio del mese. Contesta che il panettone sia tagliato a fette triangolari. Valuta nuove maggioranze tra i commensali per aprire il pandoro, ripetendo che non fa tutto questo casino per avere una fetta di panettone in più. Ma poi, a pensarci, chi metterebbe lo zucchero a velo sul pandoro? Vuole che la stesura sia collegiale. Allora torna al panettone, vuole tagliarlo lui, in subordine far aprire lo spumante a Rosato. Qualche consiglio agli altri commensali: è Natale, non litigate, dategli una fettina più grossa e vedrete che si placa. Di spumante, bevetene parecchio, ne avrete bisogno.
I regali. Ci avviciniamo al dramma. L’apertura di pacchi e pacchettini è un momento che rivela molto della natura umana, da come si esprimono gioia e sorpresa, a come si mascherano le delusioni. Le famiglie più sagge sanno che azzeccare il regalo per il ragazzo difficile è fondamentale, e qui potete sbizzarrirvi, giocare sui bei tempi andati (un bel modellino di aereo presidenziale), o puntare sulle sue abilità alla Playstation, con nuovi games fantasy, tipo “Rottamator”, un eroe sparatutto che finisce a spararsi in un piede. Un consiglio per farlo felice: il modellino Lego della Farnesina da montare, che ci tiene tanto. Per i carrarmatini del Risiko bisogna aspettare che si liberi un posto alla Nato, portate pazienza.
Nel frattempo si è fatta sera, siamo un po’ storditi e stanchi. Ci meritiamo un po’ di relax, magari la tivù, un telegiornale. Dove compare un tizio che dice che è stato un Natale bellissimo. Per merito suo. Dovremmo ringraziarlo.
 Piccola doverosa premessa: non ho nulla – ma proprio nulla – contro le primule, tutte le oltre cinquecento specie di piante primulacee che rallegrano i prati nelle nostre primavere. E non ho nulla – anzi – nemmeno contro l’architetto Stefano Boeri che con tanto entusiasmo ci ha spiegato il perché e il percome della scelta di questo allegro fiorellino, con riferimenti colti (il Verrocchio, Pasolini, Sergio Endrigo perché “ci vuole un fiore”). Eppure questa bella edificante operazione di comunicazione & vaccinazione che prevede la collocazione di 1.500 padiglioni montabili nelle nostre piazze, risveglia certi anticorpi italiani allenati da anni e anni di soldi buttati, bellurie inutili, tentativi di rendere glam una necessità, e addirittura di farsi fighi – smart, fashion, friendly – per uscire dall’emergenza con una piroetta elegante, à l’italienne.
Piccola doverosa premessa: non ho nulla – ma proprio nulla – contro le primule, tutte le oltre cinquecento specie di piante primulacee che rallegrano i prati nelle nostre primavere. E non ho nulla – anzi – nemmeno contro l’architetto Stefano Boeri che con tanto entusiasmo ci ha spiegato il perché e il percome della scelta di questo allegro fiorellino, con riferimenti colti (il Verrocchio, Pasolini, Sergio Endrigo perché “ci vuole un fiore”). Eppure questa bella edificante operazione di comunicazione & vaccinazione che prevede la collocazione di 1.500 padiglioni montabili nelle nostre piazze, risveglia certi anticorpi italiani allenati da anni e anni di soldi buttati, bellurie inutili, tentativi di rendere glam una necessità, e addirittura di farsi fighi – smart, fashion, friendly – per uscire dall’emergenza con una piroetta elegante, à l’italienne.
Lanciata dal commissario Arcuri, abbracciata con entusiasmo da Boeri, plaudita di qui e di là, l’idea è circolata bene, anche senza allegati: tempi e costi non si conoscono. L’architetto Boeri ha lavorato pro-bono, molti altri lo faranno, ma insomma: materiali, impianti elettrici, legni, viti, impianti di energia solare qualcosa costeranno.
Tenterò dunque di mettere a tacere i miei anticorpi italiani, quelli che mi ricordano il pupazzo Ciao dei mondiali del ’90, notti magiche, quando buttavamo i soldi dalla finestra in opere inutili (e alcune mai finite). Oppure – feticismo per lombardi – i 23 milioni spesi in tablet da Roberto Maroni per votare elettronicamente a un referendum-fuffa sull’autonomia lombarda. “Dopo serviranno alle scuole”, si disse. E le scuole si accorsero di avere in mano migliaia di fermacarte di due chili totalmente inutili. Ecco, diciamo che terrò a bada le mie madeleine ultraitaliane. Epperò…
Siccome vivo qui e non in una foresta del Borneo, capisco perfettamente l’esigenza di una grande campagna di informazione, sprone alla vaccinazione di massa, persino entusiasmo nello sforzo collettivo. Per cui immaginavo cinema vuoti, teatri, caserme, palazzetti dello sport, comandi dei vigili, oltre naturalmente alle asl, ospedali, studi medici, trasformati in posti per vaccinare la gente. E se apri un ambulatorio in un quartiere e poi lo lasci aperto dopo il Covid, pubblico, gratuito come articolo 32 della Costituzione comanda, non è che qualcuno si offende. E magari obbligare una clinica privata a destinare qualche spazio al pubblico per iniettare vaccini costa meno di un padiglione primulato.
Ma non è nemmeno questo – l’ottimizzazione delle risorse pubbliche – che stride, che irrita. C’è qualcosa di più profondo, che potremmo chiamare “sindrome da Expo” e che i milanesi conoscono bene. E’ quella vernicetta luccicante che si usa mettere per coprire le magagne. Bella e glamour, molto moderna e apprezzata: “Ne ha scritto il New York Times!” (me’ cojoni, ndr), che somiglia molto alla costruzione a tavolino, dall’alto, di un entusiasmo collettivo, e non riesce quasi mai. E’ come comprare l’astuccio in velluto prima dell’anello, o pensare al portachiavi prima di comprare la macchina. Trattasi, insomma, di propaganda, almeno finché non saremo sicuri che si troveranno i 3.000 medici e i 12.000 infermieri per far funzionale gli avveniristici padiglioni. E soprattutto che ci saranno tutti i vaccini da iniettare alla popolazione. Fino ad allora – fino alle garrule file attorno alle primule – la faccenda sa di bella confezione, gradevole fiocchetto, presentazione elegante. Il regalo, invece, chissà. Auguri.
 Camminare su una corda tesa tra due montagne, sfidare il vento tenendo l’equilibrio, bilanciare i pesi, avanzare a piccoli passi prudenti. E poi, quando meno te lo aspetti, estrarre una pistola e spararsi in un piede. Ecco, in sintesi, la questione politica che va in scena oggi, a cura degli antigovernativi che stanno al governo, mentre le opposizioni un po’ ci sperano e non credono ai loro occhi per l’occasione.
Camminare su una corda tesa tra due montagne, sfidare il vento tenendo l’equilibrio, bilanciare i pesi, avanzare a piccoli passi prudenti. E poi, quando meno te lo aspetti, estrarre una pistola e spararsi in un piede. Ecco, in sintesi, la questione politica che va in scena oggi, a cura degli antigovernativi che stanno al governo, mentre le opposizioni un po’ ci sperano e non credono ai loro occhi per l’occasione.
Non succederà, dicono gli esperti. Prevarrà il buonsenso. Arriverà qualche adepto della setta di Silvio a dare una mano, oppure Renzi dimostrerà ancora una volta di essere solo chiacchiere e distintivo, oppure i 5 stelle affetti da masochismo compulsivo si ridurranno di numero… Insomma, i bookmaker ci credono poco, ma tra gli scenari possibili c’è anche quello “fine di mondo”: una bella campagna elettorale in piena pandemia, la povertà che avanza, i licenziamenti che ripartono in tromba, i nervi a brandelli e 209 miliardi sul tavolo che fanno gola a molti.
Scenario interessante, e dopo entrano i clown.
Certo, è umano preferire il certo all’incerto. E vuoi mettere la rassicurante ripetitività immutabile di qualche mese di liti parossistiche, affermazioni assurde, campagne debilitanti, slogan, simboli, stracci che volano? Cose a cui siamo abituati, che hanno il caro sapore di casa. Uno, poverino, che dovrebbe tornare a baciare salami, agitare rosari e consumarsi il pollice a furia di selfie; l’altra che si sbraccerebbe come da un banco del pesce con il suo repertorio di patria e famiglia, attenta a nascondere i suoi arrestati per ‘Ndrangheta e altre faccenduole, oltre ai soliti camerati “boia-chi-molla” che spuntano come funghi ad ogni appuntamento elettorale. Poi ci sarebbe la compagine del cosiddetto centro-sinistra, con il Pd eternamente in mezzo al guado, un po’ lib, un po’ lab e un po’ vattelapesca; i 5 stelle che si menano come fabbri tra governisti e movimentisti in perenne odore di scissione; los renzistas (anche quelli “in sonno” nel Pd) che cercano di capire cosa gli convenga, ammesso che superino la soglia e riescano a entrare nel gioco. Aggiungete le varianti del caso, le tifoserie schierate, le giravolte estreme che già sappiamo – “Chiudere tutto!”, no, “Aprire tutto!”, a seconda dei sondaggi del giorno – il profluvio di puttanate sui social, ed ecco un quadretto del deplorevole spettacolo di arte varia che ci aspetterebbe. Unica consolazione: le care vecchie risse tra capataz dei partiti sostituirebbero temporaneamente gli incontri di wrestling tra virologi, un piccolo sollievo. Meglio, finché si può, non pensarci, e la speranza è che il voto di oggi allontani uno scenario tanto grottesco.
Solo una nota in margine. E’ prassi in questi casi dire che “la gente non capirebbe”, altro rassicurante topos delle fibrillazioni pre-crisi, frase sempre buona alla bisogna. Ma questa volta non è vero: la gente capirebbe, e forse ha già capito benissimo, che i mal di pancia forti arrivano insieme ai soldi, tanti soldi, abbastanza soldi da cambiare un Paese. E che sulla gestione di quei soldi si ridisegna non solo l’Italia (cioè, speriamo) ma anche il futuro degli equilibri politici e dei pesi che attualmente li garantiscono. I veti incrociati, i piccoli partitini del due per cento sempre più simili a lobby personali, gli aghi della bilancia, le furbizie da prima, seconda, terza Repubblica, verranno messe alla prova nel voto di oggi, e si potranno vedere in filigrana tutti i 209 miliardi di motivi per cui c’è chi sega il ramo su cui sta seduto.
 E’ già sparito dai giornali – puff – il dibattito sulla patrimoniale, considerato una specie di attentato al ceto medio, pur colpendo le ricchezze superiori a mezzo milione (lo 0,2 per cento, cioè mille euro fino al milione di ricchezza netta). Bon, basta, finito, pussa via. La proposta ha tenuto banco appena un paio di giorni, accolta dal solito scandalo su: a) il comunismo che arriva; b) lo Stato espropriatore; c) dove andremo a finire, signora mia.
E’ già sparito dai giornali – puff – il dibattito sulla patrimoniale, considerato una specie di attentato al ceto medio, pur colpendo le ricchezze superiori a mezzo milione (lo 0,2 per cento, cioè mille euro fino al milione di ricchezza netta). Bon, basta, finito, pussa via. La proposta ha tenuto banco appena un paio di giorni, accolta dal solito scandalo su: a) il comunismo che arriva; b) lo Stato espropriatore; c) dove andremo a finire, signora mia.
In sostanza, in un paese dove la povertà galoppa e dove qualcuno propone di trattenere dei soldi agli statali a milleduecento euro al mese perché “sono privilegiati col posto fisso”, ci sono crisi di asfissia e svenimenti perché si oserebbe chiedere mille euro a chi sta (molto) meglio.
Va detta subito una cosa: la patrimoniale italiana contiene una sua contraddizione interna, cioè a contribuire sarebbero quelli che già pagano regolarmente le tasse, quelli che il fisco conosce bene, mentre ne resterebbero esclusi, come sempre, i nullatenenti con la Porsche, gli evasori professionisti, gli occultatori di capitali. E qui ci aggredisce un ricordo antico, una vera madeleine di cui ricorre in questi giorni l’anniversario. Correva il 4 dicembre 2011 (preistoria, eh?) e Mario Monti teneva una tesa conferenza stampa di insediamento, durante la quale illustrava il suo programma lacrime e sangue. A un certo punto la questione che non ti aspetti: “Come farete per tassare i grandi capitali?”. Opporca miseria, che domande. Monti rispose con le sue circonvoluzioni che tenteremo di tradurre: “Non è possibile, oggi, prendere in considerazione, nel concetto di patrimonio da un punto di vista conoscitivo delle posizioni individuali…”. Traduzione: ad oggi non sappiamo come individuarli, ‘sti grandi capitali, mannaggia. Poi continuava: “Avremmo potuto dire: dichiariamo che mettiamo da subito all’opera dei meccanismi conoscitivi nuovi che ci consentiranno tra due anni di avere un’imposta come quella francese sulle grandi fortune”. Traduzione: abbiamo pensato di avviare un’indagine per sapere chi sono – nome e cognome – questi detentori di grandi patrimoni e forse tra due anni lo sapremmo. Bello. Ma poi: “Cosa avremmo ottenuto in questa situazione di grave emergenza? Forse tra due anni ci sarebbe stato un po’ di gettito, ma oggi ci sarebbe stata un po’ di fuga”. Traduco di nuovo: potremmo cercarli, ‘sti ricchi che non pagano, ma quelli scapperebbero.
Punto. Fine della madeleine.
Sono passati nove anni e ancora siamo qui con il problema di non conoscere, o conoscere pochino, i detentori delle grandi fortune nazionali, che sì, bisognerebbe tassare, ma quelli scappano, che disdetta, eh! Uno si immagina una task force determinata e decisa tipo l’Fbi in Mississippi Burning (magari con Gene Hackman, perché no?), pancia a terra a cercare i grandi patrimoni italiani, e invece niente. Non si fece nel 2011 – sennò scappavano – e non si fece dopo, e anzi negli anni che seguirono fu tutta una gara a farsi le residenze fiscali all’estero. Dunque, a posto così, se ci sarà una piccola patrimoniale (dubito) sui ricchi veri la pagheranno – mugugnando – i ricchi già noti, e gli altri… salvi come al solito, allineati e coperti: non sappiamo chi sono, come da tradizione nazionale. Stop, fine del dibattito, si parli d’altro, please. I posti a tavola a Natale, i vecchi in autoreclusione nella cameretta dei nipoti con panettone allo Xanax passato sotto la porta, le piste da sci, il cenone. Ricchi? Ma che ricchi, su, non fatevi idee balzane.
 Mi piacciono moltissimo gli appelli alla compattezza e all’unità del Paese, che dovrebbe attutire i colpi della crisi da virus. Ne prendo appunto ogni volta su un taccuino, sottolineando qui e là, specie quando il monito viene dai piani più nobili della Repubblica. Disse Mattarella il 2 giugno: “C’è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l’unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro”. Bellissime parole, sottoscritte all’unanimità da tutti – ma proprio tutti – i commentatori.
Mi piacciono moltissimo gli appelli alla compattezza e all’unità del Paese, che dovrebbe attutire i colpi della crisi da virus. Ne prendo appunto ogni volta su un taccuino, sottolineando qui e là, specie quando il monito viene dai piani più nobili della Repubblica. Disse Mattarella il 2 giugno: “C’è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l’unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro”. Bellissime parole, sottoscritte all’unanimità da tutti – ma proprio tutti – i commentatori.
Passati quasi sei mesi, col Natale alle porte, il dibattito sull’apertura delle piste da sci che surclassa quello sulla riapertura delle scuole (che non vendono skipass, non fatturano in polenta e stanze d’albergo, quindi chissenefrega), sarebbe forse il momento di fare il punto sulla “condivisione dell’unico destino”. E così ci vengono in aiuto due ricerche, da cui grondano numeri e dati. Una è quella del Censis, che si può riassumere con pochi punti fissi: 7,6 milioni di famiglie il cui tenore di vita è seriamente peggiorato causa pandemia, 600 mila persone entrate in quel cono d’ombra che sta sotto la soglia di povertà, 9 milioni di persone che hanno dovuto chiedere aiuto (a famigliari e/o banche). L’altra ricerca viene da PwC e Ubs (le banche svizzere), e ci dice che i miliardari (in dollari) italiani erano 36 l’anno scorso, e che quest’anno sono 40, hurrà. La loro ricchezza complessiva ammontava nel 2019 a 125,6 miliardi di dollari e poi, in quattro mesi (dall’aprile al luglio 2020) è balzata a 165 miliardi di dollari, con un incremento del 31 per cento e oltre quaranta miliardi di dollari in più. In euro, al cambio attuale, fa 33,7 miliardi. E siccome i numeri sono beffardi e cinici, ecco che il totale fa più o meno quanto si è tagliato alla Sanità pubblica in dieci anni, che è poi la stessa cifra che arriverebbe indebitandosi con il Mes (circa 36 miliardi).
Non serve sovrapporre le due ricerche per capire che i vasi comunicanti della distribuzione della ricchezza non comunicano per niente, e alla luce di questi numeri le belle parole di Mattarella strappano un sorriso.
Vengono in mente, chissà perché, le continue metafore e similitudini con cui si paragona l’attuale crisi pandemica a una guerra: le trincee degli ospedali, gli eroi sul campo (medici e infermieri), i sacrifici della popolazione, l’incertezza su mosse e contromosse, la seconda terribile offensiva del nemico. E si dimentica volentieri, in questa continua, sbandierata analogia tra Covid e conflitto armato, che chi si arricchisce durante una guerra è più “pescecane” che “dinamico imprenditore”. Però – sorpresona! – di colpo, davanti alle cifre dell’impennata dei super ricchi italiani, la metafora del “Covid come la guerra”, solitamente molto gettonata, si scolora, si attenua, sparisce del tutto. Sarà una guerra, d’accordo, ma quelli che pagano sono i 600 mila scaraventati nella loro nuova condizione di molto-poveri, o oltre sette milioni di famiglie che stringono la cinghia e i denti. Pagano i tanti soldati, insomma, mentre i pochi generali festeggiano le loro rimpolpate ricchezze. Forse con i 34 miliardi piovuti in tasca ai 40 miliardari italiani si potrebbero attenuare problemi e sofferenze di qualche milione di persone. Come “condivisione di un unico destino” non sarebbe male, anzi, sarebbe un’ottima “unità morale” che, ovviamente, non vedremo.
 Ogni tanto fa bene rileggere i classici, ripercorrere testi antichi, ritrovare righe dense e dimenticate, tipo queste: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. (Autori Vari, Costituzione della Repubblica Italiana, 1947). Magari, rileggendo quella antica letteratura di fantascienza comodi comodi sul divano, si può attendere la pattuglia volante del San Raffaele di Milano, visita, radiografia, esami del sangue e saturazione: appena 450 euro, un affarone. Prima però, una visita online, al telefono o su Skype per i più aggiornati tecnologicamente: 90 euro. Questo per dirvi se avete il Covid. Per curarlo, poi parliamone (Questa casa è sua? Ha miniere in Messico? Soldi da parte?).
Ogni tanto fa bene rileggere i classici, ripercorrere testi antichi, ritrovare righe dense e dimenticate, tipo queste: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. (Autori Vari, Costituzione della Repubblica Italiana, 1947). Magari, rileggendo quella antica letteratura di fantascienza comodi comodi sul divano, si può attendere la pattuglia volante del San Raffaele di Milano, visita, radiografia, esami del sangue e saturazione: appena 450 euro, un affarone. Prima però, una visita online, al telefono o su Skype per i più aggiornati tecnologicamente: 90 euro. Questo per dirvi se avete il Covid. Per curarlo, poi parliamone (Questa casa è sua? Ha miniere in Messico? Soldi da parte?).
Segue polemica, ovviamente (non ci viene risparmiato nulla), perché è seccante che la pandemia diventi un business, ma soprattutto è seccante (eufemismo) constatare la differenza tra il trattamento che riceve chi sborsa oltre 500 euro e chi invece imbocca il tunnel burocratico-sanitario di telefonate al medico, indicazioni sommarie (tachipirina, non cortisone!), attese snervanti, code per i tamponi, autoreclusioni per attendere l’esito.
Il risultato è che in una situazione delicata e pericolosa per tutti, la forbice delle diseguaglianze si allarga ancora. Come sempre la Lombardia fa scuola, il San Raffaele resta epicentro della cosmogonia formigoniana, il professor Zangrillo, che lì opera, invita a non affollare i pronto soccorso e curarsi a casa. Insomma, è l’oste che consiglia il vino.
Contemporaneamente, chi volesse, nella ridente città di Milano, procurarsi una dose di vaccino antinfluenzale, farà parecchia fatica rimbalzando come una pallina da flipper tra medico di base (Eh? Uh? Cosa?) e Ast, sportelli e code, anche avendone diritto in quanto categoria a rischio. Con una telefonata e 123 euro, invece, ecco la visita privata con vaccino incluso: tempi di attesa per l’appuntamento, cinque giorni. C’è anche la tariffa “smart”, solo 70 euro, ma i giorni di attesa diventano 15. Tempo (vostro), in cambio di soldi (sempre vostri). Finirà con una rivoluzione nell’empireo costoso degli status symbol: non più l’orologio, il telefono, la macchina, la casa al mare, ma il tampone in tempo reale, il vaccino sicuro, la visita domiciliare di un medico, addirittura di un’équipe, meglio di ostriche e champagne.
Ora, scandalizzarsi per tutto questo pare un po’ ingenuo: come durante il proibizionismo, il whisky si trova lo stesso, solo un po’ più caro. E del resto tra la medicina sul territorio e la terapia intensiva c’è questa grande terra di nessuno, un po’ incolta, un po’ incerta, faticosa da attraversare, dove il privato si getta come un cercatore d’oro. E questo è lo stato delle cose.
Ora sappiamo che più o meno in primavera (faccio una media tra le previsioni) ci sarà il problema (speriamo) del vaccino anti-Covid, e viene da chiedersi se le cose funzioneranno allo stesso modo. Cioè se dovremo rincorrere la nostra iniezione di tranquillità, rincorrerla, telefonare a raffica, chiedere agli amici – oppure pagare, corsia preferenziale per cittadini solventi.
Insomma, quando (e se) arriverà il famoso vaccino (uno dei), si potrà controllare in modo rapido – tipo tampone di Zaia – se l’articolo 32 della Costituzione ha ancora un senso, oppure se avremo le solite cronache di vip, milionari e calciatori che esibiscono lo status symbol dell’immunità acquisita, pagando s’intende.
Domani (sabato 14) esce, in allegato a La Stampa e La Repubblica, Il tavolo, già contenuto in un’antologia Sellerio (Vacanze in giallo, 2014) e poi da solo in e-book.
Qui l’intervista di Michela Tamburrino su La Stampa
 E’ nelle crisi, nelle emergenze, nell’abbraccio della paura che mostriamo il meglio e il peggio di noi, e questo vale, naturalmente, per il Paese che abitiamo. Quel che ne esce a prima vista è un impasto glorioso di fessi col botto e gente che fa il suo mestiere, a volte contro ogni incapacità altrui, come i medici di Alzano Lombardo che alla fine del febbraio scorso rompevano i vetri degli estintori d’emergenza per prendere almeno una mascherina, quelle che la Regione Lombardia non aveva, non mandava, ne comprava milioni farlocche (per non dire dei camici). Chissà, forse il maledetto virus potrebbe servire a qualcosa se lo si usasse per operare sul campo, di fronte agli eventi, a una scrematura decisa e massiccia di una classe dirigente incapace che può galleggiare nell’indifferenza delle cose malfatte quando tutto è tranquillo, ma diventa un pericolo quando la crisi morde.
E’ nelle crisi, nelle emergenze, nell’abbraccio della paura che mostriamo il meglio e il peggio di noi, e questo vale, naturalmente, per il Paese che abitiamo. Quel che ne esce a prima vista è un impasto glorioso di fessi col botto e gente che fa il suo mestiere, a volte contro ogni incapacità altrui, come i medici di Alzano Lombardo che alla fine del febbraio scorso rompevano i vetri degli estintori d’emergenza per prendere almeno una mascherina, quelle che la Regione Lombardia non aveva, non mandava, ne comprava milioni farlocche (per non dire dei camici). Chissà, forse il maledetto virus potrebbe servire a qualcosa se lo si usasse per operare sul campo, di fronte agli eventi, a una scrematura decisa e massiccia di una classe dirigente incapace che può galleggiare nell’indifferenza delle cose malfatte quando tutto è tranquillo, ma diventa un pericolo quando la crisi morde.
Così non passa giorno che non ci si metta, metaforicamente e non, le mani nei capelli. Il commissario alla Sanità calabrese (ex) Saverio Cotticelli che cade dalle nuvole, balbetta, si imperla, si agita, e poi si difende (in tivù) dicendo che “non ero io” e “forse sono stato drogato”, è caso così ridicolo e clamoroso da farne una specie di paradigma. Ma già altri fenomeni prendono la scena, mischiando incapacità e inconsistenza con mesmerismo, magia, superstizione. Fino al segretario del sindacato di Polizia Siap che indossa (e preme perché ne vengano acquistati a migliaia) una specie di amuleto israeliano che – a sentire lui – purifica l’aria una volta indossato come collana. Un aggeggio che “genera cationi (eh? Ndr) che inibiscono qualsiasi virus”. Insomma, tipo una collana d’aglio. Cascano le braccia.
Potrei continuare con i casi umani, gli improbabili, gli improvvisatori, i cialtroni, i guastatori a intermittenza, i “piccoli Salvini crescono”.
Ma il rischio è che i casi clamorosi – che non sono i più gravi, ma i più assurdamente evidenti – finiscano per addensare su di sé ironie, condanne e reprimende, e che questo distragga un po’ dagli errori enormi commessi e che ancora si commettono. Esempio: pochissima eco ha avuto sulla stampa il grido d’allarme che viene dall’ospedale di Monza, dove si contano oltre trecento sanitari contagiati. Qui non c’entrano i ragazzini che fanno ressa sul bus o i “signora mia, quanta gente c’era al parco” (colpevolizzazione del cittadino livello Pro), ma, evidentemente, protocolli inesistenti o non rispettati. Nonostante questo, l’assalto alle coscienze continua, lo scaricabarile, un classico della dinamica Stato-Regioni, non riguarda solo la politica, ma soprattutto la politica e il cittadino. Basta guardare la nuova campagna di “sensibilizzazione” (ahah, Ndr) della Regione Lombardia, spiritosamente battezzata “The covid dilemma”: una giovane ragazza in primo piano e una domanda: “Indossare la mascherina o indossare il respiratore?”, con tanto di chiosa: “La scelta è tua”. Incredibile. La regione che ha avuto più morti, quella dei pronto soccorso chiusi e riaperti senza sanificazione (Alzano), dei camici del cognato, delle mascherine farlocche, dei vaccini antinfleunzali pagati come caviale, dei cadaveri portati via dall’esercito, delle pressioni confindustriali per non chiudere la val Seriana, dice alla ragazzina che la scelta tra vivere e morire è sua. Come se in guerra, in presenza di generali incapaci e felloni come quelli che siedono alla Regione Lombardia, si desse la colpa ai cittadini bombardati: la scelta è vostra, che volete da noi?
 Il paziente indichi i contatti degli ultimi giorni. C’è un momento DDR che prima o poi si presenterà a molti, ed è quando devi mettere giù una lista, cioè denunciare in qualche modo che hai rischiato di contagiare qualcuno. Piccolo tremore: con la sola imposizione della penna su un foglio puoi chiudere in casa per diversi giorni molta gente. La famiglia, ovvio. I colleghi di lavoro. Eventuali amici e/o fidanzati e/o amanti. Le frequentazioni casuali di conoscenti, varie ed eventuali. Poi comincia il gioco dell’oca: attesa del tampone, fermo due turni, attesa dei risultati del tampone, fermo un turno, quarantena precauzionale, vai indietro di due caselle, volontaria, obbligatoria. Domande banali che diventano dilemmi etici (aspetto esito tampone, posso andare a prendere il pane?). Telefonate allarmate (quasi sempre allarmate di finire nella lista). Telefonate interessate, che partono per chiedere “come stai?” e invece vogliono sapere i dettagli, le pratiche, i tempi, se esistono scorciatoie, con tutte le varianti regionali (Pubblico? Privato? Dove? Quanto costa?).
Il paziente indichi i contatti degli ultimi giorni. C’è un momento DDR che prima o poi si presenterà a molti, ed è quando devi mettere giù una lista, cioè denunciare in qualche modo che hai rischiato di contagiare qualcuno. Piccolo tremore: con la sola imposizione della penna su un foglio puoi chiudere in casa per diversi giorni molta gente. La famiglia, ovvio. I colleghi di lavoro. Eventuali amici e/o fidanzati e/o amanti. Le frequentazioni casuali di conoscenti, varie ed eventuali. Poi comincia il gioco dell’oca: attesa del tampone, fermo due turni, attesa dei risultati del tampone, fermo un turno, quarantena precauzionale, vai indietro di due caselle, volontaria, obbligatoria. Domande banali che diventano dilemmi etici (aspetto esito tampone, posso andare a prendere il pane?). Telefonate allarmate (quasi sempre allarmate di finire nella lista). Telefonate interessate, che partono per chiedere “come stai?” e invece vogliono sapere i dettagli, le pratiche, i tempi, se esistono scorciatoie, con tutte le varianti regionali (Pubblico? Privato? Dove? Quanto costa?).
Se il tampone è negativo (wow!) si riparte dal via, nella speranza di non finire nella lista di qualcuno e di ricominciare il gioco da capo. Sarà così per mesi, se va bene. Una lotta inesausta e quotidiana con la nostra nuova inedita precarietà totale, la buroktatsija bislacca, la ruvida poesia dei tracciamenti, ognuno col suo percorso.
Già bruciata l’escalation dello screening: erano una sciccheria per pochi i sierologici pungidito, quasi subito diventati di massa; così che era quasi un upgrade sociale fare il tampone, quello veloce, otto minuti di attesa nervosa. Molto complicate le istruzioni del gioco, perché le vie dello screening sono infinite. Ci pensa l’azienda, con dei suoi misteriosi canali privati, no, ci pensa il dottore, no ci pensa il farmacista, che ti rimanda dal dottore, che ti rimbalza, no, ti fa una richiesta, informa la Ast, o Asl, o come si chiama la sanità nel posto dove vivi. Ed eccoti nel tunnel, benvenuto. Devi aspettare. Non uscire. Fai la tua lista. Calcola i giorni. E tutto questo se insieme all’attesa, alle telefonate, alle mail, al controllo compulsivo di fascicoli sanitari, siti, password, codici fiscali, non si aggiungono febbre, o tosse, o sa dio cosa, cioè si parla qui del migliore dei casi: l’asintomatico che incappa nella rete, seduto sulla lama che separa seccatura e fifa vera.
Dopo una vita a sentire il ritornello padronale per cui bisognava diventare flessibili, più flessibili, non basta!, più flessibili ancora, eccoci tutti elastici e modulabili dai protocolli sanitari, la vita governata dal virus, dalla paura e dal caso, ma sì, il famoso “destino” dei romanzi: “Egli parlò per dieci minuti con l’elettrauto e rimase confinato per due settimane”. “Ella prese l’ascensore con il ragioniere dell’ufficio sinistri e ora cucina torte da quindici giorni”. La sfiga.
Nessuno scenario sul “dopo” è seriamente prevedibile, ma certo di questo nostro vivere sospesi senza calendario, senza scadenze definitive – tutto può slittare, saltare, annullarsi da un momento all’altro – porteremo alla fine qualche traccia. Forse sarà il caro vecchio memento mori che rende tutto più relativo e induce a una certa indulgenza zen, o forse (più probabile) una nuova modalità di intermittenza, nel lavoro, nel tempo libero, negli affetti e insomma nella vita, che potrebbe essere un prezioso e involontario (e odioso) allenamento per le precarietà che verranno, che saranno feroci.
 Alla fine, girandola come si vuole, guardandola da più angolazioni, la situazione è questa: centinaia di migliaia di ragazzi non possono andare a scuola perché i trasporti pubblici che servono (tra le altre cose) a portarceli, fanno schifo e compassione, ovunque, senza eccezioni. Il bilancio di ciò che hanno fatto (e soprattutto non fatto) le amministrazioni regionali in sette mesi di quasi-tregua dell’epidemia è lì da vedere: desolante. Il tentativo di addossare soltanto alla famosa “movida” (in tutte le sue varianti) la responsabilità della seconda ondata non ha funzionato. Le immagini che ci vengono da treni locali, autobus urbani e metropolitane, invece, rendono bene l’idea: nessuno sano di mente può pensare che ci si infetti di più in un cinema semivuoto il giovedì sera (non dico dei teatri perché mi si stringe il cuore) che sul 31 barrato il venerdì mattina. Lo spettacolo è ancora più grottesco se si passa qualche minuto accanto ai binari di una grande stazione: la differenza tra chi scende da un Freccia Rossa – distanziato e garantito – e chi scende da un regionale – carro bestiame – è così evidente, dickensiana, da strabiliare.
Alla fine, girandola come si vuole, guardandola da più angolazioni, la situazione è questa: centinaia di migliaia di ragazzi non possono andare a scuola perché i trasporti pubblici che servono (tra le altre cose) a portarceli, fanno schifo e compassione, ovunque, senza eccezioni. Il bilancio di ciò che hanno fatto (e soprattutto non fatto) le amministrazioni regionali in sette mesi di quasi-tregua dell’epidemia è lì da vedere: desolante. Il tentativo di addossare soltanto alla famosa “movida” (in tutte le sue varianti) la responsabilità della seconda ondata non ha funzionato. Le immagini che ci vengono da treni locali, autobus urbani e metropolitane, invece, rendono bene l’idea: nessuno sano di mente può pensare che ci si infetti di più in un cinema semivuoto il giovedì sera (non dico dei teatri perché mi si stringe il cuore) che sul 31 barrato il venerdì mattina. Lo spettacolo è ancora più grottesco se si passa qualche minuto accanto ai binari di una grande stazione: la differenza tra chi scende da un Freccia Rossa – distanziato e garantito – e chi scende da un regionale – carro bestiame – è così evidente, dickensiana, da strabiliare.
E ovunque si volga lo sguardo ciò che salta agli occhi come uno squalo nella vasca da bagno è questo: le diseguaglianze volano, si moltiplicano, allargano la loro forbice, salvano chi sta in alto nella scala sociale e schiacciano chi sta in basso. La terapia intensiva sarà pure una livella, per citare Totò, ma prima di arrivarci di livellato non c’è niente. E’ una cosa che quelli dei piani di sotto, con l’ascensore sociale che non funziona, sentono ogni giorno sulla loro pelle. Gente che magari aspetta un tampone da giorni e legge costantemente di un mondo superiore dove ci si tampona ogni venti minuti allegramente tra vip, calciatori, star televisive. La serie A, insomma, sfugge all’affannata burokrazjia sanitaria mentre, la serie B e le altre serie minori arrancano al telefono con il medico di base, l’asl, la coda in macchina con bambino che tossisce, la mamma che non può andare al lavoro.
I sostenitori felloni di quell’imbroglio ideologico chiamato “meritocrazia” dovranno spiegarci come si fa a fare la gara del “merito” tra un ragazzo iperconnesso, attrezzato, munito nella sua stanza di numerosi device, e il suo omologo proletario, che si litiga il tablet con l’altro fratello, magari in un bilocale dove anche papà, o mamma, cercano di lavorare in smart-working. Situazione dolorosa per la perdita di socialità negli anni più esplosivi della vita, per tutti; ma per il secondo ragazzino anche il rischio serio di mollare il colpo, di rinunciare, di abbandonare la scuola per essere risucchiato nella palude della bassa specializzazione, della mano d’opera a basso costo.
Tracciare, curare, combattere il virus, insomma, è impresa titanica, e si sa. Ma c’è un’altra cura urgente da attuare subito: evitare che il virus diventi definitivamente e irrimediabilmente classista, cosa che già è oltre i limiti di guardia. La scommessa vera sarebbe quella di ampliare la sfera dei diritti: un tablet per ogni studente, un posto tranquillo sull’autobus, un reddito garantito almeno per campare, un accesso universale, rapido, gratuito per il vaccino, se e quando arriverà. Questa è la partita che deve giocare la politica. Se non lo fa, se nemmeno ci prova, se ci ritroveremo domani non solo in situazione di maggior povertà, ma anche in situazione di maggiore ingiustizia, significa che la politica non basta più, che il virus di classe ha vinto.
 Gli esami non finiscono mai, ma anche le rotture di palle non scherzano. Così, appena usciti dal tunnel delle elezioni regionali, eccoci entrare in quello delle elezioni comunali, con lo psicodramma di Roma in primo piano, dove per ora ballano il twist solo gli autocandidati, Carlo Calenda in primis. Il tentativo è quello di mettere i partiti davanti al fatto compiuto: o sostenete me o vi faccio perdere, che è un po’ lo schema che non ha funzionato in Puglia con Scalfarotto, Italia Viva e Azione uniti nella lotta e arrivati finalmente in doppia cifra (purtroppo con una virgola in mezzo, 1,7 per cento, come si dice, manco i parenti). Insomma, il calendismo malattia infantile dello scalfarottismo (semicit), con tutto il contorno che sappiamo da sempre: primarie sì, primarie no (Calenda non vuole: o lui o la guerra), candidati deboli o sconosciuti, tranne Monica Cirinnà, il cui nome è stato quasi immediatamente oscurato sui media dalla discesa in campo dei calenderos. Si immagina l’entusiasmo dei romani di fronte a un ipotetico ballottaggio Calenda-Giletti, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno: ci sono sempre il Tevere e l’Aniene in cui buttarsi. Per ora si tratta di mero clamore mediatico, ma va detto che l’accavallarsi delle due candidature (una fai-da-te, l’altra appena ventilata ma non smentita dall’interessato) oscura ingiustamente altri ottimi candidati al Campidoglio. Vediamone velocemente i profili.
Gli esami non finiscono mai, ma anche le rotture di palle non scherzano. Così, appena usciti dal tunnel delle elezioni regionali, eccoci entrare in quello delle elezioni comunali, con lo psicodramma di Roma in primo piano, dove per ora ballano il twist solo gli autocandidati, Carlo Calenda in primis. Il tentativo è quello di mettere i partiti davanti al fatto compiuto: o sostenete me o vi faccio perdere, che è un po’ lo schema che non ha funzionato in Puglia con Scalfarotto, Italia Viva e Azione uniti nella lotta e arrivati finalmente in doppia cifra (purtroppo con una virgola in mezzo, 1,7 per cento, come si dice, manco i parenti). Insomma, il calendismo malattia infantile dello scalfarottismo (semicit), con tutto il contorno che sappiamo da sempre: primarie sì, primarie no (Calenda non vuole: o lui o la guerra), candidati deboli o sconosciuti, tranne Monica Cirinnà, il cui nome è stato quasi immediatamente oscurato sui media dalla discesa in campo dei calenderos. Si immagina l’entusiasmo dei romani di fronte a un ipotetico ballottaggio Calenda-Giletti, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno: ci sono sempre il Tevere e l’Aniene in cui buttarsi. Per ora si tratta di mero clamore mediatico, ma va detto che l’accavallarsi delle due candidature (una fai-da-te, l’altra appena ventilata ma non smentita dall’interessato) oscura ingiustamente altri ottimi candidati al Campidoglio. Vediamone velocemente i profili.
Dinamite Bla. Personaggio minore dei fumetti Disney, ben radicato sul territorio, che difende sparando a chiunque si avvicini, pone la sua candidatura da indipendente, né di destra né di sinistra, con il segreto obiettivo di mettere in difficoltà il Pd. In ticket con Ciccio di Nonna Papera potrebbe avere qualche soddisfazione e persino arrivare al ballottaggio.
Tom Cruise. Per vederlo sfilare in macchina, in moto, in missile, in deltaplano, in monopattino, in carrozza a cavalli mentre gira Mission Impossible 37, i romani hanno sfidato assembramenti e gomitate. Punta tutto sulla viabilità: è l’unico essere vivente ad essere riuscito a compiere un tragitto urbano di più di due chilometri senza stare in coda, e questo è un elemento del programma che i cittadini apprezzano molto. La candidatura metterebbe un po’ in difficoltà il Pd, che non trova un candidato in grado di percorrere il Muro Torto a 270 all’ora caricando una Glock 9 millimetri.
Vittorio Sgarbi. Sindaco di alcuni paesi e cittadine italiane nel corso degli anni (Sutri, Salemi, Sanseverino Marche) cerca lavoro vicino a casa. E’ sostenuto da un’agguerrita compagine il cui esponente di punta è Vittorio Sgarbi, a cui Vittorio Sgarbi dà spesso ragione, il più delle volte urlando.
Rossella O’Hara. Gradita alla destra per la sua impostazione di difesa strenua delle tradizioni, non dispiacerebbe a Confindustria, data la sua teoria della piena occupazione favorita dallo schiavismo. In questo caso ci sarebbero forse problemi con la componente meloniana dello schieramento, che potrebbero però risolversi nel ticket con una personalità più forte e decisa: si cercano febbrilmente lontani parenti di Mussolini (nipoti, pronipoti, biscugini di nono grado) che tengano viva la tradizione democratica di Fratelli d’Italia.
I Sopranos. Italianissimi, attenti alle tradizioni famigliari e con esperienze all’estero (New Jersey) potrebbero continuare la tradizione ingiustamente interrotta dei Buzzi e dei Carminati, ma questa volta con un respiro più internazionale e migliore organizzazione nel ramo cooperative
 E’ l’ora delle missioni impossibili, delle avventure estreme, delle battaglie disperate. Tipo trovare un vaccino anti-influenzale nella regione più ricca d’Italia, la Lombardia, quella che ha avuto quasi 17.000 morti per Covid, quella delle mancate zone rosse, delle Rsa, quella dei camici del cognato e della moglie di Attilio Fontana, the president, quella dell’assessore al Welfare (ahahah) Giulio Gallera. Premunirsi, insomma, fare in modo che due lineette di febbre e il naso che cola non ti regalino la paranoia della peste in corso, ma vengano riconosciute come malanno di stagione, ed evitate con una semplice profilassi che da mesi tutti ci consigliano. La tivù, la radio, i giornali, i dottori, gli infermieri, i medici di base, le mamme, le nonne, ripetono indefessi che quest’anno il vaccino contro l’influenza bisogna farlo. Giusto. Bene.
E’ l’ora delle missioni impossibili, delle avventure estreme, delle battaglie disperate. Tipo trovare un vaccino anti-influenzale nella regione più ricca d’Italia, la Lombardia, quella che ha avuto quasi 17.000 morti per Covid, quella delle mancate zone rosse, delle Rsa, quella dei camici del cognato e della moglie di Attilio Fontana, the president, quella dell’assessore al Welfare (ahahah) Giulio Gallera. Premunirsi, insomma, fare in modo che due lineette di febbre e il naso che cola non ti regalino la paranoia della peste in corso, ma vengano riconosciute come malanno di stagione, ed evitate con una semplice profilassi che da mesi tutti ci consigliano. La tivù, la radio, i giornali, i dottori, gli infermieri, i medici di base, le mamme, le nonne, ripetono indefessi che quest’anno il vaccino contro l’influenza bisogna farlo. Giusto. Bene.
Ma il vaccino non c’è.
Chi volesse sperimentare l’Odissea Lombarda può partire dal proprio medico di base, che risponde allargando le braccia e consiglia di provare in farmacia, dove ti guardano come la mucca che guarda passare il treno: Eh? Cosa? Ripassi, telefoni, chieda in giro. Una settimana fa l’assessore Gallera aveva avvertito che la Regione Lombardia non potrà occuparsi del “cittadino generico”. Tradotto in italiano: lombardi, cazzi vostri.
Anche per i cittadini “non generici”, però, le cose non vanno benissimo. La Regione Lombardia – dove tutti i boss della sanità sono nominati dalla politica e sono quasi tutti della Lega – non ha dosi sufficienti nemmeno per i cittadini “non ordinari”, che sarebbero gli operatori della sanità, gli over 60, i bambini da zero a sei anni: i calcoli dicono che si tratta di cinque milioni di persone e i vaccini disponibili non arrivano alla metà, poco più di due milioni. La storia delle gare per assicurarsi i vaccini è un rosario mesto e dolente di fallimenti: alcune annullate, altre andate deserte, qualcuna incredibilmente declinata dalla stessa Regione, che voleva comprare vaccini (in marzo) al prezzo di 4,5 euro l’uno e, vista l’offerta di 5,9 euro ha preferito fermarsi. Eh, no, troppo cari! Come volevasi dimostrare: nell’ultima gara (la nona), il prezzo era salito a 10 euro, quasi il doppio, ma nemmeno la promessa del pagamento anticipato ha funzionato. In più, l’esimia Regione di mister Fontana, ha escluso dalle possibili forniture i lavoratori del settore pubblico (si arrangino) e gli operatori della sanità privata, che fino all’anno scorso erano compresi nelle forniture e quest’anno no: si arrangino pure loro.
Ridursi a indire gare di fornitura a metà ottobre è semplicemente folle: una prova di inadeguatezza politica macroscopica. A pensarci bene, Fontana & Gallera, la premiata ditta, dopo averne fatte più che Carlo in Francia, detenere il record di decessi (la metà di tutta Italia), pasticciare con gli interessi privati e famigliari, dire “va tutto bene” quando andava malissimo e “siamo stati bravi” quando facevano schifo e compassione, una cosa dovevano fare. Una sola. Una sola fottuta cosa: procurare per tempo e in abbondanza i vaccini antinfluenzali. Non l’hanno fatto.
Nel frattempo, campeggiano sulle home page dei maggiori operatori privati lombardi i severi ammonimenti: “Vaccino antinfluenzale, perché è importante farlo”, e si può prenotare, pagando s’intende: 50 euro (l’anno scorso costava tra i 12 e i 14). Così anche chi avrebbe diritto al pubblico correrà dal privato, persino ringraziando. Fine della storia dal fantastico mondo di Fontana & Gallera.
 Vorrei ringraziare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – un Briatore che ce l’ha fatta – per la sua indefessa e costante fucilazione di luoghi comuni molto vivi anche qui da noi. Ora che si gioca la rielezione e che pare un po’ in affanno (eufemismo) dopo le rivelazioni del New York Times sulle sue tasse (sulle sue non tasse, diciamo), Donald pare un po’ più fragile, il che lo rende se possibile un po’ più pericoloso, tra milizie bianche armate fino ai denti, tipini fini come quel Bannon a fargli da spalleggiatore, i matti di Qanon e tutto il campionario di fesserie psico-sovraniste che si porta appresso. Perché le carte che il New York Times ha scovato, e che rimbalzano su tutti i giornali del mondo, dicono in soldoni di scegliere tra due cose: o Donald Trump è un imprenditore totalmente incapace che accumula perdite e fallimenti, una specie di Re Mida al contrario che colleziona debiti; oppure è un evasore fiscale che, nonostante le torri con il suo nome, l’arredamento Casamonica style, i resort dove si gioca a golf e altre mille faccende danarose, paga meno tasse di un bidello di Crotone o di un precario a partita iva che si arrabatta tra mille lavoretti.
Vorrei ringraziare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – un Briatore che ce l’ha fatta – per la sua indefessa e costante fucilazione di luoghi comuni molto vivi anche qui da noi. Ora che si gioca la rielezione e che pare un po’ in affanno (eufemismo) dopo le rivelazioni del New York Times sulle sue tasse (sulle sue non tasse, diciamo), Donald pare un po’ più fragile, il che lo rende se possibile un po’ più pericoloso, tra milizie bianche armate fino ai denti, tipini fini come quel Bannon a fargli da spalleggiatore, i matti di Qanon e tutto il campionario di fesserie psico-sovraniste che si porta appresso. Perché le carte che il New York Times ha scovato, e che rimbalzano su tutti i giornali del mondo, dicono in soldoni di scegliere tra due cose: o Donald Trump è un imprenditore totalmente incapace che accumula perdite e fallimenti, una specie di Re Mida al contrario che colleziona debiti; oppure è un evasore fiscale che, nonostante le torri con il suo nome, l’arredamento Casamonica style, i resort dove si gioca a golf e altre mille faccende danarose, paga meno tasse di un bidello di Crotone o di un precario a partita iva che si arrabatta tra mille lavoretti.
Lasciamo la campagna elettorale americana, il Circo Barnum dove può vincere anche chi ha meno voti, agli esperti di caucus e primarie nell’Iowa, quelli che stanno svegli di notte per vedere i confronti in tivù manco fosse il pugilato epico del tempo che fu (tipo il duello con Biden di questa notte). Più divertente, invece, osservare come alcune narrazioni, che hanno spazio anche qui da noi, rischino di andare in pezzi. La prima: i ricchi che non rubano perché non ne hanno bisogno. Antica vulgata in gran voga pure qui negli anni del berlusconismo, si scontra periodicamente contro la realtà quando viene beccato un ricco dai comportamenti non proprio specchiati. Come sia in qualche modo attecchita questa leggenda nonostante i molti casi di miliardari furbi, non si sa bene, ma è un fatto che la ricchezza venga sempre considerata un alibi forte su due sponde. La prima: è ricco, non ha bisogno di fregare nessuno. La seconda: c’è sempre pronta la contro-accusa che parla di “invidia sociale” (traduco: ce l’hai con lui perché vorresti essere lui, e ti piacerebbe scaricare 70.000 dollari di parrucchiere dalle tasse).
Al limite, quando le due cose non funzionano, ci si può sempre rivolgere alle sirene dell’iperliberismo, quelle che sostengono che le tasse sono un furto, che lo Stato è una specie di rapinatore della gente perbene, cose che ogni tanto si vedono e si leggono anche qui. Ma sta di fatto: a leggere delle carte fiscali di mister Donald sembra che i soldi in entrata vengano quasi solo dal suo programma tivù, The Apprentice, dove giocava a fare il tycoon vincente, mentre tutte le altre cifre ci descrivono un mediocre perdente, che chiude i casinò ad Atlantic City, che segna perdite in ogni sua attività, che ha debiti per 400 milioni di dollari (il che lo rende ricattabile), che contribuisce al fisco americano con 750 euro all’anno, quasi dieci volte meno di un poveraccio qualunque. A farla breve, con buona pace dei trumpisti italiani, alla Casa Bianca dell’America Great Again si canta il più alto inno al tanto deprecato assistenzialismo, dove l’assistito non è lo sfigato proletario che “preferisce stare sul divano”, ma il grande, vincente, geniale imprenditore in costante perdita, in lotta col fisco, pieno di debiti, che casualmente è anche presidente della prima potenza mondiale.
 Assediato da Zaia ad est e dal neofascismo meloniano al sud, Matteo Salvini non se la passa bene come dice nelle conferenze stampa. Ora non è più nemmeno sicuro di essere il Gran Capo della destra, e si spera che il primo risultato del nuovo Risiko politico sia la (sempre tardiva) abolizione dei suoi decreti (in)sicurezza. Se ci mettete anche che in Lombardia il suo Attilio Fontana ne ha fatte più di Carlo in Francia, e che ha i commercialisti sotto interrogatorio, beh, diciamo che il baciatore di salami ha visto giorni migliori. Le mancate spallate leghiste hanno un nome e un cognome, il suo, e dopo il noto suicidio del Papeete dovrebbe sapere che le sconfitte si pagano. Per esempio, agire sotto costante pressione di uno che ha il trenta, il quaranta per cento, che vincerà tutto lui, che sarà presto il nuovo padrone del mondo come spesso si è pensato di Salvini nei mesi scorsi, induce una tentennante prudenza di cui davvero non c’è bisogno. Un Salvini fermo alle sue percentuali, il suo 15-20 per cento (in parlamento ha il 17) fa un po’ meno paura e un po’ meno pressione, e si spera che di questo si accorgano anche i media che ci hanno propinato la salvineide perenne. Di mettere in discussione il Capo ancora non se ne parla, ma sarebbe bello se qualcuno ci pensasse.
Assediato da Zaia ad est e dal neofascismo meloniano al sud, Matteo Salvini non se la passa bene come dice nelle conferenze stampa. Ora non è più nemmeno sicuro di essere il Gran Capo della destra, e si spera che il primo risultato del nuovo Risiko politico sia la (sempre tardiva) abolizione dei suoi decreti (in)sicurezza. Se ci mettete anche che in Lombardia il suo Attilio Fontana ne ha fatte più di Carlo in Francia, e che ha i commercialisti sotto interrogatorio, beh, diciamo che il baciatore di salami ha visto giorni migliori. Le mancate spallate leghiste hanno un nome e un cognome, il suo, e dopo il noto suicidio del Papeete dovrebbe sapere che le sconfitte si pagano. Per esempio, agire sotto costante pressione di uno che ha il trenta, il quaranta per cento, che vincerà tutto lui, che sarà presto il nuovo padrone del mondo come spesso si è pensato di Salvini nei mesi scorsi, induce una tentennante prudenza di cui davvero non c’è bisogno. Un Salvini fermo alle sue percentuali, il suo 15-20 per cento (in parlamento ha il 17) fa un po’ meno paura e un po’ meno pressione, e si spera che di questo si accorgano anche i media che ci hanno propinato la salvineide perenne. Di mettere in discussione il Capo ancora non se ne parla, ma sarebbe bello se qualcuno ci pensasse.
La ferita dei 5s è forse numericamente più grave, anche se al momento meno strategica. Con altri due anni al governo, godono di essere una forza parlamentare sovradimensionata rispetto all’effettivo peso nel Paese, insomma volendo hanno tempo per darsi una svegliata da una posizione di vantaggio. Anche lì, nonostante la bella favola delle piattaforme elettroniche, mettere in discussione la leadership – una cosa salutare dopo le sconfitte – non è facile.
Altro caso di rappresentanza parlamentare sovrastimata è Italia parlandone da Viva: anche se gioisce per la Toscana, pare che il progetto sia un po’ in affanno (eufemismo), e anche dove si è provata la Santa Alleanza con Los Calenderos – una gran voglia di riesumare il PLI – è stato un macello. L’1,7 di Scalfarotto in Puglia, con ministri e segretari di partito accorsi a dar manforte la dice tutta. Eppure è il 4,5 in Toscana che dovrebbe allarmare i renzisti. La roccaforte, il fortino… insomma, per chi vagheggiava di “doppia cifra” non dev’essere bello accorgersi che in mezzo c’è una virgola. Anche qui, però, ci si chiede cosa potrebbe cambiare, probabilmente nulla, perché in un partito personale nato nel culto del Capo nessuno metterà in discussione il gruppo dirigente.
Si registra – anche giustamente – il peana corale per Zingaretti e il suo Pd, ma anche qui a cercarla qualche ombra si trova. La strategia dell’opossum (fingersi morto mentre tutti gli altri strillano) ha funzionato, ma ora non è più attuabile. Ora bisogna passare all’attacco e, in un certo senso, all’incasso, e non sarà semplice. Tanto per raffreddare gli entusiasmi, va ricordato il triste caso delle Marche, dove una sinistra pasticcona e inconcludente (si pensi al terremoto) è stata sconfitta da uno che andava alle cene in onore del Duce, e della marcia su Roma (“Giorno memorabile e indelebile”, c’era scritto sul menu insieme ad altre amenità del Ventennio). Ecco, questo per dire, a sinistra, che sarebbe meglio non rilassarsi troppo e cominciare a ripristinare qualcosa di simile a un lavoro culturale sul territorio, come si dice, cioè a difendere alcuni valori non negoziabili. Per non trovarci magari – dopo Salvini – la destra estrema burbanzosa e vincente.
 Come tutti sapete a meno che non foste a fare l’happy hour su Saturno (anche se ora va più di moda Venere) hanno riaperto le scuole, un evento per cui dai più prestigiosi giornali italiani, alle televisioni, al sito web di Vergate sul Membro o Salcazzodove Scalo sono state scritte milioni di pagine per dire che sarà un disastro, che mancano i maestri, i prof, i maestri di sostegno, insomma come tutti gli anni scolastici che Dio manda in terra, però di più. Non mancano le nostalgie: ah, i bei tempi in cui ti crollavano soltanto i soffitti sulla testa! Ognuno ha la sua motivazione per combattere strenuamente la battaglia del perfetto funzionamento della scuola pubblica, e tutte queste motivazioni hanno come primo e unico obiettivo la gioia dei nostri ragazzi: fare un rimpasto, cacciare Conte per gestire 200 miliardi, mettere Draghi, no, Cottarelli, no, Belfagor e via così, tutte cose che ai bambini delle elementari premono tantissimo, compresa la Boschi al posto dell’Azzolina (alcuni non ci dormono di notte).
Come tutti sapete a meno che non foste a fare l’happy hour su Saturno (anche se ora va più di moda Venere) hanno riaperto le scuole, un evento per cui dai più prestigiosi giornali italiani, alle televisioni, al sito web di Vergate sul Membro o Salcazzodove Scalo sono state scritte milioni di pagine per dire che sarà un disastro, che mancano i maestri, i prof, i maestri di sostegno, insomma come tutti gli anni scolastici che Dio manda in terra, però di più. Non mancano le nostalgie: ah, i bei tempi in cui ti crollavano soltanto i soffitti sulla testa! Ognuno ha la sua motivazione per combattere strenuamente la battaglia del perfetto funzionamento della scuola pubblica, e tutte queste motivazioni hanno come primo e unico obiettivo la gioia dei nostri ragazzi: fare un rimpasto, cacciare Conte per gestire 200 miliardi, mettere Draghi, no, Cottarelli, no, Belfagor e via così, tutte cose che ai bambini delle elementari premono tantissimo, compresa la Boschi al posto dell’Azzolina (alcuni non ci dormono di notte).
Per non parlare dei politici di ogni colore, che non hanno mai esternato così abbondantemente sulla scuola (cioè, quando votavano i tagli non è che ne parlavano tanto); fino al paradosso di lady Gelmini, la grande tagliatrice, che strilla di “inadeguatezza e superficialità”: tipo il piromane che incendia il bosco e poi critica i pompieri. Divertente contrappasso quello della fotografia della scuola di Genova con i bambini in ginocchio per terra (sui ceci? ndr) che scrivono appoggiati alle sedie perché non hanno i banchi. Orrore e commozione, tanto che il presidente della Liguria Toti denuncia lo scandalo, i titoloni sono tutti per quei poveri bimbi in ginocchio. Poi leggendo il pezzo si scopre altro, che non è vero, che i banchi vecchi ci sono, che quelli nuovi arrivano domani (oggi per chi legge) e che insomma, si tratta di un falso ideologico bello e buono, ma non importa, vale tutto: se c’è un distanziamento che non viene applicato è quello delle cazzate, è un vero assembramento.
Naturalmente la propaganda fa il suo lavoro, e sarebbe cretino fare il controcanto inverso: va tutto benissimo! Che figata!, atteggiamento fesso tanto quanto e soprattutto falso: non va per niente tutto bene, com’è ovvio.
Non resta, per una volta, che affidarsi alla testa delle persone che ancora ce l’hanno, quelle che mandano i figli a scuola con un po’ di ragionevole apprensione, i prof, i bidelli, le maestre, i presidi che si fanno un culo quadro per tappare tutte le falle dell’emergenza, quelli che ci mettono dell’impegno, magari sapendo che un ragazzino con la febbre può scombinare per settimane i piani di intere famiglie, come del resto avviene negli uffici e in tutti i posti di lavoro che abbiano un minimo controllo. E mettiamoci anche i ragazzi, che si sentiranno quella solfa infinite volte, state staccati, non fare cazzate, state attenti, ma per i media all’occorrenza buoni da colpevolizzare se si ammala il nonno. E’ uno di quei casi in cui propaganda e realtà si fronteggiano in modo diretto, perché tra studenti, docenti, personale, e tutto l’indotto scuola, parliamo di oltre dieci milioni di persone, e quindi di tutto il Paese. La gente saprà che si sta fronteggiando in qualche modo un’emergenza e farà la sua tara con le cronache di Narnia del disastro sia annunciato che sperato. La buona notizia è che il paese reale potrebbe essere un po’ meglio del paese surreale che leggiamo ogni giorno. La cattiva notizia è che non ci vuole molto, davvero.
 Non c’era bisogno dei recenti fatti di cronaca, come l’omicidio di Colleferro, per capire che nel Paese è in atto, e a piede libero, una certa tendenza alla “fascistità”. Mi scuso per la brutta parola, ma siccome quando si parla di “fascismo” tutti saltano su come tappi a dire che non è allarmante, che sono casi isolati, eccetera eccetera, allora mi appello a quest’altra categoria dello spirito. Che sarebbe – i due fratelli di Colleferro e gli altri due accusati di omicidio lo dimostrano bene – più una predisposizione al fascismo, diciamo un’inclinazione armoniosa di accoglienza: ammazzare di botte la gente, del resto è una specialità della casa da almeno un secolo.
Non c’era bisogno dei recenti fatti di cronaca, come l’omicidio di Colleferro, per capire che nel Paese è in atto, e a piede libero, una certa tendenza alla “fascistità”. Mi scuso per la brutta parola, ma siccome quando si parla di “fascismo” tutti saltano su come tappi a dire che non è allarmante, che sono casi isolati, eccetera eccetera, allora mi appello a quest’altra categoria dello spirito. Che sarebbe – i due fratelli di Colleferro e gli altri due accusati di omicidio lo dimostrano bene – più una predisposizione al fascismo, diciamo un’inclinazione armoniosa di accoglienza: ammazzare di botte la gente, del resto è una specialità della casa da almeno un secolo.
Si è letta sull’argomento molta sociologia improvvisata, come sempre in questi casi, e anche qualche tentativo di minimizzare: il bullismo, le arti marziali… Insomma, anche se stavolta sarà più difficile, sta sempre in agguato l’avvoltoio che dirà: “Ragazzate”. Il fatto che a Colleferro e dintorni li conoscessero tutti, e tutti sapessero del loro alto tasso di violenza e “fascistità”, non migliora le cose, anzi, sta a testimoniare che ampie dosi di quel virus, anche organizzate, sono vive e operative nel tessuto sociale, qui e là, in tutto il paese. In qualche modo conosciute, in qualche modo tollerate, emergono poi a cose fatte, dopo il pestaggio, dopo il morto.
Eppure, l’argomento è frettolosamente circumnavigato, ogni volta l’attenzione si sposta su altri fattori, questa volta la polemica è virata sulle palestre e le arti marziali, altre volte sul disagio sociale, altre ancora sul bullismo, o lo spaccio. Insomma, c’è un gran lavorìo dei titolisti per allontanare dalle tragedie come quella di Colleferro (e se ne contano ormai parecchie) anche solo il sospetto di elementi di fascismo applicato. Poi, quando leggi le cronache, gli ambienti, le frequentazioni, i loro video sui social, i parenti che dicono “tanto ha solo ammazzato un immigrato”, ti accorgi che invece il tasso di “fascistità” è alto, anche quando non si tratta di fascismo conclamato tipo saluti romani e svastiche tatuate. Un’adesione fisica, insomma, quasi pre-ideologica, che si esprime a cazzotti e intimidazioni, che rappresenta, per le formazioni della destra ultras (e meno ultras), un notevole terreno di caccia.
Non è solo la cronaca nera, a rilevare varie pulsioni fasciste e molta “fascistità” già matura e pronta da cogliere. La manifestazione negazionista di Roma, per esempio, ha generato sui media un misto di condanna e sarcasmo, ma tutti incentrati sulla stupidità dei presenti. Il finto prete che parla del demonio, la signora preoccupata che la avvelenino coi vaccini, il complottismo esasperato e esilarante del “ci controllano col 5g”. Pochi hanno invece fatto notare che la manifestazione è stata convocata da Forza Nuova, formazione fascista, e che sul palco ha parlato il leader Giuliano Castellino, già condannato a cinque anni e sei mesi (primo grado) per aggressione. Insomma, grande biasimo e grande sarcasmo per i mattacchioni e gli svitati che danno la colpa del Covid a Bill Gates, ma poco scandalo sul fatto che un fascista già condannato per un pestaggio possa in qualche modo organizzare un raduno in piazza.
E’ come se questo conclamato e visibile aumento del tasso di “fascistità” nell’aria venisse un po’ volutamente ignorato, aggirato, sottaciuto o messo in ombra, un po’ come se creasse imbarazzo, o fastidio, invece di essere trattato per quello che è: una (un’altra!) emergenza nazionale.
Ceci n’est pas une chanson d’amour, due recensioni francesi (Libération e Lire, magazine littéraire)
Il 20 agosto è uscito in Francia “Ceci n’est pas une chanson d’amour” (Éditions de l’aube), con l’ottima traduzione di Paolo Bellomo e Agathe Lauriot dit Prévost.
Qui la recensioni di Liberation (merci à Claire Davarrieux) e di Lire, le magazine littéraire (merc1 à Éric Libiot)
 Non è detto che si debba sempre parlare di cose serie o importanti. Andiamo, ogni tanto si può anche – per divertimento e leggerezza, per cazzeggio – parlare di stupidaggini, di solenni cretinate, di puttanate clamorose: insomma della manifestazione del 5 settembre indetta dai fascisti di Forza Nuova. Titolo: “Contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”. Beh, dài, niente male.
Non è detto che si debba sempre parlare di cose serie o importanti. Andiamo, ogni tanto si può anche – per divertimento e leggerezza, per cazzeggio – parlare di stupidaggini, di solenni cretinate, di puttanate clamorose: insomma della manifestazione del 5 settembre indetta dai fascisti di Forza Nuova. Titolo: “Contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”. Beh, dài, niente male.
Divertito dalla notizia che ci sia qualcuno che sostiene che viviamo sotto una dittatura sanitaria (e altro), mi sono sentito in colpa di non saperne nulla, né della dittatura, né della manifestazione. Così, con notevole sprezzo del ridicolo, ho indossato una speciale tuta anti-cazzate (vi avverto, serve il modello potenziato) e mi sono immerso per qualche minuto nei siti, nelle home page, negli account di sostenitori e organizzatori, traendone momenti di agghiacciato divertimento. Intanto le premesse: la famosa dittatura che si vuole combattere è un diabolico marchigegno di oppressione che va da Soros (ovvio, dài!) a Mario Monti (eh?), fino a Bill Gates, all’Oms, al presidente del consiglio Conte, e spiace che gli organizzatori abbiamo dimenticato Will Coyote e i difensori dell’Atalanta. Questa terribile dittatura “che priva i bambini del loro sorriso e della loro naturalezza” – oltre a danneggiare il turismo – sarà naturalmente sconfitta da Forza Nuova, dai gilet arancioni – quelli del generale Pappalardo che ha scritto un romanzo dettatogli da un alieno del pianeta Ummo – con lo straordinario appoggio di Vittorio Sgarbi. “Sarà – cito testualmente –una rivoluzione che inizierà a Roma e che a mani nude conquisterà il mondo intero” (me cojoni, ndr).
Non è facile sapere esattamente chi ci sarà, perché questi qui che vogliono “conquistare il mondo a mani nude” hanno fatto un po’ di casino, mettendo tra i partecipanti gente che non ci andrà manco dipinta, tipo (ancora i nomi figurano in elenco sui loro siti) il pilota Hamilton, il giocatore del Liverpool Lovren, il tennista Djokovic e altri vip. Poi hanno corretto il tiro dicendo che li hanno solo inviati, tipo che al tuo compleanno dici che ci saranno Bob Dylan e Jennifer Lopez, ma non è mica vero, te lo sei inventato con un post su Facebook. Mitomania canaglia. Però pare certo l’appoggio dell’Arcivescovo Viganò, di cui siti e account riportano una lettera assai preoccupata perché la dittatura di cui sopra vuole “demolire la famiglia”. L’Arcivescovo a quanto pare, risponde a un accorato appello (altra lettera) di tale Giuliano Castellino, capataz di Forza Nuova, già condannato a cinque anni e passa per aggressione a un giornalista de L’Espresso. Bella gente.
Particolarmente esilarante l’elenco di associazioni, gruppi, club e leghe che si accodano all’iniziativa, gente che si chiama “L’elmo di Scipio”, o “Rialzati Italia”, o “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”, o “Carlo Taormina”, che forse è proprio lui. Accorati gli interventi di Manuel, “ragazzo di Ostia cuore impavido” (cit) e del “famoso Ciccio Della Magna, di Marcia su Roma” (giuro). In sostanza ci sarà la crema della società e i comunicati non lesinano sull’enfasi: se andrai alla manifestazione “L’Italia futura ti ringrazierà, i tuoi figli ti ringrazieranno, i tuoi nipoti, i tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi nonni ti ringrazieranno”. Insomma, un sacco di ringraziamenti. Mi aggiungo con il mio grazie: non ridevo così tanto da quando il generale Pappalardo andava ad arrestare Mattarella con un mandato di cattura realizzato coi trasferelli.
 L’estate sta finendo eccetera eccetera, potete cantare la canzoncina famosa senza remore, perché quel che ci aspetta è un autunno infinito, invece, e l’inverno chissà, speriamo bene. Quel che si sa, non c’è bisogno di essere un indovino, è che si assisterà al solito derby cattivo e senza esclusione di colpi tra le due compagini più rappresentative della scena politica: Los Liberistas contro lo Stato. Chi segue le cronache politiche sa di cosa si parla: da un lato un pianto continuo e inesausto per dire che i tanti soldi in arrivo dovrebbero andare a loro, industriali e imprese, che cercano finanziamenti pubblici per “il libero mercato” (ahah), e dall’altro un sistema di welfare e assistenza che consenta a tutti i cittadini – anche a quelli espulsi dal sistema produttivo – di campare la famiglia. Colpi bassi, trucchi dialettici da seconda media, sgambetti e paradossi: la solita solfa che diventa addirittura ridicola quando si svolge sui social a colpi di tweet o di post su Facebook. La narrazione aggressiva di Los Liberistas è nota: le tasse sono un furto (qualcuno lo mette nella bio del profilo), e vanno a finire tutte a quei “maledetti statali” che naturalmente “non fanno niente tutto il giorno” e hanno la terribile colpa, in subordine, di prendere lo stipendio anche quando c’è il Covid. Al contrario dei poveri Los Liberistas che sono costretti a mettere i dipendenti in cassa integrazione (cioè a far pagare gli stipendi a noi tutti), e almeno in un terzo dei casi fare i furbetti (2,7 miliardi fregati, sempre a noi).
L’estate sta finendo eccetera eccetera, potete cantare la canzoncina famosa senza remore, perché quel che ci aspetta è un autunno infinito, invece, e l’inverno chissà, speriamo bene. Quel che si sa, non c’è bisogno di essere un indovino, è che si assisterà al solito derby cattivo e senza esclusione di colpi tra le due compagini più rappresentative della scena politica: Los Liberistas contro lo Stato. Chi segue le cronache politiche sa di cosa si parla: da un lato un pianto continuo e inesausto per dire che i tanti soldi in arrivo dovrebbero andare a loro, industriali e imprese, che cercano finanziamenti pubblici per “il libero mercato” (ahah), e dall’altro un sistema di welfare e assistenza che consenta a tutti i cittadini – anche a quelli espulsi dal sistema produttivo – di campare la famiglia. Colpi bassi, trucchi dialettici da seconda media, sgambetti e paradossi: la solita solfa che diventa addirittura ridicola quando si svolge sui social a colpi di tweet o di post su Facebook. La narrazione aggressiva di Los Liberistas è nota: le tasse sono un furto (qualcuno lo mette nella bio del profilo), e vanno a finire tutte a quei “maledetti statali” che naturalmente “non fanno niente tutto il giorno” e hanno la terribile colpa, in subordine, di prendere lo stipendio anche quando c’è il Covid. Al contrario dei poveri Los Liberistas che sono costretti a mettere i dipendenti in cassa integrazione (cioè a far pagare gli stipendi a noi tutti), e almeno in un terzo dei casi fare i furbetti (2,7 miliardi fregati, sempre a noi).
Va detto che non tutti Los Liberistas sono uguali: ci sono gli estremisti e i moderati, ma il pensiero di fondo è sempre quello: meno Stato e più mercato, salvo poi presentarsi dallo Stato con il cappello in mano quando il mercato non va come vorrebbero. Dannazione. Così le cronache economiche diventano un rosario di lamenti e contumelie: ecco le scuole private addolorate dal fatto che dai rubinetti pubblici non sgorghino più finanziamenti come un tempo. Oppure ecco gli operatori della sanità privata (ma sì, angeli, eroi, salvatori, ecc. ecc) che lavorano con un contratto scaduto da dodici anni: arriveranno gli aumenti, sì, ma coperti al 50 per cento da fondi regionali, cioè pubblici, cioè sempre noi. Naturalmente se si parlasse di devolvere il 50 per cento dei profitti allo Stato si griderebbe ai Soviet, ma si sa com’è, nel rapporto tra pubblico e privato Los Liberistas intendono il flusso soltanto in entrata. Intanto, i numeri sull’evasione fiscale (120 miliardi, stima assai prudenziale) fanno tremare i polsi.
Il derby ha fasi di stanca e momenti di gioco brillante, per esempio quando gli economisti in forza a Los Liberistas (quasi tutti) si scagliano contro provvedimenti di welfare e sostegno ai cittadini più poveri. Apriti cielo: no al salario minimo, no al reddito di cittadinanza (“li pagano per stare sul divano”), no ai blocchi dei licenziamenti, per arrivare sempre lì, alla conclusione che se tu lasci fare al mercato tutto si sistemerà per il meglio. Si è visto, infatti.
Siamo solo al precampionato, la partita vera comincerà in autunno, cioè tra pochi minuti, quando dieci milioni di lavoratori del settore privato faranno gentilmente notare che i loro contratti sono scaduti. E’ probabile che si incazzeranno un bel po’, e Los Liberistas dovranno sfoderare tutta la loro capacità produttiva per realizzare la loro più grande opera: costruire un enorme cappello e presentarsi, con quello in mano, al cospetto dell’odiato Stato, quel cattivone.
 C’è sempre da diffidare quando si sente la formuletta facile che recita: “Trasformare un problema in un’opportunità”. Di solito si intende che la sfiga resta per molti, quasi per tutti (il problema), e pochi, pochissimi, colgono la palla al balzo per guadagnarci (la famosa opportunità). Insomma, mi scuso in anticipo se userò questa formuletta in modo un po’ libero, ma insomma, i tempi sono quelli che sono e quindi sì, potremmo tentare davvero di trasformare un problema in opportunità.
C’è sempre da diffidare quando si sente la formuletta facile che recita: “Trasformare un problema in un’opportunità”. Di solito si intende che la sfiga resta per molti, quasi per tutti (il problema), e pochi, pochissimi, colgono la palla al balzo per guadagnarci (la famosa opportunità). Insomma, mi scuso in anticipo se userò questa formuletta in modo un po’ libero, ma insomma, i tempi sono quelli che sono e quindi sì, potremmo tentare davvero di trasformare un problema in opportunità.
Caso di scuola: gli aiuti che lo Stato, giustamente, elargisce ai settori in difficoltà, sia ai lavoratori (la cassa integrazione e gli altri ammortizzatori) e alle aziende. Distribuiti a pioggia e senza troppi controlli nei primi mesi dell’emergenza Covid, sono diventati una coperta – corta, come sempre – che ognuno tira di qua e di là, sempre dalla sua parte, ovvio. Così la sora Meloni poteva tuonare “Mille euro a tutti”, dal bracciante a Briatore, e i capataz di Confindustria implorare di darli tutti a loro. Sono ben note le condizioni di partenza: una situazione drammatica mai vista, con il paese chiuso, molte produzioni ferme, i lavoratori chiusi in casa, eccetera eccetera. Un errore, non aver messo limiti e paletti adeguati alla distribuzione di soldi, vero, e un’unica scusante abbastanza potente: la fretta e – appunto – l’emergenza. Poi si è scoperto che almeno il trenta per cento delle aziende ha fatto lavorare i dipendenti lo stesso, pagandoli con soldi nostri (la cassa integrazione invece dello stipendio), il che è stato quantificato come un furto di circa 2,7 miliardi, non un dettaglio, insomma. Questo il problema. Veniamo all’opportunità.
Il decreto di chiusura delle discoteche offre un buon esempio per la discussione. Attentato al libero mercato, dicono i gestori, con Salvini che si accoda, forse memore dei balletti con le cubiste del Papeete, e lady Santanché che si fa riprendere mentre danza, si ribella, dice che la sua, di discoteca, non chiuderà. Tutto bellissimo. Poi vai a cercare qualche dettaglio ed eccolo qui. Proprietari e gestori di discoteche, a leggere gli studi di settore (quando ancora c’erano) e le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi, non superano in media i 18.000 euro di reddito annui, un giro d’affari che sembrerebbe miserabile anche per una piccola salumeria. I titoli dei giornali se la prendono sempre con i gioiellieri che guadagnano meno delle loro commesse – un classico -, ma a giudicare dai dati del Ministero dell’Economia (basta cercare “discoteche dichiarazioni dei redditi”) si direbbe che chi possiede una sala da ballo col bar, le luci abbaglianti, il dj, le cubiste e altre cose utili al divertimento, passi le sue giornate in fila alla Caritas, guidi una vecchia Panda del ’99 e mantenga la famiglia con meno di 1.200 euro al mese. Francamente, anche con molta buona volontà, è difficile da credere.
Ecco dunque l’opportunità: perché non cogliere l’occasione degli aiuti (sacrosanti, ripeto) per fare un serio controllo in alcuni (anche tutti) i settori economici? Intanto, ovvio, commisurare gli aiuti alle dichiarazioni dei redditi, dato che sarebbe pazzesco rimborsare oltre i guadagni dichiarati. E poi approfittare dei controlli per verificare le condizioni di lavoro: quali contratti? Quali inquadramenti professionali? Quanti lavoratori in nero? Possiamo vedere il cedolino di fine mese dei buttafuori o delle cubiste? I contratti dei dj? Coraggio, Inps, Inail, Ministero del lavoro! Trasformiamo un problema in un’opportunità!
 Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa che straborda, lo champagne in fresco e il filetto alla Woronoff che ti aspetta, sei un pezzo di merda.
Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa che straborda, lo champagne in fresco e il filetto alla Woronoff che ti aspetta, sei un pezzo di merda.
Detto questo, ecco la vostra rubrichina, questa volta (mi scuso) per fatto personale.
Il 17 aprile scorso, quando tutti stavamo chiusi in casa come l’abate Faria nella sua cella, mi scrisse un mio amico bancario. Riporto le sue parole testualmente: “Sono sconcertato. In questi giorni sto vedendo arrivare sui conti dei miei clienti il bonifico da 600€. che lo Stato riconosce ai professionisti in difficoltà per il Covid. Oltre la metà dei beneficiari ha un saldo di conto corrente e un deposito titoli valorizzati in un minimo di 50mila euro fino a punte da 3-400mila euro. Colleghi di altre filiali mi segnalano percettori con saldi oltre gli 800mila euro”.
Anch’io sono sconcertato (eufemismo). Riporto le sue parole, su twitter, ovviamente coprendo la fonte, che potrebbe passare dei guai. Apriti cielo: le reazioni sono di vari tipi. Uno: ho inventato tutto, sono un mitomane che dice “un mio amico”, che è come dire “mio cuggino”. Due: come si permette il mio amico di guardare i conti correnti dei clienti? (ndr: è il suo mestiere). Tre: la legge non mette limiti, quindi hanno ragione loro. Se la legge ti permette di ammazzare a sassate un gattino fai bene a farlo. Quattro: sono il solito comunista-nostalgico (di cosa? Boh) che odia i ricchi. Cinque, sono invidioso di quelli che hanno tanti soldi sul conto, perché io sono un pezzente e loro invece ce l’hanno fatta, nella vita.
La cosa va avanti per qualche giorno. Mi chiama un bravo inviato di Piazzapulita, il programma di Formigli: posso metterlo in contatto con il mio amico? Rispondo di sì, ma raccomando il mio amico di chiedere garanzie di anonimato, perché anche se la legge non vieta di far licenziare un tuo amico, esiste pur sempre un’etica personale.
Il 24 aprile va in onda l’intervista al mio amico bancario, non ripreso in faccia e con la voce contraffatta, cosa che mi fa sempre ridere perché mi ricorda i genitori di Woody Allen in Prendi i soldi e scappa con gli occhiali, il naso finto e i baffi. Il mio amico – travisato come un bandito pur essendo una bravissima persona – non solo ripete le cose che ha detto a me, ma mostra qualche estratto conto (con i nomi rigorosamente cancellati, ovvio) dove si può leggere: saldo 600.000 euro, più 600 di bunus Inps. Il giorno dopo, silenzio: nessuno dice che era il cuggino di Formigli, o che l’inviato di Piazzapulita è un pezzente invidioso di chi ha un conto corrente grasso come un maiale.
Ed eccoci a noi: non siamo più chiusi in casa come Formigoni ai domiciliari, e la cosa si ripresenta paro paro con i cinque deputati – maggioranza leghista – (13.000 euro al mese) che hanno chiesto (e 3 ottenuto) il bunus Inps. Leggo le reazioni di oggi e quelle di ieri: praticamente identiche, ma con qualche variante: è stato il commercialista, no, la moglie, no, il socio, no, maestra, il gatto mi ha mangiato i compiti. Tutto qui. Aggiungo solo due cosette. La prima: quelli che si indignano con chi denuncia invece che coi i farabutti denunciati non sono miliardari, ma quasi sempre sfigati, però con la sindrome di Stoccolma. La seconda: tra gli insulti più ricorrenti che ricevetti ai tempi ce n’era uno divertente: giacobino. Interessante: nella bizzarra estate del 2020 c’è ancora chi odia i giacobini e fa il tifo per Luigi XVI, forse gli piacciono le brioches.
Cosa diavolo può legare il Caravaggio, la cristallina idiozia della censura fascista, la serie americana più cool di sempre, la Milano del ‘600 (pre peste), il jazz? Seguire il filo, risalire alle fonti, alle origini, alle leggende, fino al salto sulla sedia quando uno, vedendo Breaking Bad, la serie di Vince Gilligan, una delle più famose e popolari su Netflix, pilastro contemporaneo della fiction mondiale, sente quella musica, la riconosce (e come non riconoscerla?). Maddai, possibile?
La canticchia Gale, per la precisione, chimico specializzato che “cucina” cristalli di metanfetamine, e la canticchia con il sottofondo dell’originale – un disco – mentre si prepara la cena. Il disco sta ancora girando che lo ammazzano malamente (terza stagione, episodio 13).
Ma che musica? Ecco, giusto, prima le fonti.
Crapa pelada l’ha fa i turtei
Ghe ne dà minga ai so’ fradei
I so’ fradei fan la fritada
Ghe ne dan minga a crapa pelada
Filastrocca scemetta, per bambini, una solfa, una tiritera divertente. Chi lo direbbe che è una cosa che parte dal Caravaggio, arriva a Rabagliati, viene combattuta dal fascismo, trionfa alla Liberazione e sbarca nella super-fiction americana?
Non facciamola lunga: piccola storia di una grande canzone.
Prima la leggenda, la genesi. Il Caravaggio, era ancora “soltanto” Michelangelo Merisi, viveva a Milano, più o meno il 1590. Testa calda, lo sappiamo, ma capace di innamorarsi. “Lei” si chiama Peppa Muccia, prostituta, lui la rapisce (ah, l’amore!), i fratelli di lei (tre, dice la leggenda) non possono perdonare, recuperano la ragazza, danno una sonora mazzolata al pittore e a lei, punizione umiliante, rasano i capelli a zero. Ecco “Crapa pelada” viene da lì, tradizione orale, storia di dispetti e di ripicche: lei fa i tortelli ma ai fratelli non li dà, li darebbe solo al suo amore, che però chissà dov’è (ve lo dico io: a Roma, dove di lì a qualche anno diventerà “Il Caravaggio”).
Un passaparola di generazioni. Per trovarla in forma di canzone – e che canzone! – bisogna aspettare secoli, il 1936, quando Giovanni (Tata) Giacobetti, cantante, contrabbassista, futuro fondatore del Quartetto Cetra, si ricorda della filastrocca popolare, la riscrive insieme a Gorni Kramer (Francesco Kramer Gorni, inarrivabile maestro di fisarmonica, precursore del jazz in Italia, re del varietà).
La musica viene da uno standard americano, precisamente da It Don’t Mean a Thing, che Duke Ellington scrive nel 1932, tutto è saltellante e sincopato, le parole in dialetto lombardo rimbalzano su quella tessitura che è un piacere, c’è ironia, forse sarcasmo, jazz, swing, accidenti!
Funziona. La canta Alberto Rabagliati. Funziona pure troppo. E poi la stupidità della censura fa il resto.
Basta leggere il Radiocorriere di quegli anni si capisce perché: “Musica negroide”, espressamente vietata dal ’37, ma sottotraccia si suona ancora, la Resistenza è anche un po’ swing. E dopotutto cosa regala Milton a Fulvia in “Una questione privata” di Fenoglio? Over the rainbow…
C’è di peggio (non ridete) il jazz è anche “musica afro-demo-pluto-giudo-masso-epilettoide”. Insomma, contrabbassi e orchestrine al posto di chitarre e mandolini? Non scherziamo, dove andremo a finire? Non c’è molto da ridere, se pensate che Giorgia Meloni se la prende con Imagine di John Lennon… Il lupo, il vizio, ecc. ecc.
Dunque la canzone non si sente, non passa all’Eiar, la radio, ma la canticchia mezza Italia, divertita, di nascosto, l’infantile Crapa pelada ritmata con curvature vocalese nel ritornello, così americana, esotica, divertente; nei locali da ballo la si canta alla fine, quando un po’ di gente se n’è andata, anche le guardie: carboneria jazz degli anni Trenta.
Il fatto è che nel 1936, in Italia, quando la canzone conquista tutti, “Crapa Pelada” è uno solo. Lui, il mascellone volitivo, il duce dell’Impero, la macchietta solenne del fascismo, l’assassino di Palazzo Venezia. Ridere del potere, ammiccare, fischiettare, alludere, sono tutte cose che i regimi temono come la peste nera. Canticchiare Crapa pelada ti può costare la galera: un grande successo semiclandestino.
La storia delle censure fasciste alle canzonette è vasta e in certi casi anche esilarante. Quando Italo Balbo si schianta in aereo, per dire, diventerà un problema anche cantare “Maramao perché sei morto” (Consiglio-Panzeri, 1939, esecuzione del Trio Lescano), con quel verso meraviglioso e italianissimo, “Pan e vin non ti mancava”, e quindi che cazzo andavi a schiantarti nei cieli di Tobruk? Malumori nel regime, canzonette divertenti, fischiettate come segnali, una resistenza piccola, passiva, fatta di minimi gesti, segni di riconoscimento, bastava una strofa e si sapeva come la pensavi.
Poi, il regime finiva come si sa, “Crapa pelada”, quello vero, pure, e nel 1945 il Quartetto Cetra ne incideva – sembra un festeggiamento – una versione portentosa, prima melodica e poi (mi scuso) swinghissima, vorticosa, che diceva sì, certo, usiamo lo swing per cantare filastrocche assurde, cretinate, frittate e tortelli, ma anche per dire che si può, finalmente. Si liberava tutto, si liberava anche una canzone. Grande successo.
Che Crapa pelada sia poi finita nella raffinatissima colonna sonora di Breaking Bad, e quindi definitivamente consegnata al culto pop dei nostri anni, può essere un caso, ma ne fa in qualche modo uno standard del jazz mondiale, con milioni di visualizzazioni, una cosa che non morirà, andrà avanti ancora, da quando tre fratelli di Milano diedero una manica di botte al Caravaggio.
 Ha fatto bene, benissimo, Virginia Raggi, sindaca di Roma, a bloccare sul nascere l’ipotesi di un museo del fascismo. Ha fatto bene chi aveva presentato la mozione (tre consiglieri dei 5 stelle), a ritirarla. Con l’aria che tira, coi i neofascisti che occupano palazzi (Casa Pound), che difendono gli stragisti della stazione di Bologna (il senatore Ruspandini, di Fratelli d’Italia), che si vestono da nazisti (Gabrio Vaccarin, eletto a Nimis, Udine, con Fratelli d’Italia), che vanno a cene in ricordo del duce (il candidato governatore delle Marche Acquaroli, sempre Fratelli d’Italia), si rischia l’effetto celebrazione. O una pagliacciata tipo Predappio. O un’oscenità tipo il mausoleo del criminale Graziani ad Affile. Insomma, no, grazie.
Ha fatto bene, benissimo, Virginia Raggi, sindaca di Roma, a bloccare sul nascere l’ipotesi di un museo del fascismo. Ha fatto bene chi aveva presentato la mozione (tre consiglieri dei 5 stelle), a ritirarla. Con l’aria che tira, coi i neofascisti che occupano palazzi (Casa Pound), che difendono gli stragisti della stazione di Bologna (il senatore Ruspandini, di Fratelli d’Italia), che si vestono da nazisti (Gabrio Vaccarin, eletto a Nimis, Udine, con Fratelli d’Italia), che vanno a cene in ricordo del duce (il candidato governatore delle Marche Acquaroli, sempre Fratelli d’Italia), si rischia l’effetto celebrazione. O una pagliacciata tipo Predappio. O un’oscenità tipo il mausoleo del criminale Graziani ad Affile. Insomma, no, grazie.
Ma come sarebbe veramente un museo del fascismo? Ecco, in esclusiva, il percorso della visita.
Stanza uno. Il visitatore entra in un grande salone dove viene bastonato da alcuni arditi che dicono di farlo per la Patria. Uno speciale software riconosce gli intellettuali che devono bere, per continuare la visita, due bottiglie di olio di ricino. Entusiasmo in Fratelli d’Italia.
Stanza due. Un po’ contuso, il visitatore entra nella seconda stanza, dove gli viene sottoposto un questionario: ti piace il museo? Chi risponde “no” perde il lavoro, viene licenziato o arrestato sul posto. C’è anche una domanda specifica: “Ti chiami Matteotti?”. Nessuno ha il coraggio di rispondere “sì”. Addetti di Fratelli d’Italia controllano i documenti per scovare chi ha mentito.
Stanza tre. I fasti dell’Impero. Il visitatore viene costretto a donare al museo la sua fede nuziale e tutti gli oggetti d’oro che indossa per finanziare l’allestimento sulla presa di Addis Abeba. Si tratta di una donazione spontanea, chi non aderisce viene riaccompagnato alla stanza uno.
Stanza quattro. Nuovo questionario, con una sola domanda: “Sei ebreo?”. Chi risponde “no” può continuare la visita, chi risponde “sì” viene accompagnato alla stazione per un viaggio in Germania, o direttamente alle Fosse Ardeatine.
Stanza cinque. Stanza “esperienziale”. I visitatori sono invitati a spezzare le reni alla Grecia. Dopo ingenti perdite e una considerevole figura di merda, gli addetti di Fratelli d’Italia telefonano ai tedeschi chiedendo aiuto.
Stanza sei. Siamo a metà del percorso, i visitatori cominciano a capire cosa fu il fascismo. Vengono equipaggiati con scarpe di cartone e fucili del secolo prima e mandati in Russia a fare 14.000 chilometri a piedi nella neve.
Stanza sette. Stanza interattiva, gioco di ruolo. I visitatori devono guidare interi reparti di SS a sterminare la popolazione inerme di villaggi e paesi. Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, e altre decine e decine di posti. Chi aiuta a uccidere donne e bambini ha uno sconto al bookshop.
Stanza otto. Il visitatore, ormai un po’ provato e con i nervi a fior di pelle, non ne può più, vuole farla finita in fretta. Viene invitato dagli addetti di Fratelli d’Italia a vestirsi da tedesco e scappare verso la Svizzera. Auguri!
Stanza nove. Sezione “visitare l’Italia”, piazza Fontana, Milano.
Stanza dieci. Sezione “visitare l’Italia”, piazza della Loggia, Brescia.
Stanza undici. Sezione “visitare l’Italia”, stazione di Bologna.
A questo punto i visitatori sopravvissuti hanno capito cosa fu il fascismo, e cos’è ancora oggi, escono dalla visita guidata decisamente scossi. Alcuni intellettuali vicini a Fratelli d’Italia spiegano che però, dalla biglietteria al guardaroba, il museo del fascismo ha fatto anche cose buone.
 Il convegno che si svolse a Milano nel 1630 finì malissimo. Il titolo, “La peste non esiste” era suggestivo e carico di sottintesi, si sosteneva tra le altre cose che l’epidemia fosse una favola messa in giro dai poteri forti perché un radical-chic come il Manzoni potesse, duecento anni dopo, scrivere un libro di successo. I soliti intellettuali staccati dalla realtà, ovvio, mentre la gente del popolo veniva chiusa in casa e poteva appena portare a pisciare il cane, due onesti lavoratori lombardi come Renzo e Lucia non riuscivano a sposarsi per oltre cinquecento pagine, all’Inps si giravano i pollici e gli imprenditori chiedevano sussidi. L’Innominato non metteva la mascherina, un gesto di ribellione.
Il convegno che si svolse a Milano nel 1630 finì malissimo. Il titolo, “La peste non esiste” era suggestivo e carico di sottintesi, si sosteneva tra le altre cose che l’epidemia fosse una favola messa in giro dai poteri forti perché un radical-chic come il Manzoni potesse, duecento anni dopo, scrivere un libro di successo. I soliti intellettuali staccati dalla realtà, ovvio, mentre la gente del popolo veniva chiusa in casa e poteva appena portare a pisciare il cane, due onesti lavoratori lombardi come Renzo e Lucia non riuscivano a sposarsi per oltre cinquecento pagine, all’Inps si giravano i pollici e gli imprenditori chiedevano sussidi. L’Innominato non metteva la mascherina, un gesto di ribellione.
Ora, per fortuna, è tutto diverso: al convegno organizzato in Senato da Vittorio Sgarbi il livello era decisamente più alto, infatti è intervenuto il famoso virologo Andrea Bocelli con un argomento che ha convinto tutti: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho conosciuto nessuno che sia andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?”. Giusto, implacabile, non fa una piega, mi ha convinto: anch’io non ho mai conosciuto nessuno colpito da un fulmine, quindi mi pare palese che i fulmini non esistono, saranno un’invenzione di Bill Gates, o di Saviano, o delle Ong, tutta gente senza cuore che chiude in casa milioni di persone per impedire a Salvini di girare l’Italia baciando salami e capocolli. I solti comunisti, insomma, gli stessi che hanno diffuso la foto dei camion militari che portano via i morti da Bergamo.
Non mi pronuncio sul valore scientifico del convegno, che mi sembra altissimo anche grazie a Bocelli, ma leggo che un certo Angelo Giorgianni ha parlato del Covid come di “un’ingegneria genetica per un colpo di Stato globale”. Interessante. E poi c’era un nutrizionista del Centro di Educazione al Dimagrimento, il dottor Franco Trinca, che se l’è presa con “il vaccino di Bill Gates”, che sarebbe “eugenetica nazista” e “Chissà cosa ci mettono dentro”, forse cose che fanno ingrassare, maledizione.
Va bene, mi avete convinto, mi iscrivo ai negazionisti, dopotutto non conosco nessuno che sia morto nella tragedia del Vajont, quindi sono propenso ad accettare il fatto che la cosa non sia mai successa, forse anche quella un’invenzione di Bill Gates e dei radical-chic, come del resto il bombardamento di Dresda (conoscete qualcuno che sia morto a Dresda? No, vero? Visto?).
Ora non c’è bisogno di essere fini psicologi per capire che la gente mente volentieri a se stessa per allontanare ombre e paure. È lo stesso meccanismo per cui il marito che trova un uomo nell’armadio pensa che sia il falegname che lo sta riparando, giusto? Dunque c’è il rischio che il pensiero negazionista cresca e prosperi, con due azioni parallele: negare la realtà da un lato e, se proprio bisogna accettarla, dare la colpa a qualcun altro. Ultimamente ai migranti, che sarebbero i nuovi untori (dopo i cinesi), e qui ci viene in aiuto un’altra virologa illustre, Annalisa Chirico, che garantisce quasi da sola, a mani nude, l’impianto ideologico-culturale di Salvini, compito titanico.
Pensa cosa fa la gente pur di non parlare di Attilio Fontana e dei camici del cognato, anche se credo che le finalità del prestigioso convegno fossero altre e più nobili: dare finalmente un po’ di visibilità all’organizzatore Vittorio Sgarbi, che in effetti ne ha poca, poverino, e in qualche modo deve farsi notare, visto il suo noto aplomb elegante, misurato e mai scomposto che i media trascurano.
 Ammetto di non aver studiato a lungo, ma mi pare di aver capito che l’unica abilità riconosciuta di Kim Kardashan sia usare in modo creativo il cospicuo sedere, oltre ad avere un marito, tale Kanye West, di professione rapper, candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Del quale – all’inizio distrattamente, ma sempre più avvinto secondo dopo secondo – ho visto un comizio elettorale in cui promette (tra altre cose, non tutte comprensibili) un milione di dollari a chi concepisce un figlio. Niente male: se aggiungesse uno yacht e una tenuta agricola in Arkansas sarebbe un buon incentivo alla natalità (ci metterei anche un mitra M16, non di peluche). Troppo facile prendersela con mister West, e va detto che la storia americana è piena di questi candidati “indipendenti”, pittoreschi, caricaturali. I più anziani e i più rockettari, ricorderanno le numerose candidature di Jellow Biafra, cantante dei Dead Kennedy’s (eccellente gruppo punk californiano) che aveva nel suo programma campi da golf nelle prigioni federali e nuove divise per la polizia: da clown. Un dadaista, insomma.
Ammetto di non aver studiato a lungo, ma mi pare di aver capito che l’unica abilità riconosciuta di Kim Kardashan sia usare in modo creativo il cospicuo sedere, oltre ad avere un marito, tale Kanye West, di professione rapper, candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Del quale – all’inizio distrattamente, ma sempre più avvinto secondo dopo secondo – ho visto un comizio elettorale in cui promette (tra altre cose, non tutte comprensibili) un milione di dollari a chi concepisce un figlio. Niente male: se aggiungesse uno yacht e una tenuta agricola in Arkansas sarebbe un buon incentivo alla natalità (ci metterei anche un mitra M16, non di peluche). Troppo facile prendersela con mister West, e va detto che la storia americana è piena di questi candidati “indipendenti”, pittoreschi, caricaturali. I più anziani e i più rockettari, ricorderanno le numerose candidature di Jellow Biafra, cantante dei Dead Kennedy’s (eccellente gruppo punk californiano) che aveva nel suo programma campi da golf nelle prigioni federali e nuove divise per la polizia: da clown. Un dadaista, insomma.
Ora c’è un piccolo problema: che le distanze tra lo sberleffo situazionista e quelli che ci credono veramente si sono assottigliate fino a scomparire, e questo anche per merito di un presidente in carica, Donald Trump, che ogni giorno pone il mondo davanti al dilemma classico: è matto o finge di? Insomma, con quale diritto sghignazziamo davanti a un rapper se a capo del mondo, con la valigetta dell’attacco nucleare, c’è uno che dallo studio ovale fa pubblicità ai fagioli di cui la figlia è testimonial? O che teorizza le iniezioni di candeggina contro il Covid? O che… il povero Donald è costretto a inventarsene una al giorno, un po’ come qui (in sedicesimo) sono costretti a fare alcuni bei tomi sovranisti che tifano per lui.
Per farla breve – e scusandomi con gli osservatori degli States che si sforzano di raccontarci quell’universo parallelo – bisognerebbe capire come diavolo è successo che l’America sia passata da colosso politico-militar-culturale che “ci ha colonizzato l’inconscio” (cit: Wim Wenders) a una specie di immenso circo con la donna barbuta, il cane che conta fino a otto, il presidente che vuole comprare la Groenlandia, un posto di matti armati fino ai denti.
Sempre casualmente, come per il comizio di Kanye West, si può inciampare nel sito di Turning Point Usa, formazione studentesca di sostegno a Trump, e anche in quel caso bisogna affrontare qualche secondo di spiazzamento: è uno scherzo o dicono sul serio? A parte le solite fregnacce ultra-liberiste (per esempio la maglietta “Le tasse sono un furto”, che potrebbero attecchire anche qui presso i nostri liberisti alle vongole), ci sono cose assai interessanti, come il censimento (nomi, cognomi, foto) dei docenti universitari di tendenze liberal, vere liste di proscrizione e il divertente slogan “Il capitalismo aiuta i poveri”.
C’era un confine, una volta, tra la caricatura e la realtà, e ora pare che il confine sia scomparso, che follia ideologica e grottesco non siano più distinguibili. “Gesù mi ha detto di comprare un fucile mitragliatore” non è più una battuta alla Woody Allen, è quello che dicono (peggio: pensano!) in molti, la metamorfosi del paradosso in realtà è sempre spaventosa, e la percezione diffusa che si ha dell’America oggi è quella di una specie di manicomio a cielo aperto, dove quando si annuncia una pandemia globale la gente si mette in fila per comprarsi un mitra. Fa ridere, ma mica tanto.
 E’ passata un po’ sottotraccia, un po’ nascosta, un po’ spazzata sotto il tappeto, la notizia che siamo meno, sempre meno. Noi italiani, si intende.
E’ passata un po’ sottotraccia, un po’ nascosta, un po’ spazzata sotto il tappeto, la notizia che siamo meno, sempre meno. Noi italiani, si intende.
Nel 2019 abbiamo fatto 19mila bambini in meno dell’anno precedente, toccando così, dice l’Istat, il punto più basso dall’unità d’Italia. Una curva in discesa, perché i bambini hanno questo vizio di abbassare l’età media, e se non arrivano loro l’età media si alza un bel po’, e poi la prevalenza dell’anziano fa in modo che la popolazione fertile sia sempre meno numerosa, e allora si fanno meno bambini e via così.
Non è solo a causa della carenza strutturale di nuovi italiani col pannolino che ci stiamo assottigliando. Bisogna aggiungere al bilancio i 126mila italiani che nel 2019 hanno fatto ciao ciao con la manina trasferendosi all’estero, e poi, a questi, sommare 56mila stranieri residenti in Italia (altri italiani, quindi) che hanno deciso di cambiare aria, magari verso paesi dove non vengono diuturnamente insultati e minacciati da un pittoresco baciatore di salami e dai suoi tifosi. Esilarante in proposito il titolo di Libero: “Anche gli stranieri ci snobbano”. C’è da capirli, avranno letto certi titoli di Libero.
Cabaret sovranista a parte, il saldo dei cittadini che pagava tasse e contributi qui e che ora paga tasse e contributi in altri paesi è di 25mila in più nel 2019 sul 2018), che già era stato un anno record. In una logica trumpiana cara ad alcuni pupazzi della destra bisognerebbe fare un muro ai confini, non per impedire l’ingresso agli immigrati brutti sporchi e cattivi, ma per non fare uscire gli italiani.
Ah, già. Prima gli italiani, certo. Il dibattito (un po’ stitico, si diceva) si avvita un po’, e i massimi pensatori si arrovellano per cercare di spiegare come mai facciamo meno figli, dannazione. Ma è un dibattito antico e noioso, mentre la domanda dovrebbe essere ribaltata: perché diavolo due italiani normali, medi, onesti, che vivono del proprio lavoro (meglio, dei loro mille lavoretti appiccicati con lo scotch, solubili e precari, revocabili) dovrebbero fare un bambino? In generale, uno sceglie imprese più facili, tipo scalare l’Everest con le infradito. Il problema è anche che questa faccenda dei bambini che mancano all’appello per mancato concepimento diventano qui e là, periodicamente, nel modo carsico della politica italiana, oggetto di propaganda, e ancora ricordiamo l’esilarante “mille asili in mille giorni” di quello là, parlandone da vivo.
Poi tutti incrociano grafici, disegnano tabelle, e a nessuno che venga in mente di sovrapporre la curva del calo demografico alla curva della sicurezza del posto di lavoro, insomma agli effetti delle leggi che in questi ultimi dieci anni (e più) hanno reso il lavoratore una variabile dipendente sacrificabile e comprimibile a piacere, mentre i profitti sono sacri e intoccabili. Bizzarro strabismo davanti a una verità incontestabile: se fai un figlio devi essere sicuro di dargli da mangiare, di farlo studiare e di assicurargli una vita almeno decente, tutte cose su cui una coppia intorno ai trent’anni, oggi, fa sempre più fatica a scommettere. La logica del “tutti licenziabili, hurrà!, così assumeranno altri!”, dicono le tabelle, non funziona e fa danni. Però, strano a dirsi, l’analisi si ferma quasi sempre all’elenco dei numeri e ai sospiri preoccupati, che è un po’ come stupirsi dell’allagamento dopo aver aperto tutti i rubinetti e sigillato gli scarichi. Poi, con l’acqua alle ginocchia, tutti a stupirsi: non fate più figli. Ehi! Voi! Come mai?
 Altro giro, altra corsa, altro esponente di Fratelli d’Italia che inneggia al Ventennio, altre polemiche, altre gustose minimizzazioni, altri articoli sui giornali, sui siti, altri appelli, pensosi corsivi e sacrosante prese per il culo. La questione Meloni-nostalgici fascisti si configura ormai come la storiella del criceto e della ruota: non passa giorno che non ci sia un caso di apologia del fascismo ad opera di qualche fratellino d’Italia (o lista collegata), e la competizione più entusiasmante all’interno del partito è aperta: si vedrà a fine campionato se la corrente maggioritaria sarà quella di chi si veste da SS o quella degli arrestati per ‘ndrangheta, una bella gara.
Altro giro, altra corsa, altro esponente di Fratelli d’Italia che inneggia al Ventennio, altre polemiche, altre gustose minimizzazioni, altri articoli sui giornali, sui siti, altri appelli, pensosi corsivi e sacrosante prese per il culo. La questione Meloni-nostalgici fascisti si configura ormai come la storiella del criceto e della ruota: non passa giorno che non ci sia un caso di apologia del fascismo ad opera di qualche fratellino d’Italia (o lista collegata), e la competizione più entusiasmante all’interno del partito è aperta: si vedrà a fine campionato se la corrente maggioritaria sarà quella di chi si veste da SS o quella degli arrestati per ‘ndrangheta, una bella gara.
Si è detto in lungo e in largo del consigliere comunale di Nimis (Udine) vestito da nazista, tal Gabrio Vaccarin, che nessuno aveva mai sentito nominare finché non hanno cominciato a girare foto in cui compare impettito davanti a un ritratto di Hitler, agghindato come per dirigere un campo di sterminio, croce di ferro inclusa.
Meno scalpore, per distrazione dei media, ha fatto il manifesto elettorale di tal Gimmi Cangiano, candidato in Campania per la sora Meloni, che non solo ha messo lo slogan “Me ne frego” sui suoi cartelloni elettorali, ma ci ha pure scritto sotto: “La più alta espressione di libertà”. Non fa una piega, quanto a espressione di libertà. Certo, poteva scegliere altri slogan, per esempio “Cago sul marciapiede”, che anche quella, ammetterete, è un’alta espressione di libertà, come anche “Taglio le gomme alle macchine in sosta”, o “Butto in mare l’olio esausto della mia fabbrichetta”, che sottolinea l’insofferenza del cittadino martoriato dalla burocrazia e dalle costrizioni della legge.
Mi fermo qui con gli esempi perché per correttezza giornalistica dovrei elencare anche le difese puntuali e articolate che ogni volta gli esponenti di FdI devono inventarsi per giustificare o minimizzare: una volta “non è iscritto”, un’altra volta “è una ragazzata”, oppure “è stata una leggerezza” o ancora “era carnevale”. Insomma, per dirla con la lingua loro, otto milioni di piroette per allontanare da sé i sospetti di fascismo, preoccupazione un po’ inutile visto che tre indizi fanno una prova, dieci indizi fanno una certezza e dopo cento indizi dovrebbero intervenire i partigiani del Cln con lo schioppo. Ma sia: per farsi perdonare ed allontanare i sospetti, la Meloni candida alla presidenza della regione Marche un suo deputato, tal Francesco Acquaroli, noto alle cronache soprattutto per una cena celebrativa della marcia su Roma (Acquasanta Terme, 28 ottobre 2019). Sul menu, accanto al timballo e allo spallino di vitello al tartufo campeggiavano nell’ordine: un fascio littorio, un’aquila con la scritta “Per l’onore dell’Italia”, il motto “Dio, patria e famiglia”, una foto del duce volitivo e machissimo con la frase “Camminare, costruire e se necessario combattere e vincere”. Si vede che non era necessario, perché persero malamente e il celebrato Mascellone camminava sì, ma verso la Svizzera vestito da soldato tedesco, bella figura.
Fa bene Gad Lerner (su questo giornale) a chiedere alla sora Meloni di dissociarsi una volta per tutte dalla retorica fascista dei suoi eletti e dei suoi militanti, ma dubito che succederà: quella retorica, un po’ grottesca e molto ignorante, risibile e feroce, è l’acqua in cui nuota Fratelli d’Italia, gli slogan fascisti e i vestiti da gerarchi sono il plancton di cui si nutre, e non si è mai visto un pesce svuotarsi l’acquario da solo. Bisognerebbe aiutarlo come l’altra volta, settantantacinque anni fa.
 Scrivetela su un foglietto e tenetela nel taschino della giacca, o in uno scomparto della borsa, nello zaino, in una tasca dei jeans. Poi tiratela fuori alla bisogna e leggetela ad alta voce: “Non sono d’accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”, firmato Voltaire. Fico, eh? Diciamolo, bella frase: fa colto, spaccia chi la pronuncia per persona di buone letture, anche se è convinto che Voltaire sia un difensore del Paris Saint Germain e non un filosofo letterato del diciottesimo secolo. Siamo, insomma, davanti a una citazione liofilizzata, facile da ricordare, perfetta e pronta all’uso ogni volta che qualcuno fischia Salvini nelle piazze italiane (succede spesso). Meno male che Voltaire è morto (nel 1778, quasi due secoli e mezzo fa), altrimenti Salvini dovrebbe girargli qualche prebenda (magari non tutti i famosi 49 milioni, ma una percentuale sì).
Scrivetela su un foglietto e tenetela nel taschino della giacca, o in uno scomparto della borsa, nello zaino, in una tasca dei jeans. Poi tiratela fuori alla bisogna e leggetela ad alta voce: “Non sono d’accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”, firmato Voltaire. Fico, eh? Diciamolo, bella frase: fa colto, spaccia chi la pronuncia per persona di buone letture, anche se è convinto che Voltaire sia un difensore del Paris Saint Germain e non un filosofo letterato del diciottesimo secolo. Siamo, insomma, davanti a una citazione liofilizzata, facile da ricordare, perfetta e pronta all’uso ogni volta che qualcuno fischia Salvini nelle piazze italiane (succede spesso). Meno male che Voltaire è morto (nel 1778, quasi due secoli e mezzo fa), altrimenti Salvini dovrebbe girargli qualche prebenda (magari non tutti i famosi 49 milioni, ma una percentuale sì).
Avviso doveroso: non si vuole qui parlare – che noia – del mangiatore compulsivo di ciliegie, dell’uomo-selfie (anche ai funerali), insomma, del più cinico e risibile arruffapopolo in circolazione, bensì di quella sindrome ultra-tafazzista dei presunti avversari che lo difendono sventolando una frase di Voltaire per sembrare ragionevoli e moderati. La quale frase, tenetevi forte, non è per niente di Voltaire, ma viene da un saggio del 1906 la cui autrice, Evelyn Beatrice Hall, si è più volte scusata per averla attribuita al filosofo, uno sgarbo sempiterno al vecchio parruccone Voltaire il quale è più o meno passato alla storia per una frase che non ha detto e nemmeno pensato, ma che viene usata regolarmente per difendere l’indifendibile e segnatamente per bacchettare chiunque contesti Salvini.
Le “Brigate Voltaire”, insomma, non dormono mai: se si fischia qualcuno (purché di destra), ecco alzarsi puntualissimo il pipicchiotto voltairiano sedicente di sinistra che la ricorda tra virgolette. Ultimo, dopo la cacciata di Salvini da Mondragone, l’irresistibile Roberto Giachetti, che ci ha fatto la grazia di non citare direttamente l’aforisma farlocco del grande letterato, ma ne esprime con parole sue il concetto: “Non esiste al mondo che in un paese democratico ad un esponente politico (per di più il segretario del maggiore partito italiano) venga impedito di fare un’iniziativa politica”. Gioco, partita, incontro: ci aspettiamo a stretto giro un digiuno giachettiano, uno sciopero della fame dei suoi.
Che poi, quella di Salvini a Mondragone non era “un’iniziativa politica”, era una provocazione bella e buona. Andare a parlare in un posto segnato da un’emergenza sanitaria pericolosa, incendiato da una situazione esplosiva, con una comunità di stranieri (bulgari questa volta) sfruttati all’inverosimile ed eversivamente additati come untori non è un’iniziativa politica, è correre verso l’incendio portando taniche di benzina (ci stupisce l’autorizzazione del Viminale, semmai). Se invece si volesse fare a Mondragone un’iniziativa politica seria, si potrebbe andare a chiedere di vedere i contratti di lavoro dei famosi bulgari, i loro contratti d’affitto, le posizioni Inps e Inail, e magari pure incrociare i dati per capire se quelli che fanno lavorare i braccianti bulgari nei campi a un euro e mezzo l’ora non siano per caso gli stessi che gli affittano un posto letto a prezzi da costiera Amalfitana. Ecco, quella sì, sarebbe un’iniziativa politica. Purtroppo non la farà Voltaire, che è morto, e nemmeno Giachetti, che è vivo e lotta insieme a lui (a Salvini, non a Voltaire).
 Alla fine, il primo a farsi la foto sul ponte di Genova redivivo è stato lui, Salvini Matteo, cioè lo stesso che nemmeno alla cerimonia di lutto e dolore per i morti nel crollo aveva resistito alla tentazione dei selfie sorridenti con i fans. Non conosco la borsa valori delle photo opportunity, quindi non so dire in quale percentuale una foto sul ponte di Genova possa riparare i danni dello show veronese delle ciliegie, compulsivamente ingurgitate ascoltando un discorso su neonati deceduti all’ospedale. Boh, gli strateghi dell’immagine salviniana avranno fatto i loro conti. Una cosa è certa: esiste, al posto della politica, una rappresentazione mediatica, un calcolo semantico (spesso sbagliato), un gioco molto simile alla guerra delle copertine che si fanno i giornali di gossip. Insomma, divertente, ma ormai è noto che quando la gente chiede “Ahah! Hai visto Salvini?”, non si aspetta un discorso politico, ma la mattana del giorno, il numero, lo sketch, la battuta, il balletto. Cosa ci dirà Salvini lo sappiamo già, e sappiamo pure che si tratta di ricette variabili a seconda del momento e dell’opportunità. Chiudiamo tutto, apriamo tutto, meno tasse, più soldi, più debito, meno debito, tutto facile e immediato. Inutile insistere oltre, sono cose che si sanno.
Alla fine, il primo a farsi la foto sul ponte di Genova redivivo è stato lui, Salvini Matteo, cioè lo stesso che nemmeno alla cerimonia di lutto e dolore per i morti nel crollo aveva resistito alla tentazione dei selfie sorridenti con i fans. Non conosco la borsa valori delle photo opportunity, quindi non so dire in quale percentuale una foto sul ponte di Genova possa riparare i danni dello show veronese delle ciliegie, compulsivamente ingurgitate ascoltando un discorso su neonati deceduti all’ospedale. Boh, gli strateghi dell’immagine salviniana avranno fatto i loro conti. Una cosa è certa: esiste, al posto della politica, una rappresentazione mediatica, un calcolo semantico (spesso sbagliato), un gioco molto simile alla guerra delle copertine che si fanno i giornali di gossip. Insomma, divertente, ma ormai è noto che quando la gente chiede “Ahah! Hai visto Salvini?”, non si aspetta un discorso politico, ma la mattana del giorno, il numero, lo sketch, la battuta, il balletto. Cosa ci dirà Salvini lo sappiamo già, e sappiamo pure che si tratta di ricette variabili a seconda del momento e dell’opportunità. Chiudiamo tutto, apriamo tutto, meno tasse, più soldi, più debito, meno debito, tutto facile e immediato. Inutile insistere oltre, sono cose che si sanno.
Più interessante è invece il meccanismo per cui un leader politico, o in generale una figura pubblica, tende a impersonare, e addirittura a superare, la sua caricatura, esasperando proprio i tratti grotteschi che gli si rimprovera. Salvini, dal Papeete in poi, ha deciso di creare una specie di iper-Salvini, cioè di diventare una macchietta di se stesso pensando che questo pagasse in termini di popolarità, che lui confonde con la politica. Si dirà che la colpa è dei media: se si pubblicassero foto di Salvini quando Salvini parla di politica lo vedremmo una volta al mese, mentre ormai la notizia è la foto di Salvini che si fa una foto da solo. E vabbè, non è certo una cosa nuova questa di confondere popolarità e politica, ma la differenza con l’oggi è che un tempo si cercava di coniugare popolarità e credibilità, cosa oggi considerata facoltativa. Per cui abbiamo paginate intere su un ex generale dei carabinieri vestito di arancione che abbina al ribellismo reazionario dichiarate frequentazioni con gli alieni, per esempio. E gli si dà spazio lo stesso, in lungo e in largo, invece di chiamare l’ambulanza.
Oppure abbiamo l’autocaricatura per eccellenza, il modello imprenditoriale che consiglia e indirizza, quando non si mette a sbraitare: “Questi qui sono gente matti”, all’indirizzo del governo. Flavio Briatore, ascoltato spesso come un guru dell’economia con la sublime motivazione che sa far funzionare un bar, lascia stupefatti per la sua aderenza alla propria stessa macchietta. E’ uno che dice “tachipirinha”, confondendo medicine e long drinks, che si lamenta delle piste ciclabili perché gli rallentano il macchinone da milionario, insomma, è un cinepanettone ambulante, periodicamente convocato a discettare delle sorti del Paese, una specie di Sgarbi dei privé. Questo potrebbe spiegare la crisi della commedia all’italiana, che fu una delle nostre enormi ricchezze passate. Quegli arcitaliani, quei magnifici caratteristi, sono tra noi. La realtà che si fa farsa è assai difficile da rappresentare se già esiste in natura in così perfetta forma. La cosa strabiliante è che si confonda – e che lo facciano i media assetati di clic e di ascolti – tutto ciò con la politica, come fare mediocre cabaret oratoriale e credersi Shakespeare.
 Se grattate via la polvere, lo struggente dibattito se Conte si farà un suo partito, le baruffe interne ai 5s, le valigette venezuelane disegnate coi trasferelli, lo spettacolino quotidiano delle destre melon-salviniane, insomma, se togliete il rumore di fondo, la melodia risalterà abbastanza chiara. Quello di cui si parla, malamente perlopiù, è il disegno che si può dare al Paese, nei prossimi anni e forse decenni, facendo nuovi debiti, certo, ma per una volta, si direbbe, non per tappare i buchi, ma per rilanciare.
Se grattate via la polvere, lo struggente dibattito se Conte si farà un suo partito, le baruffe interne ai 5s, le valigette venezuelane disegnate coi trasferelli, lo spettacolino quotidiano delle destre melon-salviniane, insomma, se togliete il rumore di fondo, la melodia risalterà abbastanza chiara. Quello di cui si parla, malamente perlopiù, è il disegno che si può dare al Paese, nei prossimi anni e forse decenni, facendo nuovi debiti, certo, ma per una volta, si direbbe, non per tappare i buchi, ma per rilanciare.
Dunque, a dispetto di quelli che destra e sinistra non esistono più, e le ideologie sono morte, eccetera eccetera, c’è uno scontro in atto tra visioni del mondo – o almeno della gestione economica di una società complessa, che è la stessa cosa – contrapposte e differenti. Il quotidiano punzecchiamento di Confindustria al governo Conte, un pressing duro e dai toni non proprio diplomatici (“La politica che fa più danni del Covid”), tradisce un certo nervosismo. Tanti soldi in arrivo, il timore di non avere un governo automaticamente amico, come sempre avvenuto in passato, suggerisce agli industriali una strategia aggressiva, ma anche un po’ passiva, insomma, il tradizionale vittimismo seguito dal grido “all’arrembaggio”.
Il nemico è sempre quello, il fantasma dell’”ingresso dello Stato nell’economia”, per cui una volta (illo tempore) si deploravano Alfasud e panettoni, e oggi si fanno altri esempi. Come dice il capo Bonomi, Ilva e Alitalia sono la dimostrazione dei disastri della gestione pubblica. Dimentica forse che l’Ilva fu salvata dai disastri di un privato, che ora la gestisce una multinazionale privata che chiede prebende e sconti un giorno sì e l’altro pure. Quanto ad Alitalia, di capitani coraggiosi, e generosi imprenditori, e impavidi investitori poi atterrati coi piedi per terra si è perso il conto. E si è perso il conto anche dei sedicenti leader e capi di governo dell’epoca che esultavano per aver dato un’azienda sana ai privati e aver accollato i debiti a tutti noi. Una prece.
Ma sia: per condurre la sua battaglia, il fronte liberista (coi soldi nostri) usa due argomenti forti: la burocrazia e l’assistenzialismo, due cose brutte e ripugnanti al solo pronunciarle, tanto che nei talk politici alla parola “burocrazia” escono tutti con le mani alzate e si arrendono. E’ un buon argomento, insomma, popolare. Ma raramente si pensa, poi, che molta burocrazia vuol dire controlli, procedure, fare le cose secondo certe regole, e la pretesa di “cancellare la burocrazia”, come si sente dire ogni tanto, copre il desiderio, nemmeno nascosto, di far fuori le regole. Tutto più snello, tutto più veloce, tutto naturalmente meno trasparente e più infiltrabile da interessi zozzi.
La guerra del fronte padronale all’assistenzialismo, poi, è poderosa. Per mesi abbiamo assistito al bombardamento sul reddito di cittadinanza, sui casi di cronaca, sui furbetti, su quelli che stanno sul divano, eccetera eccetera. Il sottotesto (macché, il testo!) è che si spende per assistere le fasce più deboli invece di dare quei soldi a loro – loro la luminosa imprenditoria – che le farebbero lavorare. Una tesi che ha buona stampa, come si dice, cioè l’appoggio quasi monolitico dell’informazione. E così quando l’Inps comunica di aver scovato più di duemila aziende che facevano pasticci con la cassa integrazione, e migliaia di assunzioni predatate di parenti e amici per prendere soldi in modo truffaldino, la notizia è stata sepolta, lontanissima dalle prime pagine.
 Consigli di viaggio. Se vi capita di andare a Budapest, meravigliosa città imperiale, decaduta e fané, oggi ostaggio delle truppe di Orban, ma sempre un posto straordinario, prendetevi qualche ora per visitare lo Statue Park (qualche chilometro a sud della città). Lì – brutta periferia industriale – tra il 1989 e il 1990 vennero deportate decine di statue che abbellivano (?) il centro di Budapest, statue in onore del realismo socialista, immensi catafalchi in bronzo che gli ungheresi, almeno dalla repressione del 1956, odiavano ferocemente come emblemi dell’oppressione sovietica. All’ingresso del parco, vedrete due immensi stivali: erano quelli di Stalin e della sua gigantesca statua che sorgeva un tempo nel centro di Budapest e che venne abbattuta tra grida, e funi, e feste di popolo, proprio nel ’56. Ecco: sono rimasti gli stivali, che è quello che tutti si augurano dei tiranni.
Consigli di viaggio. Se vi capita di andare a Budapest, meravigliosa città imperiale, decaduta e fané, oggi ostaggio delle truppe di Orban, ma sempre un posto straordinario, prendetevi qualche ora per visitare lo Statue Park (qualche chilometro a sud della città). Lì – brutta periferia industriale – tra il 1989 e il 1990 vennero deportate decine di statue che abbellivano (?) il centro di Budapest, statue in onore del realismo socialista, immensi catafalchi in bronzo che gli ungheresi, almeno dalla repressione del 1956, odiavano ferocemente come emblemi dell’oppressione sovietica. All’ingresso del parco, vedrete due immensi stivali: erano quelli di Stalin e della sua gigantesca statua che sorgeva un tempo nel centro di Budapest e che venne abbattuta tra grida, e funi, e feste di popolo, proprio nel ’56. Ecco: sono rimasti gli stivali, che è quello che tutti si augurano dei tiranni.
Mi scuso per la deriva Tripadvisor che ha preso questa rubrichina, ma il fatto è che qualche giorno fa, a Bristol (Gran Bretagna) i manifestanti antirazzisti hanno abbattuto e buttato nel fiume (plop!) la statua di Edward Colston, responsabile della deportazione (traduco: rastrellamento, rapimento e vendita) di 800.000 schiavi alla fine del 1600. Il sindaco della città di Bristol ha in qualche modo approvato (è nero di origini giamaicane), e anche la scritta comparsa a Londra sotto il monumento a Churchill (“Era un razzista”) non è proprio campata per aria (chiedere agli indiani).
L’argomento è controverso ma facilmente riassumibile: bisogna prendere a picconate il passato, i suoi simboli, le celebrazioni monumentali di infami ingiustizie? Tutto il mondo applaudì convinto all’abbattimento della statua di Saddam a Baghdad, per esempio, e nessuno ebbe nulla da dire quando si fece saltare la svastica in cima ai principali edifici tedeschi dopo il ‘45. Strabiliante invece che al Foro Italico in Roma campeggi ancora, sul grande obelisco bianco, la scritta “Mussolini”.
Potremmo cavarcela così: lasciamo questa faccenda agli storici e alle folle incazzate. Nessuno pretende di abbattere le piramidi perché furono costruite a frustate dagli schiavi, ma qualche opera di decenza distruttiva, converrebbe tenercela cara, e magari imitarla.
Per fare un esempio da cui si potrebbe cominciare subito, meriterebbe qualche candelotto ben piazzato il mausoleo del generale Graziani, che sorge ad Affile dal 2012, per iniziativa del sindaco Ercole Viri (tutt’ora in carica nonostante le condanne per apologia di fascismo). Il mausoleo è un orribile manufatto, brutto architettonicamente e ripugnante per quel che rappresenta. Sopra c’è scritto “Patria e onore”, dove l’onore del generale Graziani è noto: un boia senza pari, che usava armi chimiche, che aveva per soprannome “macellaio del Fezzan”, che si macchiò di efferati crimini di guerra prima da viceré d’Etiopia e poi da comandante delle forze armate della Repubblica di Salò. Per dirla con linguaggio accademico, un vero pezzo di merda o, se preferite gli eufemismi, un assassino della peggior specie.
Il monumento, dunque, non è a Graziani, ma alla vergogna di uno Stato (l’Italia) capace di celebrare i peggiori delinquenti, e non in antica epoca storica, ma ai giorni d’oggi. Ecco. Ad Affile non c’è il fiume, e il monumento a Graziani non potrà fare la fine subacquea della statua dello schiavista Colston, peccato. Ma a tutto c’è un rimedio e, dal piccone alla dinamite, c’è anche la tecnologia per porre fine a una vergogna nazionale.
Qui c’è l’intervista al Tg3 su I cerchi nell’acqua. Grazie grazie a Laura Longo
 La memoria del pesce rosso è un problema nazionale. Mi spiace per il povero pesce rosso che passa per scemo al posto nostro, ma se preferite è la memoria della mosca che – sdeng – sbatte contro il vetro, poi fa un giro della stanza e – sdeng – risbatte contro il vetro, eccetera eccetera, all’infinito. Così, la smemoratezza sembra la regina dello scenario italiano, ad ogni livello, dall’infimo sagomato sul ridicolo (il generale Pappalardo) al Celeste (il Formigoni condannato per corruzione nella sanità chiamato a discettare di sanità in tivù), e su e giù per li rami, in tutta la filiera politica che non prevede solo leader più o meno eletti, ma commentatori, corsivisti, analisti, osservatori e perdigiorno vari.
La memoria del pesce rosso è un problema nazionale. Mi spiace per il povero pesce rosso che passa per scemo al posto nostro, ma se preferite è la memoria della mosca che – sdeng – sbatte contro il vetro, poi fa un giro della stanza e – sdeng – risbatte contro il vetro, eccetera eccetera, all’infinito. Così, la smemoratezza sembra la regina dello scenario italiano, ad ogni livello, dall’infimo sagomato sul ridicolo (il generale Pappalardo) al Celeste (il Formigoni condannato per corruzione nella sanità chiamato a discettare di sanità in tivù), e su e giù per li rami, in tutta la filiera politica che non prevede solo leader più o meno eletti, ma commentatori, corsivisti, analisti, osservatori e perdigiorno vari.
Si ride molto (amaro) sui negazionisti del Covid-19, su qualche centinaio di svalvolati che si riuniscono alitandosi in faccia e gridando nei microfoni che il virus l’hanno inventato per farci stare a casa (che nel caso del generale Pappalardo sarebbe già una buona cosa), che in realtà non esiste, che era una cospirazione mondiale ai danni di parrucchieri e guide turistiche, eccetera eccetera. E’ il livello più elementare di negazionismo: si nega ciò che è evidente a tutti allo scopo di farsi notare e di ricavarne qualche minimo tornaconto (e un seggio a ‘sto Pappalando dateglielo, dai, sora Meloni, che è dei vostri!). Ma non è un bel ridere: uno potrebbe chiedersi quali sono i criteri di selezione del personale dell’Arma, per esempio, se uno così è diventato generale.
Altri negazionismi, imperano, più potenti e subdoli. A livello ideologico, per esempio, paiono causati da amnesia certi discorsi ultra-liberisti. Di fronte a un sistema che chiaramente non ha retto il colpo, che si è dimostrato fragile e diseguale al massimo grado, si invoca più mercato – non meno (o più regolato). Il neocapo di Confindustria che dice in sostanza “tutti ‘sti soldi dateli a noi”, dimentica forse che finora è andata proprio così: li hanno dati a loro, tra decontribuzioni, finanziamenti, sconti, agevolazioni. E’ un negazionismo di tipo squisitamente economico: si nega ogni errore della classe imprenditoriale italiana, ogni mancanza di visione, ogni miopia, per chiedere ancora soldi, e fiducia, e “cambiare il paese”.
Più divertenti, perché sotterranee, mimetiche, quasi inconsce, certe amnesie erose dal tempo, come date per scontate. Esempio di scuola, i tagli alla Sanità. Non c’è stato, per tre mesi, confronto, talk, polemica, discussione o dibattito in cui qualcuno non deplorasse i tagli alla Sanità. E’ per quello che dobbiamo prendere i soldi del Mes, vincolati alla Sanità. E’ perché abbiamo tagliato i posti letto, o la medicina sul territorio, o il personale, che siamo stati con l’acqua alla gola per settimane. Lo dicono tutti, ma proprio tutti, anche – autonegazionismo – esponenti delle forze che votarono in Parlamento per i tagli alla Sanità. Un disturbo della memoria che riguarda anche commentatori e conduttori che deplorano, corsivisti che bacchettano, intervistatori che domandano. E uno si chiede – a proposito di Eraserhead, la mente che cancella – se quei commentatori e conduttori e intervistatori abbiamo detto qualcosa, ai tempi dei tagli alla Sanità, oppure se abbiano avallato l’idea corrente delle “razionalizzazioni” e delle “armonizzazioni” (cioè dei tagli). Negare, insomma, rimuovere, scordarsi, che vuol dire quasi sempre assolversi da eventuali colpe passate e candidarsi al “dopo” come nuovi. Candeggiati. La mosca, il pesce rosso, la memoria selettiva, perché tutto resti com’era.
Corre voce, nei corridoi della Regione Lombardia (rimbalzata su qualche giornale), che Giulio Gallera non passerà l’estate: prima verrà affiancato da una task force per arginare le sue geniali intuizioni in campo sanitario-virologico, e poi, verso luglio, allontanato discretamente. Tasso di rimpasto 0,2, cioè, secondo le teorie di Gallera, per sostituire Gallera ne serviranno cinque. Con cinque Gallera all’assessorato alla salute, si prevede un aumento di circa il 125 per cento delle battute spiritose su Gallera, il 56 per cento delle quali faranno abbastanza ridere, e quindi serviranno 2,3 persone senza senso dell’umorismo, ma a passeggio insieme, per far smettere di sghignazzare i lombardi.
 Si calcola che su dieci cittadini della Lombardia, nove e mezzo siano molto insoddisfatti, della sua gestione dell’emergenza Covid, e Gallera ha subito risposto che bisogna attrezzare un ospedale per quel povero lombardo rimasto tagliato in due dalle statistiche: se ne occuperà Bertolaso.
Si calcola che su dieci cittadini della Lombardia, nove e mezzo siano molto insoddisfatti, della sua gestione dell’emergenza Covid, e Gallera ha subito risposto che bisogna attrezzare un ospedale per quel povero lombardo rimasto tagliato in due dalle statistiche: se ne occuperà Bertolaso.
Ma prima le buone notizie: il tasso di contagio in Lombardia è dello 0,5 per cento, quindi per infettarsi (teoria Galleriana, 2020 dC) bisogna incontrare due positivi vestiti bene: uno ti tiene fermo e l’altro ti lecca (lo so, la scena è ripugnante, ma la scienza non può essere pietosa, ragazzi!). Quando il tasso di contagio scenderà allo 0,2, sarà sufficiente incontrare sul tram una squadra di basket tutta positiva, e quando si scenderà allo 0,1 per infettarci ci sarà bisogno di un coro di alpini, tutti positivi, che ti passano il fiasco. In quel caso – come si intuisce piuttosto raro – il tampone verrà fatto agli eredi nel 2026, gratis, ma solo se non sorpresi a limonare con 3,8 fidanzate positive.
Nessuno, si sa, pare un genio ai suoi contemporanei, successe a Galileo, figurati a Gallera, ma è certo che nei secoli futuri la teoria matematica galleriana assumerà per l’umanità un certo valore. Per esempio per un tasso di divorzio dello 0,3 per cento sarà necessario esibire al giudice 3,3 (periodico) amanti della moglie, o, in subordine una dozzina di figli illegittimi già laureati in legge, come papà. Ancora una volta, la teoria darà il suo meglio nel comparto della salute: per dare un euro alla sanità pubblica bisognerà darne due a quella privata, il che lascia intuire che la matematica Galleriana è già ampiamente applicata nelle zone più avanzate del Paese (l’intuizione fu di Formigoni, un matematico del passato, oggi ai domiciliari).
Anche nella dinamica della ricerca, Gallera ha innovato parecchio. Non più il vecchio metodo: esposizione del problema-dimostrazione-soluzione. La prassi introdotta da Gallera elimina il passaggio della dimostrazione (di solito sostituito da: lo dice l’università di… aggiungere una città a caso) e introduce quello dell’”ho ragione”. Immancabilmente, ogni equazione di Gallera è seguita da un’altra equazione che spiega che voi, cretini, non avete capito l’equazione prima, così lui è costretto a rispiegarla sbagliando di nuovo: i numeri li mette lui, ma i testi glieli scrive Billy Wilder buonanima.
E’ una teoria che si autosmentisce: secondo la matematica Galleriana perché Gallera abbia ragione bisogna che 17.345 persone mediamente intelligenti muoiano di colpo, Saturno sia allineato con Giove, e il Novara vinca la Champions League. E’ una cosa che può accadere ogni due miliardi di anni, cioè il tempo – secondo Gallera – che ci metterebbe il virus ad attaccare la periferia di Sondrio in mancanza di due positivi a passeggio insieme.
Diciamolo: è ora – per la scienza, per la Lombardia e per tutti noi – di restituire questo scienziato ai suoi studi, ai suoi laboratori, ai suoi calcoli. Una simile mente in contatto costante con la metafisica non può distrarsi con piccinerie pratiche come, per esempio, affrontare un’epidemia. Con rammarico, lasciamolo andare.
Chiedo scusa se parlo di Milano, la grande città che necessita di massiccia manutenzione nella sua narrazione, nel suo racconto, di una rifondazione urgente della sua leggenda costruita forsennatamente negli anni recenti a colpi di grattacieli, di Expo, di luccichìo modernista.  Aggiungiamo dunque al vasto capitolo di come il Covid cambierà le nostre vite, l’allegato dolente che dovrà ridisegnare la narrativa della “capitale morale” e “modello per il Paese”, la grande città europea che si è svegliata una mattina, scoprendosi “solo” città italiana, come le altre: feroce delusione per chi ci era cascato (quasi tutti).
Aggiungiamo dunque al vasto capitolo di come il Covid cambierà le nostre vite, l’allegato dolente che dovrà ridisegnare la narrativa della “capitale morale” e “modello per il Paese”, la grande città europea che si è svegliata una mattina, scoprendosi “solo” città italiana, come le altre: feroce delusione per chi ci era cascato (quasi tutti).
Dunque, ecco: la vernicetta brillante si è sfarinata in un paio di mesi, la mano di coppale che rendeva tutto luccicante è venuta giù quasi di colpo, e Milano si è trovata aggrappata al ricordo delle sue eccellenze per non guardare nel baratro delle diseguaglianze spaventose portate alla luce dal lockdown, dal fermo imposto, dalla crisi che morde e morderà. Si è svegliata, insomma, senza trucco, senza belletto, senza messa in piega, stordita come quando ci si guarda allo specchio e ci si trova, di colpo, invecchiati. Il sindaco Sala che sale sul Duomo e si affida alla Madonnina, per dirne una, non suona tanto diverso dal Salvini tonante che agitando il rosario affidava (proprio in quella piazza, ma sotto, raso terra) il Paese al Sacro Cuore di Maria; e davvero non si riesce a pensare a nulla di più lontano dal furore calvinista della città degli affari e dei dané, del “qui si lavora”.
Come sia nata la leggenda è difficile dire: una città non grande, che funziona bene, con la grande massa della sua piccola e media borghesia (dire “ceto medio” è ormai una finzione scenica) eternamente disposta a farsi sedurre dall’ideologia del primato economico, del “noi siamo migliori”. Ma sta di fatto: le grandi voci di Milano, quelle che l’hanno raccontata magnificamente per decenni, erano voci critiche, sarcastiche, impietose. Il Testori delle periferie, il Bianciardi de La vita agra, Fo non ne parliamo, ma anche la stralunata malinconia di Jannacci, le atmosfere cupe di Scerbanenco, la sanguinosa critica a un arricchimento repentino e ottundente di Lucio Mastronardi (maestro ahimé dimenticato). Raccontavano tutti – appena prima o durante il boom economico – le ombre cattive create dalle luci accecanti del “progresso” e della modernità. Maestri veri.
Poi, quasi più nulla. Dalla metà degli anni Ottanta, la favola fasulla della “Milano da bere” ha nascosto, se non cancellato le rughe della città, e Milano è rimasta per più di trent’anni impigliata in un racconto unidimensionale: la moda, il design, i grattacieli, le eccellenze, i soldi. Solo luci, e delle ombre vietato parlare. Tutti ricchi, tutte modelle, tutti designers: la percezione di Milano nel resto del paese (considerato miseramente Italia, mentre qui siamo in Europa, ossignùr) è stata questa, per anni, per decenni. Innaffiata, e concimata, e ideologizzata, tanto che bastava dubitarne o storcere il naso (si ricordino i dubbi su Expo) per essere accusati di disfattismo, di pessimismo che fa male agli affari.
Intanto, quando piove, un paio di quartieri si allagano (problema trentennale, e anche più), i sanitari devono trasferire in tutta fretta malati Covid ad altre stanze, meno allagabili, e il lockdown, con la città spaventata e zitta, ha rivelato un esercito di schiavi, cottimisti pedalatori che le consegnano il cibo a domicilio, due euro e spiccioli a recapito. Essendoci in giro solo loro per due mesi, Milano ha potuto vedere i suoi lavoratori poveri, resi visibili dallo spegnersi dello scintillìo. I costruttori di leggende – sempre funzionali al mercato, ovvio – non hanno fatto un buon servizio a Milano, hanno semmai il torto di averla trasformata in macchietta. Ora serve un racconto più vero. Milano se lo merita.
 Abituati al piccolo cabotaggio, al chiacchiericcio politico fatto di sgambetti, ripicche e testacoda, ci sfugge forse un dettaglio che non è un dettaglio, anzi è il punto centrale: con 150 miliardi a disposizione (le cifre sui soldi disponibili per affrontare la crisi, in prospettiva sono più o meno queste) si potrebbe, volendo, cambiare il Paese. Lo dico subito: all’ipotesi speranzosa – ai confini del misticismo – che dopo “saremo migliori” non do molto credito, e lascio a ognuno interpretare i numerosi segnali di incattivimento. E’ evidente a tutti, comunque, che la battaglia per chi gestirà quei soldi, come li distribuirà, con quali regole, con quali benefici, a chi, quando e in che misura, è più attiva che mai.
Abituati al piccolo cabotaggio, al chiacchiericcio politico fatto di sgambetti, ripicche e testacoda, ci sfugge forse un dettaglio che non è un dettaglio, anzi è il punto centrale: con 150 miliardi a disposizione (le cifre sui soldi disponibili per affrontare la crisi, in prospettiva sono più o meno queste) si potrebbe, volendo, cambiare il Paese. Lo dico subito: all’ipotesi speranzosa – ai confini del misticismo – che dopo “saremo migliori” non do molto credito, e lascio a ognuno interpretare i numerosi segnali di incattivimento. E’ evidente a tutti, comunque, che la battaglia per chi gestirà quei soldi, come li distribuirà, con quali regole, con quali benefici, a chi, quando e in che misura, è più attiva che mai.
Si segnala per tigna e determinazione, il mondo delle imprese, insomma il non eccelso capitalismo italiano che rivendica un ruolo centrale, si oppone ai finanziamenti “a pioggia” (sugli altri), ancora mugugna sul reddito di cittadinanza (assistenzialismo!) e chiede valanghe di soldi a fondo perduto per sé (assistenzialismo, ma, sembrerebbe, più nobile perché invece dei poveracci riguarda gli imprenditori). Insomma il ritornello è sempre quello: che se stanno bene gli imprenditori poi, a cascata, staremo meglio tutti, tesi smentita da almeno trent’anni di politiche sul lavoro, ma a ancora valida nella narrazione padronale.
La storiella si incrina un po’ quando si parla di regole e controlli. Esempio: se lo Stato “regala” una cascata di soldi a un’azienda, quali richieste di garanzia potrà mettere in atto? Piccole cose elementari: niente aiuti a chi licenzia, per esempio (o divieto di licenziare per chi prende aiuti, fa lo stesso). Oppure un rappresentante pubblico nei CdA, giusto per controllare che i soldi di tutti non finiscano nell’acquisto di una barca nuova anziché andare alla produzione e ai salari per le famiglie. O ancora: niente soldi a chi delocalizza, o ancora: niente soldi a chi ha situazioni fiscali non cristalline (tipo la residenza fiscale in Olanda, per dire). Tutte cose non così peregrine, insomma, davanti alle quali si è subito alzato un muro di granito. Le giaculatorie padronali riguardano il vecchio intramontabile ritornello che lo Stato deve stare lontano dagli affari, il che però si incastra proprio male con la richiesta costante e pressante di soldi pubblici. Traduco: il liberismo ama tanto quella manina invisibile del mercato che sistema tutto, ma poi capita che quella manina si presenti col cappello in mano a chiedere soldi, e allora tutte le belle teorie sul mercato che si autoregola vanno un po’ a farsi benedire.
Le obiezioni a qualunque possibile controllo statale sulle aziende che beneficerebbero di finanziamenti, insomma, sono di tipo ideologico. La prima, un po’ sorprendente, dice che mettendo qualcuno a controllare come le aziende spendono i soldi nostri aumenterebbe la corruzione. Come dire che, uff!, se mi mettete qui qualcuno a controllare, poi mi tocca corromperlo. Strana difesa. Altri, più fantasiosi, gridano ai Soviet e all’economia di Stato, e si inalberano anche quando si chiede una partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle aziende. Vade retro, pussa via! Ma dove siamo, eh, a Mosca negli anni Trenta? Sfugge a costoro, anche se lo sanno bene, che in Germania questo già succede, e anche con buoni risultati.
Insomma, il mood confindustrial-italico è “dateci i soldi e fatevi i cazzi vostri”, in pratica la richiesta di un capitalismo assistito ma senza contropartite. In questo modo, la cascata di miliardi in arrivo non solo non cambierà il Paese, ma finirà per perpetuare all’infinito il sistema delle diseguaglianze che la pandemia ha reso visibile a tutti. E dopo, quando saremo peggiori, potrà continuare imperterrita la storiella che lo Stato deve stare alla larga dal mercato, salvo cacciare soldi a pioggia quando servono.
Grande come una città, movimento politico culturale nato nel Terzo Municipio di Roma, mi ha invitato per una chiacchierata con Christian Raimo. Abbiamo parlato de I cerchi nell’acqua ma anche soprattutto di tutto il resto, con Milano in primo piano. Qui sotto. Grazie
 Guarda a volte come succedono le disgrazie. La nostra piccola geopolitica quotidiana, fino a ieri relegata alle dispute sui confini del quartiere (sarò a meno di duecento metri da casa? Ho con me il salvacondotto autocertificante?) si allarga di colpo alle questioni planetarie. La sciura Pina in coda dal macellaio non discetta più soltanto di mascherine e disinfettanti, ma si chiede (e lo chiede sgomenta alla sciura davanti a lei) se per caso la Cina sia stata molto cattiva facendo scappare un virus dalle provette dove lo allevava, e se per caso mister Trump farà qualche mossa delle sue, e se poi, nel caso, avremo una guerra mondiale tra la prima e la seconda potenza del pianeta, che disastro, signora mia, moriremo tutti.
Guarda a volte come succedono le disgrazie. La nostra piccola geopolitica quotidiana, fino a ieri relegata alle dispute sui confini del quartiere (sarò a meno di duecento metri da casa? Ho con me il salvacondotto autocertificante?) si allarga di colpo alle questioni planetarie. La sciura Pina in coda dal macellaio non discetta più soltanto di mascherine e disinfettanti, ma si chiede (e lo chiede sgomenta alla sciura davanti a lei) se per caso la Cina sia stata molto cattiva facendo scappare un virus dalle provette dove lo allevava, e se per caso mister Trump farà qualche mossa delle sue, e se poi, nel caso, avremo una guerra mondiale tra la prima e la seconda potenza del pianeta, che disastro, signora mia, moriremo tutti.
Naturalmente ognuno si farà la sua idea, e altrettanto naturalmente se la farà senza alcuna base scientifica o fattuale: l’opinione prevalente degli scienziati, per ora, è che si tratti di una discreta bufala, alla quale si aggiunge un senso vertiginoso di déja vu. Perché chi ha un minimo di memoria storica guarda il segretario alla difesa Usa Mike Pompeo dire: “Abbiamo le prove”, e in lui vede il vecchio Colin Powell, segretario di Stato Usa nel 2003, sventolare altre “prove”, quella boccettina di antrace che “testimoniava” l’esistenza delle armi chimiche di Saddam, bufala poi conclamata, ma che servì a fare centinaia di migliaia di morti.
La disputa dunque è tra un regime dittatoriale che ha isolato con metodi assai spicci sessanta milioni di persone salvando in qualche modo una popolazione di un miliardo e quattrocento milioni di cinesi, e il leader di una democrazia avanzata che vagheggia di iniezioni di candeggina come cura e di complotti internazionali, a sei mesi dalle elezioni. Anche le immagini hanno il loro peso: da una parte la propaganda cinese dove si mostra efficienza svizzera e ferrea determinazione; dall’altro le milizie suprematiste del Michigan che manifestano mitra alla mano per contestare il Lockdown e rivendicare il loro diritto a infettarsi alitandosi in faccia slogan nazisti. Così a prima vista non mi piacerebbe vivere né da una parte, dove sei tracciato e controllato anche mentre vai al cesso, né dall’altra, dove i bravi cittadini invece che per le mascherine si mettono in fila per comprare un fucile a pompa.
Quel che sorprende è invece la qualità del dibattito interno, roba nostrana, il famoso made in Italy, dove esperti, politologi, pensosi corsivisti e aspiranti statisti della domenica si sbracciano dicendo la loro, più o meno con le stesse competenze della sciura Pina di cui sopra. Traduco: non ne sanno niente o ancora meno, ma costruiscono ardite teorie sulla nostra fedeltà atlantica, il pericolo cinese, il Risiko delle alleanze planetarie come se parlassero della riapertura dei parrucchieri. Questo riporta la gigantesca, immane, globale riflessione geopolitica alla più consona (per noi) dimensione della farsa. La Lega di Salvini che, in Regione Lombardia, presenta una mozione per chiedere i danni alla Cina (per ora un acconto di venti miliardi, poi si vedrà) ricorda la pulce che minaccia l’elefante. Ed ecco che una questione di portata mondiale finisce per somigliare alla pièce esilarante del grande Belushi che inventa scuse per la fidanzata nel sottofinale dei Blues Brothers: “Le cavallette… il terremoto… c’era il funerale di mia madre… la tintoria non mi aveva consegnato il tight…”. La premiata ditta Fontana & Gallera, insomma, responsabile di scelte deliranti durante l’emergenza, che hanno segnato con la loro disastrosa gestione il record mondiale di decessi in rapporto alla popolazione, hanno trovato finalmente un colpevole: hanno stati i cinesi. Se non ci fossero di mezzo migliaia di morti, dolore, lacrime, città martiri come Bergamo e Brescia, ci sarebbe da ridere, ma non lo faremo: prevalga la pietà.
Molti siti di libri e letture recensiscono “I cerchi nell’acqua”. Eccone tre: Il sito Kronos Books, Patrizia Debicke per The blog around the corner e il sempre ottimo Valerio Calzolaio per Libri e parole. Cliccare per leggere. Trovate tutte (?) le recensioni uscite su giornali, siti, tv, radio e altro qui
 Se fosse un gioco di ruolo, di quelli che girano sulla Playstation, la nuova fase di Salvini Matteo potrebbe intitolarsi “Sbagliarle tutte livello Pro”. E’ quella fase dove l’eroe affronta la realtà e ne viene polpettato, a dispetto del nuovo travestimento. Vi risparmio le puntate precedenti, livelli divertenti ma alla fine abbastanza facili: le ruspe, le felpe, le magliette della Polizia, i migranti sequestrati, persino le giacche di velluto a coste quando doveva battere la simil-sinistra emiliana, persino i golfini azzurri finto-sanitario. Ora siamo alla fase “commercialista di Saronno”, con gli occhiali e l’aplomb posato di chi manda all’Inps le richieste dei suoi clienti: niente di nuovo. O forse sì, varie cose.
Se fosse un gioco di ruolo, di quelli che girano sulla Playstation, la nuova fase di Salvini Matteo potrebbe intitolarsi “Sbagliarle tutte livello Pro”. E’ quella fase dove l’eroe affronta la realtà e ne viene polpettato, a dispetto del nuovo travestimento. Vi risparmio le puntate precedenti, livelli divertenti ma alla fine abbastanza facili: le ruspe, le felpe, le magliette della Polizia, i migranti sequestrati, persino le giacche di velluto a coste quando doveva battere la simil-sinistra emiliana, persino i golfini azzurri finto-sanitario. Ora siamo alla fase “commercialista di Saronno”, con gli occhiali e l’aplomb posato di chi manda all’Inps le richieste dei suoi clienti: niente di nuovo. O forse sì, varie cose.
In primis i sondaggi: una decina di punti in meno rispetto alle Europee secondo l’Ipsos di Pagnoncelli, ma non fa conto parlarne, perché i sondaggi quando non si vota sono come il vin brulé in luglio. Più interessante il comportamento sui social, dove pare che la “bestia” salviniana incominci a usare con frequenza il tasto “blocca” per escludere dalla platea virtuale nemici, avversari e semplici cittadini che gli rispondono per le rime ogni volta che si affaccia su Twitter o Facebook. E’ il segnale che la bolla mediatica perde colpi, che quel “basta che se ne parli” che gli garantiva la prima pagina un giorno sì e l’altro pure non funziona più. Da asso pigliatutto dei media, Salvini è tornato ad essere in soli sei mesi il mesto gracchiare in sottofondo della più prevedibile delle opposizioni. Chiudere se il governo dice di aprire, aprire se il governo dice di chiudere, insomma un Salvini di Pavlov le cui uscite – prima spiazzanti e sorprendenti – diventano una pièce già vista e rivista, noiosa, stucchevole e spesso grottesca (ad esempio quando mette di mezzo la figlioletta innocente).
L’uomo, diciamo così, sta ormai seduto su un’altissima piramide di cazzate che sarebbe lungo elencare. Prima tra tutte – particolarmente grave se si pensa al tragico sacrificio del popolo lombardo, martire di una gestione dissennata dell’emergenza – la strenua difesa della sua classe dirigente in Lombardia. Che Fontana e il suo pard Gallera le abbiano sbagliate tutte è ormai conclamato e riconosciuto da chiunque (tranne da loro due, giapponesi nella giungla), e il sostegno indefesso di Salvini rischia di trascinarlo in basso insieme ai Gianni e Pinotto della pandemia. La difesa della gestione lombarda, che poggia ormai su un paradossale vittimismo albertosordista è aggravata dal fatto che poco più in là, in Veneto, un altro esponente leghista, Zaia, pare, per contrasto, una specie di Einstein. Basta seguire i ghirigori dialettici degli ultras leghisti per accorgersi del ribaltone, ormai l’esempio di efficienza è Zaia, non Fontana, lo stesso Zaia al quale Salvini non dedica nemmeno una parola: in via Bellerio la Lega veneta è sempre stata considerata il cugino scemo, e ora potrebbe prendersi le sue rivincite.
Anche quando ha tentato di mettersi una medaglia, Salvini ha finito per pungersi: l’ospedale alla Fiera di Milano, costato oltre venti milioni e sbandierato come eccellenza (parola che si sconsiglia di usare in Lombardia per i prossimi secoli) è semivuoto e desolato, persino chi se lo era inventato per la propaganda non ne parla più, glissa, finge di non sentire. Si aggiungano le cattive compagnie: i vecchi tweet esultanti per Bolsonaro, o peggio ancora per mister Trump, il famoso virologo che vuole curare il Covid con pere di candeggina, non rendono un buon servizio al neo commercialista già smutandato assaggiatore di mojito. Se fai la voce grossa chiedendo “pieni poteri” e solo qualche mese dopo ti presenti col cappello in mano a chiedere “grandi intese”, fai la figura di quello che annaspa perché non sa nuotare e, annaspando, affonda ancor di più.
La temutissima pagella di Antonio D’Orrico su La Lettura de Il Corriere della Sera… ehm… grazie grazie
 Prepariamoci all’assalto, portiamoci avanti col lavoro. Si discute animatamente della app “Immuni”, per avere un tracciamento elettronico dei contagi da Coronavirus: se sarà obbligatoria, facoltativa. volontaria, se quelli che non la installano dovranno andare in giro vestiti di arancione, o con le pinne, o se i vecchietti che non hanno familiarità con la tecnologia dovranno indossare un braccialetto elettronico (un suggerimento: fatelo lavabile, sennò fa più vittime delle RSA in Lombardia). Una cosa è certa, per giorni, settimane, mesi, avremo il refrain a reti unificate: “Installate l’app!”. Lascio agli scienziati dubbi e certezze, mi limito ad alcune perplessità dettate dall’esperienza: in un posto dove per avere una carta d’identità elettronica servono tre mesi (tipo Milano) si teorizza di un congegno che dice in tempo reale se hai la febbre a quello in coda davanti a te dal panettiere. In un posto dove per avere le mascherine nelle farmacie si è dovuto aspettare due mesi e 12.000 morti (tipo la Lombardia del presidente Fontana), si gestiranno miliardi di dati sensibili in pochi secondi. Mah.
Prepariamoci all’assalto, portiamoci avanti col lavoro. Si discute animatamente della app “Immuni”, per avere un tracciamento elettronico dei contagi da Coronavirus: se sarà obbligatoria, facoltativa. volontaria, se quelli che non la installano dovranno andare in giro vestiti di arancione, o con le pinne, o se i vecchietti che non hanno familiarità con la tecnologia dovranno indossare un braccialetto elettronico (un suggerimento: fatelo lavabile, sennò fa più vittime delle RSA in Lombardia). Una cosa è certa, per giorni, settimane, mesi, avremo il refrain a reti unificate: “Installate l’app!”. Lascio agli scienziati dubbi e certezze, mi limito ad alcune perplessità dettate dall’esperienza: in un posto dove per avere una carta d’identità elettronica servono tre mesi (tipo Milano) si teorizza di un congegno che dice in tempo reale se hai la febbre a quello in coda davanti a te dal panettiere. In un posto dove per avere le mascherine nelle farmacie si è dovuto aspettare due mesi e 12.000 morti (tipo la Lombardia del presidente Fontana), si gestiranno miliardi di dati sensibili in pochi secondi. Mah.
Altre perplessità riguardano gli inventori della famosa app: nella compagine azionaria delle società produttrici figurano tra gli altri: tre figli di Berlusconi, un colosso della Sanità privata lombarda (Centro Medico Sant’Agostino), il finanziere leopoldo-londinese Davide Serra e altri. “Il salotto buono”, scrive Il Sole 24 Ore: tu pensa se era cattivo.
Ma basta con questi dubbi da disfattisti, passiamo alle proposte costruttive! Se d’un tratto si archivia ogni pretesa di privacy e di riservatezza sui dati clinici dei cittadini, ovvio che si apre un mondo di possibilità. Ecco alcune app che vi invito ad installare subito.
Illese – Un app dedicata alle donne. Segnala in tempo reale se il tizio che vi invita a cena ha precedenti per aver menato la fidanzata pregressa, se va in giro col coltello in tasca, se ha subito decreti di allontanamento. Un aggiornamento della app (“Illese Family”) dirà se per caso quel tizio è il marito che, per un motivo o per l’altro, volete lasciare e che si presenta all’improvviso con un mazzo di fiori nella sinistra e un punteruolo da ghiaccio nella destra. Illese sarà collegata ai server delle forze dell’ordine, e in subordine, a quelli – potenziati – delle pompe funebri. Un problema tecnico: funzionando con la tecnologia Bluetooth, Illese sarà efficace se qualcuno si avvicina a meno di due metri, quindi non risolve il problema dei femminicidi con armi da fuoco. Da migliorare.
Impuniti – Una app molto interessante messa a punto dalla Agenzia delle Entrate, rivelerà se chi chiede un contributo statale ha pagato tutto quello che doveva ed è in regola col fisco. La app, in tempo reale, potrà segnalare all’Inps la configurazione della Porsche Cabrio di uno che magari chiede 600 euro all’Inps, la planimetria della villa al mare di chi risulta nullatenente o il nome dello yacht di chi presenta un 730 che lo colloca al di sotto della media dei raccoglitori di arance della piana di Gioia Tauro. In questo caso, le perplessità sulla privacy si fanno più intense, strano, eh?
Indagati – Una app che segnala in tempo reale se un candidato alle elezioni comunali, regionali, politiche, a qualche nomina pubblica, a qualche posto statale o parastatale, ente, commissione, grande azienda, abbia già avuto qualche problema con la giustizia, o non addirittura qualche condanna in primo (alert giallo), secondo (alert arancione), terzo grado (alert rosso). Con questa straordinaria app, collegata a tutti i cellulari, i cittadini conoscerebbero in pochi secondi la fedina penale di chi occupa posti di responsabilità o cariche in grado di decidere sulle loro vite. Stranamente, anche in questo caso, la politica si dice molto preoccupata per la privacy.
 Mandati allo sbaraglio senza criterio verso le trincee nemiche, soldati e sottufficiali del Regio Esercito videro la verità, la videro sulla pelle dei compagni caduti e, girando le spalle al fronte, rivolsero i fucili contro gli ufficiali felloni, contro comandanti inetti e colonnelli incapaci. A rileggere oggi, nella primavera dei nostri arresti domiciliari, Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu (1937), la situazione della Lombardia – il mio posto nel mondo, la mia regione – è questa. Due lugubri generali che fanno propaganda, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il suo assessore alla Sanità Giulio Gallera, mentre in trincea ci si ammala e si muore, vittime di ordini assurdi e incomprensibili, di decisioni criminali, di rallentamenti e temporeggiamenti, incertezze, pavidità, scaricabarile su altri poteri.
Mandati allo sbaraglio senza criterio verso le trincee nemiche, soldati e sottufficiali del Regio Esercito videro la verità, la videro sulla pelle dei compagni caduti e, girando le spalle al fronte, rivolsero i fucili contro gli ufficiali felloni, contro comandanti inetti e colonnelli incapaci. A rileggere oggi, nella primavera dei nostri arresti domiciliari, Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu (1937), la situazione della Lombardia – il mio posto nel mondo, la mia regione – è questa. Due lugubri generali che fanno propaganda, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il suo assessore alla Sanità Giulio Gallera, mentre in trincea ci si ammala e si muore, vittime di ordini assurdi e incomprensibili, di decisioni criminali, di rallentamenti e temporeggiamenti, incertezze, pavidità, scaricabarile su altri poteri.
Delle responsabilità della giunta lombarda si è detto e si dice ogni giorno, e non sarà mai abbastanza. Dalla mancata chiusura di una zona rossa in val Brembana per proteggere Bergamo, poi città martire, alla gestione spaventosa dell’ospedale di Alzano, e giù, fino ai tamponi che non si fanno nemmeno ai malati, alle Residenze per anziani inzeppate di infettati Covid, case non chiuse e sigillate, ma per settimane aperte al pubblico e ai parenti. Centinaia e centinaia di interviste e testimonianze e ricostruzioni della truppa eroica in prima linea (medici, infermieri, barellieri, sanitari di ogni ordine e grado, ricoverati, parenti di degenti) puntano tutte lì: alle scelte sbagliate, a una gestione dell’emergenza che meriterebbe il processo per altro tradimento di un intero popolo.
La Regione Lombardia, per bocca dei suoi generali felloni, risponde ancora a colpi di propaganda. Chi ha causato una strage di vecchi innocenti nelle case di riposo punta il dito accusatore contro i cittadini che “escono troppo”, che è come se chi ha lanciato la bomba atomica accusasse uno che esce con la fionda. Il comandante in capo, Matteo Salvini, scrive in un tweet la sua grottesca distanza dalla realtà: “Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Orgogliosi della Lombardia”, uno sputo sulle tombe. Una vergognosa pagina pubblicitaria stampata sui grandi quotidiani (che l’hanno pubblicata senza batter ciglio, incassando i soldi) canta ancora le lodi della Sanità lombarda sbaragliata peggio che a Caporetto, con argomenti che gridano vendetta: “La Sanità privata insieme alla Sanità pubblica: 28.224 vite salvate in Lombardia”, si legge, increduli, come se di fronte a un massacro si esultasse perché non sono morti tutti, e qualcuno l’ha scampata. Firmano la pagina (bene saperlo) Confindustria Lombarda, Regione Lombardia, l’associazione degli ospedali privati e quella degli istituti sanitari religiosi. Le televisioni del Regno ospitano costantemente, come in una rubrica fissa, i deliri dei due generali felloni, che pontificano dall’alto del loro record mondiale: la Lombardia è la regione al mondo con più morti in rapporto agli abitanti. Si vantano del loro camposanto.
Si sorride amaramente pensando che solo qualche mese fa l’emergenza nazionale era (signora mia!) l’odio in rete, la prevalenza del cretino su twitter e facebook, l’intemperanza verbale. Ora è il momento di scoprire che a volte l’odio ha un suo perché, che la rabbia non nasce a caso, che se lasci marcire il senso di giustizia tra bugie e propaganda, crescerà di minuto in minuto. Nel film di Francesco Rosi tratto dal libro di Lussu il tenente Ottolenghi, che teorizzava l’ammutinamento contro i generali incapaci aveva la faccia bellissima e maestosa di Gian Maria Volonté. Oggi le facce non le vediamo, sono coperte da mascherine, occhiali protettivi, cuffie, tute, qualcuno parla col volto nascosto e la voce contraffatta, per non incorrere in rappresaglie, ma sono la stessa bellissima faccia di chi vuole giustizia.
Qui la bella recensione de La Lettura. Grazie a Ranieri Polese (cliccare per leggere). Poi l’intervista a Radio24 con Alessandra Tedesco, che è sempre un piacere e la bella recensione di Federica Politi su Contorni di Noir
 E alla fine è finalmente spuntata, la parolina magica: querela. L’assessore al welfare (ahah! ndr) della Lombardia Giulio Gallera l’ha lasciata cadere in una delle sue conferenze quotidiane. Incredibile davvero che nel centro della bufera, con le Mercedes luccicanti dei monatti che portano via le salme (quando non i camion dell’esercito, come a Bergamo) si senta questo sottofondo di “Qualcuno verrà querelato!”, di “Ci vediamo in tribunale!”. Da cittadino lombardo, abitante e lavorante in Lombardia, sento montare una certa irritazione (eufemismo) per una classe dirigente regionale che passa metà del suo tempo a difendersi dalle accuse che le piovono addosso da ogni parte (medici compresi, ovviamente, notizia di ieri). C’è poco da querelare, i numeri cantano, in questo caso, le interpretazioni possono fare tutti i ghirigori che vogliono, gli arabeschi da legulei e i sottili distinguo. Ma.
E alla fine è finalmente spuntata, la parolina magica: querela. L’assessore al welfare (ahah! ndr) della Lombardia Giulio Gallera l’ha lasciata cadere in una delle sue conferenze quotidiane. Incredibile davvero che nel centro della bufera, con le Mercedes luccicanti dei monatti che portano via le salme (quando non i camion dell’esercito, come a Bergamo) si senta questo sottofondo di “Qualcuno verrà querelato!”, di “Ci vediamo in tribunale!”. Da cittadino lombardo, abitante e lavorante in Lombardia, sento montare una certa irritazione (eufemismo) per una classe dirigente regionale che passa metà del suo tempo a difendersi dalle accuse che le piovono addosso da ogni parte (medici compresi, ovviamente, notizia di ieri). C’è poco da querelare, i numeri cantano, in questo caso, le interpretazioni possono fare tutti i ghirigori che vogliono, gli arabeschi da legulei e i sottili distinguo. Ma.
Ma la Lombardia (dati 5 aprile, tre giorni fa) ha da sola più deceduti (oltre il 27 per cento in più) di tutte le altre regioni italiane messe insieme, 8.905 morti contro i 6.982 del resto d’Italia. In effetti sono numeri che sarebbe interessante sentire in un tribunale. Altro dato interessante (fonte: Istituto Superiore della Sanità) riguarda le Residenze per Anziani, con una media di decessi tra i pazienti del 9,4 per cento nazionale, che diventa del 19,2 per cento in Lombardia, più del doppio. Diciamo che la delibera dell’8 marzo (numero XI/2906), che chiedeva alle residenze per anziani di mettere a disposizione personale e strutture per malati di Covid19 non ha aiutato (eufemismo). Ora Gallera minaccia querele a chi dice che quelle strutture sono state “obbligate” a ospitare malati contagiosi, scappatoia astuta, sembra di sentire la telefonata con gli avvocati. No, in effetti nessun obbligo, solo un “consiglio” a strutture che nella quasi totalità vivono di accreditamenti regionali (traduco: se tua nonna ti dà un consiglio è un consiglio, se il tuo principale finanziatore ti dà un consiglio non è la stessa cosa).
Ce ne sarebbe abbastanza per farne una battaglia politica. Secondo un illuminante schemino pubblicato al tempo delle recenti nomine nella Sanità lombarda (dicembre 2018), le posizioni apicali nelle Ast e Asst (Agenzie della salute territoriale, le vecchie Asl, e strutture ospedaliere), di nomina politica, sono 40 (quaranta). Eccole suddivise per partiti e forze politiche: 24 (ventiquattro) alla Lega, 14 (quattordici) a Forza Italia e 2 (due) a Fratelli d’Italia. Totale quaranta, l’en-plein, insomma. Questo rende un po’ ridicolo l’atteggiamento di molti sedicenti neutrali che dicono: non è tempo per le polemiche, prima salviamo le vite. No. Prima si salvano le vite, come ovvio, e intanto (non dopo) si capisce se chi comanda la sanità regionale sia adeguato a gestire l’emergenza: quando chiami i pompieri perché brucia la casa non vorresti vederli arrivare a gettare sul fuoco taniche di benzina, e in quel caso non diresti “poi vedremo”, ma li fermeresti subito. Le inchieste verranno (sono già in corso), le valutazioni politiche verranno (si spera prima delle elezioni regionali, a cui mancano tre anni), ma ora ci sono in effetti cose più urgenti. Da cittadino lombardo, residente e lavorante in Lombardia, non mi sento al momento sufficientemente difeso e protetto da chi governa la Sanità nel posto in cui vivo. Lo pensano in molti, qui, dove alla paura si sta lentamente aggiungendo una rabbia che diventerà furore: a furia di bombardare la gente di numeri, finisce che la gente li capisce, quei numeri, ed è difficile querelare i numeri. Accusare altri (che sia il governo, o i comuni, o chi fa jogging, o chi fa il giro dell’isolato con il bambino) per coprire la propria inadeguatezza e incapacità è un’astuzia miserabile, e i numeri le astuzie non le capiscono.
 E’ sempre affascinante quella frase che “i nodi vengono al pettine”, bellissima immagine, ma qui i nodi sono enormi, e il pettine è un pettinino da bambole. Ecco alcuni esempi di nodi enormi e pettine piccolo piccolo.
E’ sempre affascinante quella frase che “i nodi vengono al pettine”, bellissima immagine, ma qui i nodi sono enormi, e il pettine è un pettinino da bambole. Ecco alcuni esempi di nodi enormi e pettine piccolo piccolo.
Tecnologia e controllo. Si dibatte e si discute sulla possibilità di usare tecnologie di controllo per difendersi dalla peste. Chi dice sì, chi dice no (pochi), chi mette in guardia sulla privacy. I giornali pubblicano divertenti schemini: tu passeggi col tuo telefono in tasca, uno ti incrocia per la strada e il tuo telefono trilla: ti dice che quello lì che sta passando è positivo, quindi cambi marciapiede e la vita continua. Bello. Affascinante. Avanzatissimo. Coreano. Ma dunque riassumo: in un Paese dove tutti si parlano via Skype riproducendo le esilaranti conversazioni che si facevano con i primi Motorola (mi senti? No, ma ti vedo! No, non ti vedo più… ragioniere, mi sente? Io la sento!); dove per avere un certificato online servono settimane, mesi per una carta d’identità elettronica, dove le frasi più lette per i servizi online sono “Riprovare più tardi” e “Attendere prego”… ecco, in un Paese così avremmo di colpo, come per magia, una piattaforma avanzatissima e futuristica che collega tra loro cinquanta milioni di telefoni. Eh? Davvero? Dunque delle due l’una: o è pura illusione, diciamo un racconto fantascientifico che serve a rassicurare e illudere, oppure è fattibile. Il che significa che la tecnologia è in effetti avanzatissima, che non è stata (prima del virus) distribuita alla gente per semplificarle la vita, ma la si userebbe oggi per “sorvegliare e isolare” (chiedo scusa a mastro Foucault).
Socialismo padronale. Grave allarme viene dalle campagne: il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ci fa sapere che i lavoratori agricoli stranieri regolari erano nella vita precedente circa 400.000 (il che vuol dire che, contando gli irregolari, erano almeno due o tre volte tanti), e che quest’anno non li avremo. Che fare? Semplice: rivolgersi a chi prende il Reddito di Cittadinanza e mandarlo a raccogliere fragole e asparagi “Garantendo (magnanimo, ndr) il periodo di percezione pari alla durata del lavoro stagionale”. Dunque, senza più stranieri, ecco la mano d’opera di riserva, i famosi poveri. E’ una cosa che odora un po’ di soviet, di kolkoz, di collettivizzazione (pure un po’ di paludi pontine), anche se non si collettivizza niente, solo piegare la schiena e riempire cassette, perché eventuali profitti non sarebbero socializzati per niente, anzi si chiede una decontribuzione (ovvio). In questo caso il nodo è grosso e il pettine, oltreché piccolo, pare anche astutissimo.
Motivare la truppa. Ha fatto qualche scalpore il video di Urbano Cairo gongolante e in piena trance agonistica per gli affari che vanno benone. Elenca nomi, cifre, clienti (anche quelli in Polinesia), freme di orgoglio per fatturati e dividendi, elenca i segni “più” delle sue attività, e dice che il suo gruppo, nel 2020 “farà meglio” dell’anno precedente. E’ lo stesso Cairo che tre giorni prima (leggo da un comunicato del cdr del Corriere della Sera) illustrava ai giornalisti “le difficili prospettive per i conti aziendali”. Quale sarà il vero Urbano Cairo? Quello che piange miseria davanti ai lavoratori o quello che gongola in attesa di risultati migliori? Viene in mente Aristide Saccard, meraviglioso personaggio di Emile Zola (Il denaro, 1891) che concludeva la sua intemerata in difesa dell’avidità e della speculazione con un “…Saranno tutti ricchissimi”. Scriveva così bene, Zola, che Saccard pare di vederlo, come in un video su YouTube destinato ai venditori di pubblicità del gruppo Cairo: “Saranno tutti ricchissimi”. Non è vero, naturalmente: sarà ricchissimo soltanto lui, gli altri guarderanno sgomenti nodi sempre più grossi con in mano pettini sempre più piccoli.
 Le retoriche del “dopo” fanno bene al cuore. “Dopo” torneremo ad abbracciarci, a tornare là fuori, “dopo” riavremo le nostre vite sequestrate, “dopo” torneremo al gusto del caffè del bar, delle chiacchiere a distanza ravvicinata, del contatto fisico, delle strade piene. E’ giusto che sia così, giusto che ci sia un orizzonte, un tendere al futuro, un desiderio forte di passare la nottata, domani è un altro giorno. Dai, coraggio, avanti. Dopo, dopo, dopo.
Le retoriche del “dopo” fanno bene al cuore. “Dopo” torneremo ad abbracciarci, a tornare là fuori, “dopo” riavremo le nostre vite sequestrate, “dopo” torneremo al gusto del caffè del bar, delle chiacchiere a distanza ravvicinata, del contatto fisico, delle strade piene. E’ giusto che sia così, giusto che ci sia un orizzonte, un tendere al futuro, un desiderio forte di passare la nottata, domani è un altro giorno. Dai, coraggio, avanti. Dopo, dopo, dopo.
Ma siamo sicuri che il “dopo” – quando arriverà – debba essere uguale al “prima”? Che questa piaga biblica non ci stia disegnando, con precisione quasi millimetrica, storture, furbizie, ingiustizie strutturali, diseguaglianze sociali accettate come naturali e immutabili? La catastrofe amplifica, precisa i contorni, rende tutto più visibile, cristallino. A metterle in fila, le inadeguatezze, le furbizie, i calcoli cinici, c’è da riempirci un volume, si oscilla tra un senso di comunità in pericolo (ora che la comunità è chiusa in casa) e la voglia di ghigliottina, di segnarsi i nomi, i comportamenti, le dichiarazioni, a futura memoria. Per “dopo”.
Così, con lo stesso inquieto pendolarismo che ci fa fare migliaia di volte il tragitto camera-cucina, presi dall’horror vacui della giornata che ci si apre davanti, mettiamo confusamente in fila la lista delle ingiustizie. Il tampone agli asintomatici che è ormai uno status symbol come la Porsche in garage (sì ai calciatori, sì ai vip, no ai medici in trincea, possibile?). Le speculazioni politiche di bassa lega (Lega), come il vergognoso Salvini travestito da sanitario, gli industriali che resistono alle chiusure ma in fabbrica non ci vanno, le miserabili riflessioni ultraliberiste (memorabile un articolo su Il Foglio) che ci spiegavano perché è giusto che le mascherine seguano la “naturale” dinamica dei prezzi, perché il mercato sistema tutto, che vergogna. E anche i conti finalmente chiariti su chi, come, quando, in che misura ha martoriato la Sanità pubblica in questi anni, nomi e cognomi. Chi lo diceva prima, al momento dei tagli, era dipinto come un nemico, un sovversivo (le mille varianti mettetele voi, comunista, gufo, disfattista, costruttore di debito pubblico…), ora troviamo quelle cifre – i tagli di Silvio, di Monti, di Renzi – messe in fila con dovizia di dettagli. Scappati i buoi si guarda con desolazione alle porte della stalla, e lo fanno anche giornali, e media, e forze politiche che prima non facevano un fiato, che ad ogni sforbiciata esultavano per la coerenza di bilancio: ce lo chiede l’Europa, ce lo chiedono i mercati, e giù ticket, e riduzioni di prestazioni, e limiti agli esami, e meno posti letto, e meno terapie intensive, e meno ospedali locali, e numeri chiusi a medicina, che qui vogliono fare tutti il dottore, signora mia.
Saranno anche categorie antiche, novecentesche, ma siccome ci scopriamo disarmati a non averne di migliori, ecco che tocca constatare: anche il virus è di classe, e lo si vede ogni giorno nei piccoli dettagli dell’infamia corrente, quasi un campionario. Le case piccole in cui convivere, i soldi che mancano perché arrivano dal cottimo, il poderoso esercito dei lavoratori in nero (moltitudine) che non avranno ammortizzatori, i lavoratori spaventati sia dalla costrizione a lavorare sia dal fermarsi.
“Dopo”, nell’ubriacatura dell’essere di nuovo vivi, dovremo ricordarci che quel “prima” che oggi ci manca non andava bene, era fragile e ingiusto, era troppo diseguale, schiacciava i deboli e premiava i forti. Nel “dopo” ci dovremo mettere anche tutto questo, un ridisegnare complessivo del sistema, delle protezioni sociali, e sarà importante quanto lo è la voglia di tornare là fuori, di riabbracciarci, di bere il caffè al bar. Il “dopo” non arriverà soltanto, lo si dovrà costruire con le nostre mani finalmente senza guanti, dopo.
Prime reazioni. Intanto grazie grazie agli amici e ai lettori più fedeli: mi diranno meglio, in privato o sui loro social, ma insomma, mi pare che le reazioni… bene. Qui metto le prime recensioni: Un’intervista di Francesco Mannoni sull’Unione Sarda e replicata su Il Mattino di Napoli, una recensione sul messaggero di Andrea Frateff-Gianni. E poi un’ampia recensione dei Unoenessuno, che è sempre molto attento alle storie del Monterossi. Cliccate e leggetene tutti. State in casa. Ciao
 Quando facevamo Cuore, se dovevamo scrivere di un libro o di qualcosa letto e piaciuto, lo facevamo sotto la testatina “Leggete, bestie”. Mi è venuto in mente in questi giorni, perché se non si può andare in libreria, non si può parlare di libri in pubblico, fare le presentazioni, chiacchierare con i lettori, firmare le copie e, insomma, accompagnare un libro tra la gente, beh… si può farlo in privato. Quindi è possibile che troverete in giro qualche mia lettura, che sparpaglierò sui miei social* e metterò qui. Sono letture che rimbalzeranno su altri siti, sul sito della Sellerio, o delle librerie o dei festival che mi chiedono degli interventi, o di chiunque vorrà condividerle. Se vi va, come si dice, fate girare.
Quando facevamo Cuore, se dovevamo scrivere di un libro o di qualcosa letto e piaciuto, lo facevamo sotto la testatina “Leggete, bestie”. Mi è venuto in mente in questi giorni, perché se non si può andare in libreria, non si può parlare di libri in pubblico, fare le presentazioni, chiacchierare con i lettori, firmare le copie e, insomma, accompagnare un libro tra la gente, beh… si può farlo in privato. Quindi è possibile che troverete in giro qualche mia lettura, che sparpaglierò sui miei social* e metterò qui. Sono letture che rimbalzeranno su altri siti, sul sito della Sellerio, o delle librerie o dei festival che mi chiedono degli interventi, o di chiunque vorrà condividerle. Se vi va, come si dice, fate girare.
Per ora ho letto qualche pagina del mio amato Gogol’ (l’inizio de Il naso, dai Racconti di Pietroburgo, qui) e un capitoletto di un romanzo italiano bellissimo, strano e misconosciuto, Salto mortale di Luigi Malerba (qui). Sono letture casuali, cose che mi hanno colpito, o che ho sempre amato in qualche modo, o a cui sono affezionato per qualche motivo (ognuno ha i suoi motivi privati per affezionarsi). Insomma, cose da condividere in questi tempi di arresti domiciliari spaventati e scomodi. La speranza è di fare compagnia a qualcuno, forse di suggerirgli qualche lettura, o qualche minuto “radiofonico”. O forse è solo la voglia mia di andare a cercare in casa cose che è bello leggere.
*oltre a qui, i posti dove potete trovare le letture sono:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter
 Aggiorno minuto per minuto la mia personale top ten del virus bastardo, come credo faranno tutti, più o meno consciamente. Sono le dieci cose per cui vale la pena vivere, come si diceva una volta su Cuore (gli anziani ricorderanno), ma diverse, più cattive e acuminate, certe volte feroci e certe volte agrodolci, piccole commozioni passeggere, spaventi veri, sollievi infantili. Le cose per cui in una giornata standard di (benedetti, doverosi) arresti domiciliari si ride, si piange, ci si incazza, ci si preoccupa e forse sono i cuscinetti d’aria su cui stiamo sospesi, in attesa.
Aggiorno minuto per minuto la mia personale top ten del virus bastardo, come credo faranno tutti, più o meno consciamente. Sono le dieci cose per cui vale la pena vivere, come si diceva una volta su Cuore (gli anziani ricorderanno), ma diverse, più cattive e acuminate, certe volte feroci e certe volte agrodolci, piccole commozioni passeggere, spaventi veri, sollievi infantili. Le cose per cui in una giornata standard di (benedetti, doverosi) arresti domiciliari si ride, si piange, ci si incazza, ci si preoccupa e forse sono i cuscinetti d’aria su cui stiamo sospesi, in attesa.
Perdonerete il fatto personale, ma metto al primo posto il corvo. Un corvo, o cornacchia, o non so (non me ne intendo) che canta ogni mattina, alle sei precise, come fosse una sveglia, da qualche parte nella via di sotto, silenziosa e deserta. Lo sento, non riesco a vederlo. Canta nel silenzio, non allegro, non triste, non so cosa dice, certo c’era anche prima, ma non l’ho mai sentito.
C’è il tempo della rabbia, naturalmente, un livore sordo che ti monta quando senti pontificare, discettare, proporre soluzioni, gente che fino a ieri ha votato per tagliare la sanità pubblica, ridurre, ottimizzare, razionalizzare e tutti gli eufemismi usati negli anni per impoverire la vera grande opera pubblica del Paese, il Sistema Sanitario Nazionale. Odio vero, cristallino, abbastanza alto in classifica, unito alla speranza un po’ naïf che alla fine – dopo, un giorno – si faranno i conti anche con quelli lì.
E poi: “Ad ogni angolo di strada il sentimento dell’assurdità potrebbe colpire un uomo in faccia”, scriveva Camus. E l’assurdo ha il suo bel posto in classifica: gli americani in fila, distanziati di un metro, per comprare armi e munizioni con cui spararsi da molti metri; i due Mattei italiani, ormai un unico indistinguibile Matteo, che battono i media stranieri per attaccare il governo e intercettare un po’ di visibilità. E quell’altro, là, il vecchio Silvio, quello che “L’Italia è il paese che amo”, e sta a Nizza.
Macron, Johnson, Trump che vuole comprarsi il vaccino. Il cartello nell’androne: “Chi vuole vado a fargli la spesa”; il secondo movimento della Serenata per archi in Mi maggiore, op. 22 di Dvořák, quello che sembra che ti entri in casa la primavera, meraviglia beffarda; la conferenza stampa delle 18: quanti morti, quanti contagiati, quanti…
Cos’è questo mischiare piccole faccende private e immense cose pubbliche? Questo saltare tra sensazioni e stati d’animo? Persino la retorica, la retorica altrimenti insopportabile, il “ce la faremo”, l’”andrà tutto bene”, appare digeribile, pesino commovente, e questo finché non diventa retorica da telegiornale, cioè quando passa da sfogo popolare – vero, fremente, un sentimento – a servizietto giornalistico, compitino di alleggerimento, dal balcone al palinsesto.
Stanno nella top ten i libri ritrovati negli scaffali troppo alti, o troppo bassi, dove non li si cercava più da chissà quando, una distrazione dallo sfibrante esercizio su tattiche e strategie quotidiane: le mascherine, i respiratori, i letti in terapia intensiva, lo sguardo sospettoso e impaurito della commessa al supermercato. E uno strano senso di comunità in pericolo che un po’ riscalda, conforta, anche quello ai primi posti della classifica; e la narrazione su Milano, qui fuori, che va in mille pezzi, e i rider (trad: fattorini) coi loro cibi in spalla, le bici macilente, ora padroni delle strade, promossi d’incanto da schiavitù postmoderna a “servizio essenziale”, ma con la paga di merda di sempre. La top ten, cambia, muta, si trasforma, si modella agli stati d’animo, contiene speranza e odio, e stanchezza, e desideri. Tolgo Trump che chissenefrega, metto un Dylan del’75. Il corvo che canta sta sempre primo in classifica, nella mia top ten, ormai lo aspetto, grato.
 Oggi, 12 marzo, è il giorno dell’uscita del mio nuovo romanzo, I cerchi nell’acqua (Sellerio).
Oggi, 12 marzo, è il giorno dell’uscita del mio nuovo romanzo, I cerchi nell’acqua (Sellerio).
Oggi, 12 marzo è il giorno in cui le librerie sono chiuse per decreto.
Lo trovo giusto: fermare il più possibile l’ondata del virus, liberare posti negli ospedali, comportarsi responsabilmente, non cedere alla paura, all’irrazionalità. Insomma, starci con la testa, non farsi travolgere.
Credo e spero che quando tutto questo sarà passato, un barlume di normalità tornerà tra noi, e allora riapriranno le librerie e tutto il resto, e si potrà andarci, e guardare e sfogliare, e leggere le prime righe di tutto, come si faceva, si è sempre fatto e si farà. E parlarne con gli altri.
Sul nuovo romanzo, con quello che ci accade, non è il caso di dilungarsi. Metto qui il risvolto di copertina, l’esergo, insomma quello a cui dareste un’occhiata tra i banchi di una libreria. Posso dire che ora, davanti all’inimmaginabile, che è una storia noir che parla di uomini – soprattutto i miei due sbirri Ghezzi e Carella – cioè di vite, dubbi, paure, incertezze, schiene dritte e decisioni, giustizia e ingiustizia correnti. Carlo Monterossi osserva basito, incredulo, un mondo così distante da lui. Lo vede, se lo fa raccontare, dalla sua posizione di comodo privilegio, dai piani alti, mentre la storia è una storia da piani bassi, marciapiedi e brutta gente. Due mondi.
parla di uomini – soprattutto i miei due sbirri Ghezzi e Carella – cioè di vite, dubbi, paure, incertezze, schiene dritte e decisioni, giustizia e ingiustizia correnti. Carlo Monterossi osserva basito, incredulo, un mondo così distante da lui. Lo vede, se lo fa raccontare, dalla sua posizione di comodo privilegio, dai piani alti, mentre la storia è una storia da piani bassi, marciapiedi e brutta gente. Due mondi.
Libro a parte, devo dire grazie a molti. Prima di tutto alle librerie indipendenti, le piccole, le grandi, le biblioteche, i festival, i circoli di lettura, le associazioni che mi hanno invitato a parlare de I cerchi nell’acqua. Ne ho incontrate a decine, a centinaia, per i libri precedenti, e insieme a loro i lettori, attenti, o matti, o acutissimi, curiosi, che parlano dei miei personaggi come se fossero amici, o conoscenti, o gente incrociata davvero nella vita.
 Un altro grazie va a quelli che tengono in piedi, letteralmente, i libri. Perché scrivere è una cosa privata e intima, personalissima, ma c’è un momento in cui il lavoro diventa collettivo, coinvolge persone, passioni, intelligenze, tempo. Da un file di word allo scaffale della libreria c’è un mondo che lavora, pensa, elabora, si sbatte, s’incazza o festeggia.
Un altro grazie va a quelli che tengono in piedi, letteralmente, i libri. Perché scrivere è una cosa privata e intima, personalissima, ma c’è un momento in cui il lavoro diventa collettivo, coinvolge persone, passioni, intelligenze, tempo. Da un file di word allo scaffale della libreria c’è un mondo che lavora, pensa, elabora, si sbatte, s’incazza o festeggia.
Quando tutto questo sarà passato, quando avremo vinto anche perché abbiamo saputo fermarci, sarà un grande piacere tornare là dentro, in libreria, e anche rimettere in piedi tutta l’agenda, gli incontri, le chiacchiere, le presentazioni e tutto il resto.
Ora non è quel tempo, ma quel tempo arriverà.
Chi riesce a mettere le mani sul I cerchi nell’acqua può dire, ovviamente, che ne pensa.
E noi ci vediamo in giro, presto.
Qui, come sempre, trovate le recensioni, la rassegna stampa e i vostri commenti
 Dunque il virus corre più veloce dello sciocchezzaio corrente, i fatti sorpassano le letture, ciò che sembrava esagerato sembra ragionevole, ciò che sembra ragionevole forse non basterà. Con una certa lentezza si aggiustano le misure. Precauzioni basilari: lavarsi le mani, incontrare meno gente possibile e dire meno cazzate. Intanto guardare e trarre qualche insegnamento dalle cose.
Dunque il virus corre più veloce dello sciocchezzaio corrente, i fatti sorpassano le letture, ciò che sembrava esagerato sembra ragionevole, ciò che sembra ragionevole forse non basterà. Con una certa lentezza si aggiustano le misure. Precauzioni basilari: lavarsi le mani, incontrare meno gente possibile e dire meno cazzate. Intanto guardare e trarre qualche insegnamento dalle cose.
Milano. Raccontata come una landa remota e sconosciuta (specie dai media romanocentrici), di cui si-dicono-mirabilie-ma-non-ci-vivrei, oscilla tra tempio della modernità e desolato Lazzaretto. Prima non si ferma, battendosi aperitivamente il petto (giusto! Bravi!), poi si ferma (giusto! Bravi!). Il suo destino è di essere una caricatura di se stessa, di cui non si vedono i chiaroscuri, ma solo le luci scintillanti (quando si costruisce il mito), o la composta dignità (quando le cose si mettono male), o il meritocratico (ossignùr, ndr) dinamismo. La velocità dei fatti sconfigge per una volta le narrazioni collaudate. Tra poco (giorni, settimane) verrà alla luce che la struttura del mercato del lavoro, a Milano più che altrove, poggia su un esercito poderosissimo di “cottimisti” (traduco: gente che se non lavora non mangia, letteralmente) e salteranno come tappi altre narrazioni.
I supermercati. Ma guardali, che corrono a far la spesa svuotando gli scaffali! Ecco le agghiaccianti immagini. Ma sono matti? Pazzesco. Solo in Italia. Eccetera eccetera, aggiungere a piacere. Si tratta di una piccola narrazione tossica, elaborata per dire alla gente che è peggiore di quel che è veramente, una specie di denigrazione di massa. Riassumo: ti dicono che devi stare in casa, magari per giorni, lo scrivono proprio nei decreti legge, lo dicono i vip, lo ripetono in tivù, te lo consiglia il medico, ma poi ti fanno il culo perché, preoccupato, spaventato, prudente, vai a fare la spesa per stare in casa. Non sapendo contro chi suscitare indignazione, non avendo ancora individuato un capro espiatorio credibile, ecco “la massa” cattiva. Lo si registra quasi con disgusto, come a segnare una distanza tra noi ragionevoli e i buzzurri accaparratori. E poi si corre a far la spesa.
I cinesi. I cinesi passano ad intervalli di tre-quattro ore da infami appestatori del mondo (dice quello là veneto coi topi vivi) ad avanguardie del contenimento e della sconfitta del virus. Sono cattivi perché chiudono tutto. Sono bravi perché costruiscono un ospedale in sei minuti. Sottrotraccia ma nemmeno tanto: qui non siamo mica in Cina, non puoi sparare alla gente se esce di casa, ma detto con un tono che sottende un certo dispiacere, un “peccato”, solo sussurrato, a portata di intuizione. Al “quando c’era lui” si sostituisce un velato “se ci fossero loro”. Quando senti dei due che per andare a sciare impestano mezza valle è un pensiero inevitabile. Poi passa (mah).
Gli untori. Chi dice ventimila, chi un po’ meno, chi un po’ più, ma insomma, sono anche loro una piccola narrazione tossica. Le code alla stazione, l’assalto ai treni. Nella vulgata corrente (cito una professionista intervistata da Repubblica) chi prende su due piedi un treno per lasciare Milano è il “ragazzo del sud che non riesce a stare lontano dalla propria città quindici giorni”. Insomma, ecco creata la macchietta, che a pensarci è sempre quella: il mammone, il terrone, il choosy. Non si deve correre via da una zona infetta, d’accordo, ma qualcuno deve darti buoni motivi per rimanerci. Dunque se ne fa caricatura, un altro capro espiatorio, il che serve a costruire un disprezzo statistico per le vite delle persone, le storie, le necessità e le paure. L’intercapedine tra “Qui si mette male, se non lavoro che faccio?” e “Ecco, viziato rammollito che scappi e metti a rischio altri” è una crepa nel pavimento dove rischiamo di cadere tutti, chi più chi meno.
 Dunque pare sempre più evidente che il morbo cattivo che ci minaccia presenti un sintomo chiarissimo della famosa sindrome di Taranto. Cioè: si salva il lavoro o la salute? Detta dritta e brutale: quanto si può sacrificare del nostro Pil, dei nostri stili di vita, del nostro potere d’acquisto, del nostro preoccupato e mal distribuito benessere, per non far sobbalzare troppo le statistiche della mortalità? La domanda è quasi metafisica, perché nell’equazione spaventosa che ci si pone, entra una forza che sembrerebbe trascendente, potentissima, totalmente incontrollabile, che non si sa nemmeno come chiamarla. “I mercati”, oppure “i mercati finanziari”, poi naturalmente “le Borse”, che periodicamente “bruciano” (eh?) miliardi, eccetera eccetera. E’ obbligatoria la notazione linguistica: questo possente sistema di governo della ricchezza – basta guardare i titoli nelle pagine economiche – non ha volti, non ha nomi e cognomi, solo nomi comuni di cose (“i mercati”), che bastano da soli ad atterrire ogni discorso pubblico. Si esce insomma con le mani alzate: se smottano “i mercati” è come se arrivasse il terremoto, che ci vuoi fare? Ecco, stanno smottando, gli allarmi si fanno fragorosi, le previsioni molto cupe.
Dunque pare sempre più evidente che il morbo cattivo che ci minaccia presenti un sintomo chiarissimo della famosa sindrome di Taranto. Cioè: si salva il lavoro o la salute? Detta dritta e brutale: quanto si può sacrificare del nostro Pil, dei nostri stili di vita, del nostro potere d’acquisto, del nostro preoccupato e mal distribuito benessere, per non far sobbalzare troppo le statistiche della mortalità? La domanda è quasi metafisica, perché nell’equazione spaventosa che ci si pone, entra una forza che sembrerebbe trascendente, potentissima, totalmente incontrollabile, che non si sa nemmeno come chiamarla. “I mercati”, oppure “i mercati finanziari”, poi naturalmente “le Borse”, che periodicamente “bruciano” (eh?) miliardi, eccetera eccetera. E’ obbligatoria la notazione linguistica: questo possente sistema di governo della ricchezza – basta guardare i titoli nelle pagine economiche – non ha volti, non ha nomi e cognomi, solo nomi comuni di cose (“i mercati”), che bastano da soli ad atterrire ogni discorso pubblico. Si esce insomma con le mani alzate: se smottano “i mercati” è come se arrivasse il terremoto, che ci vuoi fare? Ecco, stanno smottando, gli allarmi si fanno fragorosi, le previsioni molto cupe.
Questo potere assoluto e capriccioso, una roba da dèi dell’Olimpo, condiziona le nostre vite in modo decisivo. L’ultima botta, come ricordano in questi giorni tutti i cronisti dei periodici disastri economici, fu nel 2008, e dodici anni dopo siamo ancora in pieno dentro alla morsa causata da quella stretta, meno tranquillità, meno diritti, meno redditi, tutto meno sicuro e più precario. Ora, si paventa che, di fronte al virus cattivo, i famosi mercati ci potrebbero ricascare, potrebbe ripartire un altro massiccio impoverimento, con tutto quel che ne deriva.
E va bene, tutte cose che sappiamo.
Ciò che sappiamo un po’ meno è forse questo: quando siamo diventati anche noi “mercati”? Cioè quando esattamente ci siamo dotati di quel cinismo un po’ gretto travestito da realismo che fa dire, beh, era vecchio, beh, era già malato? Si sa che spesso la morte degli altri può essere un sollievo per i vivi, ma in questi giorni – anche nei dibattiti sul tema, sempre un po’ smarriti o paradossali – si legge, e non tra le righe, ma proprio nelle righe, qualcosa che somiglia un sollievo millenarista: e vabbé, se ne va il nonno, meglio lui che io.
A vederla in termini teorici, è una specie di scambio: preferite un’altra crisi economica planetaria oppure registrare un salto di mortalità nella fascia alta e altissima d’età? Oltretutto una fascia di vittime improduttive, e questo lo direbbero senza dubbio i famosi “mercati”, ma anche molte famiglie su cui è lasciato totalmente il peso delle cure e dell’assistenza: ecco un caso in cui il cinismo del profitto si accoppia tristemente a un cinismo di necessità.
In questa oscena tenaglia, lo squilibrio è evidente: scommettendo al ribasso sui mercati finanziari, le grandi potenze della speculazione produrranno altre ricchezze per sé e per i loro azionisti, in modo non dissimile da chi vende amuchina e mascherine a prezzi da mercato nero, cioè la collocazione etica è più o meno quella. Gli altri, cioè tutti noi, costretti ad accettare un baratto non contrattabile, cioè (come a Taranto, per analogia quasi perfetta) qualche sacrificio umano a fronte del mantenimento di un regime di vita che consideriamo ancora accettabile e in qualche modo (rispetto a molta parte del pianeta) privilegiato. Forse non lo sappiamo, tutto questo, forse ne intuiamo soltanto l’incombenza e l’alito fetido, forse siamo solo alla fase del sollievo corrente di non avere ancora “età avanzata e patologie pregresse”. Ma lo scambio, nei suoi termini ideologici, è assodato, chiaro, in qualche modo accettato. E quindi, si direbbe, abbiamo già perso.
 Non risponderò a domande irrispondibili, ovvio. Per esempio: quale memento mori spinge la sciura milanese a comprare ventisei pacchi di pasta invece dei soliti due? Quale istinto delle caverne spinge persone normali (oddio, normali… magari sono lettori di Libero) a menare un cinese sul tram? E’ inutile tentare di penetrare così in profondità nell’animo umano, è una regola di tutti i tempi che nei momenti in cui servono razionalità e nervi saldi si dà fuori di matto. E’ lo stesso meccanismo per cui “niente panico” è una nobilissima frase, saggia e intelligente, ma se dici niente panico urlandolo con gli occhi fuori dalle orbite ventiquattr’ore al giorno, con toni da Apocalisse, ditini alzati, il contorno cretino dell’”io l’avevo detto” e gli speciali, e le maratone, e le edizioni straordinarie, si rischia l’effetto opposto. (A questo proposito: spero che i microfoni dei tg che da qualche giorno sventolano sotto il naso di dottori, infermieri, infettati, cittadini di zone rosse, contadini stupefatti del morbo e sindaci febbricitanti, siano tutti monouso. Altrimenti, tra sputazzi e colpi di tosse, ogni intervistato dei prossimi due anni finirà in quarantena. Non è detto che sia un male).
Non risponderò a domande irrispondibili, ovvio. Per esempio: quale memento mori spinge la sciura milanese a comprare ventisei pacchi di pasta invece dei soliti due? Quale istinto delle caverne spinge persone normali (oddio, normali… magari sono lettori di Libero) a menare un cinese sul tram? E’ inutile tentare di penetrare così in profondità nell’animo umano, è una regola di tutti i tempi che nei momenti in cui servono razionalità e nervi saldi si dà fuori di matto. E’ lo stesso meccanismo per cui “niente panico” è una nobilissima frase, saggia e intelligente, ma se dici niente panico urlandolo con gli occhi fuori dalle orbite ventiquattr’ore al giorno, con toni da Apocalisse, ditini alzati, il contorno cretino dell’”io l’avevo detto” e gli speciali, e le maratone, e le edizioni straordinarie, si rischia l’effetto opposto. (A questo proposito: spero che i microfoni dei tg che da qualche giorno sventolano sotto il naso di dottori, infermieri, infettati, cittadini di zone rosse, contadini stupefatti del morbo e sindaci febbricitanti, siano tutti monouso. Altrimenti, tra sputazzi e colpi di tosse, ogni intervistato dei prossimi due anni finirà in quarantena. Non è detto che sia un male).
E’ tutto un po’ attraente (come nei film di zombie) e fastidioso, comprese le spigolature, i dettagli, la piccola cronaca ai tempi del colera, aneddoti, notizie vere e false che rimbalzano, dicerie, messaggi whatsapp, meme spiritosi e avventure private (mio cugino…), rimembranze manzoniane. Colore, insomma, che rischia di sovrastare le domande vere e sensate che è lecito farsi in presenza di un’emergenza sanitaria. E di alcune cose si parla, sorprendentemente, poco e niente, diciamo che brillano per assenza nel grande dibattito nazional-popolar-virale.
Volando basso, la profilassi. Quel sacrosanto “lavatevi le mani, cazzo!” che dovrebbe valere anche senza epidemie in corso, e che viene giustamente ripetuto in loop, ma che non è facile come si dice. E’ una questione sanitaria, mi sembra, anche la totale privatizzazione degli spazi pubblici, l’assenza di minime strutture gratuite e accessibili a tutti, per cui lavare le mani, se siete in giro per la città, vi costa come minimo la tassa di un caffè al bar, e quelli che una volta erano spazi pubblici ora sono spazi privati (provate a lavarvi le mani, che so, alla stazione centrale di Milano, dove già costa un euro pisciare).
E poi, se possibile, l’aria spaventata ed emergenziale causa una recrudescenza dell’eterno strabismo economico, per cui si snocciolano i dati delle Borse, anche Wall Street, i sinistri scricchiolii dello spread, le reazioni dei famosi mercati, ma non si dice, non si pensa, non si prende nemmeno in considerazione la posizione dei lavoratori meno garantiti del nostro mirabolante sistema. Cioè, cassa integrazione nei casi più gravi, telelavoro per chi può e sa, attività un po’ ridotte in zone dove il Pil del paese, parlandone da vivo, dà il meglio di sé, e va bene, un minimo di garanzia. Ma resta fuori, esclusa – quella sì in quarantena – tutta la fascia della Gig economy, dei lavoretti, del cottimo più o meno mascherato, del fattorino, del contrattino scritto male, della cooperativa farlocca, del lavoro a chiamata. Redditi minimi già in tempi normali, che si riducono senza alcun ammortizzatore, e senza che questo entri minimamente nell’ardito mosaico dell’informazione di questi giorni. Per intenderci: uno tirava la cinghia con 800 euro, che è già una vergogna, ora che per emergenza rallenta il lavoro dovrà farcela con 400, senza sapere per quanto tempo: niente airbag, per lui, nemmeno la dignità di partecipare a un bello scontro tra virologi telegenici e virologi al lavoro, o a quei bei siparietti sovranisti dove si grida all’untore. Solo oblio e rimozione. E invece, a ben vedere, sarebbe un’emergenza sanitaria anche questa.
 C’è sempre un momento, nel dispiegarsi implacabile della catena alimentare, in cui un organismo si guarda indietro per controllare che nessuno tenti di mangiarlo. Capita anche agli organismi più semplici. Prendi Matteo Salvini: per più di un anno, durante la sua cavalcata di arruffapopolo, non ha avuto bisogno di guardarsi alle spalle, abituato ad avere il resto della destra come truppa di complemento. Ora, invece, vede crescere un concorrente, Giorgia Meloni, e sente quel classico brivido western: non è più l’unico sceriffo in città. I segnali di nervosismo si moltiplicano: non solo per i sondaggi sulla popolarità del leader in cui la Meloni lo supera, ma anche per un certo feeling con i media, che per lui sembra in fase calante (uff, ancora Salvini!), mentre per la sora Giorgia c’è grande interesse e giubilo.
C’è sempre un momento, nel dispiegarsi implacabile della catena alimentare, in cui un organismo si guarda indietro per controllare che nessuno tenti di mangiarlo. Capita anche agli organismi più semplici. Prendi Matteo Salvini: per più di un anno, durante la sua cavalcata di arruffapopolo, non ha avuto bisogno di guardarsi alle spalle, abituato ad avere il resto della destra come truppa di complemento. Ora, invece, vede crescere un concorrente, Giorgia Meloni, e sente quel classico brivido western: non è più l’unico sceriffo in città. I segnali di nervosismo si moltiplicano: non solo per i sondaggi sulla popolarità del leader in cui la Meloni lo supera, ma anche per un certo feeling con i media, che per lui sembra in fase calante (uff, ancora Salvini!), mentre per la sora Giorgia c’è grande interesse e giubilo.
Si aggiunga che l’organismo principale della destra, che è sempre saldamente Salvini, comincia ad avere qualche problema con la preziosa pratica della mimetizzazione. Cioè, era un maestro ai tempi di metti la ruspa togli la ruspa, metti la felpa togli la felpa, metti la divisa togli la divisa, va bene. Ma la cosa funziona meno quando si ritrova a parlare di politica. Insomma, anche un camaleonte fa fatica, se lo metti su una stoffa scozzese. Dunque ecco Salvini antieuropeista, poi corregge un po’, poi parla Giorgetti e aggiusta ancora un po’, poi rimpappa qualcosa di nuovo Salvini, ma dice che questa cosa di uscire dall’Europa gliel’ha detta un pescatore calabrese. Ora capirete il disagio di una forza politica molto forte al Nord, che pretende di parlare alla finanza e all’impresa, che chiede a gran voce di andare al governo, che si fa dare la linea da un pescatore calabrese sull’uscita dalla Ue. Imbarazzo. Si aggiunga la provocazione sull’aborto e gli stili di vita “incivili”. E si aggiunga pure il comportamento sul famoso processo per sequestro di persona, dove già si vede la china, lo scollinamento dal “me ne frego!” ardito e burbanzoso, alla ricerca di cavilli da legulei.
Giorgia s’avanza, insomma. Litigano un po’ sulle candidature alle regionali (Calabria e Campania). Poi sul Corona Virus (lui accusa il governo, lei frena). Lui – uno che va a suonare ai citofoni accusando la gente di spaccio – imputa a lei di essere “destra radicale”. Lei gli ricorda che in Europa lui sta con la Le Pen. Nemmeno Ionesco avrebbe pensato a una commedia “Fascisti che si urlano: fascista!”. Insomma, in questo nuovo Sandra e Raimondo della grande sit-com italiana, pare che lui perda colpi e lei acquisisca smalto. Fa un viaggio negli States, che è tappa obbligatoria per tutti i leader italiani che vogliano contare qualcosa, fa le cene con i fans finanziatori. Soprattutto, sempre parlando di catena alimentare, ha davanti a sé una grande riserva di caccia. Sembra moderata, e questo piace a chi si è spaventato del Salvini delirante d’agosto. Al tempo stesso quando fa il mascellone volitivo (“Io sono la destra in questo Paese!”) è più credibile di quell’altro che bacia i prosciutti, ovvio.
Gran parte della trama della commedia sarà decisa dai media. Non tanto dai titoli dei giornali o dai commenti politici, quanto dall’arietta pop che si crea intorno al nuovo fenomeno da consegnare al gentile pubblico: la costruzione di una popolarità positiva, da guardare con simpatia. Per Salvini era stata l’elementare estetica del Gianburrasca (vediamo cos’ha combinato oggi Matteo), per Giorgia sarà l’aplomb da maestrina, severa ma, in fondo, alla mano. I due pescano nello stesso mare, e questa è una cosa che non va mai a finire bene. In più ognuno dei due punta ad essere onnivoro, a nutrirsi cioè sia di elettorato moderato che di curva ultrà. Quindi mettetevi comodi per le prossime puntate. Sandra e Raimondo. Uffa che barba.
 Nella triste prevedibilità delle cose c’è anche questa: per i prossimi mesi sentirete in sottofondo, laggiù, nascosta nel rumore di fondo, la noiosa tiritera della vertenza Unicredit. Cronache sindacali, penultime notizie nei telegiornali, trafiletti stanchi nelle pagine dell’economia, incontri interlocutori al ministero, eccetera eccetera. Numeri da qui al 2023: seimila lavoratori da licenziare (o prepensionare, o agevolare all’uscita, o tutti i pietosi eufemismi che si usano in questi casi) e profitti che salgono (5 miliardi l’obiettivo) per la gioia degli azionisti. Quindi lo dico qui, prima che la questione diventi logoro tran-tran quotidiano e noiosa ripetizione: seimila persone che perdono il lavoro non sono solo una voce di bilancio, ma famiglie che vanno in crisi, ragazzi che vedono l’orizzonte incresparsi, programmi futuri che vanno a rotoli, ansia, insomma migliaia di vite che cambiano in peggio, ceto medio che scivola verso la povertà e la paura del futuro. Detta semplice e brutale, è uno scambio di ricchezza tra lavoratori e azionisti, milioni e milioni di euro che si spostano dal lavoro al profitto, dai salari di molti alla rendita di pochi.
Nella triste prevedibilità delle cose c’è anche questa: per i prossimi mesi sentirete in sottofondo, laggiù, nascosta nel rumore di fondo, la noiosa tiritera della vertenza Unicredit. Cronache sindacali, penultime notizie nei telegiornali, trafiletti stanchi nelle pagine dell’economia, incontri interlocutori al ministero, eccetera eccetera. Numeri da qui al 2023: seimila lavoratori da licenziare (o prepensionare, o agevolare all’uscita, o tutti i pietosi eufemismi che si usano in questi casi) e profitti che salgono (5 miliardi l’obiettivo) per la gioia degli azionisti. Quindi lo dico qui, prima che la questione diventi logoro tran-tran quotidiano e noiosa ripetizione: seimila persone che perdono il lavoro non sono solo una voce di bilancio, ma famiglie che vanno in crisi, ragazzi che vedono l’orizzonte incresparsi, programmi futuri che vanno a rotoli, ansia, insomma migliaia di vite che cambiano in peggio, ceto medio che scivola verso la povertà e la paura del futuro. Detta semplice e brutale, è uno scambio di ricchezza tra lavoratori e azionisti, milioni e milioni di euro che si spostano dal lavoro al profitto, dai salari di molti alla rendita di pochi.
Il piano Team 23 viene annunciato quando appena si è messo via lo champagne per la “felice” conclusione del piano Transform 19, che ha fatto la stessa cosa nel triennio precedente: via qualche migliaio di lavoratori e su i profitti. Non si tratta quindi dell’azienda in crisi, dell’imprenditore che piange e che non ce la fa, che è costretto a licenziare con la morte nel cuore, che “salva” i dipendenti rimasti (narrazione tradizionale di stile marchionniano, da tutti accettata mentre gli Agnelli stappano). Bensì di una semplice partita di giro: soldi contanti che passano dalle tasche dei lavoratori a quelle dei proprietari, azionisti, supermanager, fondi sovrani che già guadagnano molto e vogliono guadagnare di più.
Segue lo spiegone tecnico-pratico: i clienti non vanno più allo sportello, pagano col telefono e le app, che è un po’ come dire: mi spiace gente, ma siccome abbiamo inventato il telaio a vapore, nelle filande c’è un sacco di gente che non ci serve più, cioè non è la prima volta che il profitto si fa scudo della tecnologia per far pagare il conto ai lavoratori.
Non si tratta naturalmente “solo” di una banca (il tratto è comune a tutto il sistema bancario italiano: meno posti di lavoro e più utili, e più bonus ai manager), ma di capire come sarà il disegno del futuro. Le imprese attive e sane che licenziano non sono una novità, ma anzi una tendenza in atto da anni. In più, si tratta di un evidente, quasi plastico, allargamento di quella famosa forbice delle diseguaglianze che tutti dicono di voler combattere e fronteggiare: chiamatelo come volete, il piano, ma alla fine chi ha di più avrà ancora di più e chi ha meno avrà ancora di meno.
Ora, prima che tutto divenga trattativa difensiva, tira e molla e stanca cronaca sindacale, resta il disegno generale: una progressiva proletarizzazione del ceto medio, un mercato che detta le regole della selezione e della qualità della vita della gente: certi saperi non servono più, c’è l’algoritmo, c’è la app, però serve gente che consegna i pacchi, possibilmente pagata a cottimo e con turni e carichi di lavoro, quelli sì, da filanda ottocentesca. Il questo caso la narrazione corrente è: il mondo cambia, che ci possiamo fare. Ma in questa enfasi sul cambiamento non si inserisce però il profitto, che non deve cambiare mai, che è l’unica variabile indipendente riconosciuta, benedetta e intoccabile. Accettando questo impianto culturale, peraltro dominante da decenni, tra un po’ avremo veramente bisogno di un Dickens a raccontare come una volta qui era tutta piccola borghesia, sicurezza e futuro tranquillo, e adesso… Dickens ai tempi dell’iPhone.
 Spiazzante, sorprendente, imprevedibile. La mossa del cavallo, con quel suo balzo irregolare a forma di L, la possibilità di saltare gli avversari è, negli scacchi, a saperlo giocare, un vero colpo gobbo. Sarà anche il titolo del prossimo libro di Matteo Renzi, che presenterà entrambi (sia il libro che la mossa) durante un tour di cento tappe, in camper, che batterà le regioni in campagna elettorale. Come dire: siete avvertiti, poi non venite a lamentarvi.
Spiazzante, sorprendente, imprevedibile. La mossa del cavallo, con quel suo balzo irregolare a forma di L, la possibilità di saltare gli avversari è, negli scacchi, a saperlo giocare, un vero colpo gobbo. Sarà anche il titolo del prossimo libro di Matteo Renzi, che presenterà entrambi (sia il libro che la mossa) durante un tour di cento tappe, in camper, che batterà le regioni in campagna elettorale. Come dire: siete avvertiti, poi non venite a lamentarvi.
Renzi non ci dice in cosa consista ‘sta famosa mossa a sorpresa, che, come ci tiene a precisare, “non è quella di agosto, ma la prossima”, quindi si capisce la popolazione mondiale con il fiato sospeso, i primi segnali di panico, la tensione, le mascherine a 300 euro il pacco.
Devo dire la verità: mi aspetto di tutto, da Renzi, perché è l’unico politico italiano veramente palindromo, cioè leggibile sia da sinistra a destra che al contrario. Non c’è cosa che Renzi abbia detto negli ultimi due anni di cui non abbia detto l’esatto contrario prima. La prescrizione (che voleva abolire), la Brexit (che non ci sarebbe stata, fidatevi), il potere di veto dei “partitini”, contro cui oggi non tuona più, essendo partitino lui stesso, ed esercitando il suo potere di veto e di ricatto, fino all’annuncio di votare con l’opposizione contro la sua maggiornaza.
Ora in attesa di vedere questa mossa annunciata che mischierà promozione editoriale, propaganda politica, comizi, camper e tutto il circo che si sa, siamo nel campo delle ipotesi, e una l’ha già fatta Brunetta: perché non immaginare una maggioranza di volenterosi con Salvini, Meloni, Silvio Buonanima e gli italiavivaisti? Sarebbe una buona mossa del cavallo (naturalmente smentita con sdegno, ma coi palindromi non si sa mai).
In attesa che si disveli il mistero, portiamoci avanti col lavoro, e suggeriamo le prossime mosse a sorpresa dell’imprevedibile statista.
La mossa dell’opossum. Felicemente sperimentata in Emilia-Romagna, consiste nel fingersi morti durante la battaglia, poi alzarsi come se niente fosse e gioire della vittoria (oppure criticare i vinti per la sconfitta col ditino alzato). Potrebbe tornare di moda alle elezioni in Toscana, dove la popolazione, vedendo Renzi sulla scheda, potrebbe avere reazioni imprevedibili.
La mossa Xylella. Sganciare Teresa Bellanova sulla Puglia con un attacco diretto al governatore Emiliano, come già annunciato, è una mossa dirompente. Riassumendo, avremmo una ministra che ha giurato da ministra col Pd, è passata a un altro partito dopo due minuti, e nemmeno un anno dopo contribuisce alla sconfitta di un candidato del Pd, suo alleato di governo. Consigliato: xamamina compresse.
La mossa di Macron. Dimenticata e abbandonata da tempo, era una mossa interessante di quando Macron andava di moda e faceva fico sentirsi dire “Macron italiano”. Ora che il Macron vero sta messo maluccio con i suoi cittadini, la sua polizia che mena parecchio, anche i pompieri, e la stella pare offuscata, la mossa Macron non va più di moda, ma anche qui, non si sa mai.
La mossa di Saturno. Ci sono momenti in cui, annoiato dal dibattito corrente, Matteo Renzi si lancia verso le stelle. Dice che qui ci si annoia, mentre tutto il mondo parla di intelligenza artificiale, futuro, ricerca ecc. ecc. Una mossa davvero dirompente per la politica italiana sarebbe l’intuizione che su Saturno Italia Viva sarebbe senza dubbio il primo partito, e dunque l’annuncio che si prepara una spedizione sarebbe politicamente coerente.
La mossa Tony Blair. Un sempreverde. Quando festeggia per la sconfitta di qualche sinistra in giro per il mondo, ecco Renzi tessere le lodi di Tony Blair, che è un po’ come su uno si ostinasse a portare come esempio un re merovingio, o un antico condottiero delle fiabe nordiche. Un “se c’era lui…” che fa un po’ tenerezza, perché suona come un “Ci sarei anch’io”.
 C’è un piccolo paradosso conficcato nelle elezioni emiliane che hanno steso al tappeto il mangiasalsicce del Sacro Cuore di Maria. E il paradosso è questo: nelle elezioni locali più nazionali che si siano mai viste, le più politiche, le più ideologiche, se mi passate il termine un po’ impegnativo per la Borgonzoni, ha vinto alla fine chi ha “nazionalizzato” meno la sfida, chi ha parlato di cose sensate, possibili, concrete. Osservate da fuori, da non emiliano-romagnolo, le forze in campo erano soverchianti in modo addirittura imbarazzante per copertura dei media (una citofonata di Salvini valeva come mille incontri pubblici di Bonaccini), questo al netto dei prevedibili leccaculismi e della piaggeria scoperta e manifesta, addirittura garrula ed entusiasta. In un Tg (?) Mediaset, un’intervista a Salvini si è conclusa con la richiesta di firmare il vetro della telecamera, come fanno i tennisti famosi a fine match, per dire. Aggiungerei il paradosso del candidato governatore impagliato, che sta appollaiato sulla spalla del capo come i pappagalli dei pirati.
C’è un piccolo paradosso conficcato nelle elezioni emiliane che hanno steso al tappeto il mangiasalsicce del Sacro Cuore di Maria. E il paradosso è questo: nelle elezioni locali più nazionali che si siano mai viste, le più politiche, le più ideologiche, se mi passate il termine un po’ impegnativo per la Borgonzoni, ha vinto alla fine chi ha “nazionalizzato” meno la sfida, chi ha parlato di cose sensate, possibili, concrete. Osservate da fuori, da non emiliano-romagnolo, le forze in campo erano soverchianti in modo addirittura imbarazzante per copertura dei media (una citofonata di Salvini valeva come mille incontri pubblici di Bonaccini), questo al netto dei prevedibili leccaculismi e della piaggeria scoperta e manifesta, addirittura garrula ed entusiasta. In un Tg (?) Mediaset, un’intervista a Salvini si è conclusa con la richiesta di firmare il vetro della telecamera, come fanno i tennisti famosi a fine match, per dire. Aggiungerei il paradosso del candidato governatore impagliato, che sta appollaiato sulla spalla del capo come i pappagalli dei pirati.
Sia messo a verbale: l’Emilia-Romagna è caso particolarissimo, a sé, non può (e non deve) fornire indicazioni su tutto il resto del paese. Però conferma una tendenza nazionale, o almeno la evidenzia: le narrazioni troppo spinte, lo storytelling estremo, la prevalenza della recita teatrale sul contenuto effettivo, pagano molto nell’immediato e poi poco, o pochissimo in prospettiva. E’ anche divertente seguire quello là che fa il digiuno, che citofona, cha fa colazione, pranzo, cena, che si traveste prima da poliziotto, poi da intellettuale con la giacca di velluto, le felpe, le ruspe, il mojito, la “liberazione” dell’Emilia-Romagna, coi bambini, senza bambini, con la bambina di Bibbiano che poi non è di Bibbiano, ma va bene lo stesso Capisco bene il fascino del circo, quel momento di sospensione in cui ti chiedi: e ora entrerà l’elefante o il giocoliere monco? O il clown suonerà un citofono? Ecco, bene. Poi, però, quando devi decidere a chi dare in mano gli ospedali, per dire, voti Bonaccini, e non quella che dice che chiudono di notte, il sabato e la domenica.
In generale, insomma, trovo strabiliante non tanto che si equipari la politica allo spettacolo (una cosa vecchissima che ci ha insegnato per decenni nonno Silvio), ma che i politici pretendano di sfuggire alle leggi spietate del mondo dello spettacolo dove, almeno un pochino, bisogna essere credibili. Puoi inventare la storia che vuoi, se fai narrazione, ma deve almeno un po’ assomigliare al vero. L’immagine dell’Emilia-Romagna come una specie di periferia di Calcutta che Salvini e la destra hanno cavalcato per mesi non è credibile nemmeno per chi lì non c’è mai stato, è un’esagerazione grottesca, è un numero di cabaret, di quelli troppo reiterati, insistiti, sfilacciati dall’uso.
Insomma, Salvini, che era nuovissimo, a un certo punto è sembrato vecchio, già visto. Non è la prima volta che succede, come sa bene l’altro Matteo. Sarebbe sconsideratamente ottimistico trarre qualche conclusione a livello nazionale dallo spettacolino emiliano (e dare per finito Salvini sarebbe l’errore più grave), ma il dato è abbastanza chiaro: personalizzare, trasformare un’elezione in un referendum, mettersi in primo piano con in mano il rosario o il cotechino, può funzionare la prima volta, forse la seconda, ma poi bisogna un po’ cambiare repertorio, come gli attori di telenovelas che a un certo punto si mettono a fare Beckett in teatro, e questo Salvini non lo potrà fare. 70.000 persone che lo avevano votato otto mesi fa questa volta non l’hanno fatto, e si capisce dunque la difficoltà del capopopolo che vede andarsene un po’ di popolo, pubblico che abbandona la sala, proprio mentre lui fa sforzi sovrumani, inventa nuovi numeri ed è al clou dello spettacolo.
 Allacciate le cinture di sicurezza e indossata una scomoda ma efficace tuta anti-cazzate, ho intrapreso il tempestoso viaggio nel delirio salviniano del rush finale della battaglia per l’Emilia Romagna. Mi trovo in difficoltà, devo ammetterlo: passare così senza paracadute da Silvio Pellico a Gandhi, a Mandela, e tornare a Salvini, fa un certo effetto. Spararsi in un piede per provare la pistola non è da tutti, così come votare per farsi processare e poi autoincoronarsi patriota perseguitato perché (forse) ti processano su tua richiesta. La modalità, insomma, è il testacoda un po’ condito di melodramma, con il solito tocco di vittimismo aggressivo e conseguente chiamata alle armi del “popolo”. Gli avvocati del Regno si metteranno a migliaia a difenderlo, dicono i suoi, e lui tuona di preparare tribunali molto grandi perché insieme a lui si processano “gli italiani”. Insomma c’è tutto e il contrario di tutto: il capopopolo arrogante e volitivo, accanto al lamento della vittima (a Milano si dice “fare il piangina”).
Allacciate le cinture di sicurezza e indossata una scomoda ma efficace tuta anti-cazzate, ho intrapreso il tempestoso viaggio nel delirio salviniano del rush finale della battaglia per l’Emilia Romagna. Mi trovo in difficoltà, devo ammetterlo: passare così senza paracadute da Silvio Pellico a Gandhi, a Mandela, e tornare a Salvini, fa un certo effetto. Spararsi in un piede per provare la pistola non è da tutti, così come votare per farsi processare e poi autoincoronarsi patriota perseguitato perché (forse) ti processano su tua richiesta. La modalità, insomma, è il testacoda un po’ condito di melodramma, con il solito tocco di vittimismo aggressivo e conseguente chiamata alle armi del “popolo”. Gli avvocati del Regno si metteranno a migliaia a difenderlo, dicono i suoi, e lui tuona di preparare tribunali molto grandi perché insieme a lui si processano “gli italiani”. Insomma c’è tutto e il contrario di tutto: il capopopolo arrogante e volitivo, accanto al lamento della vittima (a Milano si dice “fare il piangina”).
Però confesso: sono rimasto incantato davanti alla pagina web del #digiunopersalvini su cui centinaia di adepti della Setta accolgono l’invito a non mangiare per un giorno intero per sostenere il Nelson Mandela degli ultras del Milan, già ministro dell’Interno, premier in pectore, eccetera eccetera. Sono tanti, i misteri dell’Universo, e uno di questi è cosa spinga Anna C. da Giugliano in Campania, o Jessica B. da Milano, o Gabriele V. da Rapallo, ad aderire a un simile appello: “Matteo Salvinirischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà”. C’è una piccola vertigine, e per vari motivi. Il primo è che Salvininon rischia la galera e non ha salvato la Patria; il secondo è vedere gli adoratori del baciatore di caciotte e capocolli costringersi al digiuno (boom di adesioni, va detto, dopo colazione). Un sacrificio, tra l’altro, particolarmente doloroso per chi si riconosce nei veri valori che Salviniusa declamare dal palco dei suoi comizi: “La mamma, il papà, il Natale e il Parmigiano”. Lui, intanto, si fotografa in mezzo ai salami e scrive: “Stasera cena sostanziosa, domani io digiuno”. Non è da tutti mobilitare “il popolo” prendendolo per il culo così.
Va bene, la propaganda disintermediata di questi tempi non deve stupirci, però resta il fatto che così tanta propaganda, così scoperta, e di segni così opposti (la vittima e il condottiero, Silvio Pellico ma anche il digiunatore, il voto leghista a favore processo e le piazze leghiste contrarie al processo esibite nei tweet) è sorprendente. Si aggiunga la narrazione piuttosto esilarante di un’Emilia-Romagna messa peggio del Burkina Faso, che bisogna “liberare”. Insomma, io non ho niente contro Anna C. da Giugliano in Campania, o Jessica B. da Milano, o Gabriele V. da Rapallo che digiunano per solidarietà con Salvini, sono un po’, scusate il francesismo, cazzi loro. Però mi chiedo se dimostrino la stessa garrula boccalonaggine, lo stesso convinto e tignoso “cascarci come un pollo” al momento dell’acquisto, che so, di un frullatore, o della macchina nuova, o di un qualsiasi bene di consumo. Nel qual caso, temo, il Paese è messo addirittura un po’ peggio da come ce lo immaginiamo. Il tutto mentre si lanciano allarmi e anatemi (inascoltati, inutili) contro l’assoluta preminenza del salvinismo in tivù, su tutte le reti, in tutti i programmi, spesso blandito e riverito, trattato come se fosse davvero un eroe del Risorgimento appena tornato dallo Spielberg (che per Salvini è il regista di E.T.) dove era stato ingiustamente carcerato (?) per aver “difeso l’Italia” (?). Una commedia dell’assurdo che contiene ogni vizio, ogni trucco maldestro e ogni falsità, nemmeno mascherati, ma esibiti senza veli, anzi dichiarati e rivendicati, in un paese in cui essere senza vergogna sembra un vantaggio decisivo.
 Servirebbe Ken Loach, la sua poesia, il suo rigore politico, la sua capacità di sezionare il reale, per raccontare il disagio di una famiglia inglese in gravi difficoltà, insomma il calvario di precarietà e sofferenza della famiglia Windsor. Già alle prese con i problemi che abbiamo tutti (il caro-carrozze, il costo dei palafrenieri, le pressioni della lobby dei maggiordomi), questo modesto nucleo famigliare attraversa una tempesta di fibrillazioni e sentimenti che ha mobilitato la stampa mondiale. E poi dicono che non si parla dei poveri!
Servirebbe Ken Loach, la sua poesia, il suo rigore politico, la sua capacità di sezionare il reale, per raccontare il disagio di una famiglia inglese in gravi difficoltà, insomma il calvario di precarietà e sofferenza della famiglia Windsor. Già alle prese con i problemi che abbiamo tutti (il caro-carrozze, il costo dei palafrenieri, le pressioni della lobby dei maggiordomi), questo modesto nucleo famigliare attraversa una tempesta di fibrillazioni e sentimenti che ha mobilitato la stampa mondiale. E poi dicono che non si parla dei poveri!
La storia la conoscete tutti, perché l’argomento tocca le corde più sensibili nell’essere umano, cioè la pietà e la compassione, ma dunque ecco. Harry per campare è costretto a mettere insieme tanti lavoretti. Quando gli chiedi che lavoro fai?, non sa se dire prima consegne a domicilio, o dogsitter, o ripetizioni di araldica, ma poi si decide: Sua Altezza Reale il Principe Henry, Duca di Sussex, Conte di Dumbarton, Barone Kilkeel, Cavaliere Comandante dell’Ordine Reale Vittoriano, Personale Aiutante di Campo di S.M.”, che starebbe per Sua Maestà, cioè la novantatreenne Elisabetta, con corona, cappellino e tutto.
Harry ha sposato Megan, che è americana e del tè delle cinque se ne fotte alla grande, e anche lui, Harry è un po’ stufo della sua vita. In poche parole è di fronte a quelle scelte che i dannati della Gig economy affrontano ogni giorno: tenersi stretti quei cinque o sei lavoretti noiosi ma ormai sicuri, tipo Conte di Dumbarton il giovedì e il sabato mattina, o lanciarsi in una nuova avventura? Megan, si dice, l’ha convinto che vendere tazzine con scritto sopra Sussex Royal (marchio registrato), fare conferenze, frequentare il Jet Set è più conveniente e si può anche vestirsi normali. Quindi ecco le dimissioni da Principe (eh?), ma la necessità di mantenere qualcosa da mettere nel curriculum e da stampare sulle tazzine (Duca di Sussex).
Qui la critica si divide. C’è chi dà ragione ai fuggiaschi, perché è ora che comincino a fare una vita normale, emigrino in Canada, senza privilegi, senza pesare sul contribuente britannico. Molti sudditi sospirano pensando che almeno due se li sono levati dalle spese, un po’ quel sollievo che si prova in Italia quando si annuncia lo scioglimento degli enti inutili. Sarà dura, all’inizio, se uno non conosce la città fa fatica a consegnare pizze in bicicletta, come se la caverà Harry?
L’altra scuola di pensiero è la classica sindrome da Yoko Ono che si impossessa di tutti quanti quando c’è di mezzo una ragazza. Ecco, Megan (come Yoko) divide il gruppo, una cinica arrivista che si serve di Harry e della povera famiglia Windsor (i Beatles) per la sua arrampicata sociale, ma che ci tiene un bel po’ a rimanere Duchessa del Sussex (se no, cosa scrive sulle tazzine?). Al mega vertice tra la Regina, l’eterno Principe Carlo e i due fratelli, Harry e William per chiarire le cose si è giunti a un onorevole pareggio: Harry e Megan non prenderanno più soldi pubblici, ma la permanenza a mezzo servizio in famiglia permetterà loro di farne molti da privati. Rimane l’amarezza per una famiglia dilaniata dai rancori, dagli orari impossibili, dalle incombenze per sbarcare il lunario, ma anche lo stuporoso trip di vedere in onda dalla mattina alla sera, su ogni canale, un film in costume totalmente fuori dal tempo e dallo spazio.
Ma tale è il bisogno di questa famiglia inglese, così commoventi le loro vicende e così adatte all’immedesimazione (andiamo, chi di voi non ha mai ristrutturato un castello nello Yorkshire?), che il contribuente inglese paga di buon grado alla famiglia un reddito di cittadinanza di quasi cento milioni di euro all’anno (aggiungere 29 milioni di dollari per il personale, che come si sa “non è più quello di un tempo”). Insomma ci vorrebbe Ken Loach, sì. O monsieur Guillottin.
 Chissà con che spirito leggono i giornali e seguono i notiziari i 7.000 (settemila) psichiatri americani che hanno lanciato l’allarme sui comportamenti pubblici di Trump, denunciandone un chiaro disagio mentale. Crisi psicologica acuta, fino al rischio di “atti distruttivi”, che è una brutta diagnosi, soprattutto per uno che se fa un atto distruttivo non è che fracassa i piatti in cucina, ma può far scoppiare un nuovo massacro mondiale. Va bene, mi affido al giudizio di un grande scrittore, Don Winslow sull’attuale presidente: “Dal punto di vista medico non sei in grado di giocare a bingo in una casa di riposo”. Direi che basta.
Chissà con che spirito leggono i giornali e seguono i notiziari i 7.000 (settemila) psichiatri americani che hanno lanciato l’allarme sui comportamenti pubblici di Trump, denunciandone un chiaro disagio mentale. Crisi psicologica acuta, fino al rischio di “atti distruttivi”, che è una brutta diagnosi, soprattutto per uno che se fa un atto distruttivo non è che fracassa i piatti in cucina, ma può far scoppiare un nuovo massacro mondiale. Va bene, mi affido al giudizio di un grande scrittore, Don Winslow sull’attuale presidente: “Dal punto di vista medico non sei in grado di giocare a bingo in una casa di riposo”. Direi che basta.
Eppure, nel profluvio di tweet fitti di punti esclamativi e di maiuscole (qui non serve lo psichiatra, i tweet sono oggettivamente da bimbominkia), dietro il continuo abbaiare, si scorge in filigrana qualcosa di grande, come una soave confessione, di quelle fatte nei momenti di rabbia, e quindi vere.
I soldi. Sì, i soldi che gli americani pompano nel loro progetto irakeno, sono stati, sono e saranno tantissimi, e qualche autorevole studio (come scriveva Giampiero Gramaglia ieri su questo giornale) stima che nel giro di mezzo secolo si arriverà alla cifretta tonda tonda di 6.000 (seimila) miliardi di dollari.
Le reazioni di Trump alle gentili richieste irakene di levarsi dalle palle una volta per tutte si spiegano: come imprenditore ritiene inconcepibile di aver investito finora quasi duemila miliardi e doversene andare. Come presidente sa che tutti quei soldi sono un bel pezzo di Pil americano, più ricerca e sviluppo, tecnologie, listini di Borsa che non possono sparire di scena, pena la crisi della più grande industria americana, la guerra.
Soldi, insomma. E così fa un certo effetto vedere le comunicazioni ufficiali via social media del Presidente degli Stati Uniti d’America chiedere rimborsi, il vecchio caro “indietro i soldi” dell’investitore che ha rischiato troppo. Che la macchina militare americana sia una gigantesca industria che non si piò fermare si sapeva da sempre, ma Trump lo dice senza tante storie, senza girarci intorno: abbiamo investito un sacco di soldi, abbiamo costruito una base costosa, vogliamo il rimborso. Non c’è niente da fare, è l’ésprit del palazzinaro che lo possiede. Sarebbe un delitto se proprio il presidente imprenditore facesse fallire un affare come l’Iraq. Del resto, nessuna economia al mondo potrebbe perdere un investimento di tale stellare entità.
Che un presidente sotto impeachment, che perplime gli psichiatri, con le elezioni alle porte, che si gioca il tutto per tutto, possa fare qualcosa di irrimediabilmente cretino è purtroppo nell’ordine delle cose. Ma è grazie alle maiuscole da bulletto e ai punti esclamativi dei suoi sfoghi pubblici che forse si vede oggi con estrema chiarezza di cosa stiamo parlando: un affare da moltimila miliardi di dollari che nacque con Colin Powell (Segretario di Stato dell’amministrazione Bush) che agitava all’Onu una fiala di polvere bianca, mentendo sapendo di mentire, e con quell’alto bel tomo di Tony Blair che confessava di aver trovato le prove contro Saddam su Internet (ossignùr, ndr). Così nacque il grande affare, un investimento a lungo termine, perché si è ormai scoperto che le guerre non conviene vincerle, né perderle, ma farle durare a bassa o media intensità il più possibile, in modo che la grande macchina si perpetui. Una cosa che vale anche per la guerra alla droga al confine su degli Usa, i muri, eccetera eccetera. L’impero che parlava di guerre giuste e umanitarie e di esportazione della democrazia e di buoni e nobili sentimenti al napalm (come al solito), oggi tuona “indietro i soldi”. Ecco, diciamo che Trump fa un po’ di chiarezza, toglie alla faccenda un po’ di quella nebbiolina vergognosa che chiamò “umanitari” persino i bombardamenti.
Qui c’è la recensione di Thriller Café, a cura di Fabrizio Zamuser (cliccare per leggere), Sotto c’è la bella intervista di Alessandra Tedesco per la sua trasmissione Il Cacciatore di Libri su Radio 24 (cliccare per ascoltare)
 L’Italia reale, dunque. O almeno l’Italia reale delle classifiche. O meglio l’Italia reale delle classifiche che il Sole 24 Ore compila con certosina perizia ogni anno, e quest’anno anche. Sei maxi-indicatori, raccolta dati impressionante, che consente una divertente immersione, un carotaggio nelle sfighe (parecchie) e nelle gioie (pochine) del Paese, e che dovrebbe rispondere alla ferale domanda: alla fine, dove sarebbe meglio vivere?
L’Italia reale, dunque. O almeno l’Italia reale delle classifiche. O meglio l’Italia reale delle classifiche che il Sole 24 Ore compila con certosina perizia ogni anno, e quest’anno anche. Sei maxi-indicatori, raccolta dati impressionante, che consente una divertente immersione, un carotaggio nelle sfighe (parecchie) e nelle gioie (pochine) del Paese, e che dovrebbe rispondere alla ferale domanda: alla fine, dove sarebbe meglio vivere?
A Milano, dicono.
Ora è chiaro che bisogna fare la solita premessa, sulle medie, gli indicatori, le somme e le sottrazioni, oltre al dubbio se si possa davvero fotografare una cosa personale e variabile come la “qualità della vita”. “Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media”. Lo diceva Charles Bukowski e tenderei a dargli ragione.
E’ comunque istruttivo, quando si hanno dei numeri in mano, giocare un po’ alla ricerca di paradossi. Esempio: se davvero siete ossessionati da Giustizia & Sicurezza, come la grancassa mediatico-salviniana ci fa intendere da un paio d’anni, dovete andare a vivere a Oristano, prima in classifica per questo indicatore.
Ma poi, se i luoghi comuni sono comuni un motivo ci sarà, e quindi ecco Milano al primo posto per Affari & Lavoro, al secondo per Ricchezza & Consumi (dopo Aosta, saranno milanesi espatriati in montagna, vai a sapere), terza per Cultura & Tempo libero. Peccato certi dettagli: Milano vanta il primato nella densità dell’offerta culturale (2.059 spettacoli ogni 10 km quadrati), ma è quarantunesima per librerie (8,3 ogni 100.000 abitati), e ancora più giù per quanto riguarda le biblioteche: sessantaseiesima. Bene ma non benissimo. Prima per reddito medio complessivo per contribuente, prima per depositi bancari pro-capite, la capitale morale, faro e modello per il Paese, è prima anche per il totale dei delitti denunciati, piazzata benissimo su rapine, estorsioni e reati informatici, e insomma, dove ci sono i soldi ci sono anche quelli che li fregano, sembrerebbe una legge di natura. Risponde il sindaco Sala che è un posto dove i reati vengono denunciati, e questo spiega il dato. Vero, probabilmente. Emerge anche, però, un certo nervosismo degli abitanti, dato che ogni 100.000 milanesi ci sono più di 3.600 cause civili, e questo a parte il fatto che è piuttosto rischioso girare a piedi, in macchina o con altri mezzi (8,2 tra morti e feriti ogni 1.000 abitanti). Qualità della vita, ma attenti a attraversare.
Del resto, il primato di Milano, se ci aggiungiamo anche l’exploit della Brianza Ridens (Monza e Brianza sale al sesto posto, dal ventesimo di quattro anni fa) non è che la conferma di quel che si sapeva: il Nord nelle alte posizioni, il Centro piazzato decentemente, il Sud tramortito ai piani bassi della classifica. Nelle prime venti posizioni (con l’eccezione di Roma e Cagliari) c’è solo Nord; nelle ultime venti (con l’eccezione di Rieti e Imperia) c’è solo Sud, e la prima città meridionale in classifica è Bari, sessantasettesima.
Rimane aperto il quesito iniziale, cioè se si possa veramente disegnare una mappa della “qualità della vita”, ma è argomento troppo vasto per questa piccola rubrica. Tocca accettare la media come ulteriore beffa a chi viene per ultimo, a chi la abbassa, a chi non è primo per reddito, né per depositi bancari, oppure a chi nella tabella Affari & Lavoro non può dire quanti lavori o lavoretti deve fare per mettere insieme un reddito quasi intero. Spiacenti, la classifica ci dà la media, il famoso pollo di Trilussa, la cui funzione specifica è compattare gli estremi, il reddito medio è quello di chi ordina il sushi più il reddito di chi glielo porta in bicicletta, diviso per due. La qualità della vita, la testa nel forno, i piedi nel congelatore, appunto.
 Querele, avvisi di querele, promesse di querele, querele in mazzetti come gli asparagi o in bouquet come i fiori; al matrimonio c’è il lancio della querela, la damigella che la prende al volo verrà querelata entro l’anno. Oppure: vuoi salire a vedere la mia collezione di querele?
Querele, avvisi di querele, promesse di querele, querele in mazzetti come gli asparagi o in bouquet come i fiori; al matrimonio c’è il lancio della querela, la damigella che la prende al volo verrà querelata entro l’anno. Oppure: vuoi salire a vedere la mia collezione di querele?
Questa faccenda delle querele mi sa che ha preso un po’ la mano a tutti quanti, tra i fatti e i misfatti che riferiva ieri questo giornale (la signora Casellati) e le recenti performance di querele incrociate (annunciate) tra il Presidente del Consiglio e Salvini, prima che scivolasse sulla Nutella. La querela va di moda e si porta con tutto. Si aggiunga l’incredibile attività annunciatoria-querelatoria di Matteo Renzi, che fa il simpatico dichiarando che darà il nome dei querelati alle aiuole del suo parchetto, e siamo dunque alla pochade surrealista. Ma sia, la querela, vera, presunta, annunciata, precompressa, spedita via media, recapitata tramite il pizzino di un’intervista compiacente, o su carta intestata di qualche avvocato, fa ancora la sua porca figura. Dà un brividino, in qualche caso intimidisce, ovvio, ci si immagina uno stuolo di avvocati che sentono l’odore del sangue, tipo film americano.
Per carità, la giustizia faccia il suo corso, ma va segnalato che nel tempo dei social e delle tifoserie politiche, questa faccenda delle querele assume una curvatura che la colloca a metà tra Ionesco e Campanile, insomma, tra l’inarrivabile assurdo e il confortante ridicolo del mondo. Non già i potenti, ma i loro eserciti social – segnatamente negli ultimi giorni, quello di fede renzista – si trasformano magicamente in esegeti del codice civile, o penale, in collegi di azzeccagarbugli che lavorano all’uncinetto articoli e commi. Oppure in zelanti delatori. Mi risponde una signora su twitter: “La segnalo a Matteo Renzi, poi vedrà lui se querelarla”. Non rendendosi conto, la signora, di portare con sé un sapore così vintage, così démodé e al tempo stesso affascinante, un retrogusto di DDR e di Stasi, incartato come una caramella in quel “La segnalo”. Meraviglia.
E del resto, va detto, i supporter somigliano sempre al supportato: avere un leader che firmò querele sul palco, con l’avvocato, circondato dal pubblico plaudente, che diffuse indirizzi mail a cui segnalare offese ai suoi danni, aiuta nell’immedesimazione. Tutto scorre e tutto è querelabile o minacciabile di querela. Fatti conclamati, opinioni, battute, calembour, una volta gettati nell’arena dei social, hanno immancabilmente come risposta l’ombra di un avvocato che viene a tirarti i piedi di notte. Pacifiche signore, professoresse, impiegati, nonni felici, fulminati sulla via di Rignano, elencano articoli di codice, sfumature tribunalizie, sofismi da leguleio. E in questa loro spirale trascinano tutto quanto: i giornalisti tutti feroci nemici del loro Golden Boy, le televisioni peggio ancora, uh! Il Fatto, figurarsi! L’Espresso, non me ne parli! Uh! Cairo, pussa via! Ah, quel Formigli! Si crea così, presso piccoli ma inferociti strati di militanti da tastiera, una sindrome da isolamento che confina con il complottismo. Tutti ce l’hanno con loro, tutti fanno gossip (la casa di Renzi) invece di fare informazione (che so, il “milione di posti di lavoro” del Jobs Act). Poi passano a rimproverarti di quello che non scrivi (e Casaleggio? E Di Maio?, eterna variante di “e allora le foibe?”), poi dicono che è colpa di quelli che hanno votato no. E infine passano a vagheggiare attorno al codice civile e penale, sognando colonne di penitenti in fila davanti alla giustizia che renderà finalmente onore al loro Capo. Come si diceva: tra Ionesco e Campanile, una vernice spessa di ridicolo che copre la tragica sostanza: militanti che diventano arditi e truppe d’assalto, la querela tra i denti e molto sprezzo del ridicolo.
 Bene, è arrivato anche il docente universitario. Ora mancano solo il tramviere e l’astronauta, e poi il campionario dei nazisti è completo e possiamo finire l’album dei negazionisti del 2019. Non ci eravamo ancora ripresi da Miss Hitler, quella signorina con l’aquila e la svastica affrescati sulla schiena (Francesca Rizzi, 36 anni), così fiera di sé per aver vinto, appunto, un concorso di bellezza riservato alle “donne ariane” (ahahah!) su un social russo, che ecco arrivare altre chicche dal Terzo Reich. Una di queste delizie per intenditori è la signora Antonella Pavin, una che dice che ad Aushwitz c’erano piscine, il teatro e il cinema, insomma una specie di villaggio vacanze per ebrei, comunisti, gay, zingari e tutto il campionario di quelli che non dovevano restare al mondo. Perché, ci spiega l’esimio professore di Filosofia del diritto dell’Università di Siena, Emanuele Castrucci, “Hitler difendeva l’intera civiltà europea” e quelli che lui ammazzava a milioni sono “i mostri che oggi vi governano dominando il mondo”.
Bene, è arrivato anche il docente universitario. Ora mancano solo il tramviere e l’astronauta, e poi il campionario dei nazisti è completo e possiamo finire l’album dei negazionisti del 2019. Non ci eravamo ancora ripresi da Miss Hitler, quella signorina con l’aquila e la svastica affrescati sulla schiena (Francesca Rizzi, 36 anni), così fiera di sé per aver vinto, appunto, un concorso di bellezza riservato alle “donne ariane” (ahahah!) su un social russo, che ecco arrivare altre chicche dal Terzo Reich. Una di queste delizie per intenditori è la signora Antonella Pavin, una che dice che ad Aushwitz c’erano piscine, il teatro e il cinema, insomma una specie di villaggio vacanze per ebrei, comunisti, gay, zingari e tutto il campionario di quelli che non dovevano restare al mondo. Perché, ci spiega l’esimio professore di Filosofia del diritto dell’Università di Siena, Emanuele Castrucci, “Hitler difendeva l’intera civiltà europea” e quelli che lui ammazzava a milioni sono “i mostri che oggi vi governano dominando il mondo”.
Insomma, il catalogo è questo, soltanto nell’ultima settimana: una signorina tatuata che scriveva (a proposito degli ebrei) cose come “Questi subumani devono sparire dalla faccia della terra. Con i forni ci vorrebbe troppo tempo”, bontà sua. Poi la signora Pavin, comprese le esilaranti dichiarazioni del marito, che non sapeva delle passioni hitleriane della consorte (bisogna capirlo, sua moglie dice con un certo disprezzo che “lui vota Salvini”, un moderato, quindi, puah!). E infine il professor Castrucci, titolare di cattedra universitaria, dal cui profilo twitter escono perle di pensiero critico, come “Impalare la Boldrini” (tutto maiuscolo, come si addice ai veri leoni da tastiera), o “Si può dire zingari di merda?”, oltre all’immancabile “Hitler non aveva tutti i torti”.
Forse dovremmo inserire nell’elenco anche il consigliere comunale di Trieste (eletto con la Lega, poi passato a Forza Nuova, poi al gruppo misto), un certo Fabio Tuiach, che in un accorato intervento in consiglio si è detto “offeso” perché “Liliana Segre ha detto che Gesù era un ebreo”. Lui pensava venisse dalla California e fosse lì in vacanza.
D’accordo, fermiamoci, anche perché a compulsare la cronaca i casi sono decine. Si noti l’interclassismo: pezzi di lumpernproletariat ignorante, signore insospettabili nella loro villetta, docenti ordinari di filosofia del diritto, come dire che il virus contagia in ogni ambiente. E questo ci porta ai meccanismi di difesa che, una volta scoperti, mettono in campo le piccole aspiranti SS di casa nostra. Il percorso è sempre lo stesso, se ci fate caso. Primo passo: minimizzare e ridicolizzare, “ragazzate”. Libero titola sopra le foto delle due signore: “E questi sarebbero i nazisti che fanno paura”, col sottotesto (ma anche il testo, poracci) che la butta in burletta. Poi, quando scoppia il caso del docente universitario, scatta invece una specie di grottesco garantismo ideologico, per cui uno che dice che “Hitler difendeva la civiltà europea” o sogna di “impalare” l’allora presidente della Camera, finisce per appellarsi alla libertà di pensiero, un po’ come il cannibale che rivendica il diritto di non essere vegetariano. Tra questi due estremi, colpevoli e miopi, tra il “ma che sarà mai” e il “sono libero di dire quello che penso”, si annida la nuova barbarie nazista, e anche il morbido e banale giustificazionismo delle destre. Che nemmeno si nasconde più, come le armi (canne mozze, carabina modificata, pistola e revolver) trovati a casa del signor Maurizio Aschieri, 57 anni, che voleva fondare il Partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori. Anche lui, tra labari e svastiche, ce l’ha con gli ebrei. Chissà quanto pagherebbe per rimandarli ad Auschwitz, ma stavolta senza il cinema, il teatro e la piscina.
 Le probabilità che un italiano si imbatta in Matteo Salvini quando accende la tivù sono altissime, le cifre dell’Agcom parlano chiaro, a meno che non guardiate solo le lezioni di fisica alle quattro del mattino, prima o poi lo beccate. Ora che si veste come un regista della Nouvelle Vague farete un po’ fatica a riconoscerlo, ma solo per pochi secondi. Non sono un feticista delle classifiche, però, a memoria di spettatore, non ricordo una così clamorosa preminenza in tivù dell’opposizione rispetto al governo. Tra Salvini, che è un one-man-band, la sora Meloni in trance agonistica, e Silvio Buonanima che sulle reti Mediaset fa sempre il pieno a dispetto del disastro ambulante di Forza Italia, le percentuali sono schiaccianti. Di Maio e Zingaretti, che sarebbero i leader dei principali partiti di governo, risultano (mese di ottobre) presenti in tivù rispettivamente un terzo e un quinto del tempo di Salvini, ed entrambi meno di Matteo Renzi, che ha una presenza spropositata sia al suo spessore nei sondaggi, sia a ciò che ha da dire al mondo.
Le probabilità che un italiano si imbatta in Matteo Salvini quando accende la tivù sono altissime, le cifre dell’Agcom parlano chiaro, a meno che non guardiate solo le lezioni di fisica alle quattro del mattino, prima o poi lo beccate. Ora che si veste come un regista della Nouvelle Vague farete un po’ fatica a riconoscerlo, ma solo per pochi secondi. Non sono un feticista delle classifiche, però, a memoria di spettatore, non ricordo una così clamorosa preminenza in tivù dell’opposizione rispetto al governo. Tra Salvini, che è un one-man-band, la sora Meloni in trance agonistica, e Silvio Buonanima che sulle reti Mediaset fa sempre il pieno a dispetto del disastro ambulante di Forza Italia, le percentuali sono schiaccianti. Di Maio e Zingaretti, che sarebbero i leader dei principali partiti di governo, risultano (mese di ottobre) presenti in tivù rispettivamente un terzo e un quinto del tempo di Salvini, ed entrambi meno di Matteo Renzi, che ha una presenza spropositata sia al suo spessore nei sondaggi, sia a ciò che ha da dire al mondo.
Questo serve anche per dire che sì, la rete, la rete, i tweet, i post, i video, i gattini, le ruspe, i cotechini, va bene, ma poi è la cara vecchia tivù che fa i grandi numeri, che ti porta a casa di un pubblico spesso anziano e poco scolarizzato, terreno arabile per la propaganda. La questione delle regole, il sogno antico del “fuori i partiti dalla Rai” sta diventando come “la pace nel mondo”, bello, sì, ma è una cosa che si dice quasi per convenzione, mica che uno ci crede davvero, dai!
Denunciata giustamente la prevalenza del Salvini in tivù, resta un quesito che riguarda tutti i leader: in tivù per dire cosa? Quella di Salvini è ormai una campagna di mantenimento, all’ufficio marketing la chiamerebbero “fidelizzazione del cliente”. Ora che ha fatto il pieno nei sondaggi, vende la versione light, non più ruspante, nel senso di ruspa, non più smutandato per “essere come noi” (Ma come noi chi? Si copra! ndr), un po’ ripulito nei toni e nelle argomentazioni. Il solito esercizio mimetico che dovrebbe esser noto ormai a chiunque abbia più di sei anni. Diverso il caso di donna Meloni, che puntando tutto sulla faccenda identitaria (siamo italiani, cristiani, biondicci, un po’ fasci, che male c’è?) basta che alzi un po’ la voce. Il suo programma in fondo è essere quello che è, non una gran fatica.
In generale, insomma, il leader in tivù sta diventando un format piuttosto prevedibile. Finiti i tempi in cui il capo compariva solo in casi clamorosi, per dichiarazioni forti, per dare la linea. Ora ognuno gioca un suo ruolo già scritto. Di Maio in perenne arrossata difesa, Zingaretti guardingo, Renzi guascone incorreggibile, più altre comparse e personaggi minori che si dividono i pochi metri di palcoscenico rimasti (e a volte sarebbe meglio di no).
E poi?
E poi non si dice niente. Le posizioni, i caratteri, le parole, gli argomenti, sono cristallizzati come le zanzare del Mesozoico imprigionate nell’ambra, tutto è generico, tutto è volatile, come se la preoccupazione di essere in tivù fosse prioritaria rispetto a cosa poi dire in tivù, cosa comunicare, quale senso dare alla propria presenza.
Anche per questo Salvini tiene fieramente la posizione: lui è l’unico strumento della sua banda, suona solo lui, per il suo fronte parla solo lui, esiste solo lui. Sia quando balbetta imbarazzato di fronte a una domanda scomoda (una rarità), sia quando fa il ganassa sovranista (cosa che volentierissimo gli si lascia fare), dà anche fisicamente l’idea dell’uomo solo al comando, il contagioso fascino del pensiero elementare, il supremo “ghe pensi mi” che ben si conosce e che ha fatto tanti danni. Non c’è solo lo strapotere di Salvini in tivù, c’è il suo modo, diciamo così sovranista, di usarla. O meglio (o peggio) di lasciargliela usare.
 Non so se siete pronti alla Rivelazione e spero che ciò non sconvolga troppo le vostre vite, ma venerdì questo, cioè dopodomani, nasce il nuovo partito di Calenda Carlo, come il countdown sulle sue homepage fa intuire (meno tre! Meno due!, tipo razzo nordcoreano). Non ci soffermeremo sull’evento, programmi, statuto, leadership, simboli e nomi, ma sul vezzo italiano di farsi un partito quando la situazione si fa confusa (cioè sempre). Onore a Calenda che almeno ha un suo percorso politico (simile al labirinto di Shining, peraltro), ma in generale si sente un intenso profumo di proporzionale e c’è chi pensa di contare tanto contando poco, un classico dai tempi di Bettino buonanima.
Non so se siete pronti alla Rivelazione e spero che ciò non sconvolga troppo le vostre vite, ma venerdì questo, cioè dopodomani, nasce il nuovo partito di Calenda Carlo, come il countdown sulle sue homepage fa intuire (meno tre! Meno due!, tipo razzo nordcoreano). Non ci soffermeremo sull’evento, programmi, statuto, leadership, simboli e nomi, ma sul vezzo italiano di farsi un partito quando la situazione si fa confusa (cioè sempre). Onore a Calenda che almeno ha un suo percorso politico (simile al labirinto di Shining, peraltro), ma in generale si sente un intenso profumo di proporzionale e c’è chi pensa di contare tanto contando poco, un classico dai tempi di Bettino buonanima.
Va detto che ne abbiamo visti un bel po’, passare sotto i ponti, e la questione dei nomi da dare ai partiti si fa complicata. Sembra passato un secolo, ma era solo il 2011 quando Montezemolo sventolava il suo programma per salvare l’Italia, (“il foglio del fare”, lo chiamava), annunciando sue liste alle elezioni, che poi non fece. Era una specie di liberismo operoso, un volenteroso lasciate-fare-a-chi-ha-la-Ferrari, smart, futurista, poi si aggregò al carro di Monti e se ne persero le tracce. Si chiamava Italia Futura, non risulta nemmeno una lapide da nessuna parte.
Siccome “futura” aveva portato un po’ sfiga, Corrado Passera si inventò Italia Unica, sembra un altro secolo, ma era l’altro ieri: 2015. L’ambizione era di fare “un grande partito, anzi il più grande partito italiano”. Ministro di Monti, gran capo di Banca Intesa, anche Passera aveva un sogno efficientista-liberista, anche lui parlava molto di fare, di sbloccare, di agevolare, con quel virile su-le-maniche-e-lavorare che ha reso famosi i lombardi, specie nelle barzellette. Dopo il pomposo varo, della nave si perse traccia, fino al momento del naufragio, nemmeno due anni dopo, un dignitoso autoscioglimento, erano tristi pure le tartine.
E poi, diciamolo, il partito è una specie di status symbol, un po’ sopra lo yacht di lusso, la villona col molo privato, il jet personale. Così abbiamo Flavio Briatore che si mette “al servizio degli italiani” con il suo Movimento del Fare. Tutti vogliono fare, fare, fare, ma le cose si complicano quando si cerca di spiegare che cosa cazzo fare. Se ho ben capito dalla laboriosa spiegazione del leader, si tratterebbe di mettere in rete alcuni talenti (mia supposizione: imprenditori), per fare delle cose. Un po’ vago, diciamo, a parte il sogno di Briatore più volte ripetuto: fare della Sardegna una specie di Ibiza e della Puglia un cronicario per pensionati ricchi europei (come la Florida, infatti). Trattandosi di imprenditore turistico, direi che siamo più vicini al Movimento del Fatturare.
Più preciso il disegno di Noi italiani, il movimento di Della Valle, fondato e annunciato nel 2015, poi scomparso dai radar, recentemente tornato a galla, forse causa invito televisivo. Dice il leader e fondatore Della Valle che lui la pagherebbe anche, una patrimoniale, ma poi non sa dove vanno a finire i soldi. E allora propone di pagare questa patrimoniale telefonando al sindaco e chiedendo se c’è da mettere a posto un’aiuola, o da pitturare il soffitto del Comune. Facessero così tutti gli imprenditori… Eccellente proposta politica che teorizza, in pratica, il ritorno alle Signorie, con il miliardario di zona che elargisce welfare e manutenzione. A quei tempi i signorotti gareggiavano a chi aveva la torre più alta, ora si inventano un partito, sempre, sia chiaro, improntato al buon senso e soprattutto al fare, fare, fare, qualunque cosa voglia dire. Diciamo che tra banchieri, imprenditori, grandi manager, questa faccenda di fare i salvatori della patria torna periodicamente di moda, nel nome c’è sempre Italia, o Italiani, o futuri, o unici, o a tempo perso. Insomma, suggerirei di lasciar perdere, per decenza.
 Vorrei avvertire il direttore e gli avvocati che qui si rischia grosso. Perché io vorrei scrivere sulla ridente città di Verona, quella con “la squadra fantastica a forma di svastica”, come cantano certi suoi tifosi. Vorrei scrivere di quel bellissimo borgo, insomma, ma mi capita sotto gli occhi una mozione presentata da un consigliere comunale proprio a Verona, in cui si chiede una “condanna politica” (eh?) per chi diffama la città di Verona. Quindi se io faccio una battuta su Verona – che è in effetti il più bel quartiere di Brescia – può anche darsi che debba subire una “condanna politica” dalla città di Verona, di Giulietta, dell’Arena, eccetera eccetera, che potrà anche (leggo la mozione) “adire le vie giudiziali” se uno si permette di attaccare Verona “diffamandola ingiustamente”.
Vorrei avvertire il direttore e gli avvocati che qui si rischia grosso. Perché io vorrei scrivere sulla ridente città di Verona, quella con “la squadra fantastica a forma di svastica”, come cantano certi suoi tifosi. Vorrei scrivere di quel bellissimo borgo, insomma, ma mi capita sotto gli occhi una mozione presentata da un consigliere comunale proprio a Verona, in cui si chiede una “condanna politica” (eh?) per chi diffama la città di Verona. Quindi se io faccio una battuta su Verona – che è in effetti il più bel quartiere di Brescia – può anche darsi che debba subire una “condanna politica” dalla città di Verona, di Giulietta, dell’Arena, eccetera eccetera, che potrà anche (leggo la mozione) “adire le vie giudiziali” se uno si permette di attaccare Verona “diffamandola ingiustamente”.
Che palle, nasce tutto dallo stadio, dai cori razzisti a Balotelli, che hanno causato un’ondata di sordità in città, con la difesa schierata a testuggine: Cori razzisti? Ma nemmeno per sogno! E intanto fioriscono su Youtube filmini e prove audio-video, oltre a certi divertenti cortometraggi con capo ultras – aspirante SS allo spritz – che inneggia a Adolf Hitler. Ma insomma, la città di Verona, di cui vorrei parlare un gran bene per non incorrere in una “condanna politica” (eh?) del consigliere comunale Andrea Bacciga (già rinviato a giudizio per saluto fascista), non è nuova alle orecchie foderate di prosciutto. Meno di un mese fa i buuu razzisti erano per Kessie, bravissimo zappatore del Milan, e la risposta della società Hellas Verona, via social, è che non era vero e avevano solo fischiato l’arbitro. Insomma, niente, orecchie tappate. E occhi ben chiusi, perché è capitato che sugli spalti degli ultras del Verona comparissero bandierine con la svastica, per dire.
E’ vero: di Verona si parla soprattutto per questioni di destra ultrà, cattolici col cilicio e feti di plastica per portachiavi, buontemponi che inneggiano a Hitler e che al family day, sfilano con politici di prima fila (tipo quel Fontana che diventò ministro per la famiglia). Non è giusto. Ora se ne parlerà anche per la mozione che punisce chi “getta fango” su Verona, è un passo avanti.
Immagino una simile mozione votata, che so, a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento. Zola e Balzac nella stessa cella che giocano a briscola rimproverandosi certe descrizioni: “Ma che cazzo, potevi star zitto sui topi della Senna!”. Oppure lo stato dell’Arizona che condanna Steinbeck per aver messo in cattiva luce gli abitanti di laggiù, un po’ severi (a schioppettate) con i migranti. Insomma, la mozione di Verona, per cui vorrei che questa bella città andasse famosa nel mondo, apre scenari interessanti soprattutto dal punto di vista letterario (Dostoevskij fu condannato a morte per molto meno, e la scampò all’ultimo minuto). Denuncerei anche Shakespeare, se fossi in loro, perché Verona non merita che si getti fango su di lei e la si descriva come un posto dove le famiglie si odiano e una storia d’amore finisce con tutti quei morti. Presto, una “condanna politica” (eh?) per il vecchio William! Immagino lo sconcerto in città quando Otello (che è “negro” come Balotelli) strangola Desdemona (le “nostre” donne!).
So perfettamente che a Verona abitano anche molte persone normali, bravi cittadini e gente perbene, che probabilmente vivono male questa fama della città e che vedranno a occhio nudo lo tsunami di ridicolo portato da una simile mozione. A loro va tutta la solidarietà, ovvio, ma anche quel vecchio monito da avanspettacolo, per cui si potrebbe dire all’ultras nazi: “Io non ce l’ho con te, ma con chi non ti butta di sotto”. Per dire che sottovalutazione e accettazione del fenomeno, i vari “sono ragazzate” e “non è vero”, non curano e non sopiscono, ma suonano come incoraggiamento.
Ps. Comunque è bellissima, eh!
 Se state nel centro di una piazza, è difficile vedere la città. Meglio su una torre molto alta. Meglio ancora in elicottero (per noi umani: Google maps). Per le elezioni in Umbria è la stessa cosa: si cercano col microscopio le crepe nelle tattiche recenti, i dettagli contingenti, mentre alzandosi un po’ sull’orizzonte si vedrebbe una storia lunga, che ha portato fin qui dove siamo finiti: leghisti e scontenti (e non vale solo per l’Umbria, anzi). Se ogni tanto si capisse (ma così, per passatempo) che la politica è soprattutto comprensione delle dinamiche sociali, delle curve che prendono le vite della gente, si spiegherebbe meglio la regione rossa, laboriosa e civilissima, che si butta nelle braccia del mangiatore di salsicce sovranista. “Dopo 50 anni!”, esultano da destra, manco avessero preso la Bastiglia.
Se state nel centro di una piazza, è difficile vedere la città. Meglio su una torre molto alta. Meglio ancora in elicottero (per noi umani: Google maps). Per le elezioni in Umbria è la stessa cosa: si cercano col microscopio le crepe nelle tattiche recenti, i dettagli contingenti, mentre alzandosi un po’ sull’orizzonte si vedrebbe una storia lunga, che ha portato fin qui dove siamo finiti: leghisti e scontenti (e non vale solo per l’Umbria, anzi). Se ogni tanto si capisse (ma così, per passatempo) che la politica è soprattutto comprensione delle dinamiche sociali, delle curve che prendono le vite della gente, si spiegherebbe meglio la regione rossa, laboriosa e civilissima, che si butta nelle braccia del mangiatore di salsicce sovranista. “Dopo 50 anni!”, esultano da destra, manco avessero preso la Bastiglia.
L’aumento dell’affluenza ingrossa il vantaggio di Salvini e fa intuire che un po’ dei famosi astenuti che “bisogna riportare alla politica” ce li ha riportati lui. L’alleanza che lo contrastava era messa su in fretta e furia, il candidato un perdente perfetto (per contrastare la destra montante, un imprenditore moderatissimo, la solita solfa), senza contare i 5s in caduta libera e il governo della Regione che ne ha fatte più di Carlo in Francia, trattando (un classico) la Sanità come agenzia di collocamento per gli amici, e molti altri pasticci. Ce n’è abbastanza per disamorarsi, anche se per uno che abbia qualche anche vaga formazione “di sinistra” per votare Salvini ci vuole qualcosa di più.
E quel qualcosa di più è il cambiamento senza cambiamento. Dopo anni e anni di retorica su “gli operai non ci sono più” – brutti volgari, pussa via, noi vogliamo le startup – i metalmeccanici di Terni sono ancora lì a farsi il culo. E quando andarono a Roma a protestare (ottobre 2014, con un governo Renzi scintillante post-europee e Alfano agli interni) vennero manganellati duramente, come per dire chiaro e tondo che il modello di sviluppo era un altro. Il grande cioccolato è multinazionale, il tessuto di piccole e piccolissime aziende manifatturiere è fittissimo. La terra, l’agricoltura, quelle benedette eccellenze di olii e vini, scivola sempre più verso la Disneyland del turismo, dal mezzadro al Bed and Breakfast è un attimo.
L’imperativo categorico, a destra, a sinistra, ovunque in cielo e in terra, è sviluppo-sviluppo-sviluppo, e naturalmente questo cambia sentimenti, umori e composizioni sociali. Fino a un appiattimento di orizzonti e di desideri: è tutto un indistinto ceto medio spaventato di riscivolare indietro, scontento, incazzato, deluso.
Come si vede, a mettere insieme non gli ultimi sei mesi, ma gli ultimi dieci, vent’anni, quella cartina impressionante dell’Umbria che era tutta rossa e ora è tutta verde un po’ si spiega. Probabile che la faccenda sia ancora più strutturale (l’Emilia-Romagna sì, che sarà un test!), cioè che il sistema progressista, il modello di sviluppo delle regioni “rosse” abbia fatto quel che doveva fare, e che ora non serva più, ciao, tanti saluti. Bella e nobile, la tradizione contadina, ma il proprietario di B&B, temo, tenderà a preferire la flat tax alla pace nel mondo, e nelle città d’arte “il decoro”, nome nobile della guerra ai poveri, verrà prima di tutto il resto. C’è insomma un “egoismo di necessità”, che certo non verrà scalfito dai famosi “valori” della sinistra, che, tra l’altro, trascolorano e impallidiscono giorno dopo giorno. Troppi pochi elettori, in Umbria, per fare veramente da test, troppe variabili contingenti dettate dall’emergenza. Ma il disegno su larga scala è abbastanza preciso: molti elettori passano dalla fase “non ti voto più” alla fase “ti voto contro”. Non è nemmeno politica, certe volte, ma un umore, un’onda, un sentimento, che viene da quello che si è seminato per anni, non negli ultimi mesi.
 Lo dico in latino per adeguarmi all’argomento: Dan Brown gli fa una pippa. E poi lo dico anche da lettore stupefatto di cronache e giornali: ma guarda che razza di storia.
Lo dico in latino per adeguarmi all’argomento: Dan Brown gli fa una pippa. E poi lo dico anche da lettore stupefatto di cronache e giornali: ma guarda che razza di storia.
Vabbé, prima la cronaca. In una meravigliosa alba dell’ottobrata romana, alcuni tizi entrano in una chiesa molto importante (Santa Maria in Traspontina, 90 secondi a piedi dalla cattedrale di San Pietro), rubano alcune sculture in legno, escono e le buttano nel Tevere. Filmano tutto e diventano più o meno eroi dell’ala destra della Chiesa, quelli che fanno la guerra a Francesco, che apre troppo, esagera, fa casino, rinnova di corsa, stai calmo, amigo. Oggetto del contendere, il sinodo dell’Amazzonia, convocato dal papa, dietro il quale si combattono una guerra politica e una guerra di religione, il tutto all’interno della stessa religione. Si mettano nel conto anche dissesti economici, sgambetti, dossier, accuse di qua e di là, dispute teologiche, frizioni politiche, fino al furto in chiesa (Dan Brown, come sopra). In soldoni: il sinodo dell’Amazzonia si occupa di cose toste come la difesa del pianeta, il fatto che quei milioni che vivono là, accanto alla foresta, sono un po’ seccati che gli taglino il posto in cui vivono allo scopo di coltivare mangime per futuri hamburger. Naturalmente (mea culpa) non ho nemmeno la più pallida idea di come funzioni un sinodo, discuteranno tra loro, credo. Ma intanto, nelle cerimonie di apertura, le popolazioni indigene hanno portato in dono queste statue di legno, che raffigurano la Pachamama, cioè una donna incinta, cioè, per loro, la Madre Terra, da cui viene tutto, eccetera eccetera. Insomma, un dono simbolico, un pezzo consistente della cultura india, un buon auspicio per il dialogo. Finché un commando di aspiranti Templari ruba le statue e le butta nel fiume (notevole la zoomata mistico-turistica su Castel Sant’Angelo).
Ora viene il bello, perché uno pensa: cazzo, furto di opere d’arte in una chiesa! E’ una cosa per cui puoi prenderti qualche annetto come niente, se oltre ai testi sacri leggi anche il Codice Penale. Invece pare sia tutto un po’ in sordina, già i ladri che si filmano è bizzarro, poi compaiono qui e là delle simil-rivendicazioni. Cioè analisi e cronache che giustificano il gesto.
E’ vero che un giro esplorativo nella galassia internet degli ultra-cattolici è sempre istruttivo (tipo andare a cena con Bonifacio VIII), ma stupisce lo stesso di trovarsi di fronte al ragionamento tipico delle guerre di religione. Simboli nemici, sacrilegio. Il furto è definito “Autodifesa”, oppure “Cattolici gettano gli idoli nel Tevere”, o “Non è furto ma legittima difesa”, poi via con citazioni, versetti, pezze d’appoggio, sacre scritture per dire che gli idoli pagani, eccetera eccetera, guai vade retro, pussa via, buttamolo ar fiume.
Disputa dal sapore vagamente ztl-medievale, d’accordo, ma attenzione che la curvatura farsesca non faccia velo alla sostanza. Non solo all’interno della Chiesa e contro questo papa ci sono pressioni e fronde e dispetti a non finire, ma si agisce anche con azioni che travalicano un pochino il codice penale. Chiunque abbia mai frequentato uno stadio sa che comincia così, prima ci si ruba le bandiere e poi finisce a botte (si perdoni il paragone). Disputa teologica, ma anche segno di fortissima pressione e di scontro ideologico, tipo la ragazza Greta che avverte il mondo dell’emergenza (in questo caso il papa), contro i suoi insultatori e denigratori professionisti à la Feltri (in questo caso i ladri di statue). E’ una serie che va avanti da duemila anni, quindi attendiamo le prossime puntate e i prossimi secoli, ma intanto si registra, sempre per la cronaca, un’impennata mediatica dei tradizionalisti, Così tradizionalisti, da mettere le loro gesta su Youtube. Dai, cazzo, un po’ di coerenza! Giovanna d’Arco non l’avrebbe mai fatto.
 Gli amici del Book Pride (a Genova dal 18 al 20 ottobre) mi hanno chiesto di dire qualcosa sul tema della manifestazione, che è il Desiderio, anzi, “Ogni desiderio”. E mi hanno chiesto se c’era qualche personaggio della letteratura a me caro con un suo desiderio, e che io lo spiegassi, lui e il suo
Gli amici del Book Pride (a Genova dal 18 al 20 ottobre) mi hanno chiesto di dire qualcosa sul tema della manifestazione, che è il Desiderio, anzi, “Ogni desiderio”. E mi hanno chiesto se c’era qualche personaggio della letteratura a me caro con un suo desiderio, e che io lo spiegassi, lui e il suo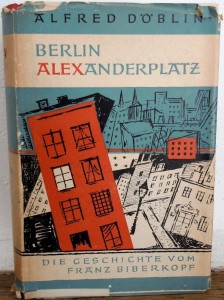 desiderio.
desiderio.
Così ho scelto uno con cui faccio a botte da un sacco di tempo, che è Franz Biberkopf, il protagonista di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin. Franz cosa vuole, cosa desidera? Vuole vivere onestamente, è uscito dal carcere e vuole rigare dritto. E’ davvero questo il desiderio di Franz Biberkopf? Ho ripreso in mano il libro, mi sono tuffato ancora una volta in quella Berlino del ’28 che Döblin agita e disegna e fa muovere in quelle pagine, cercando di star dietro a Franz, di capire cosa vuole davvero.
E’ un libro pazzesco, Berlin Alexanderplatz, e Franz BIberkopf è un personaggio vivo e perfetto, ripugnante, gretto, e al tempo stesso così umano nel suo essere vittima del Destino. I suoi desideri, vedremo, contano niente, spazzati ogni volta dai colpi che la vita gli tira. Vittima e complice. Una pallina nel flusso.
Parlerò di lui, a Genova (domenica 20, sala dell’Archivio Storico del Comune di Genova, a Palazzo Ducale, ore 17.00), ma non solo di lui. E cosa (e come) succede a Frank Biberkopf ci dirà del suo desiderio, del suo essere schiacciato e della sua resurrezione – finalmente senza desideri, pulito, mondato, finalmente innocuo, pronto (il libro esce nel 29, Doblin, ebreo, aveva capito cosa aspettava il mondo) ad essere trasportato in un Destino più grande di lui. Grazie a chi viene ad ascoltare la storia di Franz Biberkopf, e grazie a Book Pride per avermi dato l’occasione di ributtarmi ancora lì dentro insieme a Franz, perché, come scrive Döblin: “Per molti non sarà tempo perduto osservare e ascoltare tutto questo, per coloro che, come Franz Biberkopf, abitanoin una pelle d’uomo, e ai quali succede, come a Franz Biberkopf, di pretendere dalla vita più che il pane quotidiano”
Ci vediamo lì.
Book Pride – Domenica 20 ottobre, Sala dell’Archivio Storico del Comune di Genova, a Palazzo Ducale, ore 17.00
 Così, abbiamo un problema di soldi. Sai, la novità, d’accordo. Ma qui c’è un problemino un po’ più grosso, diciamo globale, che riguarda potenzialmente sette miliardi di persone, con l’obiettivo di farglieli spendere, i soldi. Mister Zuckerberg, cioè Facebook, comparirà settimana prossima davanti a un Comitato della Camera degli Stati Uniti per spiegare la sua moneta, Libra. In sostanza (stavo per dire: in soldoni) si tratta di una criptovaluta (tipo bitcoin) legata al valore del dollaro, scambiabile via Facebook, Messenger, WhatsApp. Siccome il ragazzo Zuckerberg non è per niente ambizioso, dice cose come “Reinventare la moneta”, e “Trasformare l’economia globale”. Al primo momento entusiasti, alcuni grandi gruppi del settore sono scesi precipitosamente dal carro: PayPal, poi Visa e Mastercard: grazie, il progetto è interessante ma abbiamo anche altro da fare, non saranno tra i soci fondatori. In ogni caso, molto probabilmente nel 2020 potremo pagare qualunque cosa mandando la cifra e un messaggio sul telefono. Comprare una Porsche a Singapore, spostare capitali ovunque, fare regali di compleanno, e – sarò pessimista io – già mi vedo i sacerdoti del “che figata!”, “smart!”, “il mondo cambia e voi state ancora lì coi sindacati!”. Eccetera eccetera. Una banca, insomma, e contando gli utenti di Facebook, una banca con due miliardi e mezzo di potenziali clienti, cioè una mostruosità globale mai vista in natura (come tutte le banche, dirà che fa tanto del bene, ovvio). Un bottoncino accanto al “like” con cui spostare soldi.
Così, abbiamo un problema di soldi. Sai, la novità, d’accordo. Ma qui c’è un problemino un po’ più grosso, diciamo globale, che riguarda potenzialmente sette miliardi di persone, con l’obiettivo di farglieli spendere, i soldi. Mister Zuckerberg, cioè Facebook, comparirà settimana prossima davanti a un Comitato della Camera degli Stati Uniti per spiegare la sua moneta, Libra. In sostanza (stavo per dire: in soldoni) si tratta di una criptovaluta (tipo bitcoin) legata al valore del dollaro, scambiabile via Facebook, Messenger, WhatsApp. Siccome il ragazzo Zuckerberg non è per niente ambizioso, dice cose come “Reinventare la moneta”, e “Trasformare l’economia globale”. Al primo momento entusiasti, alcuni grandi gruppi del settore sono scesi precipitosamente dal carro: PayPal, poi Visa e Mastercard: grazie, il progetto è interessante ma abbiamo anche altro da fare, non saranno tra i soci fondatori. In ogni caso, molto probabilmente nel 2020 potremo pagare qualunque cosa mandando la cifra e un messaggio sul telefono. Comprare una Porsche a Singapore, spostare capitali ovunque, fare regali di compleanno, e – sarò pessimista io – già mi vedo i sacerdoti del “che figata!”, “smart!”, “il mondo cambia e voi state ancora lì coi sindacati!”. Eccetera eccetera. Una banca, insomma, e contando gli utenti di Facebook, una banca con due miliardi e mezzo di potenziali clienti, cioè una mostruosità globale mai vista in natura (come tutte le banche, dirà che fa tanto del bene, ovvio). Un bottoncino accanto al “like” con cui spostare soldi.
Ma di più: per la prima volta a livello così esteso e internazionale, un’azienda privata possiede una sua valuta, e dunque, alla lunga, uno strumento di pressione economica e politica, che travalica di un bel po’ la faccenda dell’impresa e del profitto. Comprensibile che alcune delle grandi compagnie che maneggiano denaro si siano leggermente spaventate: se questa famosa moneta Libra si libra davvero, con la velocità con cui è cresciuta la galassia Facebook, ecco che Zuckemberg piglia tutto in pochi anni. Pare che la famosa “concorrenza” che rende tanto fico il “mercato” si risolva sempre più spesso nel vecchio sistema che il grosso mangia tutti gli altri. Gli manca solo l’esercito, insomma, e Facebook diventa una grande potenza: ci toccherà fare il G8, o G9 se viene anche Google.
In più, si sa che i dubbi sulle criptomonete sono molti, a partire dalla tracciabilità, dalle possibilità di facilitare il grande riciclaggio e gli affari zozzi. E va bene, sono cose di cui dovranno occuparsi i tecnici, gli stati, le banche centrali eccetera. Solo che di solito i tecnici, gli stati, le banche centrali, eccetera sono lenti, e invece l’Impero virtuale è veloce.
Resta un dettaglio, diciamo così, per cavarci d’impiccio, “culturale”. E cioè: ma tutte le lezioni sul liberismo, sull’idea che il mercato poi sistema tutto lui, che non bisogna regolarlo sennò si muore, signora mia, lasci fare alla manina santa, dove vanno a finire? Davanti a un’azienda che si inventa la sua moneta, oppure davanti a due-tre monopolisti assoluti che dominano non solo le economie di casa loro, ma del pianeta, che hanno per clientela praticamente tutta la popolazione mondiale, e che possono orientarne gusti e opinioni (oltre a sapere tutto dei loro clienti) sarà davvero un grande successo libeale? Avere due o tre operatori nel campo della comunicazione, che complessivamente coprono tutto il pianeta, non sarà un po’ rischioso? E un liberismo che tende al monopolio (soprattutto in settori molto strategici come la comunicazione, lo scambio emozionale, e tra un po’ anche economico, tra umani) non sarà troppo? “Trasformare l’economia globale”, come dice Zuckerberg, non sarebbe per niente male, ma qualche dubbio sul lasciarlo fare a un’azienda privata me lo terrei stretto.
 Duecentoquaranta euro al mese per figlio sarebbe una riforma che mette qualcosa nelle tasche degli italiani, e questa è cosa buona e giusta. Naturalmente in qualche modo dovrà prendere risorse dalle tasche dagli italiani (si parla di varie rimodulazioni, per esempio di quota 100, del reddito di cittadinanza, degli 80 euro), ma anche qui niente da dire. La leva fiscale – il chi paga cosa, e quanto, e il chi riceve cosa, e quanto – è uno strumento per cercare una specie di equilibrio economico dove non ci sia chi ha troppo poco. Il lato comico, semmai, si può trovare nel gioco dell’oca infinito di detrazioni e bonus, premi, esenzioni, moduli, magie contabili, abracadabra da commercialisti, e tutti i mesmerismi che si aggrappano come alghe a un regime fiscale.
Duecentoquaranta euro al mese per figlio sarebbe una riforma che mette qualcosa nelle tasche degli italiani, e questa è cosa buona e giusta. Naturalmente in qualche modo dovrà prendere risorse dalle tasche dagli italiani (si parla di varie rimodulazioni, per esempio di quota 100, del reddito di cittadinanza, degli 80 euro), ma anche qui niente da dire. La leva fiscale – il chi paga cosa, e quanto, e il chi riceve cosa, e quanto – è uno strumento per cercare una specie di equilibrio economico dove non ci sia chi ha troppo poco. Il lato comico, semmai, si può trovare nel gioco dell’oca infinito di detrazioni e bonus, premi, esenzioni, moduli, magie contabili, abracadabra da commercialisti, e tutti i mesmerismi che si aggrappano come alghe a un regime fiscale.
Dunque, a farla breve, che lo Stato intervenga sull’economia delle famiglie è sacrosanto, anche se c’è una cosa che suona bizzarra: ogni ritocco dei redditi operato negli ultimi anni è fatto, appunto, solo di interventi statali e pare che parlare invece di politiche salariali sia come bestemmiare in chiesa. Di fatto, il peso dei bonus, delle detrazioni, degli 80 euro, del reddito di cittadinanza, è sostenuto dalla comunità (spesso a debito, quindi dai figli della comunità), mentre i salari sono fermi.
La forbice che si allarga tra la parte benestante degli italiani e quella povera è una realtà conclamata dell’ultimo decennio (dice l’Istat che nel 2008, la parte più povera della popolazione poteva contare su un reddito che corrispondeva al 2,6 per cento del totale, che dieci anni dopo è scesa all’1,8). E’ una forbice che ricalca quella tra profitti e salari, tra dividendi e stipendi, tra quello che porta a casa un azionista e quello che porta a casa un lavoratore.
Il doveroso rabbocco che lo Stato farebbe (con i 240 euro a figlio, per esempio, ma anche con altri mezzi e sistemi) è un sostegno al potere d’acquisto dei cittadini che ha tutta l’aria di una supplenza: ti veniamo incontro perché il tuo reddito non basta, perché il tuo salario è fermo, perché a guardare le dinamiche dei salari in Europa l’Italia è quella dove non crescono, e paiono inchiodati.
Insomma, dal grande dibattito nazionale su come e in che modo e in che quantità dare una mano ai redditi degli italiani (al netto delle convenienze tattiche, sia Pd che 5s hanno dato qualcosa), brilla per assenza la parte privata che paga gli stipendi. Quella classe imprenditoriale di cui pare obbligatorio dire sempre che è un’eccellenza, eroica, indomita, innovativa, eccetera eccetera, secondo la ben nota retorica, non solo non sembra intenzionata a partecipare a questa piccola redistribuzione, ma non ne discute neanche. Anzi, capita sempre più spesso che sposti qui e là, dove più conviene, residenze fiscali, e quartier generali, o che delocalizzi, o che precarizzi i lavoratori.
Probabilmente c’è, alla base di tutto questo, un vecchio tabù, cioè che si possa sconfiggere la povertà senza toccare la ricchezza. Anzi, il pensiero dominante (e abbondantemente praticato) è che se stanno meglio i ricchi, poi cadrà qualche briciola dalla tavola anche per gli altri, una cosa che si continua a sostenere, ma che è smentita nei fatti e dai numeri in modo clamoroso negli ultimi dieci anni.
Se davvero lo Stato intende attuare una politica economica che va incontro ai redditi medio-bassi, cosa che si spera fortemente, dovrebbe chiamare a partecipare anche quella parte di Paese che negli ultimi dieci anni si è arricchita, anche con grandi aiuti pubblici, decontribuzioni, sconti, sanatorie, salvataggi. Insomma, il capitalismo italiano. E la sinistra, parlandone da viva, dovrebbe cominciare a pensare che la battaglia per il salario – il lavoro in cambio di condizioni di vita decenti – non è una cosa da bolscevichi assatanati, ma una delle sue ragion d’essere.
 E’ un peccato che non ci siano in circolazione pensieri estremi, che nessuno rompa la superficie per guardarci sotto, o peggio ancora che nessuno guardi in alto, sognando e progettando cose che sembrano impossibili (Majakovskij: “Ehi, voi! Avanti con il cielo!”). Tutto è medio, tutto è ragionevole, tutto agisce nell’orbita del consentito. Con questo sistema di assoluta e cieca protezione del presente avremmo ancora gli zar, o magari un’app che ci convoca a costruire le piramidi. Ma tant’è: si fa il presente con quello che c‘è, per il futuro ci penseremo. Niente estremismo, quindi. Peccato.
E’ un peccato che non ci siano in circolazione pensieri estremi, che nessuno rompa la superficie per guardarci sotto, o peggio ancora che nessuno guardi in alto, sognando e progettando cose che sembrano impossibili (Majakovskij: “Ehi, voi! Avanti con il cielo!”). Tutto è medio, tutto è ragionevole, tutto agisce nell’orbita del consentito. Con questo sistema di assoluta e cieca protezione del presente avremmo ancora gli zar, o magari un’app che ci convoca a costruire le piramidi. Ma tant’è: si fa il presente con quello che c‘è, per il futuro ci penseremo. Niente estremismo, quindi. Peccato.
Come per quasi tutto, le cose resistono in farsa, in burletta, e così ci stiamo abituando lentamente al più noioso degli estremismi, quello dialettico, che è quasi solo paradosso e provocazione, in sostanza esagerazione e argomento da talk show. Talmente mitridatizzati e assuefatti a certe caricature della realtà – però vendute come vere e assodate – che nemmeno ce ne accorgiamo più.
L’ultimo caso, abbastanza indicativo, è quello delle reazioni degli ultrà cattolici alla recente sentenza della Consulta sul suicidio assistito. Che è lecito solo in pochissimi terribili casi, che prevede paletti rigidi e severissimi. Ed ecco arrivare la caricatura, la visione estrema che polverizza il ragionamento. Nelle incursioni, e scritti, e interventi di chi sostiene un no duro, puro e definitivo a qualunque eutanasia, si presenta una realtà parallela in cui lo Stato autorizza il suicidio di chiunque, in qualunque momento. Cazzo, ho preso quattro in fisica… beh, tranquillo, vai alla Asl e ti fai fare una puntura di curaro. Oh, mi ha mollato la ragazza! E subito il medico pone fine alle tue sofferenze di giovane Werther.
E’ una cosa che fa sempre abbastanza ridere, questo estremismo catastrofista del paradosso. Il “moriremo tutti!”, il “dove andremo a finire”. E il meccanismo, poi, è semplicissimo. Basta prendere l’argomento di cui si discute, stirarlo all’inverosimile come un elastico, e poi lanciarlo, costringendo tutti a prendere per vero ciò che non lo è.
Nel recente dibattito sulla “tassa sulle merendine” (a proposito di guardare il cielo…), che ha occupato ore e ore di dibattiti televisivi, non si discuteva più se fosse giusto o sbagliato mettere un balzello su determinati prodotti, ma si strologava su come una tassa sugli snack avrebbe potuto “risolvere i problemi del Paese”. E’ un ben strano estremismo, si converrà, ed è anche facile: si pone una situazione paradossale come se fosse vera e si discute su quella. “Pensate di risolvere i problemi del Paese con una tassa sulle merendine?”. Al che la risposta corretta sarebbe “Non diciamo puttanate”, e invece si balbetta, cadendo nel vuoto e nelle sabbie mobili.
Storico esempio mai tramontato: l’estremismo dialettico anti-immigrati e una frase-tipo, ormai accettata nel gergo politico-mediatico. “Non possiamo accoglierli tutti”. E’ come un interruttore: detto quello (e su quella base: non possiamo accoglierli tutti) parte il dibattito. Nessuno che chieda: tutti chi? Gli africani? I libici? I siriani? Tutti sette miliardi di esseri umani? Nessuno che dica all’interlocutore: ma è sicuro che un miliardo e passa di africani voglia venite qui? E perché, poi?
E invece niente: si parte a discutere di immigrazione, accoglienza, integrazione su una base la cui ovvia risposta è “no” (possiamo accoglierli tutti? No). E’ il disordine del discorso, insomma. Quello delle chiacchiere, insomma, è l’ultimo estremismo che vediamo all’opera, un banale trucchetto dialettico, polvere alzata e cortina fumogena. Ogni discorso pubblico ne è pieno, se ci fate caso, ogni discussione, o confronto, tende a creare una situazione paradossale, estrema ai limiti del surreale, e poi a discutere di quella, invece che della realtà. Oplà, facile, no?
Il Fatto Quotidiano mi ha chiesto di recensire il libro di Flavio Oreglio sulla storia del cabaret. L’arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano (Sagoma editore). Ecco qui
 Basta una piccola pedana, a volte nemmeno un microfono perché si parla a platee minuscole, intime. Poi serve saper mettere insieme le parole, spesso i gesti, a volte suoni e musica, ed ecco il cabaret. Facile a dirsi, e invece no, tutt’altro. Perché la storia è lunga e complessa, piena di curve e di svolte, e per raccontarla (ma vorrei dire: per spiegarla e ripulirla da quiproquò e luoghi comuni) serve uno che al cabaret ha dedicato vita e carriera: militante, praticante e infine storico, Flavio Oreglio, che firma questo piccolo tomo prezioso, L’arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano (Sagoma editore).
Basta una piccola pedana, a volte nemmeno un microfono perché si parla a platee minuscole, intime. Poi serve saper mettere insieme le parole, spesso i gesti, a volte suoni e musica, ed ecco il cabaret. Facile a dirsi, e invece no, tutt’altro. Perché la storia è lunga e complessa, piena di curve e di svolte, e per raccontarla (ma vorrei dire: per spiegarla e ripulirla da quiproquò e luoghi comuni) serve uno che al cabaret ha dedicato vita e carriera: militante, praticante e infine storico, Flavio Oreglio, che firma questo piccolo tomo prezioso, L’arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano (Sagoma editore).
Già dalle quattro piccole prefazioni (Enrico Intra, Roberto Carusi, Tinin Mantegazza, Roberto Brivio) si capisce che fa sul serio, che il saggio storico si mischia al pamphlet critico. E Oreglio parte davvero in quarta, gli preme mettere i puntini sulle i, come lo storico che delimita il suo ambito di ricerca ma anche come l’appassionato che freme davanti alle ingiustizie, alle ricostruzioni affrettate, agli errori. Il primo, clamoroso: far coincidere il cabaret con la comicità e con la risata, cosa sbagliatissima, perché le forme di spettacolo che “fanno ridere” (o vorrebbero) sono molte e lui, invece, è alla ricerca dei caratteri specifici di un’arte che fa storia a sé, e lo fa nel modo più intenso: mischiando e contaminando molte arti.
Pensate a Gaber, ci dice Oreglio: era forse soltanto risata? E – aggiungo io – pensate all’intrinseca tristezza facciale di Felice Andreasi, alle malinconie stralunate di Enzo Jannacci, e vedrete che l’equazione cabaret-uguale-si-ride diventa piccola piccola, riduttiva. Con tutto che (e diciamolo!) si ride anche.
Dunque Oreglio rivendica, con il giusto orgoglio, la specificità di un genere, e questa sua dichiarazione di poetica, annunciata come un manifesto programmatico, viene confermata riga dopo riga, nella strabiliante evoluzione della storia.
All’inizio fu il Cafè chantant, la Parigi della Belle Epoque, il Secondo Impero, un posto dove sedevano più o meno comodi i grandi narratori dell’epoca da Hugo a Zola. Le Chat noir, il locale ai piedi di Montmartre da cui, per convenzione, partì tutto, era un ritrovo di poeti e scapestrati, intellettuali e assenzio. Davvero un peccato non aver assistito (e per forza, era quasi tre secoli fa!) alle stralunate recite degli Hydropathes (più o meno: quelli a cui fa male bere acqua), o ascoltare la chanson canaille di Aristide Bruant, o immergersi in quell’esplosione di circoli, riviste, tumulti artistici e affabulazioni che mischiavano nonsense e cronache politiche, satira e goliardia.
Poi, la diaspora. Dalla Francia al resto d’Europa, e qui si rischia davvero il salto sulla sedia, perché il cabaret ha sfiorato, attraversato e fiancheggiato i più vividi movimenti culturali di ogni epoca. Dalla Parigi mitica della Belle Epoque alle più disparate avanguardie europee. Ha giocato con i fermenti della Berlino degli anni Venti e Trenta (avete presente un certo Bertold Brecht?), dove Karl Valentin entusiasmava con i suoi monologhi (apparentemente) insensati; oppure il futurismo, in Italia, quando l’immenso Petrolini poteva permettersi lo sberleffo al regime (“Bravo! Grazie!”, meraviglia vera), o ancora la Russia, la Svizzera, la Polonia, e il cabaret diventava patrimonio d’Europa.
Ma dunque, almeno per l’Italia, le connessioni sono nobili e note già dall’inizio del secolo: dal Caffè Concerto al Tabarin, dal Varietà, all’avanspettacolo, con le diramazioni che Oreglio mette in ordine: la rivista, il salone Margherita, l’Ambra Jovinelli, insomma, la storia nostra. E poi (viene il bello), la capacità di abbeverarsi a un movimento (e di crearlo) fatto di giornali satirici, fogli irriverenti, sfide al pensare solito e comune. Fino (viene il bellissimo) all’esplosione del dopoguerra, che si chiamava Derby, a Milano (ma non solo), e qui va ringraziato Oreglio per la capacità di non cadere nella semplice mitologia ormai stucchevole, ma di sezionarla, spiegarla, analizzarla.
Lasciamo perdere l’indice dei nomi: tutti i più grandi hanno portato il loro mattoncino (Franco Parenti, Dario Fo, può bastare?, ma sono centinaia) alla costruzione di un’arte quasi underground e però popolare. Cavalcata entusiasmante che qui (mi scuso) si riesce solamente ad abbozzare. Peccato: la storia si ferma a metà degli anni Ottanta, quando il Grande Errore si impose e prosperò, e quando il cabaret (o meglio, la sua percezione) si ridusse a risata, battutismo, tormentone. Che ingiustizia, venire da così lontano e andare così vicino (traduco: in tivù), ma mai disperare: il gatto ha sette vite, e il cabaret anche di più. Cioè, speriamo.
Metto qui, solo per maniaci, due recensioni spagnole di Esta no es una canciòn de amor…
Ediciones Salamandra, 2009
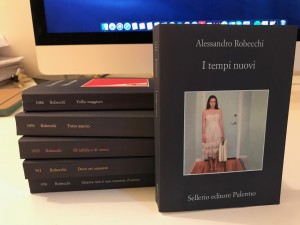 Qui sotto le presentazioni e le chiacchierate pubbliche su “I tempi nuovi” e altri appuntamenti del mese di ottobre.
Qui sotto le presentazioni e le chiacchierate pubbliche su “I tempi nuovi” e altri appuntamenti del mese di ottobre.
Sabato 5 ottobre – Brescia – ore 19.00, Librixia, fiera del libro Brescia – piazza Vittoria, con Leonardo Laricchia
Sabato 12 ottobre – Mestre – ore 17.00, Chiostro M9 – via Poerio 24 con Niccolò Groja
Domenica 13 ottobre – Belluno – ore 18.00, Libreria Tarantola – Via Rodolfo Psaro, 13/a
Domenica 20 ottobre – Genova – ore 17.00, BookPride – Palazzo Ducale, sala del Maggior Consiglio, Presentazione collettiva dell’antologia “50 in blu”, otto racconti gialli (con Marco Malvaldi, Giampaolo Simi e Fabio Stassi)
Domenica 20 ottobre – Genova – ore 18.00, BookPride – Palazzo Ducale, sala Archivio Storico “Il desiderio di Franz Biberkopf in Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin”
Lunedì 21 ottobre – Cernusco sul Naviglio – ore 21 – villa Fiorita, via Guido Miglioli
Sabato 26 ottobre – Vigevano – ore 16, Cavallerizza del Castello Via Rocca Vecchia 1. con Alessandra Tedesco
 Italia e Germania allo stadio Azteca di Città del Messico (1970). Muhammad Ali e George Foreman allo stadio di Kinshasa (1974). Renzi e Salvini a Porta a Porta a Roma (2019). C’è qualcosa di nuovo, anzi di antico, eccetera eccetera. E c’è anche qualcosa di patetico nell’annunciare con un mese d’anticipo un allenamento tra sparring partner come se fosse uno scontro tra campioni. Del resto quando la propaganda politica si incrocia con il promo televisivo non c’è da aspettarsi molto (e questo è l’antico). Si annuncia però il primo scontro per il nuovo modello di leader: il leader generalista (e questo è il semi-nuovo).
Italia e Germania allo stadio Azteca di Città del Messico (1970). Muhammad Ali e George Foreman allo stadio di Kinshasa (1974). Renzi e Salvini a Porta a Porta a Roma (2019). C’è qualcosa di nuovo, anzi di antico, eccetera eccetera. E c’è anche qualcosa di patetico nell’annunciare con un mese d’anticipo un allenamento tra sparring partner come se fosse uno scontro tra campioni. Del resto quando la propaganda politica si incrocia con il promo televisivo non c’è da aspettarsi molto (e questo è l’antico). Si annuncia però il primo scontro per il nuovo modello di leader: il leader generalista (e questo è il semi-nuovo).
Dei motivi si sa tutto: i due Mattei hanno interesse ad accreditarsi a vicenda come nemici, uno tiene su l’altro, per dirla veloce. L’arbitro del match spera di aggiungere un altro mattoncino a quel castello di cartone e conformismo che qualcuno chiama “la terza camera dello Stato” (e qui sì che servirebbe una riforma costituzionale che riduce le Camere, da tre a due). Il contesto è noto, dunque, senza nemmeno fare grandi sforzi di fantasia se ne potrebbe scrivere la cronaca prima che accada.
I characters in campo si conoscono, è una battaglia culturale, perché ogni venditore di aspirapolveri ha il suo stile e il suo linguaggio. Uno va alla fiera della cipolla (popolare, a contatto col territorio, qui si lavora, via i negher! Super-local-medievale), e l’altro discetta di “intelligenza artificiale” (le tecnologie, il futuro, che palle i lavoratori! Super-global-su-Saturno).
Dunque il format Renzi-Salvini di metà ottobre sarà paragonabile ad altri format televisivi. Il talent, prima di tutto, perché un così considerevole scontro tra ego non si vedeva da tempo e le probabilità che venga ambientato in una seconda media sono piuttosto alte. Uno che dice Mojito! E l’altro con i faldoni della cronaca nera (solo quella dei neri) sotto il braccio. Sarà anche un po’ Temptation Island, però, con il gioco di seduzione, le occhiatine, le spiritosaggini, le ciglia che sbattono. Già se ne sanno i toni, già si immaginano le pose e le mossette. Di Salvini sappiamo quella passione per gli elenchi con le dita che contano, metà arbitro di pugilato e metà dizionario dei sinonimi. Di Renzi si sa la finta autoironia e certi guizzi teatrali. Uno spingerà sul vittimismo – che gli vogliono tutti male, che lo odiano, che c’è il complotto contro di lui -, l’altro farà intendere alla platea che tutto questo non esisterebbe se gli italiani non fossero stati così scemi da non capire il suo referendum (e ogni volta che apre bocca sull’argomento, la gente corre all’inginocchiatoio per ringraziare il Cielo di aver votato no). Si prenderanno a colpi di Bibbiano in faccia, evabbé.
E poi ci sarà spazio per il leader generalista, il mio format preferito. Renzi pare espertissimo in ogni tipo di sport purché si vinca: Formula Uno, pallavolo, scherma, ginnastica artistica, farà la battutina sui viola; Salvini farà il Berlusca e detterà la formazione del Milan (o qualcosa di polemico, come uno della curva, ma ancora a piede libero). Parleranno dei figli, “da papà”.
Non si dimentichi, nella Gran Sagra del Prevedibile, la reazione dei social, come si fronteggeranno i sostenitori del “Capitano” (ossignùr, n.d.r) e i Renziani Rinati del Settimo Giorno (già #senzadime). Le tifoserie, assiepate tra le tivù e gli smartphone, potranno intonare i loro cori, dare pagelle, urlare “merde!” agli altri. Poi diranno che il loro beniamino ha “asfaltato” l’avversario, e qui vedremo linguaggi perfettamente sovrapponibili, le stesse identiche parole, in scala uno a uno, persino nella sciatteria sintattica e nell’avventurismo grammaticale. Niente di collettivo, mi raccomando, solo esercizi di stile privati esibiti in pubblico, come è giusto per tifosi personali di partiti personali, privati, esibiti in pubblico.
 Restiamo amici. Ti lascio ma è per il tuo bene. Io non ti merito. Ti vorrò sempre bene. Ci vediamo in giro. La vita continua. No, non ho un’altra, voglio stare un po’ da solo. Devo riflettere. Una pausa ci farà bene. Non parlerò mai male di te. Se sommate tutte queste belle frasette, come per magia, avrete la sacrosanta reazione: “Ammazza che stronzo”.
Restiamo amici. Ti lascio ma è per il tuo bene. Io non ti merito. Ti vorrò sempre bene. Ci vediamo in giro. La vita continua. No, non ho un’altra, voglio stare un po’ da solo. Devo riflettere. Una pausa ci farà bene. Non parlerò mai male di te. Se sommate tutte queste belle frasette, come per magia, avrete la sacrosanta reazione: “Ammazza che stronzo”.
E ora passiamo al caso Renzi.
Le lusinghe di Zingaretti per non farsi lasciare rasentavano l’assurdo. Si è ventilato persino di Boschi presidente del partito, che è come mettere la volpe a guardia del pollaio. Il capogruppo Pd rimane un renziano di ferro (Marcucci), che al momento resta, in modo da vedere come si mette la faccenda e decidere dopo, e così fanno altri renzianissimi, tipo Lotti. E’ come quando si abbandona il campo, ma prima lo si cosparge di mine antiuomo che saranno attivate alla bisogna. Renzi fa le valige e si porta via due ministri e un sottosegretario, tutta gente che si sbracciava scrivendo #senzadime, mai, meglio morto, dovrete passare sul mio cadavere, zotici maledetti che sbagliate i congiuntivi; e poi hanno fatto inversione di marcia in autostrada.
Renzi ha spinto Zingaretti all’alleanza con i 5stelle e poi ha preso cappello: cara, è per il tuo bene. Vuole (confessato apertamente) i voti di Forza Italia (parlandone da viva), gli viene l’itterizia se sente cantare Bandiera Rossa alle feste dell’Unità, giornale che fu glorioso e che ha chiuso perché non si inginocchiava abbastanza. La cosa più ridicola della fuga di Renzi Matteo è la narrazione sulla casa da cui scappa: il Pd descritto come un partito comunista, sinistra estrema, Soviet supremo, dove i grandi pensatori centristi (sarebbe lui, Renzi, magari anche Rosato e Scalfarotto, per dire del trust di cervelli) sono angariati in tutti i modi, mandati in Siberia, ostracizzati e messi ai margini pur avendo il capogruppo, due ministri, un sottosegretario. Annuncia il possibile ritorno di D’Alema e Bersani come se fossero Stalin e Beria, e lui, povero Solgenitsin, deve mettersi in salvo. Dunque tenta di passare per un democratico moderato che fugge da un partito nordcoreano. Non è difficile leggere la faccenda in filigrana: il partito nordcoreano gli va bene solo se Kim Jong Un è lui, se no tanti saluti. E del resto, uno che ha portato il Pd al 18 per cento dopo aver tuonato “Non lasceremo il Pd a chi lo ha portato al 25 per cento” in un altro partito sarebbe stato cacciato a calci in culo, e invece è stato tutto un “Matteo è una risorsa”, “Resta con noi”, “Non ci lasciare”.
Ma basta con il passato. Basta con le recriminazioni, le ripicche, gli sgambetti. Renzi fa il suo partito, di ispirazione boyscoutiana-jovanottesca-recalcatian-leopolda, che tradotto in italiano significa tanta fuffa, ma tanta fuffa, e colpi a sorpresa ogni minuto. Da grande annusatore ha capito che il gioco di Salvini ministro dell’Interno era astuto: stare al governo ma fare opposizione, fingere accordo ma alzare l’asticella, spararne una al giorno e vedere l’effetto che fa, prendersi le prime pagine, dettare l’agenda, far passare gli alleati di governo come idioti mentre lui, se avesse i pieni poteri, signora mia… Insomma, il salvinismo intrinseco di Matteo Renzi è così evidente che viene voglia di chiamarlo “capitano”, anche se il suo stile non è la foto col cotechino, ma con gli imprenditori che sganciano soldi alla sua fondazione. Finisce un equivoco: una banda di mediocrissimi che aveva preso il partito per miopia e cecità dei vertici ed ennesima beota illusione della base, se ne va rancoroso con un commosso: “Non mi avete capito”. Mentre tutti avevano capito benissimo che Matteo Renzi ha una visione, un orizzonte culturale, un disegno politico e un enorme sistema di valori precisissimo, che è riassumibile in due semplici parole: Matteo Renzi.
Spettacolari, i fascisti italiani. Nel senso che lo spettacolo è impareggiabile: salti mortali, carpiati e piroette. Testacoda e salti di corsia, capottamenti, inversioni a U e altre mirabolanti gesta, come per esempio urlare in piazza Montecitorio col braccio teso nel saluto romano, indifferentemente “Duce-Duce” e subito dopo “Elezioni!-Elezioni!”. Il fascista che si appella alla democrazia fa molto ridere, è come il rapinatore che chiama il 113.
 Poi, nella bolgia della piazza boia-chi-molla è calata la notizia che a mollarli è stato Facebook, oscurando le pagine di alcuni gerarchetti di Forza Nuova e Casa Pound, e lì è scattato il pandemonio. Lo spettacolo dei fascisti che urlano “fascista” a qualcun altro è delizioso, un contrappasso esilarante, la storiella del bue che dà del cornuto all’asino, in confronto, era roba da dilettanti. Così, eccoli precipitarsi su un social network che non li ha (ancora?) oscurati, Twitter, e lì fioccano le perle, come quella di Simone Di Stefano, Obergruppenführer di Casa Pound che sostiene che Facecebook “si configura come un servizio pubblico” visto che ci sono moltissimi italiani iscritti. Un po’ come dire che siccome negli anni Sessanta tutti avevano una Fiat, allora la Fiat era di tutti. Invece no: Facebook è un’azienda privata, ha un suo regolamento, quando vi si accede si accettano le sue regole, e ogni tanto le applica pure.
Poi, nella bolgia della piazza boia-chi-molla è calata la notizia che a mollarli è stato Facebook, oscurando le pagine di alcuni gerarchetti di Forza Nuova e Casa Pound, e lì è scattato il pandemonio. Lo spettacolo dei fascisti che urlano “fascista” a qualcun altro è delizioso, un contrappasso esilarante, la storiella del bue che dà del cornuto all’asino, in confronto, era roba da dilettanti. Così, eccoli precipitarsi su un social network che non li ha (ancora?) oscurati, Twitter, e lì fioccano le perle, come quella di Simone Di Stefano, Obergruppenführer di Casa Pound che sostiene che Facecebook “si configura come un servizio pubblico” visto che ci sono moltissimi italiani iscritti. Un po’ come dire che siccome negli anni Sessanta tutti avevano una Fiat, allora la Fiat era di tutti. Invece no: Facebook è un’azienda privata, ha un suo regolamento, quando vi si accede si accettano le sue regole, e ogni tanto le applica pure.
Diciamolo: è un peccato.
E’ un peccato che un azienda privata faccia quello che lo Stato avrebbe dovuto fare da anni, da decenni. Perché sembrerà strano, ma anche la Repubblica Italiana, come Facebook, ha le sue regole, che sono scritte nella Costituzione (XII disposizione finale: “E’ vietata la ricostituzione del partito fascista in ogni sua forma”) e in qualche legge scarsamente applicata (la legge Scelba, la legge Mancino). Insomma, duole constatare che un’azienda privata è arrivata prima dello Stato, che è stata più efficiente e meno timorosa.
Detto questo, cioè che la Repubblica Italiana doveva fare da tempo quello che la ditta di Zuckerberg ha fatto l’altro ieri, rimane sospeso nell’aria un certo sentore di corto circuito. Riassumiamo a grandi linee: i nostri nonni, dopo l’immane disastro e i milioni di morti regalatici dal puzzone mascelluto, hanno cacciato il fascismo a colpi di schioppo. Poi hanno fondato una Repubblica. Poi hanno scritto una Costituzione. Poi hanno fatto delle leggi perché i fascisti non potessero fare apologia di quel disastroso crimine. E poi però, per cacciare i fascisti dal dibattito pubblico e impedirgli la diffusione di odio etnico e razziale, è dovuto intervenire un multimiliardario americano inventore dei “like”.
Difficile non sentire la nota stonata, la campana fessa.
Infatti l’azienda, in un comunicato, ha spiegato la sua decisione appellandosi alle regole che gli utenti dovrebbero conoscere, e ha sottolineato che alla base della decisione “non ci sono motivi ideologici”. E questo è un altro peccato, è come dire che se un fascista inneggiasse alla dittatura, al boia-chi-molla, al me-ne-frego, con parole gentili andrebbe tutto bene. Invece no. Si dimostra che le regole dello Stato sono migliori e più rigide di quelle di Facebook (bene), ma che lo Stato non le applica e invece Facebook sì (male), e questo mette un po’ di tristezza. Del resto, si sa (leggere il prospetto illustrativo) che quando metti qualcosa sul più grande social network del mondo, la proprietà intellettuale di quello che pubblichi diventa sua, che siano gattini, foto di nipotini o virili appelli a otto milioni di baionette. Forse qualcuno dovrebbe spiegarlo ai nazionalisti, sovranisti, suprematisti, che i loro frementi prima-gli-italiani sono stati regalati a un algoritmo made in Usa il quale, come da regolamento, può farne ciò che vuole, anche mandarli al confino quando gli pare.
 Sessantasei (66) stragi di piazza Fontana. Quattordici (14) stragi di Ustica. E ora ditemi che non fa impressione, paura, ditemi se non è un’offesa al nostro vivere civile. Ma non c’è nemmeno bisogno di confronti aritmetici e paradossi, basta anche il numero secco. Anno di grazia 2018, Italia: millecentotrentatré (1.133) morti sul lavoro, più di tre al giorno contando anche Natale, Capodanno, Ferragosto. E i primi sei mesi del 2019 da record: 482 infortuni mortali, tredici in più dell’anno prima, che già aveva un bilancio spaventoso (peggio del 2017, peggio del 2016). Una strage, molte stragi, anzi, che finiscono di solito in un trafiletto di venti righe: il nome, il posto, la dinamica dell’incidente (nemmeno sempre) e avanti fino a domani, con altri trafiletti a pagina venti, altre parole di circostanza.
Sessantasei (66) stragi di piazza Fontana. Quattordici (14) stragi di Ustica. E ora ditemi che non fa impressione, paura, ditemi se non è un’offesa al nostro vivere civile. Ma non c’è nemmeno bisogno di confronti aritmetici e paradossi, basta anche il numero secco. Anno di grazia 2018, Italia: millecentotrentatré (1.133) morti sul lavoro, più di tre al giorno contando anche Natale, Capodanno, Ferragosto. E i primi sei mesi del 2019 da record: 482 infortuni mortali, tredici in più dell’anno prima, che già aveva un bilancio spaventoso (peggio del 2017, peggio del 2016). Una strage, molte stragi, anzi, che finiscono di solito in un trafiletto di venti righe: il nome, il posto, la dinamica dell’incidente (nemmeno sempre) e avanti fino a domani, con altri trafiletti a pagina venti, altre parole di circostanza.
Va bene, non siamo sprovveduti, sappiamo quanto l’informazione possa essere lontana dalla vita, distante e distaccata. Ma nel caso delle morti sul lavoro quella distanza è siderale. Finite le dieci righe di prammatica, l’informazione va avanti, parla d’altro, si distrae, e la realtà invece resta lì. Le vedove, i figli, i compagni di lavoro, quel sudore freddo che mischia dolore e dispiacere, insieme a un pensiero che agghiaccia: poteva capitare a me.
La rabbia del “dopo” non la si racconta quasi mai, e come al solito le statistiche sono un coltello a due lame: utili a dare le dimensioni del fenomeno – della mattanza, per chiamare le cose col loro nome – e così fredde, invece, nel parlare delle vite, delle dita schiacciate, dei muletti rovesciati, delle esalazioni assassine, del caldo dei campi e delle serre. Insomma, siamo sempre lì: i numeri e la vita vera, i grafici (in salita sempre, maledizione) e il lutto. Ogni tanto una storia balza in primo piano. Questi giorni, ad esempio: Pasquale Fusco, 55 anni, tre figli, morto per il caldo e la fatica in una serra di meloni, in un campo vicino Giugliano, regolarizzato dai datori di lavoro un’ora dopo la morte, come dire che non gli è stata risparmiata nemmeno la grottesca rincorsa della burocrazia, la vergogna delle carte in ordine, dei diritti, finalmente, ma post mortem.
Di lavoro si parla molto, moltissimo. Da mesi, da anni, le statistiche su occupazione e disoccupazione tengono banco nella polemica politica, servono ad accusare l’avversario, se ne misurano le impercettibili variazioni, si cantano vittorie e si denunciano sconfitte per qualche zero virgola. E intanto si muore, con quella vigliacca copertura delle parole per dirlo: incidente, morti bianche, infortuni, disgrazie. Si aggiunga il maleodorante dibattito sulla “sicurezza”, così sbandierato e pompato, così utile ai facili consensi e all’operazione indefessa di instillare paura. Tutte cazzate: i crimini sono in picchiata, gli omicidi diminuiscono. Tutti, tranne quelli che si compiono sui posti di lavoro, che invece aumentano, e però lì, in quell’ambito, la parola “sicurezza” si usa meno, si bandiera meno, diventa anzi a volte sinonimo di seccatura. Uff, la burocrazia, uff, le norme, uff, la prevenzione, tutte cose che costano, che erodono i margini di profitto. Come se “sicurezza” fosse una parola che va bene per lo scippo e lo scippatore e non per il lavoro e il lavoratore, come se si accettasse come rischio naturale che, lavorando, puoi restarci secco.
Destino, fatalità, parole pietose che coprono una vergogna nazionale. Ecco: dato lo stato dell’arte della politica non c’è da stare allegri, non si vede all’orizzonte nessun deciso cambio di parametri, nessuna rivoluzione, continuerà il sacrosanto dibattito di come dare un lavoro a chi non ce l’ha, ma su come salvare la vita a chi ce l’ha il dibattito langue, non interessa, non fa notizia. Come se in una Repubblica “fondata sul lavoro” il primo diritto non fosse quello di tornare a casa vivi, dopo il lavoro.
 Per la storia sarà “L’Angelus dell’ascensore”, 1 settembre 2019, un po’ come se a Bonifacio VIII si fossero infortunati tutti i portantini e fosse rimasto bloccato. Ehi! Chiamate qualcuno! Venticinque minuti di attesa, e poi tutto è bene quel che finisce bene: papa Francesco si è scusato con la folla, dalla sua finestra, e ha raccontato la sua avventura ascensoristica, il calo di tensione, gli interminabili minuti di angoscia, finendo per ringraziare il Principale (quello sempre, dovere d’ufficio) e poi chiamando l’ovazione per i pompieri (“Facciamo un applauso ai vigili del fuoco”) in bello stile televisivo. Un apologo che ci dice questo: le vie del Signore saranno infinite, ma anche la manutenzione è importante.
Per la storia sarà “L’Angelus dell’ascensore”, 1 settembre 2019, un po’ come se a Bonifacio VIII si fossero infortunati tutti i portantini e fosse rimasto bloccato. Ehi! Chiamate qualcuno! Venticinque minuti di attesa, e poi tutto è bene quel che finisce bene: papa Francesco si è scusato con la folla, dalla sua finestra, e ha raccontato la sua avventura ascensoristica, il calo di tensione, gli interminabili minuti di angoscia, finendo per ringraziare il Principale (quello sempre, dovere d’ufficio) e poi chiamando l’ovazione per i pompieri (“Facciamo un applauso ai vigili del fuoco”) in bello stile televisivo. Un apologo che ci dice questo: le vie del Signore saranno infinite, ma anche la manutenzione è importante.
Ovvio che ci sono cose che non sapremo mai.
La prima: tutto il resto che il papa avrà detto nell’Angelus a cui nessuno avrà fatto caso, perché la notizia è solo l’ascensore (Google: “papa ascensore”, un milione e 120.000 risultati già qualche ora dopo).
La seconda: da solo? Con qualcuno? Con chi ha diviso il Santo Padre quei minuti di forzata ristrettezza e intimità? Siccome gli vogliamo bene ci piacerebbe pensarlo bloccato con qualcuno di carino, simpatico, disponibile alla… ehm… consolazione, aperto al dialogo e… Insomma, impossibile non pensare all’irresistibile Stefania Sandrelli trentenne (al massimo della sua potenza, diciamo) che restò bloccata in ascensore con il Monsignor Alberto Sordi (“Quelle strane occasioni”, 1976, in regia la serie A di quando nessuno faceva la commedia come noi: Loy, Magni, Comencini, che firma l’episodio “L’ascensore”, appunto). Si perdoni l’accostamento osé (e non dico qui della Sandrelli, ma del marpionissimo albertosordismo del Maestro Sordi vestito e svestito da prelato), ma è probabile che il papa, anche se un papa alla mano, faccia una vita assai grama, densa di impegni, seccature, trame, nomine, viaggi faticosi, sveglie all’alba… venticinque minuti di tregua e di grazia è quel che gli augureremmo per il suo bene.
Non sarà stato così, d’accordo, ma è bello pensarlo, come sarebbe bello e umanissimo figurarsi che il sorriso del Santo Padre, rilassato nonostante la dura prova, rivelasse proprio qualche minuto di piacere terreno. Invece niente. Rimarranno per anni (forse per secoli, trattandosi della Chiesa) le freddure e le barzellette sul povero Francesco bloccato in ascensore, senza, ahilui, la signorina Donatella del film. Peccato.
Restano solo amare considerazioni: per esempio che le disgrazie non vengono mai da sole e quindi ci aspettiamo adesso un nuovo mattone di Dan Brown (titolo: “Gli ascensori del Vaticano”). E poi, diciamolo, se si rompe l’ascensore del papa, hai voglia a lamentarsi per l’ascensore sociale che non va. Senza contare che nessuno di noi sarebbe uscito dopo 25 minuti di blocco, gli allarmi, i pompieri, con quel sorriso e quell’aria serafica: tutti avremmo tirato giù santi e madonne, oltre naturalmente alle minacce di brutta morte per l’amministratore del condominio, quelli della manutenzione, i vicini che non sentono le grida. Lui no, perché è meglio di tutti noi (non che ci voglia molto), e gliene va dato atto.
 Chiedo scusa se parlo di politica. E non intendo quella che si vede in questi giorni (ieri poi!), con un sabba stupefacente di sgambetti, furbizie, tatticismi, schermaglie più o meno finte, giri di valzer, esternazioni infantili, tweet da seconda media, ipocrisie, opportunismi, e ognuno aggiunga a piacere. Parlo invece, di quello che ci dovrebbe dare la politica, cioè un disegno futuro delle nostre esistenze, uno schema di dove si vuole arrivare, e come, per essere un po’ migliori (sì, mi rendo conto del démodé polveroso di queste parole). Ma insomma, a volerle dare una nobiltà di intenti, a crederci ancora, nella famosa politica, si arriva lì, alla desolante inadeguatezza della classe politica attuale.
Chiedo scusa se parlo di politica. E non intendo quella che si vede in questi giorni (ieri poi!), con un sabba stupefacente di sgambetti, furbizie, tatticismi, schermaglie più o meno finte, giri di valzer, esternazioni infantili, tweet da seconda media, ipocrisie, opportunismi, e ognuno aggiunga a piacere. Parlo invece, di quello che ci dovrebbe dare la politica, cioè un disegno futuro delle nostre esistenze, uno schema di dove si vuole arrivare, e come, per essere un po’ migliori (sì, mi rendo conto del démodé polveroso di queste parole). Ma insomma, a volerle dare una nobiltà di intenti, a crederci ancora, nella famosa politica, si arriva lì, alla desolante inadeguatezza della classe politica attuale.
Non si tratta di mettere, come pure è stato fatto, le foto di Salvini con le tette al vento, ebbro di cubiste e di mojito, accanto a quella di Aldo Moro in spiaggia in giacca e cravatta. Si tratta piuttosto di fare un piccolo bilancio dopo quasi un decennio di hurrà e di giubilo, perché si affacciava alla soglia delle istituzioni un’ondata di “giovani”, di splendidi quarantenni, di ragazzi moderni che superavano le barriere ideologiche, smart, operativi, veloci, interconnessi. Porca miseria, sembrava la svolta, e ci fu anche chi su quella storiella del ricambio giocò (a parole) molte delle sue carte. Vennero i tempi della retorica generazionale, del “basta coi vecchi”, dell'”arriviamo noi”. Fino al paradosso e all’assurdo: un finanziere miliardario con sede a Londra che alla Leopolda arringava giovani benestanti accusando padri e madri in pensione di “rubargli il futuro” (en passant: gli stessi padri e madri che si sono fatti un culo a capanna per farli studiare, e la laurea, e il master, e lo stage a Londra…). Oppure l’insofferenza per i vecchi (“vecchio” era l’insulto principale) meccanismi di mediazione tra poteri, per ogni tipo di complessità. Tutto deve sembrare semplice, facile, che ci vuole, ecco qua, basta un tweet.
Il linguaggio, come al solito, è rivelatore, si è passati dal tanto vituperato politichese (orrore) a schermaglie che sarebbero già troppo stupide in una seconda media (“Mummia”! “Bikini”!), alla forzata banalizzazione del mondo, alle soluzioni sputate in tre righe con le faccine che ridono, o piangono, cuoricini, battutine, freddure, quello là in mutande col cigno, quell’altro che sembra cagare nel campo di zucche di Verdini, uno che si fotografa mentre fa la corsetta mattutina, potete scegliere a catalogo, l’album delle figuracce è praticamente infinito.
I famosi quarantenni che dovevano liberarci dai cascami dei vecchi riti hanno imposto riti nuovi, e sempre immancabilmente al ribasso. C’è da capirli, poveretti, sono figli di un’egemonia culturale, quella di vent’anni di dominio berlusconiano sull’immaginario collettivo, gente che ha capito male (per forza, non studia!) la lezione della cultura “alta” e della cultura “bassa”, col risultato di fare un pappone immangiabile dove un Gramsci vale un cartone animato giapponese, dove un Max Weber ha lo stesso peso di un Jovanotti. E intanto, da questa pattuglia di “nuovi”, di “giovani”, di “adesso finalmente tocca a noi” non esce un’idea nuova a pagarla oro. Tattiche (quasi sempre sbagliate, oltretutto) e trucchetti, niente di grande a cui tendere, niente di immenso da far tremare i polsi, nessun disegno strategico, nessun obiettivo storico, nessun progetto, o tensione ideale, o visione del futuro. Solo l’ostensione grottesca di ego offerti alle masse, con la risibile giustificazione che in questo modo si è più vicini al “popolo”. Che tragico errore, che inconsistenza, che disastro epocale pensare al popolo (qualunque cosa sia) come una moltitudine di troll e tifosi ultrà, solo perché, come diceva un cantante, “Qualsiasi tipo di fallimento ha bisogno della sua claque”.
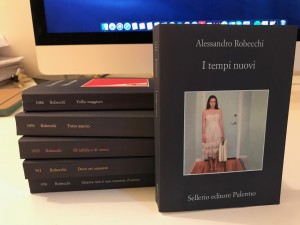 Buongiorno, gente. Riassuntino: I tempi nuovi sta benone, sei mesi dopo il parto si affaccia ancora nelle classifiche… insomma, è piaciuto, ecco, sono molto contento. Chi vuole leggere (e guardarsi, e sentirsi) qualche intervista e qualche recensione può andare qui.
Buongiorno, gente. Riassuntino: I tempi nuovi sta benone, sei mesi dopo il parto si affaccia ancora nelle classifiche… insomma, è piaciuto, ecco, sono molto contento. Chi vuole leggere (e guardarsi, e sentirsi) qualche intervista e qualche recensione può andare qui.
Intanto, ecco le date d’agosto:
Mercoledì 21 agosto, 21.15, Porto San Giorgio, Corso Castel San Giorgio. Si parla de I tempi nuovi con Eleonora Vagnoni
Venerdì 23 agosto, 21.30, Lido di Camaiore, . E’ la serata di chiusura della rassegna Giallo D’Amare, si parla del romanzo con Andrea Montaresi
Lunedì 26 agosto, 19.15, Senigallia, cortile della biblioteca Antonelliana. La rassegna è “Ventimila Righe Sotto i Mari”, uno dei festival del giallo che amo di più (e che porta una certa fortuna al Monterossi). Si parla de I tempi nuovi con Matteo Massi
Ci vediamo qui e là
 L’incursione di Briatore Flavio, il genio di Cuneo (si contende il titolo da anni con Daniela Santanché) nell’agone politico riporta finalmente la situazione italiana al livello che merita: dadaismo situazionista con venature nichiliste e uso di yacht. Tra l’altro, non passa giorno senza che arrivino prestigiosi endorsement per Salvini da parte di imprenditori, padroni del vapore, azionisti di maggioranza, il signor Riello, il signor Zoppas, persino (tremate!) a nipote della stilista Luisa Spagnoli, tutti pronti a salire sul palco del vincitore annunciato (?), gente previdente che compra i biglietti in prevendita molto prima del concerto. E’ un piacere osservare l’entusiasmo e la vivacità del mondo imprenditoriale, in alcuni casi sono gli stessi che facevano la òla per l’altro Matteo. Perché tanto amore? La risposta si trova nelle pieghe più recondite della manovra economica scritta a sei mani dalla crema dell’intellighenzia della Lega: Garavaglia, Bitonci e Borghi, che è quello (tra l’altro) dei minibot, uno che sogna una moneta parallela, un trio di esperti come non si vedeva dai tempi dei Fratelli Marx. Insomma, a leggere le indiscrezioni sul quel che vorrebbe fare Salvini con l’economia italiana c’è da aspettarsi altre entusiastiche adesioni, magari Rossella O’Hara (sottosegretaria allo schiavismo), o il boia di Riga (rapporti con il sindacato). Ma andiamo con ordine.
L’incursione di Briatore Flavio, il genio di Cuneo (si contende il titolo da anni con Daniela Santanché) nell’agone politico riporta finalmente la situazione italiana al livello che merita: dadaismo situazionista con venature nichiliste e uso di yacht. Tra l’altro, non passa giorno senza che arrivino prestigiosi endorsement per Salvini da parte di imprenditori, padroni del vapore, azionisti di maggioranza, il signor Riello, il signor Zoppas, persino (tremate!) a nipote della stilista Luisa Spagnoli, tutti pronti a salire sul palco del vincitore annunciato (?), gente previdente che compra i biglietti in prevendita molto prima del concerto. E’ un piacere osservare l’entusiasmo e la vivacità del mondo imprenditoriale, in alcuni casi sono gli stessi che facevano la òla per l’altro Matteo. Perché tanto amore? La risposta si trova nelle pieghe più recondite della manovra economica scritta a sei mani dalla crema dell’intellighenzia della Lega: Garavaglia, Bitonci e Borghi, che è quello (tra l’altro) dei minibot, uno che sogna una moneta parallela, un trio di esperti come non si vedeva dai tempi dei Fratelli Marx. Insomma, a leggere le indiscrezioni sul quel che vorrebbe fare Salvini con l’economia italiana c’è da aspettarsi altre entusiastiche adesioni, magari Rossella O’Hara (sottosegretaria allo schiavismo), o il boia di Riga (rapporti con il sindacato). Ma andiamo con ordine.
Primo punto: sterilizzare gli aumenti dell’Iva. Servono 23 miliardi, che sono un bel po’ di soldi, talmente tanti che nemmeno mandare Savoini in missione tutti i giorni col cappello in mano basterebbe (fanno circa 1.700 miliardi di rubli). Naturalmente si potrebbe chiedere all’ex sottosegretario Siri se mette una buona parola coi suoi amici dell’eolico, ma anche così non sarebbe facile. Quel che non si raccatta con gli affarucci russi si può sempre segnare a deficit.
C’è poi la faccenda della flat tax, punto irrinunciabile di Salvini se mai riuscirà a salire le scale di Palazzo Chigi: tutti al 15 per cento, si dice che servirebbero 5 o 6 miliardi, aggiungendo i 10 degli ottanta euro renziani, fa poco meno di venti miliardi, e qui le strategie per le coperture si fanno più astute. Trovarli in un tombino è la prima ipotesi, la più sensata, peraltro, ma Borghi suggerisce anche di vincerli all’enalotto (probabilità: uno su sessantacinque miliardi), oppure di vendere al Papeete le navi delle Ong, che potrebbero diventare location per cubiste, o ottimi mezzi per le escursioni marine dei figli di Salvini.
Altro capitolo interessante, quello delle tasse sulla casa, che gli economisti della Lega spingono come fosse una cosa nuova. Si parla della Tari, delle seconde case, delle terze, delle quarte, ma l’ingresso di Berlusconi nella coalizione sposterebbe l’asticella ancora più in altro: niente tasse fino alla decima casa. Ci sono poi molti incentivi, bonus, premi in denaro e in natura (tutti i salami che Salvini non è riuscito a mangiare in questo anno di selfie al colesterolo). Ad esempio la convenzione con il beauty center “Il capriccio” di Busto Garolfo: tre lettini abbronzanti al prezzo di due, per venire incontro al popolo che non può permettersi l’ombrellone al Papeete. Poi detassazione totale per la menta da mettere nel mojito (sarebbe compensata da un aumento dell’iva su cannucce e ombrellini da cocktail).
La manovra potrebbe essere finanziata dalla vendita di gadget salviniani, in certi casi vere e proprie reliquie da esporre in salotto sotto una teca (novecento rosari, seicentottanta immaginette di varie Madonne, santini di ogni dimensione, brandelli di infradito indossate durante i comizi, magliette sudate, ruspe giocattolo, bacioni). Si capisce dunque la gioia degli imprenditori italiani, convinti da una tenacia operosa come non si vedeva dai tempi di Wile Coyote.
 Spiace contraddire Ennio Flaiano, ma non è vero che la situazione è “grave ma non seria”. Invece è grave, è seria e molto ridicola. Ma c’è un’altra bella frase di Flaiano che deve farci da monito, ed è questa: “Nel nostro paese la forma più comune di imprudenza è quella di ridere, ritenendole assurde, delle cose che poi avverranno”.
Spiace contraddire Ennio Flaiano, ma non è vero che la situazione è “grave ma non seria”. Invece è grave, è seria e molto ridicola. Ma c’è un’altra bella frase di Flaiano che deve farci da monito, ed è questa: “Nel nostro paese la forma più comune di imprudenza è quella di ridere, ritenendole assurde, delle cose che poi avverranno”.
Sabato 10 agosto. Anziani combattenti e reduci di Forza Italia si accampano sotto la sede della Lega per farsi adottare, battono le ciotole sul marciapiede: manganellati a sangue grazie al decreto sicurezza bis. Zingaretti ripete ciò che dice da giorni: “Renzi, aiutaci a vincere”, una battuta da teatro dell’assurdo che nessuno capisce. Calenda, dopo i serpenti, twitta di aver incontrato un unicorno, il medico dice che è meglio non contraddirlo. Intervistato in tivù, Luigi Di Maio nega di aver mai conosciuto Salvini. Chi? Quando? Ci dev’essere uno scambio di persona… In un comizio a Policoro Salvini dice: “Ordine e disciplina” e anche “Otto milioni di baionette”, poi va a ridirlo in una spiaggia lì vicino, poi in un altra, poi in un’altra. Tutto a scrocco.
Lunedì 12 agosto. Al posto dei suoi graziosi completini in tugsteno così charmant, il presidente del consiglio Conte ordina al suo sarto una tuta in carbonio di tipo difensivo-offensivo, con raggi laser e mitragliette. E’ un segno che ha preso bene le ultime dichiarazioni di Salvini. L’enorme macchina della comunicazione 5stelle si mette al lavoro con un obiettivo ciclopico: trasformare tutti i post contro il Pd in post contro Salvini, bisogna fare a mano, perché con il “trova e sostituisci” non si riesce. Calenda trova in salotto uno stambecco dei Pirenei, strano, perché è estinto da anni. Renzi annuncia che farà il suo partito. Anzi no, anzi sì. Giovedì se non piove. Ok, ci sentiamo dopo il calcetto, dammi il cinque, bro. Salvini fa un comizio a Salcazzodove Beach (Salerno), poi balla in topless fino all’alba, ma con grande rispetto delle istituzioni.
Ferragosto. E’ la grande giornata della crisi estiva. Persino il presidente Mattarella si concede un po’ di relax allentando leggermente la cravatta. Cronaca, tristissimo caso a Milano. Un signore grida “negro di merda” a un immigrato. Poi scopre che è Lukako e in un pomeriggio guadagna come lui in sessant’anni, e si butta dal Duomo. Finalmente un lieto fine. Giachetti annuncia che inizia uno sciopero della fame, ma non ricorda per che cosa. Accorato appello di Zingaretti: restiamo uniti. Purtroppo Renzi non è presente perché sta firmando l’affitto della nuova sede. Calenda ha trovato una volpe sotto il letto e sta pensando di andare a vivere con lei. Giorgia Meloni sbaglia il salto nel cerchio di fuoco e provoca un incendio all’Argentario.
Venerdì 16 agosto. Nottataccia per Salvini. Ieri sera, al comizio di Inculoamondo Beach (Crotone) si è dimenticato di chiudere lo spettacolo con la commozione per i figli. Cioè, Springsteen alla fine dei concerti fa il bis, lui fa la scenetta dei figli e finge di commuoversi. Quindi è tornato indietro, ma ormai la piazza era vuota. Tristezza. (Nota dell’autore: i figli di Salvini sono belli, felici, in ottima salute, usano la polizia come animatore di spiaggia, hanno un padre di alto reddito anche se non lavora mai… cosa c’è da commuoversi e da frignare? Fine nota dell’autore).
Domenica 18 agosto. Prime proteste ai comizi in spiaggia di Salvini. Il manifesto annunciavano Miss maglietta bagnata, e poi è risultato che ballava lui: delusione. Però intenso il passaggio su “la cinematografia è l’arma del regime” e “le potenze straniere che ci vietano un posto al sole”. Alla fine si commuove per i figli. Il presidente del consiglio Conte incontra Sergio Mattarella al Quirinale. Massimo riserbo, ma dopo l’incontro Conte si reca in un’armeria e acquista un fucile a pompa. Di Battista, intervistato da Di Battista, dice che di questo Salvini lui non ha mai sentito parlare, sarà perché era via, a Macondo o chissà dove, ma ora chiede a Sarah.
Lunedì 19 agosto. Nel cuore della notte decine di parlamentari 5stelle si svegliano di soprassalto. Si ricordano solo ora che loro hanno votato a Salvini i suoi schifosi decreti sicurezza (uno e due), e poi al momento di votare la riduzione dei parlamentari Salvini ha detto: “Cucù! Col cazzo!”. Ressa per sapere se Camera e Senato pagano le cure psicologiche. Salvini chiude il comizio di Madovecazzosiamo Beach (Reggio Calabria) attaccando i terroni: per sbaglio ha letto un testo di cinque anni fa. Poi si commuove per i figli. Calenda trova un puma delle nevi in giardino, che brutta fine per un liberale.
Martedì 20 agosto. Si riunisce il Parlamento. Crisi di governo. Elezioni imminenti. I parenti degli italiani sono stati avvertiti.
Altra nota dell’autore.A volte si ride per non piangere, d’accordo. Ma mentre ridiamo di tutti questi pupazzi, ci sono 121 persone vere, in mare da quasi dieci giorni, che il cubista in topless che ci tocca come ministro dell’interno sta sequestrando. E lì non c’è niente da ridere. Buone vacanze
Se chiamiamo le cose col loro nome, i rapporti di forza sono un tipo abbastanza raffinato di ricatto. Esempio di scuola: se si votasse domani, Salvini farebbe il pieno e comanderebbe praticamente da solo (dicono i sondaggi), quindi, per evitare il rischio che Salvini faccia quello che vuole nel governo italiano dopo le elezioni, gli si consente di fare quello che vuole prima delle elezioni. Se il governo cade ci guadagna Salvini, se il governo sta in piedi ci guadagna Salvini. E’ per quello che il ministro dell’Interno balla seminudo nello stabilimento balneare di proprietà di uno che ha fatto eleggere al parlamento europeo: può fare – uso un francesismo – il cazzo che vuole, potendo contare sull’alleanza di un partito di maggioranza relativa che ormai è minoranza nel paese (dicono i sondaggi e le recenti europee).
A vedere il bicchiere mezzo pieno, i 5 stelle se la sono giocata male, a vederlo mezzo vuoto non sanno nemmeno da che parte si comincia a giocare, a vederla tutta, Salvini si è fregato il bicchiere, la bottiglia e pure il tavolino, il bar è di un suo amico, gli avventori lo adorano e lui balle con le cubiste, intimidisce la stampa, irride gli avversari e fa la vittima.
E intanto si prepara al futuro, perché davanti, tipo iceberg, c’è una finanziaria che dovrà trovare chi dice trenta chi dice cinquanta miliardi, e non li troverà certo nelle tasche dei milionari o degli evasori fiscali (che anzi vengono perdonati e condonati), ma in quelle degli italiani che lavorano, che magari si incazzeranno un po’. E’ per quello, e non per qualche nave delle Ong, che ha voluto il decreto Sicurezza Uno e il Decreto Sicurezza Due: le norme sui cortei, sui blocchi stradali, sull’onnipotenza della celere nelle piazze, sulla repressione preventiva di qualunque protesta seria. Insomma, mentre tutti pensano che sia un cazzaro che balla in spiaggia, Salvini mostra una discreta lungimiranza: basti dire che il ministro dell’Interno non ha mai avuto tanto potere, e il ministro dell’Interno è lui.
Dunque se mettiamo in fila le forze che possono opporsi a Salvini, il quadro si fa ancora più buio. I 5 stelle sono alleati molto affidabili e gli fanno passare tutto pur fingendo qualche mal di pancia, esternando spesso come se fossero all’opposizione, per poi votare come vuole lui. Se non lo fanno (la Tav), lui vota con gli altri, non c’è problema. La sora Meloni non vede l’ora di sostenerlo, il brandelli del palloncino esploso di Forza Italia pure (e apprendiamo dell’esistenza dei totiani, in un primo momento ci eravamo rallegrati leggendo “totani”). Il Pd si distrae ogni tanto dalle sue liti interne, con un leader ostaggio del leader precedente che fa da tappo a qualunque iniziativa e che sta facendo i conti della serva sul suo nuovo partitino. Insomma, a parte la realtà economica e sociale del paese, il suo malessere, la sua emigrazione all’estero in cerca di quell’ascensore sociale che qui è rotto da anni (e che di certo non riparerà Salvini), nessuno sembra opporsi al ballerino in topless, se non qualche intellettuale che tiene botta e non accetta la sua narrazione. Il dubbio è se farlo cadere consentendogli di prendere tutto il banco, e di farlo continuare in una situazione in cui tiene tutto il banco. E’ l’alternativa del diavolo.
Ma intanto, questo lo dicono i numeri, ci sono sei milioni di persone che in un anno (dalle politiche 2018 alle europee 2019) hanno abbandonato i 5stelle, tanti quanti quelli che (dalle europee del 2014 alle politiche del 2018) hanno abbandonato il Pd renzista. Sono italiani (tanti) in cerca di una casa, non a tutti piace quella che gli offre Salvini, ma pagheranno l’affitto comunque: dai trenta ai cinquanta miliardi con il solito metodo: meno sanità, meno scuola, meno diritti, nemmeno un buon contratto per le cubiste che ballano col lupo.
 In coda sull’Everest. La montagna, il contatto con la natura, l’azzurro del cielo e le cime innevate. Che bello, eh! Così migliaia di terrestri annoiati dal resto della Terra corrono verso il Nepal per qualche giorno di contatto totale con la natura. Una vacanza rispettosa dell’ambiente: un aereo per arrivarci, poi macchine, jeep, fuoristrada, elicotteri. Poi campo base. Poi mettersi coda a settemila metri con l’obiettivo di arrivare a ottomila. Una fila lunga, un serpentone che arriva quasi a valle, e stupisce che dal tetto del mondo non rimbombino tonitruanti le parole care: “Serviamo il numero 47!”. Andare sull’Everest costa un bel po’, è ancora una status symbol che consente di tornare dalla vacanze con tante foto bellissime del culo di quello che stava in fila davanti a te. Urge democratizzazione: se alle Poste si trovasse il modo di togliere un po’ di ossigeno all’aria tutti potrebbero godere del brivido di fare la coda in altura (e la morìa di pensionati aiuterebbe i conti pubblici).
In coda sull’Everest. La montagna, il contatto con la natura, l’azzurro del cielo e le cime innevate. Che bello, eh! Così migliaia di terrestri annoiati dal resto della Terra corrono verso il Nepal per qualche giorno di contatto totale con la natura. Una vacanza rispettosa dell’ambiente: un aereo per arrivarci, poi macchine, jeep, fuoristrada, elicotteri. Poi campo base. Poi mettersi coda a settemila metri con l’obiettivo di arrivare a ottomila. Una fila lunga, un serpentone che arriva quasi a valle, e stupisce che dal tetto del mondo non rimbombino tonitruanti le parole care: “Serviamo il numero 47!”. Andare sull’Everest costa un bel po’, è ancora una status symbol che consente di tornare dalla vacanze con tante foto bellissime del culo di quello che stava in fila davanti a te. Urge democratizzazione: se alle Poste si trovasse il modo di togliere un po’ di ossigeno all’aria tutti potrebbero godere del brivido di fare la coda in altura (e la morìa di pensionati aiuterebbe i conti pubblici).
Al concerto in spiaggia. E’ il must dell’estate e l’ha inventato Jovanotti. Quale modo migliore di difendere la natura e di sensibilizzare il mondo sull’ecologia che stipare quarantamila persone su una spiaggia dalla mattina a notte fonda? Pensateci, è come pulire il mare col detersivo per piatti, magari funziona. I teatri, i palasport, gli stadi, le piazze non bastano più, per i concerti, ora serve qualcosa di più deciso, di più simbolico, che so, ballare in centomila su un prato di montagna per difendere i pascoli lasciando le mucche nelle stalle, oppure sparare ai cuccioli di tigre per sensibilizzare il mondo sulla loro estinzione. Naturalmente dal palco rimbomberà il verbo ambientalista: “Dopo puliamo per bene!”. In più, educazione al futuro per tanti giovani volontari: lavoro gratuito in cambio di un panino e una maglietta, così si abituano a quello che li aspetta nella vita.
La movida a Roma. Chi è in cerca di emozioni forti e di brividi non dovrà più passeggiare per la periferia di Lagos con tre Rolex al polso, basterà una serata a Campo de’ Fiori per una vacanza a contatto con la natura. Tra americani ubriachi, tedeschi in overdose di birra, spacciatori che ti tirano il pacco, carabinieri in divisa e in borghese, borseggiatori, attaccabrighe vari, turisti che trovano tutto molto suggestivo e pagano due aperitivi come un pranzo di nozze, l’avventura è assicurata. I vacanzieri potranno finalmente tornare a Medellin, a Scampia o in un liceo americano sospirando: “Finalmente al sicuro”.
Crociera a Venezia. Chi resisterebbe al fascino di navigare a bordo di un condominio di nove piani lungo come una fila al casello dell’autostrada, con la coda al buffet, le risse per gli ascensori, le liti tra quelli delle cabine secondo ponte versus la ressa festante e rumorosa che corre al pianobar? Notti vivaci e albe suggestive, finché si arriva a Venezia e tutti sul ponte grande a guardare se finalmente ci si riesce. Poi, un mormorio deluso: anche questa volta non siamo riusciti a centrare il campanile di San Marco con la prua. Dannazione.
Milano marittima. Tutti gli esperti concordano: è la località migliore per il Salvini watching. Aggirandosi in infradito per la spiaggia privatizzata dagli stabilimenti balneari, le possibilità di intravvedere il ministro dell’Interno in bermuda e mojito è piuttosto alta, superiore a quella di vedere una iena al parco Kruger in Sudafrica o uno sciacallo a Yellowstone, stesso brivido, ma più probabilità di farsi un selfie con l’animale. Pochi giorni di relax, prima di tornare a casa e mostrare agli amici, in quelle noiosissime serate post-ferie, le foto delle vacanze, ma quelle di Salvini. Meno facili gli avvistamenti sulla spiaggia libera, che potrà comunque essere privatizzata e chiusa ai bagnanti meno abbienti per un bel concerto ecologico. Buone vacanze.
Se avessi uno stemma nobiliare (già fa ridere l’idea) ci scriverei quella frase di Billy Wilder: “Se proprio devi dire la verità, fallo in modo divertente. Quelli che fanno ridere verranno risparmiati”. Ecco. Con tutto che alla famosa formula “una risata vi seppellirà” non ci ho mai creduto molto, nemmeno da ragazzino quando avevo, come tutti, il poster di quell’anarco-sindacalista che rideva in faccia agli sbirri (Parigi, 1905). Ma resta il fatto che ridere è un moto eversivo del cuore, che smuove e squassa, che vede l’assurdo dove gli altri non lo colgono, che dà fastidio a chi non sa ridere, e già questo è uno sberleffo.
Ma insomma, onore al vecchio Billy: uno che ha scritto A qualcuno piace caldosi è meritato risate nei secoli del secoli, e come omaggio basta così. Ma poi c’era anche L’ispettore generaledi Gogol’, Mistero buffodi Dario Fo, Vonnegut, Mastro Benni, e insomma, grandi, grandissimi, inarrivabili. E in più: fanno ridere. Non è mica un dettaglio.
Aborro il dibattito sulla satira, mi accontento della lezione del maestro Fo: “L’unica regola è non avere regole”, per cui toglierei di mezzo le accuse di volgarità, di assenza di grazia, di inopportunità: tutte scemenze, la satira c’è dai tempi di Aristofane e ci sarà sempre. Anni di frequentazione (militanza?) dell’ambiente mi hanno insegnato che la satira piace molto quando parla degli “altri”, e molto meno quando parla dei “nostri”, ma è un problema che non riguarda chi fa satira, che non deve riguardarlo.
E però qualche regola c’è. Suscitare la risata, costruire la battuta, limarla, renderla acuminata e facile da lanciare, ecco le regole. Mica facile. E’ una grammatica, una lingua. Ribaltare i fattori, l’assurdo passato per reale come difesa dal reale così assurdo che ci circonda.
Cuore(1991-1996. R.I.P.), meraviglioso collettivo di penne e matite geniali non a caso aveva per sottotitolo: “Settimanale di resistenza umana”. Ecco, ridere è per me questo: resistere, ribaltare, passare al contrattacco. E quanto all’imparare a usare quella grammatica e quella lingua, è soprattutto questione di sintesi e idee chiare, sapendo che si maneggia la dinamite e che una battuta ben fatta può descrivere un’epoca, un tempo, un contesto, meglio di un saggio ponderoso. “Scatta l’ora legale, panico tra i socialisti” (marzo 1991) fu uno di quei guizzi diventato storia, due righe di titolo e c’era tutto, e ancora fa ridere, e ancora si cita. L’aver fatto parte di quel manipolo di talenti ha a che fare con mia éducation satirique, perdonerete l’orgoglio. E poi altri gruppi, altre mirabolanti squadriglie del far ridere, fino, storia di oggi, all’ensemble dei mirabili autori di Maurizio Crozza, uno potente, uno che quando ha un testo buono lo trasforma in un testo ottimo, perché far ridere è anche questione di faccia, di costruzione, di volo pindarico, di stratificazione, di significati. E di avere un pensiero, che altrimenti, senza un pensiero tuo, che ridi a fare?
Sarà che “ridere è un altro modo di piangere”, come dice Radu Mihaileanu (ma sì, Train de viel’avrete visto, no?), ma insomma, faccio fatica a pensare di scrivere qualcosa che fa ridere senza un obiettivo, un bersaglio. Perché del ridere mi piace ciò che il ridere nasconde per finta e mette in evidenza sul serio: l’assurdo e l’ingiustizia. Non è un caso che niente fa più incazzare i regimi totalitari della gente che ride, e potevi farti decenni di Siberia per una battuta (citofonare Solženicyn).
Caso di scuola: Il lavoratore Boris riceve una telefonata dal capocellula della fabbrica, è il 1974:
“A riconoscimento del tuo impegno per la costruzione del socialismo, compagno Boris, è stata accettata la tua domanda di avere un’automobile, che ti verrà consegnata il 7 maggio 1984″.
“Ma è tra dieci anni!”, risponde il bravo operaio Boris. E poi: “Va bene, grazie compagno dirigente, il 7 maggio 1984, ottimo, me lo segno. Mattina o pomeriggio?”
“Mancano dieci anni, compagno Boris, che importanza ha?”
“No, è che alla mattina mi viene l’idraulico”.
Eccola là l’Urss brezneviana, assurda, pachidermica, lenta e noiosa, opprimente. E per una barzelletta così si poteva andare in galera, eppure si rideva lo stesso, di nascosto, ma si rideva, persino là. E non tutto faceva ridere, eppure la smorfia divertita c’era, come nella famosa battuta rumena dei tempi di Ceausescu: “Cosa c’è, nella nostra meravigliosa Repubblica Socialista di più freddo dell’acqua fredda? L’acqua calda”. Chapeau.
Ma poi – tristezza – della frase di Billy Wilder che vorrei sul mio stemma, la seconda parte non funziona più. Non è vero che “Quelli che fanno ridere verranno risparmiati”, non è vero almeno dalla strage a Charlie Hebdo(gennaio 2015). Morì fucilato per reato di risata anche il mio preferito, un mio amore: Georges Wolinski, meraviglioso cochon, genio assoluto. L’ultimo messaggio l’aveva già lasciato: “Voglio essere cremato. Ho detto a mia moglie di gettare le ceneri nel water: così potrò guardarti il culo tutti i giorni”.
Non fa ridere, dite? Boh, però è meraviglioso.
 Se è vero che “Dio acceca chi vuole perdere”, come diceva (pare) il profeta Isaia, nella politica attuale, e segnatamente nel Pd, ci sono molti Ray Charles, purtroppo senza il senso del blues (e del ridicolo). Insomma, mentre il governo traballa, Conte va in Parlamento a parlare di affaracci russi al posto di chi dovrebbe andarci veramente (Salvini), si allarga il solco paraideologico della Tav, volano sberle, impera il battibecco e si fa la guerra a ministri del proprio stesso esecutivo, il principale partito d’opposizione non trova di meglio che prendersi a schiaffoni da solo, minacciare defezioni e scissioni, mandarsele a dire attraverso i giornali, i tweet, i selfie e magari addirittura, chi lo sa, si telefonano pure.
Se è vero che “Dio acceca chi vuole perdere”, come diceva (pare) il profeta Isaia, nella politica attuale, e segnatamente nel Pd, ci sono molti Ray Charles, purtroppo senza il senso del blues (e del ridicolo). Insomma, mentre il governo traballa, Conte va in Parlamento a parlare di affaracci russi al posto di chi dovrebbe andarci veramente (Salvini), si allarga il solco paraideologico della Tav, volano sberle, impera il battibecco e si fa la guerra a ministri del proprio stesso esecutivo, il principale partito d’opposizione non trova di meglio che prendersi a schiaffoni da solo, minacciare defezioni e scissioni, mandarsele a dire attraverso i giornali, i tweet, i selfie e magari addirittura, chi lo sa, si telefonano pure.
Ieri il derby era Franceschini contro Renzi. Uno a dire che per fare opposizione bisogna entrare nelle contraddizioni del governo, allargare le crepe nei muri della maggioranza, insomma accorrere con taniche di benzina dove le scintille tra Lega e 5stelle producono incendi. L’altro, reduce da un viaggio in America dove è andato a parlare di futuro (e te credo, il passato non è entusiasmante), che risponde piccato con il solito #Senzadime, cancelletto più nove lettere, supporto teorico della luminosa strategia dei popcorn, quella che ha portato la Lega al governo, e poi al 36 per cento, e poi… Uno scontro tra titani, anche con colpi sotto la cintura, tipo Renzi che rimprovera a Franceschini i suoi insuccessi, che detto da lui è come se i tedeschi prendessero in giro i giapponesi perché hanno perso la guerra mondiale.
Guerriglia interna, dunque. Come la mozione di sfiducia per Salvini, lanciata senza concordarla con il segretario (cioè una corrente che prende un’iniziativa parlamentare), come il continuo stillicidio di dichiarazioni che vanno dall’ironico all’ostile. Aggiungiamo, più per dare colore alla scena che per sostanza politica, l’eterno penultimatum di Carlo Calenda, che anche lui minaccia di mettersi in proprio e uscire dalla ditta se si farà un accordo coi 5stelle, ma è contrario alla mozione di sfiducia di Renzi e Boschi contro Salvini che ricompatterebbe la maggioranza (come dice anche Franceschini e come pensa Zingaretti). In ogni caso, si registra un grande risveglio dei troll di tutte le parti in commedia, che in confronto le guerre nei Balcani erano partite a bocce. Gente che recupera hashtag antichi e consunti (#senzadime, appunto), o che sberleffa il nemico di turno, o che elenca le malefatte grilline per dire che gli unici affidabili sono loro, con questo dettaglio, ahimé, che hanno solo il 18 per cento.
Ecco, l’aritmetica dirà l’ultima parola, chissà quando. Però pare davvero contro le leggi della fisica e della natura fare un governo Pd senza destra (la Lega) e senza 5stelle, cioè immaginare di andare a palazzo Chigi soli e splendidi contando sul voto di un italiano (scarso) su cinque. Qualcuno ci riuscì anche con meno (il vecchio Bettino), ma in quel caso c’era un sistema di alleanze, mentre ora è tutto un “senza di me”, che significa: se si gioca io non gioco, l’ambizione di vincere una partita restando a cazzeggiare negli spogliatoi.
Nei fatti, si tratta di un mirabolante asse Renzi-DiMaio, alleati strettissimi, entrambi preoccupati che il governo regga, che non scivoli malamente, che non si faccia male. Si accusano a vicenda di inenarrabili nefandezze (non tutte inventate) per tenersi in piedi l’un l’altro, per sostenersi. Fuori di lì, la Lega fa quasi quello che vuole, Zingaretti fa l’amministratore di un condominio dove quelli del primo piano mandano a cagare quelli del secondo, che litigano con quelli del terzo e così via, ad libitum. Spettacolo piuttosto indecoroso, non il primo, non l’ultimo. Non resta che sedersi ad ammirare lo spettacolo, comodi, nel buio della sala. I popcorn li porta Renzi.
 In un paese in cui il lavoro scarseggia e le statistiche sull’occupazione fanno spavento, la piaga del doppio o triplo impiego diventa insostenibile. E’ come se uno facesse il tornitore alla Breda, poi il tramviere, poi in pausa pranzo l’idraulico e dopo cena il pediatra. Tipo Salvini, insomma, che alla mattina fa il ministro dell’Interno (sgombero di 300 persone tra cui 80 bambini), il ministro del Lavoro al pomeriggio (incontro coi sindacati), il presidente del Consiglio per una mezz’oretta, il piazzista di flat tax mentre gli altri mangiano un panino, poi, per tutto il resto della giornata fa quello che a Milano si chiama “il piangina”, cioè quello che “tutti ce l’hanno con me”, quello che frigna. Puro salvinismo, insomma, che è una variante bulimica del classico “chiagni e fotti” del potere italiano. A tempo perso twitta foto di cibo e gattini (ieri un poliziotto che nutre una gattina incinta, che non è sta gran notizia, avrebbe fatto certo più scalpore una gattina che dà da mangiare a un poliziotto incinto, probabilmente Salvini ci sta lavorando). Insomma, per la prima volta ci troviamo di fronte a un multi-ministro, che in confronto i travestimenti di Silvio buonanima erano cabaret (il presidente operaio, il presidente ferroviere, ecc. ecc.). Come sempre quando qualcuno esagera sorge spontanea una domanda: non sarà un po’ colpa nostra che gli diamo retta (e per “nostra” intendo: di chi ha a che fare con lui)? Dopotutto lo spaccone da bar, quello che alza gli occhi dalla Gazzettasolo per intervenite a cazzo, nella vita lo abbiamo incontrato tutti, dovremmo sapere come si fa.
In un paese in cui il lavoro scarseggia e le statistiche sull’occupazione fanno spavento, la piaga del doppio o triplo impiego diventa insostenibile. E’ come se uno facesse il tornitore alla Breda, poi il tramviere, poi in pausa pranzo l’idraulico e dopo cena il pediatra. Tipo Salvini, insomma, che alla mattina fa il ministro dell’Interno (sgombero di 300 persone tra cui 80 bambini), il ministro del Lavoro al pomeriggio (incontro coi sindacati), il presidente del Consiglio per una mezz’oretta, il piazzista di flat tax mentre gli altri mangiano un panino, poi, per tutto il resto della giornata fa quello che a Milano si chiama “il piangina”, cioè quello che “tutti ce l’hanno con me”, quello che frigna. Puro salvinismo, insomma, che è una variante bulimica del classico “chiagni e fotti” del potere italiano. A tempo perso twitta foto di cibo e gattini (ieri un poliziotto che nutre una gattina incinta, che non è sta gran notizia, avrebbe fatto certo più scalpore una gattina che dà da mangiare a un poliziotto incinto, probabilmente Salvini ci sta lavorando). Insomma, per la prima volta ci troviamo di fronte a un multi-ministro, che in confronto i travestimenti di Silvio buonanima erano cabaret (il presidente operaio, il presidente ferroviere, ecc. ecc.). Come sempre quando qualcuno esagera sorge spontanea una domanda: non sarà un po’ colpa nostra che gli diamo retta (e per “nostra” intendo: di chi ha a che fare con lui)? Dopotutto lo spaccone da bar, quello che alza gli occhi dalla Gazzettasolo per intervenite a cazzo, nella vita lo abbiamo incontrato tutti, dovremmo sapere come si fa.
Siccome viviamo qui da tempo, ricordiamo che questo prendersi spazio, prime pagine, attenzione sfrenata, non è una novità. Ci fu un periodo in cui Berlusconi finiva nei titoli di testa anche se raccontava una barzelletta zozza (forse soprattutto per quello), Renzi se ne inventava una al giorno, e quando in prima pagina finiva qualcun altro gli veniva la gastrite. Salvini uguale col rilancio: vuole i titoli suoi, ma anche quelli degli altri. Ed è stato un grande momento quanto un sottosegretario leghista dimissionario per le accuse di corruzione, il famoso Siri, si è alzato nella grande sala del Viminale per spiegare ai sindacati la flat-tax. Ecco un caso di scuola del “noi che gli diamo retta”. Possibile che tra le mille e mille sigle sindacali che sono affluite ordinatamente al Viminale per sentire la lezioncina sulla flat-tax dell’indagato dimissionato non ci sia stato uno – che ne so, un vecchio delegato, una rappresentante delle commesse, un sindacalista degli edili – che si sia alzato dicendo: “Questo è troppo me ne vado”? Davvero strabiliante.
Si è un po’ imbizzarrito il presidente del consiglio vero (Conte), quando ha capito che il ministro dell’economia falso (Salvini) stava usurpando il suo posto. E forse il ministro del Lavoro (quello vero, Di Maio) avrebbe dovuto presentarsi anche lui, per parlare al posto di quello falso (sempre Salvini). E magari mandare Salvini (quello vero) a rispondere al Parlamento delle sue trame russe. Insomma, un pesce a secco non sopravvive (provate a metterlo su un tavolo) e si sa che gli serve l’acqua. Ecco. L’acqua in cui nuota Salvini, grazie alla quale sopravvive, è l’assoluta incapacità di metterlo al suo posto, di arginarlo nel suo ruolo, che già sarebbe troppo. Lo so, è più facile dirlo che farlo, però prima o poi bisognerà cominciare, e forse proprio Salvini può insegnarci come. Basta fare come lui, far finta di niente, cadere dal pero. Lo trovi pappa e ciccia con un narcos e lui dice: non lo conosco. Savoini tratta forniture di petrolio con lo sconto per regalare 65 milioni alla Lega e presenzia ai bilaterali, e lui dice “Non l’ho invitato io”. Insomma, negare sempre. Ecco, bisognerebbe fare così: Salvini chi, quello dei gattini?
 Bello come un orso, forte come un orso. E poi è un orso. Di più. E’ il Papillon degli orsi, uno capace di scappare da un recito elettrificato a settemila volt, alto alcuni metri, davanti al quale (non al quale orso, al quale recinto) il governatore del Trentino Maurizio Fugatti (Lega) si è fatto immortalare per dire che non è un orso normale, ma una specie di orso superman.
Bello come un orso, forte come un orso. E poi è un orso. Di più. E’ il Papillon degli orsi, uno capace di scappare da un recito elettrificato a settemila volt, alto alcuni metri, davanti al quale (non al quale orso, al quale recinto) il governatore del Trentino Maurizio Fugatti (Lega) si è fatto immortalare per dire che non è un orso normale, ma una specie di orso superman.
Dunque il Fugatti, che aveva fatto catturare l’orso e lo aveva fatto trasferire in quella specie di centro di accoglienza per orsi col filo spinato elettrico contro il parere del ministero dell’ambiente, ora si ritrova con un orso scappato (senza radiocollare, tra l’altro) e ha dato ordine di sparare a vista. Non possiamo accoglierli tutti (nemmeno gli orsi). Legittima difesa. Grave turbamento. Eccetera eccetera.
Ah, delizioso dettaglio nel dramma della caccia di armati a un disarmato: l’orso si chiama M49, e ora fate voi, ma pensare che un governatore leghista dia ordine di abbattere qualcuno che si chiama M49 è uno scherzo davvero sorprendente. Non mi intendo di nomi da orsi (ero rimasto a Yoghi) ed è probabile che M non stia per “milioni”, ma insomma, di tutti i numeri che ci sono, proprio un fuggiasco che si chiama M49… Lui rischia la fucilata, ma noi la metafora l’abbiamo presa in pieno. Bastano i titoli di cronaca per strappare il sorriso storto: “La Lega a caccia di M49″, oppure “M49, sparare a vista”, o “M49, dov’è finito?”. Ah, saperlo (e non vale solo per l’orso).
L’ordinanza che permette l’abbattimento sembra un ordine dei marines, e ci si immagina il bosco di quelle parti come teatro di squadre Swat che cercano nel buio, con mirini laser, il clandestino che ha lasciato il centro. Probabilmente è tutto più rustico, ma più o meno ci siamo, una caccia è sempre una caccia.
Però, però… Dal Ministero dell’ambiente è arrivata alla Provincia di Trento una diffida: M49 non deve essere abbattuto. Anche gli animalisti dicono che catturarlo è stato un errore, che ora sarà più impaurito, che togliergli il radiocollare è stato un altro errore e che, insomma, M49 rischia di pagare per errori non suoi. Così M49 rischia di diventare un altro attrito, l’ennesimo, tra 5stelle e Lega, nuovo motivo di lite. A ben vedere, sembra che ci sia più scontro per M49 che per i 49 milioni spariti da via Bellerio, che passarono via come acqua fresca (pagabile in ottant’anni di comode rate).
Ora, non resta che fare il tifo per M49. Non solo perché tra un governatore leghista (ma anche non leghista) e un orso preferiamo l’orso, ma anche perché è giusto che le metafore facciano il loro corso, vadano fino in fondo, la dicano tutta. Ora abbiamo la Lega che insegue per i boschi M49, che non si trova. Dove sarà finito? Nei boschi vicini? In conti cifrati all’estero? Lussemburgo? Mosca? Che figura, però: Putin sarebbe comparso tra le fronde, supemacho a torso nudo, freddo come un killer per giustiziare il fuggiasco dissidente M49. I leghisti trentini se lo sono fatti scappare sotto il naso e ora tengono il dito sul grilletto contro il parere del ministero. Non c’è più il vecchio Bossi che tuonava “le pallottole costano 300 lire”, adesso c’è questo qui dei bacioni, forte coi debole e debole coi forti. Corri, M49, corri!
 La domanda sorge spontanea, come si dice: ma ora che si combatte una guerra senza quartiere a dei poveracci che rischiano la pelle nell’attraversamento del Mediterraneo, ora che le statistiche farlocche di Salvini dicono “meno sbarchi”, ora che il paese pare essersi piegato alle scemenze del tipo “non possiamo accoglierli tutti”, ora, dico – qui e ora – per i famosi italiani che vengono “prima”, è cambiato qualcosa? Voglio dire: più reddito? Migliori condizioni di lavoro e di vita? Sono forse più felici? Garruli? Spensierati? Guardano al futuro con rinnovata fiducia?
La domanda sorge spontanea, come si dice: ma ora che si combatte una guerra senza quartiere a dei poveracci che rischiano la pelle nell’attraversamento del Mediterraneo, ora che le statistiche farlocche di Salvini dicono “meno sbarchi”, ora che il paese pare essersi piegato alle scemenze del tipo “non possiamo accoglierli tutti”, ora, dico – qui e ora – per i famosi italiani che vengono “prima”, è cambiato qualcosa? Voglio dire: più reddito? Migliori condizioni di lavoro e di vita? Sono forse più felici? Garruli? Spensierati? Guardano al futuro con rinnovata fiducia?
Della propaganda salviniana, culminata l’altro giorno con il patetico “mi sento solo” (cfr, il Gassman de I soliti ignoti: “M’hanno rimasto solo, quei quattro cornuti!”) e rinfocolata ogni giorno da minacce e proclami, si vede solo una sponda: quella dei non italiani che vengono “dopo”, mentre degli italiani, che verrebbero “prima”, si dice poco e niente.
Non irrita solo la propaganda del capo, che deve trovare ogni giorno un nuovo nemico per applicare la sua tattica di incattivimento guidato delle masse, ma anche quella dei subalterni, sottoposti, dipendenti e famigli, inclusi gli strilloni da talk show. Caso di scuola, infinite volte ripetuto: ecco!, aiutano gli africani e non i poveri terremotati italiani! Che è forse il trucchetto più semplice per fregare la gente: fare leva su una (presunta) ingiustizia e promettere di sanarla, una cosetta che funziona sempre. Naturalmente è una fesseria, anzi peggio, è il solito trucchetto di indicare ai penultimi gli ultimi, e aizzarglieli contro. Peccato però che se cerchi “Lega-terremotati”, oppure “Lega- terremoto”, per trovare tracce di questo solennissimo e umanissimo appello di levare soldi agli stranieri cattivi in mezzo al mare per darli ai poveri terremotati di collina, trovi come primo risultato la storia del sindaco di Visso Pazzaglini (Lega). Accuse di peculato e abuso d’ufficio per un bel po’ di soldi destinati ai “poveri italiani terremotati” finiti su conti correnti privati. Ahi, ahi, ahi. La giustizia farà il suo corso, per carità, ma intanto la favola bella del “fermiamo gli stranieri per fare un favore a voi italiani” si sporca un bel po': gli stranieri li fermano (o dicono di), ma il favore per gli italiani non arriva, nemmeno per quelli di Visso. E i “poveri terremotati italiani” restano lì, alcuni con le macerie, le zone rosse, le recinzioni, le casette già marce, la ricostruzione ferma. Nessuno di loro, nemmeno per un istante, pensa di non riavere una casa, o il suo centro storico, o le scuole, per colpa di una quarantina di naufraghi stipati su una barca a vela.
Il fatto che il ministro dell’Interno si sia auto-incoronato con l’auto-interim alla Difesa, all’Economia, alla Giustizia e agli Esteri (più altre cariche che si appiccica sul bavero della felpa quando conviene), complica le cose. Ci sono due guerre in corso, al momento: una di Salvini verso le Ong, partita in cui finora ha perso quattro a zero pur continuando a fare leggi su misura per batterle (e bis, e tris, per le leggi su misura, pur avendo frequentato per anni l’ambiente berlusconiano, non ha imparato molto); l’altra quella di Salvini contro tutti i ministri che non si chiamano Salvini. Bello spettacolo, ma in ogni caso, per gli italiani che dovrebbero venire “prima”, niente, zero, solo il biglietto gratis per lo spettacolino. Forse vengono prima nell’essere presi per il culo da Salvini che, comunque, è già un “prima”.
Poi, forse, un giorno si farà il conto – economico, soldi, euro, dané – di quanto costa il rimpiattino di Salvini con due o tre navi umanitarie, tra motovedette, marina, udienze, sequestri, trasferimenti, burocrazia, avvocati e altro. E si scoprirà che le guerre di Salvini sono un po’ care, dispendiose, e che le pagano (prima) gli italiani.
 Eccola qui. L’antologia di racconti Sellerio. Cinquanta in blu. Che quest’anno è un po’ speciale, perché in ognuno di questi racconti c’è un riferimento, un gioco, una trama, che prende spunto, cita, stravolge, ridisegna un libro del catalogo Sellerio. E’ il cinquantenario, bisogna festeggiare. Gioco interessante, e sorprese. Ci sono Costa, Malvaldi, Piazzese, Recami, Savatteri, Simi e Stassi, quindi roba buona da leggere.
Eccola qui. L’antologia di racconti Sellerio. Cinquanta in blu. Che quest’anno è un po’ speciale, perché in ognuno di questi racconti c’è un riferimento, un gioco, una trama, che prende spunto, cita, stravolge, ridisegna un libro del catalogo Sellerio. E’ il cinquantenario, bisogna festeggiare. Gioco interessante, e sorprese. Ci sono Costa, Malvaldi, Piazzese, Recami, Savatteri, Simi e Stassi, quindi roba buona da leggere.
Il raccontino mio si intitola Piccola suite borghese e l’indagine questa volta la fa proprio il Monterossi con il suo amico Falcone e Bianca Ballesi che è… beh, sorprendente. Il libro che mi ha dato la traccia è Ognuno muore solo, di Hans Fallada, che è un vero capolavoro, un libro importante. Mi scuso di avere attinto a un maestro simile, a un libro così spaventoso e nobile, per un pastiche del nostro misero “qui e ora”, ma giocare con quelli bravi è sempre bello e quindi… (leggetelo, Fallada!)
Non vi dirò di più, per ora, Cinquanta in blu esce il 4 luglio
 Partito con ridanciano allarme sui social, ripreso dai giornali, rilanciato da commenti più o meno colti, più o meno sensati, più o meno arguti dei pensatori contemporanei da corsivo, è ormai conclamato il tormentone dei “49 milioni”, che la pagina Facebook di Salvini Matteo vi risputa indietro come parola non gradita. Un vero respingimento, anche un po’ brutale (“Your comment contains a blacklisted word“) nello stile del mangiasalsicce del Viminale, del suo staff, della Bestia, dell’algoritmo, eccetera eccetera. Fa abbastanza ridere che nell’era della comunicazione totale, della libertà d’espressione totale, della rete totale, ci sia da qualche parte una “lista nera di parole” che non si possono usare perché Salvini si irrita. Ma insomma, per qualche minuto ognuno ha fatto le sue prove: “49 milioni” no, il commento sulla bacheca salviniana non passa; “Quarantanove milioni” sì, passa. E naturalmente via con i 48+1, i 50-1, a esaurimento scorte, e si sa che la matematica è inesauribile (personalmente, suggerisco sette al quadrato, ho controllato, non è nella lista nera). Altre parole che erano nella lista nera ora sono uscite dalla lista nera, potete scriverle sui muri, sulle fiancate della macchina, nelle lettere alla fidanzata, e persino sulla pagina FB di Salvini, parole come “Siri” (il sottosegretario dimissionato) o “Trota”, l’indimenticato pargolo. Dentro e fuori, parole permesse, parole vietate, parole amnistiate, a seconda del momento e della bisogna.
Partito con ridanciano allarme sui social, ripreso dai giornali, rilanciato da commenti più o meno colti, più o meno sensati, più o meno arguti dei pensatori contemporanei da corsivo, è ormai conclamato il tormentone dei “49 milioni”, che la pagina Facebook di Salvini Matteo vi risputa indietro come parola non gradita. Un vero respingimento, anche un po’ brutale (“Your comment contains a blacklisted word“) nello stile del mangiasalsicce del Viminale, del suo staff, della Bestia, dell’algoritmo, eccetera eccetera. Fa abbastanza ridere che nell’era della comunicazione totale, della libertà d’espressione totale, della rete totale, ci sia da qualche parte una “lista nera di parole” che non si possono usare perché Salvini si irrita. Ma insomma, per qualche minuto ognuno ha fatto le sue prove: “49 milioni” no, il commento sulla bacheca salviniana non passa; “Quarantanove milioni” sì, passa. E naturalmente via con i 48+1, i 50-1, a esaurimento scorte, e si sa che la matematica è inesauribile (personalmente, suggerisco sette al quadrato, ho controllato, non è nella lista nera). Altre parole che erano nella lista nera ora sono uscite dalla lista nera, potete scriverle sui muri, sulle fiancate della macchina, nelle lettere alla fidanzata, e persino sulla pagina FB di Salvini, parole come “Siri” (il sottosegretario dimissionato) o “Trota”, l’indimenticato pargolo. Dentro e fuori, parole permesse, parole vietate, parole amnistiate, a seconda del momento e della bisogna.
Risultato: applicare una censura così rozza (vietare una parola) è sempre una fesseria, perché per due giorni si è parlato molto di quella parola, dei 49 milioni e, in subordine, di quanto sono scemi i censori di ogni ordine e grado. Come sempre, il diavolo sta nei dettagli: brutta l’idea di creare un piccolo universo di parole sgradite al Capo e quindi vietate, ma decisamente grottesco il gesto in sé, l’esecuzione dell’opera, diciamo. Cioè uno si alza la mattina, raggiunge il suo posto di lavoro, accende il computer e digita la parola vietata: una triste vicenda umana (ancora più triste, se considerate che è pagato da noi tutti, essendo lo staff della disinformatsijasalviniana passato al libro paga del ministero).
Insomma, che alla fin fine Salvini sia il grande comunicatore circondato da geniali comunicatori è dura da credere: al momento si registra un passaggio dalle cose commestibili ritratte insieme al leader (aperitivi, mozzarelle, cotechini), a piante e fiori, in vaso o recisi (azzurri, rosa, gialli), sempre naturalmente seguiti da “bacioni” o domande retoriche (“Faccio bene?”).
E’ questione peregrina e di poco conto: il sentimentdel paese è di battagliera contrapposizione, e la sensazione è che Salvini potrebbe farsi immortalare mentre bastona un cucciolo di foca o annega dei gattini e “i suoi” lo applaudirebbero comunque, quindi non sarà l’astuzia un po’ nordcoreana di vietare una parola a farlo sembrare ridicolo agli occhi dei suoi.
E però la cosa resta lì, sospesa, minacciosa. Vietare le parole, le espressioni sarcastiche, i motti di spirito, le barzellette, ha sempre portato ai censori una sfiga notevolissima. Non saremo alla melma maleodorante del breznevismo, quando il Kgb batteva i bar alla ricerca di barzellettieri d’opposizione, ma insomma, c’è una vena di ridicolo nel parlare costantemente a nome del popolo (che è di 60 milioni, e non di 9, come i voti della Lega) e poi vietare al popolo di scrivere “49 milioni”. Anche senza tirare in ballo Orwell, la neolingua, gli algoritmi, le strategie, la censura e l’apocalisse, rimane il fattore umano: un tizio è andato lì e con le sue manine ha inserito una parola “vietata”. Magari l’ha fatto sentendosi molto furbo, magari ha solo “eseguito un ordine”, oppure pensa che siamo tutti scemi: tre cose, anche queste, che prima o poi ti fanno finire male.
Qui la mia recensione per TuttoLibri di “Chi ama, odia”, il giallo argentino del ‘46 di Silvina Ocampo e Adolfo Bioy Casares (con Borges nume tutelare e consigliere…).
 Se vi piace la caccia al tesoro – come gioco, passatempo, rebus enigmistico, giallo intricato o citazione letteraria – siete nel posto giusto. E la caccia al tesoro presuppone che ci sia un tesoro, che nessuno sappia dov’è, oppure che chi sa dov’è lo tenga ben nascosto agli altri concorrenti, come fa il viceministro all’economia Massimo Garavaglia: “Le coperture ci sono, non le dico altrimenti Di Maio me le ruba”.
Se vi piace la caccia al tesoro – come gioco, passatempo, rebus enigmistico, giallo intricato o citazione letteraria – siete nel posto giusto. E la caccia al tesoro presuppone che ci sia un tesoro, che nessuno sappia dov’è, oppure che chi sa dov’è lo tenga ben nascosto agli altri concorrenti, come fa il viceministro all’economia Massimo Garavaglia: “Le coperture ci sono, non le dico altrimenti Di Maio me le ruba”.
Questa immagine di Di Maio che ruba le coperture a Garavaglia, pare una nuova variante della politica economica – gli studiosi la collocano tra Keynes e Macario – e intanto veniamo a sapere per vie traverse (lo dice uno degli economisti ultras della Lega, tale Rinaldi) che il tesoro che tutti cerchiamo è di 53 miliardi di euro. Il giallo s’infittisce. Cresce la tentazione di catturare e torturare Garavaglia perché dica tutto: “Dove sono ‘ste coperture? Parla subito, oppure diamo il tuo numero di telefono a Calenda!”. Che orribile minaccia.
Mentre si segue la pista principale – Garavaglia sa dov’è il tesoro e Di Maio si mette la tutina da Diabolik per derubarlo – nella Lega dilaga il surrealismo. Da Losanna Giancarlo Giorgetti, potentissimo della Lega, una specie di Salvini senza cotechino nell’inquadratura, manda platealmente al diavolo un sedicente economista della Lega, Claudio Borghi, negando la possibilità di calcolare come parte del tesoro i famosi mini-bot. In effetti sarebbe la prima caccia al tesoro al mondo in cui i cacciatori si stampano il tesoro da soli.
Il ragionamento di Giorgetti ha un senso: “Se i mini-bot si potessero fare li farebbero tutti”. Elementare. Che è anche, tra parentesi, la cosa che dovrebbe dirsi sempre chi ha un’idea nuova: magari se non l’ha mai fatto nessuno prima, ci sarà un motivo. Come per incanto, riparte l’epopea dei mini-bot, che è una sotto-trama del giallo principale (il tesoro da 53 miliardi). Non solo i mini-bot nessuno sa esattamente cosa sono, ma nessuno sa nemmeno come si scrive mini-bot (io scelgo il trattino radical-chic, ma qualcuno lo scrive tutto attaccato, minibot, e altri con lo spazio, mini bot). E’ un po’ come se si discutesse del ritorno alla li-ra o alla l’ira.
Grande confusione. Alimentata dal fatto che alcuni sostenitori del mini-bot ne hanno diffuso dei fac-simile dove ci sono Tardelli, Falcone e Borsellino e Oriana Fallaci (5, 10, e 20 euro), e invece di pensare a cercare il tesoro, tutti hanno cominciato a discutere forsennatamente: e perché non Pertini? E Sofia Loren, no? Eccetera, eccetera. Divertente, ma ricordo a chi si è distratto dicendo la sua (e Totò?), che stiamo sempre cercando 53 miliardi di euro che solo Garavaglia sa dove sono (ma non lo dice).
Naturalmente i mini-bot avrebbero un nobile scopo: quello di saldare i fornitori della pubblica amministrazione che vengono pagati con enorme ritardo con soldi veri, mentre così verrebbero pagati in tempi ragionevoli con mini-bot da cinque euro sui quali campeggia Tardelli esultante perché ha segnato alla Germania, oppure la sora Fallaci che voleva far saltare le moschee in Toscana. Lo spericolato immaginario leghista. Del resto, l’alternativa è secca, e questo lo dice sempre il Rinaldi di cui sopra, leghista economico: per trovare 53 miliardi “o si usa la bacchetta magica o si usano i mini-bot”. Bene, apprezziamo le basi scientifiche del ragionamento. Resta da capire come, quando, quanto, in che modo funzioneranno, chi li potrà ricevere, o magari spendere, o magari (esagero, attenzione) incassare come fossero soldi veri. Intanto che (non) se ne discute continua la caccia al tesoro, che è quel che poi è diventata da anni la vera pratica italiana della politica economica, un cercare riserve dimenticate, tesoretti spuntati dal nulla, risorse insperate. Garavaglia, che sa, tace, se no Di Maio gli ruba le coperture.
 Purtroppo, il convegno su “L’istituto giuridico dell’autosospensione – Confini legali, etici e morali” è stato rinviato perché tutti i relatori si sono autosospesi e nessuno sapeva cosa dire. Quindi andremo felicemente a tentoni con le nostre piccole forze, cercando di precisare i contorni di questa pena autoinflitta, di questa autoflagellazione un po’ mimetica che va di gran moda. Dai, su, se non sei autosospeso da qualcosa, oggi come oggi, non sei nessuno, è una cosa trendy.
Purtroppo, il convegno su “L’istituto giuridico dell’autosospensione – Confini legali, etici e morali” è stato rinviato perché tutti i relatori si sono autosospesi e nessuno sapeva cosa dire. Quindi andremo felicemente a tentoni con le nostre piccole forze, cercando di precisare i contorni di questa pena autoinflitta, di questa autoflagellazione un po’ mimetica che va di gran moda. Dai, su, se non sei autosospeso da qualcosa, oggi come oggi, non sei nessuno, è una cosa trendy.
Ultimo clamoroso episodio, come si sa, quello di Luca Lotti, un imputato che andava di notte a discutere le nomine nella procura che lo ha indagato. Non è una cosa carina, ma si dice che non abbia violato nessuna legge. Cioè, per esempio, se dici alla fidanzata “Andiamo a fare una gita” e poi l’abbandoni in un bosco sperduto e te ne torni a casa da solo, non hai infranto nessuna legge, ma qualcuno potrebbe incazzarsi lo stesso. In quel caso, suggerisco: autosospensione. Oppure dici che hai parlato di qualcosa con Mattarella, e quando Mattarella dice che non è vero, e che stai millantando… suggerisco: autosospensione dal guardarsi allo specchio.
Autosospendersi è comodo, non impegna più di tanto, e può persino servire a fare un figurone in società, ammesso di vivere in una società di deficienti in sollucchero: “Uh, si è autosospeso! Che coraggio! Che tempra!”.
In più, ci sono molti tipi di autosospensione: quella un po’ offesa (“Fintanto che non sarà tutto chiaro mi autosospendo!”, modello sindaco di Milano Sala) che suona un po’ come “Non mi meritate!” ed equivale a sbattere la porta uscendo dalla stanza. Oppure c’è l’autosospensione difensiva, tipo il sottosegretario Siri che la propose come ultimo disperato tentativo al posto delle dimissioni (che è un po’ come proporre di farsi due settimane alle Maldive invece che due mesi in miniera, niente male).
Unico problema: ci si autosospende daqualcosa. Da una carica. Da una funzione. Da un ruolo. Guidavo il tram, mi autosospendo, non guido più il tram.
Risulta invece difficile capire dacosa si sia autosospeso Luca Lotti, non avendo cariche, né ruoli, né funzioni note e ufficiali. Si è autosospeso dal Pd, bene, però sarebbe bello sapere cosa significa. Non paga più la tessera? Non va alle riunioni? E’ davvero pensabile che un importante capocorrente come Luca Lotti (secondo la vulgata dei giornali controllerebbe 40-50 deputati) smetta di incontrare, brigare, sollecitare, consigliare, tessere strategie e ricamare tattiche, incontrare colleghi? Va nel gruppo misto? Escursioni in montagna? Torneo di golf?
Generalmente, il nobile gesto di autosospendersi è compiuto a garanzia dell’istituto da cui ci si autosospende. Per esempio se un iscritto al circolo del bridge uccide sei persone, sarebbe carino da parte sua autosospendersi, come dire: sono io il mostro, il nobile circolo del bridge non c’entra niente.
A quel punto, quelli del circolo del bridge si chiudono in un triste silenzio. Invece nel Pd all’autosospensione di Lotti si sono alzate voci esultanti: “Che coraggio! Si è autosospeso! Che leone!”.
Suggerirei alla politica qualche cautela. Se la cosa prende piede nella vita normale non se ne esce più. Gente che si autosospende dalle rogne, dalle seccature, dal pagamento dell’Imu, da tifoso del Milan, da moglie, da marito. E naturalmente l’autosospensione (“auto”) è una cosa autonoma, personale. Come uno si è autosospeso può sempre decidere di autosospendere l’autosospensione e di tornare. Si faceva da bambini gridando “arimo!”, che era una versione popolare di “arimortis” e che significava: sospendere per un attimo il gioco, le regole, i tempi, i modi, insomma una specie di time-out. Però, vuoi mettere il pathos? Il fulgore di un gesto elegante, nobile, che offre il petto alle pallottole, dignitoso. Mi autosospenado! Addio!
Nuovi appuntamenti per I tempi nuovi. Dal 20 al 22 giugno a Cagliari c’è Marina Café Noir, Festival di letterature applicate, che è un bel festival. Il tema quest’anno è “Il contrario di uno”, e chi ha letto “I tempi nuovi” sa che è una cosa che fa parte del discorso. Il programma completo del festival lo trovate qui. Insomma, appuntamenti: venerdì 21 giugno, in piazza Garibaldi, alle 23, ci sarà un reading con brani tratti dal romanzo. Leggono e suonano Elio Turno Arthemalle e Armeria dei Briganti. Il giorno dopo, sabato 22, si parla del libro (e du tutto il resto) con Nicola Muscas e tutti quelli che vengono. Alle 19 in piazza San Domenico).
Venerdì 28 giugno, invece, si parla de I tempi nuovi a Cremona, al PAF, Porte Aperte Festival. L’appuntamento è alle 21 al Bastioni di Porta Mosa. Venite, eh!
Herbert Lieberman, Il fiore della notte (Minimum fax). Un giallo ma non solo. Qui sotto la recensione
 Uno scenario raccapricciante, situazione spaventevole e foriera di tregenda. Gabicce Mare, Italia. Scena: interno giorno, pizzeria. I clienti spazientiti si alzano dai tavoli e infornano da soli le loro pizze. Turisti belgi lavano i piatti. Le mogli sono salite a rassettare le stanze dell’albergo.
Uno scenario raccapricciante, situazione spaventevole e foriera di tregenda. Gabicce Mare, Italia. Scena: interno giorno, pizzeria. I clienti spazientiti si alzano dai tavoli e infornano da soli le loro pizze. Turisti belgi lavano i piatti. Le mogli sono salite a rassettare le stanze dell’albergo.
Esterno giorno, si compila la lista degli annegati, perché i bagnini erano “giovani del Sud” che adesso che sono ricchissimi col reddito di cittadinanza, e col cazzo che vengono a Gabicce a fare i bagnini. Vale anche per camerieri, cuochi, aiuto cuochi, fattorini, commessi, baristi. Insomma ha fatto rumore il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi: manca personale per la stagione estiva perché “mancano i destinatari del reddito di cittadinanza”. Mannaggia! Non c’è giornale italiano, sito, rivista, blog, che non riprenda la notizia. Come faremo? Moriremo tutti.
Un senatore del Pd eletto in Toscana, non dei più svegli, salta subito sul carretto: “Ecco, pagano la gente per stare a casa!”.
Fine del siparietto. Tutta roba archiviabile come rumore di fondo. Anche perché, naturalmente, non è così. Il presidente degli albergatori del posto dice (intervistato da questo giornale) che il reddito di cittadinanza non c’entra niente, insomma fake news in piena regola (aggiungo che se uno l’anno scorso ha lavorato a Gabicce, regolarmente, coi contributi, e dichiarato tutto per bene, il suo Isee non gli concederebbe quest’anno il reddito di cittadinanza). Allarmismo e furbizia, conditi come spesso avviene con quella sottile patina di scandalo borghese antico come il mondo: “signora mia, dove andremo a finire”. Un borbottio padronale travestito da moralismo: il reddito di cittadinanza “diseducativo” (sempre il senatore di prima). Cioè che ti disabitua a prendere un treno da Salerno o Avellino, e andare a fare la stagione in Romagna alla pensione Vattelapesca, dieci-dodici-quindici ore al giorno, metà in nero, per guadagnare alla fine un salario da fame senza diritti, come subito hanno precisato in rete migliaia di “fannulloni” dal loro divano, raccontando le loro vite reali di stagionali.
Ma i più attenti riconosceranno in questa schermaglia pre-estiva, un nucleo centrale della narrazione padronale di questi anni. Una cosa che rimbalza periodicamente su titoli e titoloni, servizi dei Tg, costernate filippiche: la favola dell’imprenditore che non trova i lavoratori, che pure assumerebbe felice e generoso, ma quelli niente, maledetti, non hanno voglia di lavorare. E’ una favola bella, ma solo all’inizio, perché poi immancabilmente, qualcuno va a vedere meglio. E così si scopre che l’annuncio era un cartello di carta sulla vetrina, o su Facebook, oppure che le condizioni sono insopportabili, o gli orari assurdi, e la paga troppo bassa. Dopo la notizia (tipo: “Panettiere disperato su butta nel forno perché non trova garzoni”) arrivano migliaia di domande e curriculum, ovvio. Ma intanto la voce gira, la favola si consolida, il sentire comune diventa: “Guarda, il lavoro c’è, ma la gente non ha voglia”.
E’ che il dumping sui salari, la compressione del lavoro, il disprezzo dei contratti nazionali, la mortificazione del lavoratore hanno bisogno di un sostegno narrativo, di una voce diffusa che li sostenga in qualche modo, di quel “Signora mia, dove andremo a finire”. Una piccola marea, un’increspatura di indignazione popolare, costante, immutabile, ogni volta risvegliata dalla notizia del giorno, da un sindaco di Gabicce o di altrove, per quei lavoratori che non vogliono lavorare. Che nello storytelling padronale di fine anni ‘10 sono quasi sempre giovani, quasi sempre “del Sud” e sempre immancabilmente fancazzisti. “Diseducati” ad accettare regole del mercato che scivolano spesso (e volentieri!) verso la schiavitù. Che stronzi, eh?
 Stanco dei soliti trucchetti e delle piaghe ormai note (inondazioni, terremoti, cavallette, Bruno Vespa) il Signore volle mandare agli italiani la più terribile delle punizioni: la campagna elettorale estiva. Due mesi a quaranta gradi, umidità novanta per cento, Salvini su tutte le spiagge, Di Maio soffocato dalle giacchette in tugsteno, Silvio immerso nel ghiaccio secco come i gelati da asporto, Zingaretti non pervenuto, Calenda con le infradito sul Cervino. Spossati da due anni di campagna elettorale (politiche, amministrative, europee, condominiali), sessanta milioni di italiani si preparano con terrore a una nuova stagione di avanspettacolo.
Stanco dei soliti trucchetti e delle piaghe ormai note (inondazioni, terremoti, cavallette, Bruno Vespa) il Signore volle mandare agli italiani la più terribile delle punizioni: la campagna elettorale estiva. Due mesi a quaranta gradi, umidità novanta per cento, Salvini su tutte le spiagge, Di Maio soffocato dalle giacchette in tugsteno, Silvio immerso nel ghiaccio secco come i gelati da asporto, Zingaretti non pervenuto, Calenda con le infradito sul Cervino. Spossati da due anni di campagna elettorale (politiche, amministrative, europee, condominiali), sessanta milioni di italiani si preparano con terrore a una nuova stagione di avanspettacolo.
Giugno. Rotti gli indugi, ecco i principali leader accusare tutti gli altri della crisi, compattare le proprie fila, riorganizzare la comunicazione. Salvini esordisce presentandosi con due fidanzate, una bionda e una bruna, segno di pluralismo. Di Maio risponde con una fidanzata bionda e un orso bruno che suona l’organetto. Proteste degli ambientalisti. Giorgia Meloni lancia un grande sondaggio popolare: a chi vorreste spezzare le reni entro giovedì? C’è grande attesa per la formazione delle liste. Calenda chiede a Zingaretti il permesso di formare un nuovo partito che tolga voti a Zingaretti per poi allearsi con Zingaretti. Zingaretti tentenna. La sinistra a sinistra del Pd punta tutto sull’unità: ottenere un solo voto. Uno studio americano svela il mistero degli applausi a Di Martedì: pur di non sentire altre cazzate, il pubblico potrebbe applaudire per tre ore filate.
Luglio. Secondo i primi sondaggi, l’incremento più sostanzioso è quello dei candidati che si chiamano Mussolini. Oltre ad Alessandra e a Tizio Caio Sempronio, già noti alle cronache e recentemente trombati, correranno anche Brunello Mussolini, 13 gradi, pienezza di corpo con retrogusto fruttato, e Dolores Mussolini, utilitaria ibrida con motore bicilindrico a spinta. L’osservatorio Ocse per la trasparenza delle elezioni cataloga i tweet di Salvini: 235 con cocomeri, 211 con gelati e/o ghiaccioli, 121 in apnea per trattenere la pancia e solo 47 con elettori di colore, 45 dei quali, dopo attenta analisi si rivelano Giorgetti molto abbronzato. La cronaca influenza l’umore popolare e infuoca le polemiche: un commercialista di Sondrio naufragato con il suo dodici metri lancia l’SOS nel Mediterraneo meridionale, viene raccolto da una motovedetta libica e internato in un lager a Misurata. Si moltiplicano in Puglia le apparizioni di Padre Pio che invita a votare Salvini. Zingaretti: “Sempre meglio delle apparizioni di Renzi”. Di Maio appare a Di Maio, che si spaventa a morte.
Agosto. La tenuta psicofisica degli italiani preoccupa l’ordine dei medici. Calenda apre un nuovo partito in franchising. Emma Bonino lancia il suo nuovo movimento, “Più o Meno Europa”, Giorgia Meloni presenta i suoi candidati: il nipote di Mengele, la figlia novantenne del Boia di Riga e l’avvenente Giorgina Pinochet, giovane youtuber cilena. Si discute molto per l’endorsement di Pamela Prati: invita a votare per un partito che non esiste. Si profilano le nuove alleanze. Salvini e Meloni discutono se assumere nuovo personale, Berlusconi manda un curriculum ma viene scartato. Polemiche nel Pd: Calenda ha fondato un nuovo partito per allearsi con Zingaretti. Non contento, è uscito dal nuovo partito per fondarne un altro che si alleerà con Calenda e Zingaretti. Non contento, è uscito dal nuovo partito per fondarne un altro. Si calcola che alle elezioni ci saranno settantadue partiti fondati da Calenda con un unico slogan: “Unità a sinistra”. Renzi corre la maratona in 46 minuti e 09, sequestrato il motorino. Per un tragico errore dovuto alla stanchezza, Salvini si scatta un selfie con il mojito e inghiotte il telefonino: prognosi riservata.
Settembre. Si vota (?)
 Ultim’ora: tutti i tentativi di vedere il bicchiere mezzo pieno stanno fallendo. Cioè: non è mezzo pieno o mezzo vuoto, è che qualcuno si è proprio fregato il bicchiere con tutta la bottiglia. Nonostante questo, c’è chi ci prova: Renzi esulta per Nardella a Firenze (premio di consolazione), il Pd esulta per la tenuta di qualche roccaforte, la sora Meloni mai così in alto che non ci credeva nemmeno lei, gli altri non pervenuti, col povero Silvio a tenere insieme quel che resta di passate grandezze e i 5 stelle tramortiti dalla batosta. E’ tutto, vostro onore, se si aggiunge che la sinistra a sinistra non esiste, che la signora Bonino è l’eterna promessa che non mantiene mai, e che incombe su ogni cosa un possibile (sulla carta) governo di destra-destra che verrà usato come bastone se i 5stelle non mangiano la carota. Poteva andare peggio? No.
Ultim’ora: tutti i tentativi di vedere il bicchiere mezzo pieno stanno fallendo. Cioè: non è mezzo pieno o mezzo vuoto, è che qualcuno si è proprio fregato il bicchiere con tutta la bottiglia. Nonostante questo, c’è chi ci prova: Renzi esulta per Nardella a Firenze (premio di consolazione), il Pd esulta per la tenuta di qualche roccaforte, la sora Meloni mai così in alto che non ci credeva nemmeno lei, gli altri non pervenuti, col povero Silvio a tenere insieme quel che resta di passate grandezze e i 5 stelle tramortiti dalla batosta. E’ tutto, vostro onore, se si aggiunge che la sinistra a sinistra non esiste, che la signora Bonino è l’eterna promessa che non mantiene mai, e che incombe su ogni cosa un possibile (sulla carta) governo di destra-destra che verrà usato come bastone se i 5stelle non mangiano la carota. Poteva andare peggio? No.
Si conferma che il voto è mobile, un po’ ondivago, un po’ isterico e, come si dice oggi, liquido, e che solo Salvini aveva un contenitore per mettercelo, una bella tanica capiente dove piazzare tutte le scontentezze, dove sistemare tutto e il contrario di tutto, dal ceto medio spaventato, alle fasce più disagiate a cui si sono sapientemente (e con molte complicità) indicati gli ultimi come nemici. La vituperata propaganda ha vinto, insomma, e questo mette in crisi le propagande degli altri: non ne avevano una all’altezza, la retorica “popolo contro élite” non bastava più, e quella dei “competenti” peggio che andar di notte.
Ma c’è un altro attore che prende la scena delle europee salviniane, ed è il famoso ceto medio di cui un bel giorno toccherà seriamente definire i parametri. Ora che le hanno date e prese, tutti corrono a inseguirlo, blandirlo, parlargli con parole suadenti. Si allargano renzisti e calendisti, dicendo che serve un partito di centro che poi si alleerà con Pd. Una strana equazione, perché si tratterebbe di uscire dal Pd (sottraendogli voti) per creare una formazione politica che poi si alleerà col Pd. Mah. Va detto che la strategia zingarettiana dell’opossum (fingersi morti, lasciar passare la tempesta senza segnare all’avversario, ma almeno evitando gli autogol) ha garantito l’esistenza in vita, che è già qualcosa dopo i disastri renziani, ma se si vanno a vedere i voti assoluti c’è ancora un calo. Insomma, per il bicchiere mezzo pieno bisogna essere strabici forti.
Quanto a Silvio buonanima, anche lui batte sul tasto del ceto medio, e anche lui porta a casa la sua sconfittona sonante, dopo che la ricomparsa della mummia aveva fatto sperare nella soglia del dieci per cento. Altra sirena (stonata da tempo) che il ceto medio non ha ascoltato, e dunque si fa pressante la domanda: ma ‘sto famoso ceto medio, che un tempo si chiamava borghesia, dove guarda? A leggere i dati si direbbe che si sia riversato tutto su Salvini, il che pone qualche dubbio sulle analisi correnti. Si è sempre ragionato, infatti, su un ceto medio moderato, impaurito dai toni forti, dagli estremismi, voglioso di rifugiarsi in schieramenti che tranquillizzano, che sopiscono le pulsioni più agguerrite. E invece eccolo, il buono e bravo ceto medio della nazione, saltare sul carro salviniano, forse nella speranza di avere veramente una flat tax, forse incantato da quell’essere “potenza” che la propaganda ha spinto fino all’eccesso (a volte fino al ridicolo, cin tanti di santi e madonne). Ora si dice che la differenza non è solo quella. C’è il divario tra città e provincia, la frontiera delle speranze deluse, la fuga dai 5 stelle passato in pochi mesi da movimento di protesta a establishment. Tutto vero. Ma il dato rimane: anziché esserne spaventata, la piccola e media borghesia italiana si è riversata su Salvini. Non è l’estremismo a farle paura, ma di non essere rappresentata e così sceglie il vincitore, chiunque sia, persino Salvini.
Qui la puntata di Quante Storie (Rai Tre) condotta da Corrado Augias, dedicata a I tempi nuovi.
L’intervista su I tempi nuovi che mi ha fatto Bruna Miorelli, per “La Domenica dei libri”, il programma di Roberto Festa su Radio Popolare. Audio
 Mancano quattro giorni alle elezioni europee, che si attendono ormai con l’apprensione dello schianto del meteorite: quali forme di vita sopravviveranno?, chi si salverà?, emigrare in Nuova Zelanda potrebbe servire? Ecco la spaventosa cronaca degli ultimi giorni in esclusiva per i lettori de Il Fatto Quotidiano.
Mancano quattro giorni alle elezioni europee, che si attendono ormai con l’apprensione dello schianto del meteorite: quali forme di vita sopravviveranno?, chi si salverà?, emigrare in Nuova Zelanda potrebbe servire? Ecco la spaventosa cronaca degli ultimi giorni in esclusiva per i lettori de Il Fatto Quotidiano.
Mercoledì– Matteo Salvini si presenta in consiglio dei ministri con il decreto Sicurezza-ter che prevede il confino a Ventotene per chi racconta barzellette su Salvini, mazze chiodate in dotazione alle forze dell’ordine e il Milan in Champions League. I dubbi del Colle. I dubbi di Conte. I dubbi della governatrice dell’Umbria Catiuscia Marini, che si dimette, ma solo durante i pasti. Polemiche per il papa che agita il rosario durante l’Angelus. Il sottosegretario Giorgetti: “Basta simboli politici nella Chiesa!”. Proposta choc dell’economista (?) della Lega Borghi: usciamo dall’euro e adottiamo il dollaro canadese, ma solo il sabato e nei centri commerciali convenzionati. Cronaca: sparatoria a Napoli in un asilo nido. Umorismo: recital in piazza di Giorgia Meloni.
Giovedì– Si scaldano gli animi durante il consiglio dei ministri, dove Salvini presenta il decreto Sicurezza-quater che prevede l’arresto immediato per chi si veste da Zorro, una tassa sui balconi e il daspo per i cani di grossa taglia. Corretta la norma sulle multe per chi salva naufraghi in mare, non più 5.000 euro, ma 4.985: un cedimento alle perplessità del Quirinale, ma ancora non c’è l’accordo: i 5 stelle si battono perché si arrivi a 4.970. In un comizio a Caserta Luigi Di Maio prende le distanze da Luigi Di Maio: “Mai al governo con la Lega”, poi si chiude da solo in albergo per un chiarimento. Grosse novità nella campagna elettorale del Pd: ricompare Renzi che promette un milione di posti di lavoro, un nuovo referendum, duemila asili in duemila giorni… finché non lo chiudono nei bagni. Catiuscia Marini, governatrice dell’Umbria, si scorda di dimettersi durante il pranzo, ma vota contro il dessert. Cultura: manifestazione nazionale a Roma contro gli sceneggiatori di Games of Thrones.
Venerdì – A sorpresa, la governatrice dell’Umbria Catiuscia Marini si dimette durante la prima colazione, poi convoca una riunione e vota contro le dimissioni. Sconcerto nel Pd. In un comizio a Ravenna, Luigi di Maio attacca duramente Luigi Di Maio: “Mai al governo col Pd” e annuncia un chiarimento interno a Luigi Di Maio. Salvini al lavoro sul decreto sicurezza quinquies che prevede pene severissime (fino a tre anni di carcere) per chi entra troppo abbronzato in un porto turistico, i neonati che girano senza documenti saranno deportati in Valtellina, detrazioni fiscali per chi mette sul balcone un crocefisso alto almeno due metri. Esteri: in Alabama potranno abortire solo gli uomini. Sport: Conte all’Inter, ma il presidente del consiglio smentisce: con uno spogliatoio così litigioso, meglio il governo.
Sabato – Giornata di silenzio elettorale. Salvini presenta il decreto sicurezza sextus, che prevede pene pecuniarie per chi non vota Lega, l’arresto immediato per chi acquista formaggi francesi e l’amnistia per tutti i cittadini con il cognome che comincia per F e che abbiano fatto il sindaco di Legnano. I dubbi del Colle. Proposta-choc di Carlo Calenda: i lavoratori devolvano una giornata di stipendio alla settimana alla parte più debole della popolazione: gli imprenditori del Nord-est. In un comizio a Udine, Luigi Di Maio usa toni provocatori contro Luigi Di Maio: “Mai un governo coi 5 stelle”, poi annuncia un vertice con Luigi Di Maio. Catiuscia Marini, governatrice dell’Umbria, dimentica di dimettersi ma si ricorda di ritirare le dimissioni, sconcerto di Zingaretti. Esteri: suicidio di massa dei sovranisti austriaci, ma l’autopsia smentisce: “E’ stato lo champagne russo”.
Domenica –Si vota.
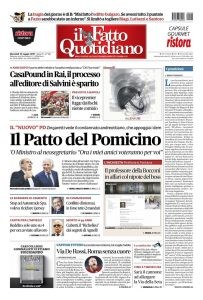 In principio fu la Digos. Poi si chiamarono i pompieri. In entrambi i casi qualche polemica ha turbato le coscienze civili del Paese. E ora, chi toglierà dai balconi d’Italia gli striscioni che contestano Matteo Salvini durante i suoi pittoreschi comizi? Il Fatto Quotidianoè in grado di rivelare le prossime mosse dello staff del ministro dell’Interno per staccare dalle case le lenzuola con messaggi e scritte a lui dedicati. Ecco le forze chiamate a intervenire.
In principio fu la Digos. Poi si chiamarono i pompieri. In entrambi i casi qualche polemica ha turbato le coscienze civili del Paese. E ora, chi toglierà dai balconi d’Italia gli striscioni che contestano Matteo Salvini durante i suoi pittoreschi comizi? Il Fatto Quotidianoè in grado di rivelare le prossime mosse dello staff del ministro dell’Interno per staccare dalle case le lenzuola con messaggi e scritte a lui dedicati. Ecco le forze chiamate a intervenire.
I lagunari.Contattato da Luca Morisi e retribuito con otto barattoli di Nutella, il famoso reparto d’assalto anfibio dell’esercito interverrà prontamente in caso di contestazione al capo della Lega. Giunti nei paesi della bassa padana a bordo di un sommergibile, i lagunari saranno per l’occasione dotati di cesoie per staccare gli striscioni dai balconi degli italiani più ingenerosi, colpevoli di non amare il Capitano. Azione rapida, silente ed efficace, solo un po’ complicata dal dover attraversare di corsa le piazze italiane con le pinne.
I cosacchi.Forte di una collaborazione con i corpi speciali della polizia russa, il ministro dell’Interno italiano si è assicurato il fedele supporto di un reggimento di cosacchi del Don. Abbeverati i cavalli alle fontane pubbliche, i valorosi combattenti, giunti in pullman da Vladivostock, hanno staccato a colpi di sciabola due lenzuola matrimoniali dal secondo piano di una palazzina di Carugate. Polemiche per i saccheggi e i rapimenti di giovani donne del luogo. Vodka esaurita in tutta la Brianza.
I redattori di Libero. Milizia ardita e coraggiosa, famosa per lo sprezzo del ridicolo, interverrà agli ordini dello staff di Matteo Salvini per rimuovere graffiti offensivi e manifesti sgraditi al Capo. Le scritte sui muri (“Salvini vattene” o “Salvini non ti vogliamo”) saranno coperte con gli editoriali di Vittorio Feltri che daranno un tono di scanzonato buonumore alcolico alle location scelte da Salvini per i suoi comizi. Gli striscioni di contestazione esposti alle finestre verranno sostituiti con pittoresche vedute di Bergamo alta e gigantografie di grandi del passato che non sono stati capiti, come Mussolini, Videla, Pinochet e altri geni incompresi che hanno fatto “anche cose buone”.
Olindo e Rosa.Ottenuto dal ministro dell’Interno uno speciale permesso premio, i due dinamici simpatizzanti della Lega interverranno personalmente per staccare gli striscioni sgraditi al vicepresidente del Consiglio in carica. Mentre Olindo, affronterà le pareti in mattoni arrampicandosi fino ai balconi, Rosa realizzerà all’uncinetto stendardi alternativi con frasi di elogio al Capo, ricette del coniglio in umido ed enormi scritte “Bacioni” tracciate a punto-croce. Timide proteste del ministro della giustizia.
La guardia costiera libica. Forza di interdizione addestrata alla cattura e compravendita di disperati diretti in Europa, collaborerà all’azione di bonifica delle piazze destinate ai comizi di Salvini, rimuovendo striscioni e cancellando scritte sui muri. Si tratta di un’azione spontanea per sdebitarsi dai favori ricevuti dal ministro dell’Interno italiano. “Da quando comanda lui i nostri affari nel settore schiavismo vanno a gonfie vele”.
Gli scrittori di Casa Pound. Seccato alle critiche sulla sua indifferenza per la letteratura, Matteo Salvini passa all’attacco e decide di utilizzare gli autori della casa editrice di Casa Pound per stroncare sul nascere le contestazioni a base di lenzuola appese ai balconi. Purtroppo, molti autori della casa editrice sono stati impiccati dopo il processo di Norimberga, alcuni hanno superato i novant’anni e altri, anche più anziani, vivono nascosti in Argentina. Restano dunque pochi arditi disposti a scalare le pareti delle palazzine fino ai balconi e ad agire con virile determinazione armati di otto milioni di baionette.
 Finalmente c’è della verità nel faccione finto giocoso di Salvini Matteo, capo della Lega, vicepresidente del Consiglio, ministro dell’Interno, eterno comiziante, inviatore di bacioni e ometto forte. Accade quando qualcuno gli si mette a fianco sorridente come lui, gli chiede un selfie, e poi dice qualcosa di vero. Come la ragazza di Salerno (“Non siamo più terroni di merda?”), come l’altro giovane che gli chiede conto di 49 milioni spariti, puff; come il quindicenne sardo che fece lo stesso e molti altri, comprese Gaia e Matilde, che dopo averlo lusingato (“Salvini! Un selfie!”) si baciano nell’inquadratura, con lui, il federale, che fa la faccia del tonno appena pescato. Con quella faccia è finito anche sulla Cnn, che il mondo sappia, ecco.
Finalmente c’è della verità nel faccione finto giocoso di Salvini Matteo, capo della Lega, vicepresidente del Consiglio, ministro dell’Interno, eterno comiziante, inviatore di bacioni e ometto forte. Accade quando qualcuno gli si mette a fianco sorridente come lui, gli chiede un selfie, e poi dice qualcosa di vero. Come la ragazza di Salerno (“Non siamo più terroni di merda?”), come l’altro giovane che gli chiede conto di 49 milioni spariti, puff; come il quindicenne sardo che fece lo stesso e molti altri, comprese Gaia e Matilde, che dopo averlo lusingato (“Salvini! Un selfie!”) si baciano nell’inquadratura, con lui, il federale, che fa la faccia del tonno appena pescato. Con quella faccia è finito anche sulla Cnn, che il mondo sappia, ecco.
I reperti elettronici giunti fino a noi in forma di foto e video, sono quelli sopravvissuti a perquisizioni e identificazioni degli autori (sicuramente molti altri non hanno passato i controlli), e fa ridere sentire lo staff di Salvini gridare mentre il video sfuma: “La Digos, la Digos!”. Insomma, lo sceriffo di Nottingham che chiama le guardie, altro che “uno del popolo”, altro che “uno di noi”, siamo al gerarchetto che chiama la milizia perché l’hanno preso in giro.
Probabile che spunteranno altri video, altri selfie. Oppure che – prudenza – Salvini sarà costretto ad abbandonare la pratica di usare i cittadini come comparse plaudenti della sua narrazione tossica: dannazione, non tutti battono le mani, dannazione, non tutti lo osannano come quelli che gli fanno il baciamano (ad Afragola, con tanto di inchino in ginocchio), dannazione, il giochetto si è sporcato, forse addirittura rotto.
Siccome sta diventando prassi diffusa, mettersi accanto a Salvini e sbertucciarlo come fosse un concorrente di Ciao Darwin, tipo umano a cui in effetti somiglia, sarà interessante vedere le contromisure. La prima, come da ricchissima tradizione, è il vittimismo. Così da qualche tempo Salvini non si limita a parlare ai suoi, ma non perde occasione per attaccare i nemici. Se i “comunisti” (e i “centri sociali”) fossero numerosi come li vede Salvini, saremmo in Corea del Nord. Ma la risposta secondo cui o stai con lui o sei “comunista” (uh!) è deboluccia e zoppicante. Così mister 49 milioni batte su un tasto vecchio, posta sui social le scritte sui muri contro di lui, lamenta di ricevere pallottole e minacce (ma dove le riceve, che al Viminale non va mai?), insomma gioca il gioco vecchio del chiagni e fottidei potenti, secondo tradizione. Con una mano fa il duro, con l’altra, come si dice a Milano (lui capisce la lingua) fa il “piangina”. Ma essendo, come si conviene ai capi della truppa, sempre circondato da forza pubblica ai suoi ordini, bisogna beffarlo con l’inganno, rivoltargli contro la sua stessa comunicazione: bacioni!
Immaginiamo le riunioni dello staff. Chiamare le guardie come i vecchi re offesi dai sudditi che ridono funziona, ma non può durare. Fischiare un ministro è lecito – ancora e per fortuna – anche se le intimidazioni sono quotidiane: signore prese in malo modo e portate in questura, gente identificata con modi bruschi, persino qualcuno denunciato per avergli urlato “fascista!”. Insomma, repressione di pensiero e di parola, vietato disturbare, non più il “o con noi o contro di noi”, ma “o con noi o chiamo la Digos”, una cosa un po’ à la Ceausescu.
Piano piano, la paccottiglia propagandistica si sfalda e si mostra ridicola, fino al culmine della tradizione paracul-mediatica: la visita a Padre Pio, a cui (e te pareva!) “chiede consiglio”, e dove è andato a “pregare per Noemi”, la bambina colpita da un proiettile vagante per strada, a Napoli. Cioè la bambina che se avessimo un ministro dell’Interno invece di un piazzista porta-a-porta, comizio-a-comizio, ora sarebbe all’asilo con le sue amichette.
I tempi nuovi continua la sua corsetta. Molto contento, e molto contento di incontrare i lettori. Qui sotto le date di maggio, prendete nota.
Lunedì 6 maggio, ore 18.00, Milano, Il Libraccio Bovisa (via Candiani 102)
Domenica 12 maggio, ore 12.00, Salone del Libro, Sala Viola, con Giancarlo De Cataldo
Lunedì 20 maggio, ore 21, Lecco, Libreria Volante (via Bovara 30)
Domenica 26 maggio, ore 18, La Loggia (Torino), Castello Galli della Loggia, Festival Castelli in Giallo, con Tommaso De Lorenzis
Se si aggiungeranno altre date le comunicherò qui, o là, o da qualche parte che vedrete di sicuro. Ci vediamo in giro
 Già era fastidiosa un bel po’ questa faccenda delle “nostre donne” da difendere dalle violenze altrui. Mai capito cosa vuol dire quel “nostre”: libere al rogito? Immatricolate come la macchina? Poi erano venuti quei bei manifesti stile ventennio con il soldato nero che ghermisce la donna bianca e la scritta: “Difendila!”, penosa estetica modello Salò, rossi drammatici e il solito paraculismo familista: “Potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia”. Bene. Se non rientra nella casistica, liberi tutti, compreso il camerata Chiricozzi (per conquistare il mondo urgerebbe nome d’arte, perché in effetti sentite come suona male “Vincere, e vinceremo!”, firmato: Chiricozzi), e il suo socio in stupri Riccardo Licci, arditi di CasaPound, bella gente. Così astuti, “rapidi ed invisibili”, che si sono anche fatti il filmino della loro violenza sessuale per vantarsi con le altre camicie nere. Chissà, forse perché come diceva l’appeso buonanima “la cinematografia è l’arma del regime”.
Già era fastidiosa un bel po’ questa faccenda delle “nostre donne” da difendere dalle violenze altrui. Mai capito cosa vuol dire quel “nostre”: libere al rogito? Immatricolate come la macchina? Poi erano venuti quei bei manifesti stile ventennio con il soldato nero che ghermisce la donna bianca e la scritta: “Difendila!”, penosa estetica modello Salò, rossi drammatici e il solito paraculismo familista: “Potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia”. Bene. Se non rientra nella casistica, liberi tutti, compreso il camerata Chiricozzi (per conquistare il mondo urgerebbe nome d’arte, perché in effetti sentite come suona male “Vincere, e vinceremo!”, firmato: Chiricozzi), e il suo socio in stupri Riccardo Licci, arditi di CasaPound, bella gente. Così astuti, “rapidi ed invisibili”, che si sono anche fatti il filmino della loro violenza sessuale per vantarsi con le altre camicie nere. Chissà, forse perché come diceva l’appeso buonanima “la cinematografia è l’arma del regime”.
Le cronache, come al solito, contengono le sfumature più grottesche. Per esempio il “viene da una famiglia assolutamente perbene” che non manca mai. Mah. Sarà. Ma se uno a diciannove anni ha già alle spalle un procedimento giudiziario per pestaggio, un daspo allo stadio (portava dei razzi) e ora uno stupro con videoclip annesso, qualche dubbio anche sull’ambiente familiare è lecito farselo venire. Insomma, scatta il “salutava sempre” (romanamente, si suppone) d’ordinanza, ed è pieno di gente che cade dal pero: ah sì? Quei bravi ragazzi! Aggiungiamo la scena del crimine: una sede ufficiale di CasaPound e lascio ai lettori immaginare cosa succederebbe se una donna (nostra? loro? boh) venisse stuprata nella sede di un partito.
Insomma, ce n’è abbastanza per partire dallo stupro di Viterbo e guardare finalmente con attenzione dentro quella galassia di delinquenti che è il neofascismo italiano, che va dal nostalgico dei treni in orario (altra cazzata) al “fascista del terzo millennio”, quasi sempre poco scolarizzato, ignorante come un caprone e convinto che ci vogliono le maniere forti contro i più deboli (contro i forti, come da tradizione: a pecora).
Il prode ministro dell’interno, forse reduce da un poderoso testa a testa con un cotechino o un selfie con la mitraglia, ha pensato bene di fare un tweet senza nominare né il fatto, né i colpevoli, né CasaPound, né il neofascismo, ma attivando i fumogeni per fare confusione e parlar d’altro. Così lui e Di Maio si sono messi a litigare sulla castrazione chimica, invece di pensare a ristabilire la legge presso la HitlerJugend de noantri che da anni agisce indisturbata.
Basta cercare in rete la mappa delle aggressioni fasciste, periodicamente aggiornata, che segnala centinaia e centinaia di casi di pestaggi, spedizioni punitive, botte, agguati, accoltellamenti e altri delitti. Oppure leggere le acute riflessioni di giornalisti, anche famosi, che li andavano a legittimare nelle loro sedi, partecipando a dibattiti con gente che per una sera indossava la cravatta e non il tirapugni. Oppure il delizioso reportage del Tgr Emilia-Romagna (servizio di Paolo Pini, caporedattore Antonio Farné, direttore responsabile in quota Lega Alessandro Casarin), che mostrava come buona e brava gente della nazione i fascisti accorsi a Predappio a celebrare con “onore” (ahahah!) il vigliacco che dopo aver ammazzato mezzo milione di persone scappava in Svizzera travestito da tedesco coi soldi e l’amante. O ancora lo striscione dei fascisti laziali esposto a Milano a due passi da piazzale Loreto, o ancora le millemila volte che si è minimizzato un fenomeno criminale vietato da leggi e Costituzione. Chissà, magari la retorica del “sono bravi ragazzi” si fermerà a Viterbo grazie alle gesta del camerata Chiricozzi. Sarebbe ora. E sarebbe comunque tardi.
Qui c’è la recensione del romanzo di Anatolij Kuznecov
 Primo capitolo, prima riga: “Tutto in questo libro è verità”.
Primo capitolo, prima riga: “Tutto in questo libro è verità”.
Il lettore ci penserà spesso, leggendo, e persino l’autore gli chiederà a un tratto, in mezzo a una storia, di andare a rileggersi quella riga iniziale. Tutto vero, tutto scritto come bisogna scriverlo.
Ma prima la storia. Nel settembre del 1941 i nazisti prendono Kiev, Ucraina, nuovi padroni, la grande civiltà germanica. Il 29 settembre convocano la popolazione ebraica dicendo di portare valori, soldi, indumenti pesanti. Si presentano tutti, forse sanno, ma non vogliono sapere. Li mettono in fila a Babij Jar, un grande dirupo nella parte occidentale della città, una gola stretta e profonda, li fanno spogliare, li uccidono a uno a uno con raffiche di mitra, li gettano nel burrone, coprono con uno strato di terra. E ricominciano.
Per giorni.
Trentatremila vecchi, donne e bambini. Poi arriveranno gli zingari, poi i bolscevichi, i russi, e poi chiunque trasgredisca ad ogni capriccio nazista, colpevole di avere una fetta di pane nascosta, o di possedere una patata, o di avere più di quattordici anni, confine tra vita e morte, oltre il quale ti spedivano in Germania “a lavorare”.
Tolik di anni ne ha dodici, e vede, e sguscia in quell’orrore e in quella barbarie con la tenacia del gatto che mira a sopravvivere: indomito, eroico, ironico e spaventato, è lui che racconta “la verità”. Nonno Semerik, che aveva visto cacciare lo zar, e poi venire i bolscevichi, e poi ammazzare i kulaki – contadini con un pezzo di terra come lui avrebbe voluto essere – è la Storia vivente: oppressioni su oppressioni su oppressioni. Quella che vede Tolik, di storia, è la barbarie nazista al culmine del suo delirio: alla fine di tutto, quando i tedeschi creeranno i forni per cancellare le prove, in fondo a Babij Jar si conteranno oltre centomila morti innocenti, ma il numero vero non si saprà mai.
I liberatori – la gloriosa Armata Rossa – portano uno stalinismo al massino del suo fulgore: altra paura e altra oppressione. Su Babij Jar, invece che un monumento, faranno una diga, che crollerà, infine una strada. Niente più burrone, niente memoria: l’antisemitismo dello stato sovietico era ben vivo, niente da ricordare.
E invece ecco il libro di Anataolij Kuznecov. Cos’è? E’ una testimonianza, certo, una ricostruzione, documenti, fatti, nomi veri. Ed è anche il racconto tesissimo e spaventoso di un ragazzino – Kuznecov tredicenne – che ha momenti epici e quasi picareschi, personaggi perfetti immersi nella tragedia e nella paura, un popolo di mendicanti finito “tra l’incudine e il martello”. Una scrittura nitida, piana, perfetta, con spaventose impennate, impeccabile, terribile.
Ma in Babij Jarc’è anche un’altra storia, che è proprio la storia del libro. Consegnato nel 1965 alla rivista Junost(considerata progressista nell’Urss post-stalinana), fu tagliato, censurato, corretto, mutilato. Tutto ciò che riguardava il potere sovietico, critiche, osservazioni, testimonianze, persino avventure del piccolo Tolik, spariva sotto i colpi della censura (minuscoli segni grafici segnalano i tagli del testo e ci dicono ancora una volta quale ottuso imbecille può essere un censore). Nel 1969 Kuznekov fugge in Occidente e si mette a ricucire tutto, parti cancellate, pagine sparite, testimonianze strappate, e pubblica (1970) Babij Jarnella sua versione definitiva. Quella vera, quella in cui “tutto è verità”.
Libro importante e potentissimo disegno nitido di quella guerra “tra due campi di concentramento” che furono il nazismo prima e lo stalinismo poi. Il calvario di Kiev, la storia del piccolo Tolik. Insomma, un grande, poderoso, romanzo russo.
 Provenienza sanscrita, termine caro agli indù, quattro lettere: Guru. Che significa più o meno maestro spirituale. Bello. Sul come e sul perché un termine così antico, denso e nobile sia – qui e ora – appiccicato a gente che maneggia Facebook e Twitter con disinvoltura da nerd ripetente sorvoliamo volentieri: l’arte di maltrattare le parole è un classico della politica italiana, si pensi alle molte volte che si è scomodato il termine “statista” per gente a cui non avreste affidato nemmeno una gelateria. Ora, dopo la foto pasquale di Salvini col mitra, eccoci di nuovo a parlare di guru, e quello di cui si discute oggi si chiama Luca Morisi a cui, sia detto per inciso, paghiamo lo stipendio tutti. Un guru statale, insomma.
Provenienza sanscrita, termine caro agli indù, quattro lettere: Guru. Che significa più o meno maestro spirituale. Bello. Sul come e sul perché un termine così antico, denso e nobile sia – qui e ora – appiccicato a gente che maneggia Facebook e Twitter con disinvoltura da nerd ripetente sorvoliamo volentieri: l’arte di maltrattare le parole è un classico della politica italiana, si pensi alle molte volte che si è scomodato il termine “statista” per gente a cui non avreste affidato nemmeno una gelateria. Ora, dopo la foto pasquale di Salvini col mitra, eccoci di nuovo a parlare di guru, e quello di cui si discute oggi si chiama Luca Morisi a cui, sia detto per inciso, paghiamo lo stipendio tutti. Un guru statale, insomma.
Come si sa, la vita del “guru della comunicazione” ha solitamente tre fasi. La prima: un illustre sconosciuto insegna al politico di turno come si accende un iPad, come si scrive un tweet, come si concentra un pensiero (quasi sempre debolissimo) in 280 caratteri di testo. Poi c’è la fase del trionfo: se il politico a cui il guru fa da badante ha qualche successo (anche virtuale), arriva la celebrazione. Uh, come è bravo il guru, uh, come è forte il guru, con tanto di giornalisti, commentatori e direttori che pendono dalle sue labbra, che si inginocchiano adoranti, magari in cambio di una confidenza, della promessa di un’intervista al Capo, di un segno di attenzione. La terza fase, triste, solitaria y final, è quella del viale del tramonto: quando le fortune del leader badato si offuscano, quando la popolarità scende perché finalmente ci si accorge che tutta quella strabiliante comunicazione era quel che era, fuffa e furbizia. E allora non solo del guru non si ricorda più nemmeno il nome, ma il politico di turno si accanisce su di lui e dice: “Non abbiamo saputo comunicare!”.
Inutile riassumere le puntate precedenti, ma insomma, chi ricorda le fotine seppiate di Renzi che lo facevano sembrare un Bob Kennedy toccato dalla grazia, sa di cosa si parla. Sul guru d’importazione Jim Messina, pagato fior di migliaia di euro per perdere un referendum devastante, caleremo un velo pietoso.
Ora, da qualche tempo, c’è un nuovo guru in città, ed è questo Luca Morisi, assunto al Viminale, pagato da noi per maggior gloria di Salvini Matteo. Uno che parla di “esistenzialismo salviniano”, ossignur, e a cui i giornali dedicano articoli e riflessioni, per dire – in fondo – sempre la stessa cosa: uh, quanto è bravo il guru! Siamo insomma nella fase due, quella del trionfo, quindi basta aspettare.
Naturalmente, e giustamente, molti notano che non è bello (e non ci sono esempi analoghi nella recente storia delle democrazie occidentali) un ministro dell’Interno descritto come “Armato e con l’elmetto” (testuale) e fotografato con in mano un mitra. Suona un po’ minaccioso, diciamo, ed è il solito impasto di vittimismo e aggressività: “Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega?”, comincia il post del guru che stipendiamo tutti. Cioè: poveri noi, ci gettano fango! Che ingiustizia! Scatta poi l’elemento aggressivo e minaccioso del “Siamo armati e con l’elmetto”, con fotina del leader mitraglietta alla mano (nella foto compare pure il guru, pare preoccupato che parta un colpo, a dirla tutta). Il meccanismo comunicativo non è diverso da quello dell’ex marito stalker che aspetta sotto casa l’ex moglie: fase uno, vittimismo (“Guarda cosa mi hai fatto!”); fase due, aggressività: “Guarda che ho un coltello”.
Per farsi perdonare, dopo qualche ora, ecco la foto di Salvini con tre pupazzi di peluche. Messaggio: è armato e con l’elmetto, ma è anche un tenero cucciolone. Una cosa che sarebbe considerata troppo scema anche in una quarta elementare, se la classe non fosse impegnata a battere le mani e a dire: “Bravo guru!”.
Ehi, gente! “Questa non è una canzone d’amore”, il primo libro con Carlo Monterossi, è uscito in Grecia per le edizioni Ellinika Grammata. Si intitola “Black rapsody of love”, e se sapete il greco potete leggere una (ottima) recensione qui
Qui le recensioni uscite su Mattino di Napoli, Il Piccolo di Trieste, L’Eco di Bergamo. Grazie grazie
 Quesito per solutori più che abili, di quelli che ci passi la notte e non ne vieni a capo, ma ti sei tanto divertito. Indichi il candidato come sarà la soave convivenza tra la formazione nazionalista dei Veri Finlandesi (prima i finlandesi) e la lega di Salvini Matteo (prima gli italiani). Cioè, per dire, al buffet che succederà? Prima i finlandesi o prima gli italiani? Già mi vedo la rissa. Aiutino: i Veri Finlandesi, l’altro giorno a Milano rappresentati dal signor Olli Kotro, sono per prendere a colpi di salmone congelato sui denti chi osi fare più deficit, mentre Matteo nostro (?) va promettendo tasse piatte, soldi di qua e di là, aiuti alle imprese, tutto in deficit. Ce n’è abbastanza per un duetto divertente, tipo Stanlio e Olli, ma a sganassoni.
Quesito per solutori più che abili, di quelli che ci passi la notte e non ne vieni a capo, ma ti sei tanto divertito. Indichi il candidato come sarà la soave convivenza tra la formazione nazionalista dei Veri Finlandesi (prima i finlandesi) e la lega di Salvini Matteo (prima gli italiani). Cioè, per dire, al buffet che succederà? Prima i finlandesi o prima gli italiani? Già mi vedo la rissa. Aiutino: i Veri Finlandesi, l’altro giorno a Milano rappresentati dal signor Olli Kotro, sono per prendere a colpi di salmone congelato sui denti chi osi fare più deficit, mentre Matteo nostro (?) va promettendo tasse piatte, soldi di qua e di là, aiuti alle imprese, tutto in deficit. Ce n’è abbastanza per un duetto divertente, tipo Stanlio e Olli, ma a sganassoni.
I finlandesi (tutti, veri e falsi) sono più o meno cinque milioni e mezzo, i Veri Finlandesi hanno preso alle (loro) elezioni il 17 per cento, proprio come Salvini in Italia, uno che girava con le magliette “Padania is not Italy” e che quindi pensa anche lui che ci siano veri italiani e italiani falsi, e pare l’unica cosa su cui vanno d’accordo. L’idea che i Veri Finlandesi si comportino da veri signori e consentano ai Veri Italiani di spendere e spandere facendo veri debiti è piuttosto peregrina: se ognuno è rigorosamente sovranista a casa sua, i primi a stargli sui coglioni saranno i sovranisti di altri posti, che sovranino a casa loro, e giù le mani dai dané.
La grande alleanza delle destre europee, comunque, procede spedita fingendo di non vedere gli ostacoli. Uno di questi, non un dettaglio, la Russia di Putin, che piace tanto a Salvini (foto solitaria sulla piazza Rossa, ma senza cibo né fidanzata di turno) e Le Pen, ma che a svedesi, finlandesi, e polacchi sta simpatica come una vespa che ti entra nel casco mentre guidi la moto. Su una cosa sono tutti d’accordo: non vogliono gli immigrati, di nessun tipo e colore, dalla Danimarca alla Polonia, dall’Austria all’Ungheria, e ognuno di loro ha deliziosi rapporti con crani rasati e nostalgici del Reich, gente che pensa “quando c’era lui” (intendono il Führer), negazionisti dell’Olocausto, possibilisti delle dittature e ammiratori di Mussolini (che come si sa fino al ’38 “fece anche cose buone”, tipo ammazzare Matteotti e i Fratelli Rosselli, arrestare Gramsci, chiudere giornali, aprire galere, eccetera eccetera). Metteteci anche gli spagnoli di Vox, che “quando c’era lui” lo dicono del generalissimo Franco. Una bella compagnia, insomma, alla quale manca ancora il pezzo più pregiato, l’ungherese Orban, che fa “anche cose buone” a Budapest, ma si ostina a stare nel Ppe e sembra non sentire le sirene dei sovranisti che lo vorrebbero come centravanti.
A fare il leader di tutto questo sarebbe proprio il nostro Salvini (cioè: se c’è una gara di fascisti, prima l’italiano), che qualcuno vagheggia addirittura alla guida dell’Unione Europea in caso di vittoria schiacciante delle forze sovraniste. Uno che ha una visione così attenta, sicura e lungimirante, da dichiarare (29 marzo) che la Libia è un porto sicuro e poi (8 aprile) di essere molto preoccupato di quel che succede in Libia, dove di sicuro non c’è niente, nemmeno se sei libico e (peggio mi sento) nemmeno se sei l’Eni.
Tutta questa allegra compagnia minaccia di vedersi a Milano il 18 maggio (ci sarà anche madame Le Pen, si dice) per recitare il suo rosario: danesi che dicono prima i danesi, polacchi che dicono prima i polacchi, finlandesi che dicono prima i finlandesi (veri), austriaci che dicono prima gli austriaci e così via, con tonitruante chiusura del nostro mangiatore di Nutella e salsicce che intimerà: prima gli italiani. Insomma, tutti prima e gli altri dopo. Si prevede grande spiegamento di forza pubblica, forse per impedire le risse alla toilette (prima io, no, prima io, no, prima io, ma lo sa quanta birra ho bevuto?).
Qui il video dell’intervista a Ibs… buona visione
 Non è un paese per vecchi, e vabbé. Non è un paese per giovani, e vabbé pure questo. Per le donne lasciamo perdere, visto che se ne ammazza una ogni 72 ore. Poi si scopre che non è nemmeno un paese per medici, infermieri, barellieri, anestesisti, caposala, mancano 800 infermieri nei pronto soccorso della Campania, 500 in Puglia e via elencando. Giornali e tivù mandano i loro inviati in Molise e in Veneto, a registrare il fenomeno dei pensionati richiamati in corsia, si stabiliscono record, si festeggiano primati assoluti. Tutti ammirano il professor Giron, per esempio, che a dicembre compirà 85 anni e che fa l’anestesista a Padova: è l’età in cui ti tolgono la patente perché dubitano dei tuoi riflessi, ma possono ridarti dei pazienti da addormentare. Aspettiamo con ansia il cardiochirurgo centenario col monocolo, o l’ortopedico che vide correre Coppi e Bartali. C’è il rischio che si senta rimbombare per i corridoi il grido d’emergenza: “Salasso! Presto, portate le sanguisughe in sala due!”. Oppure lunghi interventi a cuore aperto dove si misura spesso la pressione, ma non al paziente, al dottore.
Non è un paese per vecchi, e vabbé. Non è un paese per giovani, e vabbé pure questo. Per le donne lasciamo perdere, visto che se ne ammazza una ogni 72 ore. Poi si scopre che non è nemmeno un paese per medici, infermieri, barellieri, anestesisti, caposala, mancano 800 infermieri nei pronto soccorso della Campania, 500 in Puglia e via elencando. Giornali e tivù mandano i loro inviati in Molise e in Veneto, a registrare il fenomeno dei pensionati richiamati in corsia, si stabiliscono record, si festeggiano primati assoluti. Tutti ammirano il professor Giron, per esempio, che a dicembre compirà 85 anni e che fa l’anestesista a Padova: è l’età in cui ti tolgono la patente perché dubitano dei tuoi riflessi, ma possono ridarti dei pazienti da addormentare. Aspettiamo con ansia il cardiochirurgo centenario col monocolo, o l’ortopedico che vide correre Coppi e Bartali. C’è il rischio che si senta rimbombare per i corridoi il grido d’emergenza: “Salasso! Presto, portate le sanguisughe in sala due!”. Oppure lunghi interventi a cuore aperto dove si misura spesso la pressione, ma non al paziente, al dottore.
In Veneto, Friuli, Molise si richiamano in cliniche e ospedali medici pensionati, che avevano salutato colleghi e pazienti al grido garrulo di “largo ai giovani”, ma i giovani non sono arrivati, non ce ne sono abbastanza, non li prendono ai corsi di specializzazione, che non bastano, e a Medicina c’è il numero chiuso.
Vediamo il bicchiere mezzo pieno: al reparto geriatria pazienti e medici saranno coevi e potranno raccontarsi vecchi episodi della guerra e della Resistenza. Il bicchiere mezzo vuoto: ma davvero vi fareste operare da qualcuno che ha fatto il suo primo intervento quando si inventava il Moplen e ballavano le Kessler? Assicurano i governatori coinvolti (in prospettiva: quasi tutti, anche se oggi in prima linea stanno Veneto, Molise e Friuli) che si tratta di una cosa temporanea, che i pensionati richiamati saranno presto restituiti ai loro tornei di bocce, ma quanto temporanea non sa dirlo nessuno. Di (quasi) certo c’è che nei prossimi 5 anni (quattro, ormai, perché la stima è dell’anno scorso) andranno in pensione 45.000 medici, e che non tutti verranno rimpiazzati. Le borse per i corsi di medicina di base sono poco più di mille all’anno, e i conti, in deficit, sono presto fatti. E nel Servizio Sanitario Nazionale, unica vera gloria italiana ripetutamente picconata dai tagli, le cose vanno pure peggio.
Riassumendo a grandi linee questo Comma 22 tutto italiano, abbiamo un paese da cui i giovani scappano, e i loro nonni medici che tonano a lavorare perché non ci sono giovani. E’ un bel paradosso, ma spiega bene che cosa è, e anche cosa non dovrebbe essere, la politica.
Correva l’anno 1999 quando si decise che avremmo avuto troppi medici mentre il paese, sfiancato dalla scolarizzazione di massa, chiedeva a gran voce idraulici e tornitori. Il numero chiuso a Medicina (e non solo) è di quegli anni, avviato nel 1997, ordinato da una legge due anni dopo (ministro dell’Università Ortensio Zecchino, governo D’Alema), e fu anche lui figlio della narrazione dell’epoca, di previsioni sbagliate, dell’orrido ma eterno benpensantismo dei tempi: “Ecco, vogliono fare tutti i dottori!”, con quel sottotesto qualunquista (oggi si direbbe populista) che fingeva di guardare alle sorti del Paese: avremo troppi sapientoni e niente idraulici! Dove andremo a finire, signora mia! Si aggregava la grande stampa con la solita lancia della “meritocrazia”, ovvio. Meritocrazia che consiste a tutt’oggi nel decidere con un test fatto a diciott’anni se uno sarà poi un buon medico a quaranta. Chi lo faceva notare all’epoca, tirando fuori fregnacce novecentesche come il diritto allo studio, veniva sbeffeggiato e tacciato di demagogia, non si diceva ancora “gufo”, ma insomma, come se.
Qui l’intevista di Cristina Aicardi per Milano Nera (cliccare sull’immagine per leggere. Il link è qui)
Prima di tutto… grazie, grazie a quelli che sono venuti alle presentazioni de I tempi nuovi. Qui sotto trovate il calendario della prima parte di aprile, compreso il tour siciliano… prendete nota, dai!
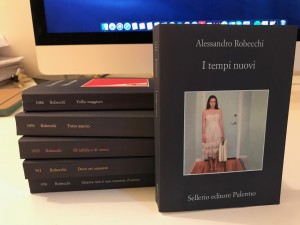 Sabato 30 marzo
Sabato 30 marzo
CORREZZANA (MB) – ORE 17.00
Festival Iter, Sala Consiliare, via De Gasperi 7
Sabato 6 aprile
GARDONE VAL TROMPIA (BS) – ORE 17.00
Oblomov, Festival dei narratori, biblioteca comunale, via XX settembre 31
Lunedì 8 aprile
SESTO SA GIOVANNI – ORE 18.30 –
Libreria Tarantola, piazza martiri di via Fani 1
Sabato 13 aprile
PALERMO – ORE 17.00
Libreria Feltrinelli, via Cavour 133
Domenica 14 aprile
CAPO D’ORLANDO – ORE 20.00
Presentazione e cena con l’autore
Lunedì 15 aprile
MESSINA – ORE 18.00
Libreria Feltrinelli, Via Ghibellina, 32
Martedì 16 aprile
CATANIA – ORE 19.30
Leggo. Presente indicativo al Ma Catania, via Vela 6
Mercoledì 17 aprile
CALTAGIRONE – ORE 18.00
Libreria Dovilio, Piazza Bellini 12
 Lo spettacolo d’arte varia di un ministro dell’Interno che irride e fa il bullo con un ragazzino di tredici anni sembra la plastica rappresentazione dei meccanismi psicologici che spingono tanta gente a votarlo. Forte con i deboli, morbido con i forti, basta con tutta quella faccenda complicata che è l’etica, tutti quei discorsi teorici da professoroni o da buonisti. Qui si fanno i fatti, si menano le mani, si stringe la mascella, si querelano gli scrittori, si bullizzano i ragazzini, non ce n’è per nessuno. E questo piace.
Lo spettacolo d’arte varia di un ministro dell’Interno che irride e fa il bullo con un ragazzino di tredici anni sembra la plastica rappresentazione dei meccanismi psicologici che spingono tanta gente a votarlo. Forte con i deboli, morbido con i forti, basta con tutta quella faccenda complicata che è l’etica, tutti quei discorsi teorici da professoroni o da buonisti. Qui si fanno i fatti, si menano le mani, si stringe la mascella, si querelano gli scrittori, si bullizzano i ragazzini, non ce n’è per nessuno. E questo piace.
A differenza della gran voglia di ometti forti che abbiamo visto in passato (e uomini della provvidenza, e ultime spiagge e “o lui o la morte nera”), Salvini rappresenta un vero condensato delle passioni medie e medio-basse del Paese: l’irrefrenabile ammirazione verso colui che vince la rissa per il parcheggio, che salta la fila, che abbaia solo a chi non può rispondergli a tono. E’ bastato che un ragazzino gli dicesse due parole sensate e l’ometto forte si è subito irrigidito, circondato dalla sua canea di negazionisti quando c’è da negare e allarmisti quando c’è da allarmare.
Anche nel caso di Salvini la teoria italiana dell’ometto forte si conferma in tutta la sua malagrazia: uno che sembra un duro da saloon ma che si gioca la lacrimuccia quando si vota per processarlo, uno che si veste da sceriffo ma parla d’altro quando gli si chiede conto di un colpo da 49 milioni. Uno che combatte le battaglie a presa rapida – la paura, l’invasione, prima gli italiani – lasciando ai soci di governo, povere stelle, le faccende spinose e complicate (e quelli ci cascano con tutte le scarpe, e ci si incasinano mentre lui ghigna). Insomma, perfettamente coerente con quello spirito-guida tra il furbetto e il prepotente che sotto sotto piace tanto. E che dà il segnale del liberi tutti: le pulsioni più banali ed egoiste, la prima cosa che salta in mente, il luogo comune logoro travestito da buonsenso, tutto è permesso, tutto è lecito.
Ora tutti si interrogano su come Salvini si giocherà questa passeggera (si spera) overdose di consenso. Se lo chiedono i suoi cannibalizzati alleati dei 5stelle, che forse cominciano ad accorgersi di avergli spianato troppo il terreno; se lo chiedono a destra mentre si interrogano su dove parcheggiare una volta per tutte il corpo imbalsamato del loro Lenin, Silvio buonanima. Se lo chiedono anche a sinistra, indicando in Salvini il nemico da battere, ma facendolo poco e male, e soprattutto con due fardelli sulle spalle. Uno, il minnitismo che fu il prodromo culturale del salvinismo; l’altro l’insopportabile spirito elitario di una sinistra che, diventata liberale, ha dato lezioncine a tutti col ditino alzato senza sapere più nemmeno lei cosa stava insegnando.
Ora la solfa dice: che farà Salvini in Piemonte? E in Europa? Un asse con la Meloni? Coi sovranisti europei? Si accatastano sul nuovo ometto della provvidenza aspettative di trionfo totale, commettendo l’errore di pensare solo ai meccanismi politici, alle triangolazioni e ai pesi, alle alleanze tattiche. Insomma, ancora una volta (come già avvenne per l’ipnosi collettiva sul Renzi “nuovo” e “rottamatore”) si commette l’errore di vederne solo il lato politico e non il risvolto – diciamo così – antropologico. Non c’è solo il premio di maggioranza dato da di chi corre ad acclamare il vincitore, c’è anche il sollievo di vedere un vincitore senza precisi meriti, o particolari abilità, o qualità sopra le media (bassa) del paese reale. Un’immedesimazione di massa per l’ennesima (con alcune varianti sempre uguale) santificazione del mediocre Una specie di “uno di noi” che ce l’ha fatta, che ha fatto la voce più grossa, che ha vinto nella lite al semaforo, che si trincera dietro il suo potere, che prende in giro un ragazzino, semplicemente perché può farlo.
Qui tre recensioni uscite in questi giorni. Andrea Riscassi sul suo sito, Cristina Aicardi per Milano Nera e Carla Colledan su Veleni e antidoti
Due recensioni in rete, da ottimi siti che si occupano di libri e letture: Libroguerriero (firma Patrizia Debicke) e Telegraph Avenue (firma Angelo Cannamo). Cliccare sulle imagini per leggere. Grazie, grazie
 La velocità con cui è ripartito il trenino della flat-taxè direttamente proporzionale alla velocità con cui si avvicinano le elezioni europee. Dopo le felpe geolocalizzanti e le divise delle forze dell’ordine, Salvini si veste da commercialista (bacioni!) e si rivolge al corpaccione scontento del ceto medio italiano (un bel regalone, amici!).
La velocità con cui è ripartito il trenino della flat-taxè direttamente proporzionale alla velocità con cui si avvicinano le elezioni europee. Dopo le felpe geolocalizzanti e le divise delle forze dell’ordine, Salvini si veste da commercialista (bacioni!) e si rivolge al corpaccione scontento del ceto medio italiano (un bel regalone, amici!).
Si tratta di un dibattito altamente teorico, come dire che faremo un cinema sulla luna, ma parlarne tiene vivo il fuoco, sposta Salvini dal tema immigrazione/sicurezza – dove ha preso tutto quello che poteva prendere – al tema silviesco per eccelleza: meno tasse per tutti, con una certa progressività all’incontrario, cioè si favoriscono i più ricchi. Così come è scritta e ipotizzata nei sogni leghisti (e scritta nel contratto di governo), diciamo la versione harddella flat tax, costerebbe più o meno 60 miliardi, il settanta per cento dei quali (più di 40) andrebbero al venti per cento più ricco della popolazione. Più che un esproprio proletario, un esproprio ai proletari.
Oltre alle questioni costituzionali, di cui, ahimè, parlano in pochi (la progressività della tassazione non sarebbe un dettaglio), ci sarebbe il caro vecchio conto della serva. Con 23 miliardi da cacciare in pochi mesi per evitare l’aumento dell’Iva, altri miliardi (parecchi) per rifinanziare quota 100 e reddito di cittadinanza, l’ipotesi che si tirino fuori altri 60 miliardi è abbastanza peregrina, è come andarsi a comprare una Porsche per festeggiare il rosso in banca.
Naturalmente già si parla di varianti, correzioni, gradualità, equilibri, ridisegni e insomma tutto il campionario delle parole vuote per dire che non sarà così: la Lega e i suoi economisti (Signore perdonami) avanzano nuove proposte. Per esempio una flat tax sotto i 50.000 euro di reddito familiare (che sarebbero più o meno l’ottanta per cento dei contribuenti) e il resto come prima, cioè come adesso. Ma è solo un giro dei tanti giri di valzer che vedremo sul tema: sventolare dei soldi prima delle elezioni (il gioco del portafoglio col filo, che ti scappa via mentre lo raccogli) è una tradizione italiana a cui non rinunceremo mai. E insomma quel che interessa a Salvini, per il momento, è tenere vivo l’argomento in modo da arrivare alle europee non solo vestito da poliziotto, ma anche da Robin Hood dei ceti medi.
Vorrei però porre da subito una questione, come a dirlo prima e mettere le mani avanti. Una domanda. Si scatenerà anche in questo caso la corsa ai furbetti come fu per il reddito di cittadinanza? Cioè: anche davanti a una riforma che premia i redditi medi ci sarà la caccia grossa al truffatore, al millantatore, a chi se ne approfitta? Eppure il motivo ci sarebbe: sapendo che con un reddito di 50.000 euro paghi il 15 per cento, chi te lo fa fare di denunciarne 51.000 e pagare il 38 per cento? A dirla veloce, un sincero e cordiale incoraggiamento a lavorare in nero, o a non dichiarare tutto, almeno quel che ti porterebbe sopra la soglia fissata per la flat tax. Sarà interessante vedere se si riproporrà la grande canea esplosa quando si parlava di dare soldi ai più poveri: il divano! I furbetti! E via strepitando. Una specie di linciaggio della parte meno protetta della popolazione accusata a gran voce di fregare soldi a tutti.
Altro effetto collaterale (ma mica tanto) con la nuova flat tax“versione popolare” ventilata dalla Lega c’è il rischio che due stipendi in casa facciano varcare alla famiglia la fatidica soglia, e quindi, per motivi fiscali, conviene se lavora solo uno, e la moglie sta a casa, lava, stira, cucina e fa i bambini. E insomma ecco là la famiglia come la vogliono la Lega, il ministro Fontana, il convegno di Verona, Pillon e il Ku Klux Klan. E questo è Salvini vestito da commercialista, perché nulla ci verrà risparmiato.
 Come sempre accade nelle grandi battaglie, è interessante quel che succede nelle retrovie, e le retrovie del caso Tav sono le parole, il linguaggio, l’apparato narrativo del grande dibattito nazionale: farla? Non farla? Rimandare finché si sarà finalmente inventato il teletrasporto? La questione è ormai quasi secondaria rispetto all’intrecciarsi delle narrazioni efficientiste. Ringrazio Tomaso Montanari per aver coniato, su questo giornale, il termine “sipuotismo” per dire di quella corrente di pensiero che considera possibile tutto, purché frutti qualche soldo. Lui parlava di spostare un Caravaggio di qualche chilometro – cosa considerata più remunerativa che far spostare di qualche chilometro chi vuole ammirarlo -ma il concetto è applicabile un po’ a tutto, e in primis alle famigerate grandi opere.
Come sempre accade nelle grandi battaglie, è interessante quel che succede nelle retrovie, e le retrovie del caso Tav sono le parole, il linguaggio, l’apparato narrativo del grande dibattito nazionale: farla? Non farla? Rimandare finché si sarà finalmente inventato il teletrasporto? La questione è ormai quasi secondaria rispetto all’intrecciarsi delle narrazioni efficientiste. Ringrazio Tomaso Montanari per aver coniato, su questo giornale, il termine “sipuotismo” per dire di quella corrente di pensiero che considera possibile tutto, purché frutti qualche soldo. Lui parlava di spostare un Caravaggio di qualche chilometro – cosa considerata più remunerativa che far spostare di qualche chilometro chi vuole ammirarlo -ma il concetto è applicabile un po’ a tutto, e in primis alle famigerate grandi opere.
Se si riesce a mettere da parte le scempiaggini di chi si improvvisa ingegnere in tre minuti, magari in camerino prima di entrare in un talk show, o le menzogne dure e pure (tipo far passare il tunnel geognostico per la galleria del treno, un falso abbastanza diffuso), si vedrà che c’è una speciale curvatura negli argomenti dei “sipuotisti” che potremmo sintetizzare così: moderni contro antichi, futuro contro passato, sviluppo contro arretramento. E’ una retorica abbastanza efficace, variamente coniugata a seconda dell’abilità di chi la sostiene, ma insomma, la sintesi è questa. Se non vuoi il Tav la tua visione del mondo è fatta di carretti a cavalli, scarpe di cocomero e clave per cacciare le fiere dalla grotta, mentre invece se la vuoi sei un europeo moderno che compete con il mondo. A questo punto (è una specie di regola) si tirano fuori mirabolanti cantieri cinesi dove il viadotto viene realizzato in nove minuti, o stupefacenti gesta nipponiche, tipo la strada terremotata ricostruita un’ora dopo il terremoto. Mentre qui – è il sottotesto – c’è ancora chi ferma i lavori perché è un nostalgico della peste del Seicento.
Naturalmente si tratta di uno storytelling(chiedo scusa) un po’ zoppicante, ma risponde al bisogno di dividere in due, con semplicità, una faccenda non semplice, e noi-buoni-contro -loro-cattivi funziona sempre.
Naturalmente le opere bloccate non sono solo la Tav (sono più di seicento, e per i motivi più disparati), ma poi gira e rigira, si finisce lì.
La prova che ciò che succede nelle retrovie, cioè il racconto all’opinione pubblica, è importante per i sipuotisti, ce la fornisce un’iniziativa dell’Associazione Costruttori italiani annunciata ieri dal Corriere. Distribuire al popolo (“davanti ai supermercati e alle stazioni della metropolitana”) dei nastri gialli con cui recintare, e dunque segnalare, le opere ferme, “le scuole fatiscenti, le voragini nell’asfalto delle strade cittadine”. Poi si scopre che tra le molte iniziative delle molte associazioni sipuotiste, il Tav è sempre ben presente come esempio di “paese bloccato”, mettendo nello stesso calderone il Tav e tutto il resto, sommando mele e pere.
In sostanza, dopo aver trasformato il gentile pubblico in due frange estreme – quelli che vogliono il bene e il progresso e i maledetti frenatori che non vogliono farci andare a Lione – ecco l’altro passo: identificare il blocco del Tav con il blocco dei lavori in generale. Si propone cioè un’equazione truccata: non vuoi il Tav, quindi sei per bloccare le opere, quindi non vuoi nemmeno riparare la buca sulla provinciale, o il tetto del liceo. Il giochetto è un po’ sporco, ma, come si dice, à la guerre comme à la guerre. La battaglia di chi non ci sta si giocherà anche nel saper ribaltare questa nuova narrazione: dire chiaro e tondo che si è “moderni” e non “antichi” proprio perché si preferiscono opere utili a quelle inutili, e non viceversa, e che “bloccare” non è una categoria filosofica, ma dipende dal bloccare cosa, e quando, e perché.
Ecco qua. Settimana prossima (giovedì 14 marzo) esce il nuovo romanzo, I tempi nuovi. C’è sempre il Monterossi, ovvio, e anche gli altri, il Ghezzi, Carella, tutti. E’ una storia nera che parla di vite in bilico, di vite da cambiare e ricominciare da capo, del flusso dei tempi nuovi che investe tutti, e ognuno li subisce o cavalca a suo modo, ci fa i conti, o la sua piccola Resistenza. E’ un giallo, sì, è anche un giallo, un’indagine, anzi due, come una caccia al tesoro. Un morto con troppi indizi intorno, per cominciare, un marito scomparso… Della trama non si può dire di più, la quarta di copertina la trovate qui.
E’ passato più di un anno da Follia maggiore (qui tutte le recensioni), che mi ha dato molte soddisfazioni, e chi l’ha letto ha capito, ecco, diciamo così. Soprattutto ho incontrato i lettori, ho detto, ho ascoltato, visto librerie, biblioteche e gente che vive coi libri dappertutto. Insomma, bene, ora lo rifaremo. Per I tempi nuovi c’è già un primo calendario per il mese di marzo.
 Leggo in ogni dove consigli, incoraggiamenti, vaticini, messaggi speranzosi, pacche sulle spalle, profondi respiri d’orgoglio ritrovato e gran dispiegamento di suggerimenti su tattiche e strategie per il nuovo segretario del Pd Nicola Zingaretti. Mi associo agli auguri, non gli invidio il titanico compito. Confesso però una difficoltà: a leggere gli incoraggiamenti e i messaggi di stima, non si capisce esattamente come facciano (faranno) ad andare d’accordo tra loro i tanti sostenitori di Zingaretti. Perché tra post, tweet, gruppetti più o meno organizzati, ex missionari del verbo renzista velocemente riconvertiti, sinceri democratici, generici di sinistra che sperano in una svolta e scettici vari, non pare che la base sia granitica. Verrebbe da dire: meglio! In questo modo un grande partito ricomincia a discutere, litiga, si confronta. Però è impressionante vedere quanto lontane siano le anime in coabitazione. Vogliono unità, si legge nei sondaggi e nei carotaggi della pubblica opinione che ha votato alle primarie, ed è una bella cosa, ma poi bisogna vedere unità tra chi, e chi vuole cosa, e come farlo. A quanto pare il contenitore contiene un po’ di tutto, dai Calendiani del Settimo Giorno ai Renziani Redenti, ai nostalgici della Ditta e del prodismo, a molta sinistra dispersa che non sa più dove sbattere la testa. Insultatori seriali da social e pensosi strateghi convivono per ora, in questa piccola luna di miele zingarettiana.
Leggo in ogni dove consigli, incoraggiamenti, vaticini, messaggi speranzosi, pacche sulle spalle, profondi respiri d’orgoglio ritrovato e gran dispiegamento di suggerimenti su tattiche e strategie per il nuovo segretario del Pd Nicola Zingaretti. Mi associo agli auguri, non gli invidio il titanico compito. Confesso però una difficoltà: a leggere gli incoraggiamenti e i messaggi di stima, non si capisce esattamente come facciano (faranno) ad andare d’accordo tra loro i tanti sostenitori di Zingaretti. Perché tra post, tweet, gruppetti più o meno organizzati, ex missionari del verbo renzista velocemente riconvertiti, sinceri democratici, generici di sinistra che sperano in una svolta e scettici vari, non pare che la base sia granitica. Verrebbe da dire: meglio! In questo modo un grande partito ricomincia a discutere, litiga, si confronta. Però è impressionante vedere quanto lontane siano le anime in coabitazione. Vogliono unità, si legge nei sondaggi e nei carotaggi della pubblica opinione che ha votato alle primarie, ed è una bella cosa, ma poi bisogna vedere unità tra chi, e chi vuole cosa, e come farlo. A quanto pare il contenitore contiene un po’ di tutto, dai Calendiani del Settimo Giorno ai Renziani Redenti, ai nostalgici della Ditta e del prodismo, a molta sinistra dispersa che non sa più dove sbattere la testa. Insultatori seriali da social e pensosi strateghi convivono per ora, in questa piccola luna di miele zingarettiana.
Ora che le faccende politiche corrono molto in fretta, che la cronaca supera il pensiero, non sarebbe male, invece, guardare un po’ al di là. Al di là anche delle europee, delle grandi opere, al di là degli scenari contingenti. Chiedersi, come debba stare al mondo una forza di (ritrovata?) sinistra. Il pensiero, insomma, qual è? Si possono tenere insieme blocchi sociali così eterogenei? Si può stare allo stesso tempo con le madamine della collina torinese e con i magazzinieri Amazon che corrono dietro ai loro pacchi senza nemmeno riuscire a fermarsi per pisciare? Mi scuso per l’ampiezza della domanda, cercherò di farla breve: puoi rappresentare allo stesso modo uno che tifa Calenda, che si fa dettare la linea da Il Foglio, o rimpiange Marchionne, e uno che chiede soluzioni sulla sua precarietà, sul suo lavoro pagato male e sulla strenua difesa del poco welfare rimasto?
Chi ha visto la manifestazione di Milano, un fatto politicamente notevole, ha capito che una spinta da sinistra c’è, ed è forte. E nemmeno tanto generica, a sentire discorsi, striscioni e slogan sulla questione immigrazione. Un sussulto antisalviniano evidente e conclamato, bene. La domanda per il nuovo segretario è se sia possibile accogliere quelle energie, ma anche come connetterle alla dottrina Minniti sull’immigrazione, sempre difesa nella campagna per le primarie.
Non si chiedono soluzioni immediate, ovvio, però già la presa di coscienza che non si può tenere insieme tutto e il contrario di tutto sarebbe una bella svolta. Dal punto di vista politico la differenza è già evidente: chi vuole la guerra senza quartiere al governo giallo-verde e chi spera di staccare, alla lunga, il giallo dal verde, rimescolando le carte. Ma più che la strategia politica interessa la prospettiva ideale (se è consentita la parolaccia, ideologica): si vuole risarcire chi in questi anni ha pagato la crisi e colpire finalmente chi l’ha usata per arricchirsi? La sensazione per ora è che sia saltato il tappo renzista che bloccava tutto, e che si possa ricominciare a ragionare. Ecco, bene. Ma ragionare di cosa, quali priorità darsi, sarebbe da decidere in tempi brevi. “Tornare a sinistra” si legge nel sentiment diffuso, bella notizia, ma questo vorrebbe dire cambiare radicalmente le politiche degli ultimi anni. Riuscirà il nostro eroe… eccetera eccetera?
 Qualche settimana fa, in questa rubrichina, ebbi l’ardire di parlare di salari. Lo feci un po’ imbizzarrito, ammetto, dal fatto che alcuni (Confindustria, Boeri e altri) notavano che molti italiani che lavorano prendono più o meno come il reddito di cittadinanza. Pareva dagli accenti, dalle sfumature, e a volte anche da affermazioni dirette, che ciò fosse gravemente lesivo del libero mercato che – prendendo un disoccupato una certa cifra – non avrebbe potuto comprimere ancora di più i salari. Una specie di concorrenza sleale tra disoccupati poveri e lavoratori poveri su cui i “poveri” imprenditori versavano accorate lacrime.Mal me ne incolse, perché venni subito apostrofato da Carlo Calenda che mi chiedeva (a me!) idee su come alzare i salari, che è un ben strano modo di intendersi esperti del ramo, un po’ come se l’elettrauto mi chiedesse col ditino alzato: “Beh? Come si monta questa cazzo di batteria? Me lo dica, non stia lì solo a criticare!”. Non fa una piega. Segnalo comunque che nelle settimane intercorse si sono ascoltati tuttidiscutere su come abbassare il reddito di cittadinanza, e nessuno su come alzare i salari, quindi diciamo così che a pensar male ci si azzecca.
Qualche settimana fa, in questa rubrichina, ebbi l’ardire di parlare di salari. Lo feci un po’ imbizzarrito, ammetto, dal fatto che alcuni (Confindustria, Boeri e altri) notavano che molti italiani che lavorano prendono più o meno come il reddito di cittadinanza. Pareva dagli accenti, dalle sfumature, e a volte anche da affermazioni dirette, che ciò fosse gravemente lesivo del libero mercato che – prendendo un disoccupato una certa cifra – non avrebbe potuto comprimere ancora di più i salari. Una specie di concorrenza sleale tra disoccupati poveri e lavoratori poveri su cui i “poveri” imprenditori versavano accorate lacrime.Mal me ne incolse, perché venni subito apostrofato da Carlo Calenda che mi chiedeva (a me!) idee su come alzare i salari, che è un ben strano modo di intendersi esperti del ramo, un po’ come se l’elettrauto mi chiedesse col ditino alzato: “Beh? Come si monta questa cazzo di batteria? Me lo dica, non stia lì solo a criticare!”. Non fa una piega. Segnalo comunque che nelle settimane intercorse si sono ascoltati tuttidiscutere su come abbassare il reddito di cittadinanza, e nessuno su come alzare i salari, quindi diciamo così che a pensar male ci si azzecca.
Ora che il Pd affronta un congresso per decidere dove andare, non è male che qualcuno, là dentro, rifletta sul tema della rabbia. Un grande partito sa incanalarla, farne strumento di pressione, volgerla verso decisioni meno inique, mentre il Pd, per quello che si è visto e sentito, l’ha guardata crescere come la mucca guarda passare il treno, e in qualche caso fomentata. Dal 2010 al 2017 (governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni) i salari reali sono calati del 4,3 per cento (fonte: Sole 24 ore), un dato che dice tutto, a proposito di incazzatura. Se volete sommare altri numeretti, che sono noiosi ma spiegano l’ampiezza del problema, sappiate che un italiano su tre dichiara meno di 10.000 euro l’anno, cioè una cifra insufficiente a campare degnamente. Si aggiunga la questione del lavoro “sovraistruito”, cioè quel trentacinque per cento di lavoratori diplomati e laureati che hanno un’occupazione non adeguata al titolo di studio. Insomma: ingegneri che consegnano pizze, sì, ne abbiamo.
E del resto, quando si trattava di ingolosire investitori esteri a venire qui (ottobre 2016), il Ministero dello Sviluppo Economico stampò e diffuse delle belle brochure colorate dove si leggeva: “Un ingegnere in Italia guadagna mediamente in un anno 38.500 euro, mentre in altri Paesi lo stesso profilo ha una retribuzione media di 48.500 euro l’anno”. Tradotto: venite qui che costiamo meno, veniamo via con poco, due cipolle e un pomodoro. Un vero e proprio vanto (ancora da quella brochure): “I costi del lavoro in Italia sono ben al di sotto dei competitor come Franciae Germania”. Che culo, eh! Il ministro era – lo dico senza ridere – Carlo Calenda.
Ora, a farla breve, bisogna capire come il salario (che si sognava, a sinistra, variabile indipendente) sia diventato variabile dipendentissima, subordinata e in ginocchio, mentre a diventare variabile indipendente (cioè intoccabile) sono i profitti e le rendite. Capire, sì. E magari anche intervenire sulla vera manovra urgente: riequilibrare la voragine che si è aperta nel reddito dei lavoratori italiani, quelli che hanno pagato la crisi. Quali forze politiche oggi vogliono e possono prendere questo problema e farne il centro della loro azione? Si direbbe nessuna. Eppure, a proposito di popolo e populismo, quella sui salari sarebbe una battaglia assai popolare, a patto di tornare un po’ verso sinistra (il Pd) o di andarci (i 5 stelle). Chissà, forse disegnare intorno al lavoro (dignità, salari, diritti) una qualche politica di medio-lungo termine, invece di stare appesi alle battaglie dello sceriffo Salvini, sarebbe una luce in fondo al tunnel.
 Per il suicidio assistito non hanno nemmeno dovuto andare in Svizzera, lo hanno fatto da casa, cliccando sul salvacondotto per Salvini Matteo, imputato per sequestro di persona. In pratica trentamila italiani, hanno detto alla magistratura in puro stile Antonio Razzi: “Amico mio, fatti li cazzi tua”, una notevole riforma della Costituzione. Nello stesso istante il presunto sequestratore offriva il petto al plotone di esecuzione sapendo che i fucili sono caricati a salve. Riesce così a scappare da un processo e al tempo stesso a mangiarsi i suoi alleati che hanno preso a picconate i loro sacri (?) principi. Gioco, partita, incontro: un caro pensiero al movimento dell’uno-vale-uno che ci saluta da lassù.
Per il suicidio assistito non hanno nemmeno dovuto andare in Svizzera, lo hanno fatto da casa, cliccando sul salvacondotto per Salvini Matteo, imputato per sequestro di persona. In pratica trentamila italiani, hanno detto alla magistratura in puro stile Antonio Razzi: “Amico mio, fatti li cazzi tua”, una notevole riforma della Costituzione. Nello stesso istante il presunto sequestratore offriva il petto al plotone di esecuzione sapendo che i fucili sono caricati a salve. Riesce così a scappare da un processo e al tempo stesso a mangiarsi i suoi alleati che hanno preso a picconate i loro sacri (?) principi. Gioco, partita, incontro: un caro pensiero al movimento dell’uno-vale-uno che ci saluta da lassù.
Nelle stesse ore, quasi negli stessi minuti, finivano ai domiciliari i coniugi Renzi, genitori di cotanto figlio, che subito ci spiega che lui voleva cambiare il Paese e per questo gli arrestano mamma e papà. A leggere i social l’altra sera (hasthag #SiamotuttiMatteoRenzi, risposta #colcazzo) sembrava che avessero arrestato i genitori di Gramsci per cospirazione e non due persone per bancarotta e fatture false. Un divertente ritorno al passato, dove non risuona la formula “giustizia a orologeria” solo perché nessuno vuole pagare la Siae a Silvio.
Ora, lascerò ad esperti e dietrologi le superbe analisi sui due casi incrociati, i complottismi, gli sfottò da tifoserie in lutto e/o visibilio e dirò due parole sulle parole. Sì, le parole, per dirlo.
Eravamo abituati a una neolingua smart e anglofona, dove il furto di diritti si chiamava rotondamente Jobs act e il condono per gli esportatori di valuta Voluntary disclosure. Roba al passo coi tempi, tecnica, da consiglio di amministrazione. Ora l’inglese non va più di moda e tornano i vecchi cari azzeccagarbugli manzoniani, un po’ come se la neolingua tornasse a casa, dall’empireo del global business a materia per avvocaticchi. Un “sequestro di persona” che diventa “ritardo nello sbarco” (nel quesito per firmare online il salvacondotto a Salvini) fa abbastanza ridere, è come dire che un omicidio è “interruzione indotta dell’attività cardiaca”. E siccome la neolingua non riguarda solo le parole nuove, ma anche quelle vecchie che non si devono usare più, ecco che nel referendum sull’immunità a Salvini la parola “immunità” non compare mai, per essere una neolingua suona abbastanza old-paracula.
Un’altra neolingua che viene dritta dal passato ce la regalano i renzisti della rete, quell’esercito di ultras speculare e contrario che scava nella sua memoria vocaboli per dire l’ingiustizia, e trova solo le vecchie parole di Silvio buonanima. Unanime evocazione del pensiero del capo: “Perché proprio oggi?”. “Cercano di fermarlo”. “Lo attaccano sulla vita privata”. Un focherello di grida al complotto (ma la parola “complotto” è vietata in quanto precocemente usurata) avviato da Renzi in persona: “Se io non avessi cercato di cambiare questo paese i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione”. Tradotto in italiano: me la fanno pagare.
Il vertice della neo-vecchia-lingua berlusconiana lo tocca l’onorevole Pd Luciano Nobili che dice: “Prima un vero e proprio colpo di stato per farlo fuori da Palazzo Chigi. Ora, addirittura, vengono arrestati i suoi genitori”. Quindi, a rafforzare l’idea che Matteo Renzi sia vittima di un complotto arriva anche un certo revisionismo storico: fu cacciato da Palazzo Chigi con un “golpe” (cfr. “Berlusconi: golpe contro di me”, novembre 2013 e stessa solfa per anni). Ma siccome il bello della rete è il “tempo reale”, accade che le due neolingue (paraculismo burocratico e vittimismo di matrice arcoriana) si mischino, si intreccino e si sovrappongano. Parole spiegazzate, stirate male, furbizie parallele eppure convergenti: le parole di un potere (di qui e di là) non all’altezza. Nemmeno delle parole.
 Giocate anche voi con il nuovo fenomeno del momento! Un successo superiore a quello del Monopoli! Acquistate subito il nostro straordinario gioco da tavolo Popolo contro élite®, un passatempo che dura da decine di migliaia di anni ora finalmente disponibile per lo svago in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro. Popolo contro élite®, il primo gioco da tavolo in cui i ruoli sono equamente divisi: il popolo lo compra e le élite scrivono le regole. E si può giocare ovunque: all’alba con i figli dopo il turno di notte (popolo) o nelle pause rigeneranti tra un consiglio di amministrazione e l’atro (élite). Ma per i pochi che ancora non conoscessero questo entusiasmante passatempo, ecco qualche spiegazione. Poche righe e poi… giocate tutti a Popolo contro élite®!
Giocate anche voi con il nuovo fenomeno del momento! Un successo superiore a quello del Monopoli! Acquistate subito il nostro straordinario gioco da tavolo Popolo contro élite®, un passatempo che dura da decine di migliaia di anni ora finalmente disponibile per lo svago in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro. Popolo contro élite®, il primo gioco da tavolo in cui i ruoli sono equamente divisi: il popolo lo compra e le élite scrivono le regole. E si può giocare ovunque: all’alba con i figli dopo il turno di notte (popolo) o nelle pause rigeneranti tra un consiglio di amministrazione e l’atro (élite). Ma per i pochi che ancora non conoscessero questo entusiasmante passatempo, ecco qualche spiegazione. Poche righe e poi… giocate tutti a Popolo contro élite®!
Le edizioni. Gioco democratico, Popolo contro élite®è realizzato in diverse versioni. Si va da quella in cartonaccio riciclato dipinto con colori tossici (dieci euro, ma si trova usato) alla Deluxe edition numerata in pelle di cervo, con i segnalini dei giocatori in oro, dadi Swarovski e il tabellone in risotto di Cracco pressato (9.700 euro, ma può arrivare anche a 38.000 se autografata da Calenda).
Scopo del gioco.I giocatori partono con un ruolo ben definito: chi fa il popolo e chi fa le élite. Alla fine, dopo molti turni (una partita può durare anni) vincono le élite, ma speriamo che anche il popolo si sia divertito. Assegnare i ruoli ai giocatori fa parte del gioco. Ognuno si sentirà élite a qualcun altro, fino al paradosso: professori di liceo pagati come minatori dell’Ottocento si sentiranno élite culturale rispetto a chi fa la fila di notte per comprare l’ultimo modello di telefono. E del resto chi fa la fila di notte per comprare l’ultimo modello di telefono si sentirà superiore a chi fa la fila alla Caritas per mangiare qualcosa. E del resto chi fa la fila alla Caritas per mangiare qualcosa si sentirà superiore all’immigrato, e anzi penserà che l’immigrato gli frega l’ultimo panino e vorrà cacciarlo in malo modo. Per chi compra la Deluxe edition, in omaggio un vassoio di brioches da tirare agli avversari.
Regole.Come si sa il popolo è più numeroso delle élite, e questo ha costretto gli sviluppatori a riequilibrare un po’ le regole (si trovano nel libretto allegato, in inglese e latino, proprio per non avvantaggiare troppo il popolo). Le élite, inoltre, hanno una serie di bonus, come buoni avvocati nel caso finiscano nei guai, mentre il popolo può pescare dalla casella “imprevisti” la temutissima carta “Cazzi tuoi”, che può giocare nelle sezioni sanità, welfare, scuola e mondo del lavoro. Essendo a volte il gioco molto lungo, è prevista la possibilità di lasciarlo in eredità, in modo che ci siano giocatori neonati con la Porsche già pre-iscritti ad Harvard e giocatori costretti a vivere coi genitori a causa del basso reddito e del lavoro precario (ma possono sempre ereditare la carta “Cazzi tuoi”). E’ a questo punto che le élite giocano la carta “Meritocrazia”.
Scambio di ruoli.Ciò che rende Popolo contro élite® imprevedibile e divertente è il possibile scambio di ruoli tra giocatori. Per esempio un giocatore élite può fingersi popolo, mandare in giro selfie in cui mangia la polenta, dire “sono come voi, amici, un bacione” e vincere con l’inganno. Più difficile il passaggio inverso (un giocatore popolo che diventa élite), ma può accadere, soprattutto quando un giocatore élite gioca la carta “Ma sì, fingiamoci democratici”. Come nel Monopoli, c’è la carta maledetta che manda in prigione, ma a giudicare dalla popolazione carceraria italiana, le élite non la pescano quasi mai. I giocatori della categoria “élite culturale” possono pescare la carta “Disprezzo” e giocarla ogni volta che un giocatore della categoria popolo gioca la carta “Rabbia”. Pronti? Bene, buon divertimento!
 Uno spettacolo impareggiabile, quello dei poveri che picchiano i poveri, una battaglia deprimente che ognuno può vedere come vuole attraverso le sue lenti: un effetto del darwinismo sociale quotidiano, oppure un’abile strategia per dividere i poveracci tra buoni (quelli che lavorano e sono poveri) e cattivi (quelli che non lavorano e prenderanno il reddito di cittadinanza, restando peraltro poveri).
Uno spettacolo impareggiabile, quello dei poveri che picchiano i poveri, una battaglia deprimente che ognuno può vedere come vuole attraverso le sue lenti: un effetto del darwinismo sociale quotidiano, oppure un’abile strategia per dividere i poveracci tra buoni (quelli che lavorano e sono poveri) e cattivi (quelli che non lavorano e prenderanno il reddito di cittadinanza, restando peraltro poveri).
Il nodo della questione l’hanno sollevato in parecchi (nessun povero) l’altro giorno: se diamo 780 euro ai poveri disoccupati senza casa, chi vorrà andare a lavorare per 800 euro? Lo hanno chiesto in rapida successione il presidente dell’Inps Boeri e Pierangelo Albini di Confindustria (auditi in Commissione Lavoro) e l’immancabile Carlo Calenda (cuoricinato via twitter). Siccome è tradizione tirare in ballo i morti che non possono mandarti a quel paese, Calenda si è addirittura nascosto dietro il grande leader del passato: “Berlinguer sarebbe inorridito davanti a un sussidio superiore a un reddito da lavoro”.
(Qui vorrei aprire una parentesi. Se dovessimo chiederci davanti a quali cose degli ultimi trent’anni sarebbe inorridito Berlinguer, la lista comincia qui e finisce a Pasqua, quindi lasciamo perdere, ma temo che Calenda sarebbe nell’elenco, vabbé, torniamo al punto).
Dunque si accetta e certifica da parte di un aspirante leader del centrosinistra (eh?) che in Italia 700-800 euro siano un “reddito da lavoro”, cioè il denaro che consente a una persona di vivere decentemente la sua vita. Il presidente dell’Inps mette anche le virgole: lo stipendio medio di un under trenta italiano è 830 euro e (avvertenza, dato strabiliante) al Sud il 45 per cento dei lavoratori privati ha redditi inferiori a quello di cittadinanza al suo massimo (cioè guadagnano, lavorando, meno di 780 euro). Questi i dati, più o meno.
Ora, seguendo i ragionamenti di Calenda, potremmo chiederci cosa farebbe più inorridire Berlinguer, se lo scandalo di dare un sostegno ai più poveri o il fatto che in Italia vivano milioni di lavoratori galleggianti sulla soglia dell’indigenza. Magari, che so, Berlinguer si chiederebbe come mai siamo tra i pochissimi paesi a non avere un salario minimo fissato per legge. Oppure si chiederebbe perché i salari italiani sono tra gli ultimi in Europa, perché il potere d’acquisto è sceso, perché si è permesso al mercato di spezzettare, cottimizzare, precarizzare il lavoro, svalutarlo e pagarlo poco. Come mai si può demansionare un dipendente rendendolo ricattabile, per esempio.
Insomma, seguendo il chiacchiericcio di Calenda su twitter e le analisi economiche di Boeri, lo scandalo dovrebbe essere quello dei salari da fame di chi lavora, non quello di darne uno a chi non ce l’ha. Ed ecco la guerra dei poveri, le truppe calendate affollano i social: mia figlia guadagna 720! E ne danno 780 a chi non fa niente! Mio cugino si fa un culo così per 800 e potrebbe stare sul divano a prenderne 780! Un rosario, una giaculatoria, di chi, povero al lavoro, vede aiutare i poveri senza lavoro. E così, con mossa perfetta, la famosa “invidia sociale” (come i liberisti chiamano la lotta di classe) si ferma ai piani bassi, che se la vedano tra loro, quelli del seminterrato, che tanto nell’attico si continua a stappare. Dopotutto è la plastica conseguenza della filosofia corrente dell’accontentarsi sempre e comunque: meglio un lavoro di merda che nessun lavoro, tra niente e piuttosto, meglio piuttosto, eccetera eccetera. Resta, se può servire, il pesante odore del paradosso: per dire che il reddito di cittadinanza è troppo alto si prendono ad esempio i salari, e si scopre (non che non si sapesse) che sono troppo bassi, indecentemente bassi e che è lì, sulla politica dei redditi (avrebbe detto Berlinguer) che si è scaricata gran parte della crisi.
 Sperando di fare cosa grata ai lettori che non possono star dietro a tutto e monitorare minuto per minuto le risse in corso, i testacoda e gli autogol, forniamo un provvisorio quadro della situazione. Insomma, se non avete tempo di andare al cinema, ecco i migliori film nelle sale. Tranquilli, se questa settimana saltate un talk show non ve ne accorgerete nemmeno.
Sperando di fare cosa grata ai lettori che non possono star dietro a tutto e monitorare minuto per minuto le risse in corso, i testacoda e gli autogol, forniamo un provvisorio quadro della situazione. Insomma, se non avete tempo di andare al cinema, ecco i migliori film nelle sale. Tranquilli, se questa settimana saltate un talk show non ve ne accorgerete nemmeno.
Salvini, dramma psicologico – Indietro i soldi! Ma si fa così? Insomma, tu paghi per vedere un bel western con lo sceriffo molto macho, severo ma giusto, e ti ritrovi in pieno in una commedia degli equivoci. Avevamo lasciato il Salvini dentro il saloon che diceva “Mi processino pure!”, con l’aggiunta del solito luogocomunismo delle arance da portargli a San Vittore. E ora eccolo invece mediare dietro le tende, mandare i suoi col cappello in mano di qua e di là, riflettere se questo duello gli conviene, valutare se può raggranellare qualche voto in commissione, magari i 5 stelle o un voto segreto, e far tuonare i fedelissimi che se si processa lui si processano tutti. Insomma, già si comincia male col protagonista che si tira indietro e fa retromarcia “dopo aver riflettuto a lungo sulla vicenda ritengo che l’autorizzazione a procedere vada negata”. E’ come se John Wayne, al momento di uscire in strada con la Colt in pugno, pronto a diventare martire per motivi elettorali, cominciasse a consultare codici e codicilli… “Ehm, ma l’articolo 36 comma 7 e 8…”. Insomma, prima ha fatto il gradasso, poi ci ha riflettuto,
Di Maio, legal thriller – Classico film di avvocati e tribunali. Si narra il conflitto di coscienza di un giudice. Deve far processare il suo amico Salvini? Ha detto di sì, poi ha detto che nella vicenda Diciotti era “graniticamente” d’accordo con lui. Interessante conflitto interiore: far processare il sequestratore dicendo però che eri d’accordo col sequestro. Un tormento interiore che fa del film l’analisi di una profonda introspezione: si vede che la regia ha lavorato sullo spessore psicologico del personaggio, e poi ha lasciato perdere. Alla fine tutto un po’ scontato, ma qualche scena si salva, ottimi i caratteristi.
Madamine, commedia arancione – Pellicola leggera di vago sapore dialettale (siamo a Torino), ricca di colpi di scena davvero sorprendenti. Alcune signore fondano un club, ma si accorgono che una di loro sta per candidarsi alle elezioni usando le gardenie del giardino e il colore arancione della loro pashmine. Un fulmine a ciel sereno che ha turbano le Olimpiadi subalpine di burraco in tutti i salotti della collina torinese. Apriti cielo! Tutte fingono di stupirsi, cioè: chi ha portato in piazza abbracciati nel nome del Tav Pd e Forza Italia, con la Lega a fare il tifo, ora finge di stupirsi. Dialoghi divertenti, sceneggiatura qui e là zoppicante, bella la scena finale con gli idranti di bagna cauda e la rissa a bosettatte di Gucci.
Pd, horror a basso costo – Per gli amanti del genere, lo splatter a vocazione minoritaria, un thriller con venature grottesche. A una settimana dalla votazione nei circoli del Pd ancora non si sa il risultato definitivo e ufficiale, ogni giorno si consultano le previsioni per sapere se Zingaretti è sopra o sotto il 50 per cento, Martina sembra vivo, i renziani convergono su Giachetti, tipo gli zombie che barcollano verso la fattoria dove hanno sentito un rumore umano (si sono sbagliati, era la Ascani). Finale a sorpresa ma mica tanto, gli sceneggiatori promettono il sequel per il 3 marzo (primarie), poi un terzo episodio (congresso). Trama noiosa, alla fine, scarsi anche gli effetti speciali e nelle scene di massa non ci sono mai più di quindici persone. In generale la serie necessita di un volto nuovo, nella speranza di spostarla dall’horror al comico, si tenterà di ingaggiare Calenda, che però sta già girando una fiction tutta sua.
 Ed ecco che anche quest’anno, puntuali come le cambiali, arrivano le classifiche dei ricconi del mondo, le statistiche sulle diseguaglianze che aumentano (rapporto Oxfam), e il teatrino per miliardari di Davos. Tutto insieme, così, per gradire, scandalizzarsi un po’, dedicarci una quota del proprio fondo-indignazione, e poi passare ad altro. In attesa di un nuovo anno, quando avremo la nuova classifica dei ricconi del mondo, il rosario delle diseguaglianze che aumentano, e il privé svizzero dei potentissimi. Altro giro, altra corsa.
Ed ecco che anche quest’anno, puntuali come le cambiali, arrivano le classifiche dei ricconi del mondo, le statistiche sulle diseguaglianze che aumentano (rapporto Oxfam), e il teatrino per miliardari di Davos. Tutto insieme, così, per gradire, scandalizzarsi un po’, dedicarci una quota del proprio fondo-indignazione, e poi passare ad altro. In attesa di un nuovo anno, quando avremo la nuova classifica dei ricconi del mondo, il rosario delle diseguaglianze che aumentano, e il privé svizzero dei potentissimi. Altro giro, altra corsa.
Questo accade da anni, da molti anni, ed è diventato ormai un esercizio di stile mettere in fila le cifre più strabilianti: i 26 ricchi che hanno in mano la stessa ricchezza dei quattro miliardi di persone più povere, oppure il 5 per cento di italiani con patrimonio pari a quello del 90 per cento dei meno abbienti, eccetera, e potremmo continuare.
In effetti, il rosario è impressionante, se il libero mercato è “libera volpe in libero pollaio”, qui nel mercato liberissimo le volpi sono diventate onnivore e grasse da far schifo, mentre intere moltitudini di terrestri sono condannate a morte o a stenti quotidiani, mentre il lavoro viene sempre più precarizzato e svilito, mentre nei paesi ricchi avere un’occupazione non è più nemmeno una garanzia di non essere poveri.
Insomma, a farla breve, ogni anno si lancia l’allarme e ogni anno le cose sembrano peggiorare, ci si scandalizza ma non si attacca la rendita, che fa somigliare il mondo a una specie di paesino medievale con quattro signorotti padroni di tutto che fanno a chi ha il cazzo più lungo, e la plebe che sopravvive a stento. Molta plebe, tra l’altro, imbesuita e accecata dal terrore di scivolare ancora più in basso, difende i signorotti e li ammira, in una specie di masochismo di massa.
Ora il problema è semplice e non riguarda “le politiche” degli anni passati, ma la sola univoca e praticamente unanime politica che si è portata avanti in trent’anni, ovunque nel mondo, dalla cosiddetta destra e dalla cosiddetta sinistra: quella di non disturbare, e anzi agevolare, l’accumulazione vergognosa di fortune immense. A destra lo fanno per ideologia: da Trump che aiuta i grandi patrimoni perché fa parte del club, ai vagheggiatori nostrani di flat tax. A sinistra, almeno dal signor Blair in poi, ha prevalso l’idea furbetta che aiutando i ricchi, quelli ci avrebbero pensato loro a redistribuire, sotto forma di sviluppo e lavoro. Il vecchio concetto un po’ scemo che se il principe ha quindici polli sulla tavola imbandita forse finirà per lanciare una coscia ai quelli che non mangiano da due giorni. Scemenza grossa, come si vede dai numeri che smentiscono ogni anno questa risibile teoria social-paracula. Si aggiunga come aggravante la sudditanza psicologica e culturale di questa sinistra moderna ed ex-rampante per le figurine dei padroni del mondo, con cui ama flirtare, posare in foto e disquisire di sviluppo e progresso, che è un po’ come andare a pranzo con lo zar nel 1916, e lodare gli antipasti.
Controcanto un po’ grottesco: sulle politiche sociali si recita continuamente il mantra del non-ci-sono-i-soldi, proprio mentre si nota – classifiche e indignazione alla mano – che i soldi ci sono, invece, e pure tanti, e ce li hanno quasi tutti quei 26 tizi lì, quelli dell’album delle figurine dei padroni del mondo (più qualche migliaio di loro amici). I quali possono permettersi tali e tante pressioni sulle politiche fiscali da aumentare ogni anno il loro bottino, ed è chiaro come il sole che finché non si va a toccare lì, quell’accumulazione, quell’esagerazione, ogni bel discorso su popolo ed élite somiglia a un altro teatrino, in attesa di altre classifiche, di altra sincera indignazione, ah, che diseguaglianze, signora mia!, ma passiamo ad altro, ci ripenseremo tra un anno.
 Fare l’esegeta del signor Salvini, ministro dell’Interno, è una faccenda complicata. Non sai mai quando cazzeggia e quando fa sul serio, con quale cappello sta parlando, capopopolo, responsabile della security, addictedallo spuntino di mezzanotte. In divisa sembra il poliziotto dei Village People, e questo in attesa che si incazzino un po’ i poliziotti veri, che la divisa la mettono tutti i giorni.
Fare l’esegeta del signor Salvini, ministro dell’Interno, è una faccenda complicata. Non sai mai quando cazzeggia e quando fa sul serio, con quale cappello sta parlando, capopopolo, responsabile della security, addictedallo spuntino di mezzanotte. In divisa sembra il poliziotto dei Village People, e questo in attesa che si incazzino un po’ i poliziotti veri, che la divisa la mettono tutti i giorni.
Eppure il Salvini va decrittato, ed ecco una frase su cui esercitarsi per bene, pronunciata dal signor ministro alla riunione sulla violenza negli stadi: “Sul razzismo è troppo difficile trovare criteri oggettivi”. Cioè, cerchiamo di tradurre. Se mezzo stadio grida buu-uu ogni volta che un nero tocca palla, come fai a dire “oggettivamente” che si tratta di razzismo? Potrebbe essere che prima della partita quello ha rigato la macchina a ventimila persone. Potrebbe essere una cosa personale. Affari di cuore. Questioni di soldi. Insomma, se tu vai allo stadio e ti siedi lì per gridare buu-uu a un nero non è detto che tu lo faccia perché è nero, non ci sono “criteri oggettivi”, Salvini dixit.
Nel malaugurato caso di razzismo sovranista nazionale – caso di scuola, i cori contro Napoli e i napoletani – si tratta secondo Salvini di “campanilismo”. Detto a dieci giorni da una battaglia col morto fuori dallo stadio tra nazisti italiani e francesi e tifosi napoletani, è piuttosto sorprendente. Non vorrei scoprire un domani che il campanilismo può spingersi fino alla strage, al bombardamento, alla guerra batteriologica, ma c’è tempo, aspettiamo con fiducia. Ad oggi, quel che sappiamo per certo è che Salvini, l’uomo della linea dura, sul razzismo “non oggettivo” da stadio è per la linea morbida, troncare, sopire, dopotutto sono ragazzate, campanilismo, che male c’è, eccetera eccetera.
Intanto, fuori dal magico mondo di Salvini, nel disgraziato paese reale, c’è gente che organizza spedizioni con spranghe e bombe carta. Mica tanto ragazzini, poi, perché nelle retate (e negli ospedali) spuntano signori quaranta-cinquantenni, imprenditori, padri di famiglia, buona e brava gente della nazione, e non adolescenti disadattati.
“Cara, hai visto la mia roncola?, sai, volevo andare allo stadio”.
Inutile dire che poi molti di questi gentiluomini così sportivi risultano iscritti a circoletti non proprio hegeliani, che amano le svastiche, che cantano coretti contro gli ebrei, che si fregiano di nomignoli spensierati come Blood & Honour e cosucce consimili, che dovrebbero interessare parecchio un ministro dell’Interno, ma che sono alla fin fine ideologicamente contigui a Salvini e al salvinismo.
E’ sbagliato dire che alla riunione sul razzismo negli stadi non c’erano i capi delle tifoserie più estreme, quelli che “per campanilismo” urlano “Forza Vesuvio”. Era presente, infatti, l’ultrà ad honorem di tutti gli ultrà, Matteo Salvini, già noto per un video in cui canta cori vergognosi contro i napoletani (puzza, colera, disoccupati, il luogocomunismo del nordista ignorante). Lo stesso Salvini, tra l’altro, sorpreso in affettuosi abbracci con un capo ultrà pluricondannato (tal Luca Lucci, condanna definitiva per lesioni, patteggiamento per spaccio). Difficile pensare che gli ultrà delle curve avranno grossi problemi con un ministro così amico, e anche una minima indagine semantica su slogan da stadio e slogan politici del salvinismo, ormai vaporizzato nella società, rivelerebbe grandi somiglianze: per quelli che fanno buu-uu ai giocatori neri avere Salvini al Viminale non è niente male. La famosa riunione sugli stadi italiani con arbitri, associazioni, leghe varie, istituzioni, forze dell’ordine, è stata presieduta da uno che due settimane prima rideva e scherzava insieme a un delinquente della curva a una festa di tifosi, nient’altro da aggiungere, vostro onore.
 Chiedo scusa e perdono se inizio l’anno parlando di una cosa poco glamour, un po’ démodé, fastidiosa da pensare, specie dopo i festeggiamenti di fine anno: i poveri.
Chiedo scusa e perdono se inizio l’anno parlando di una cosa poco glamour, un po’ démodé, fastidiosa da pensare, specie dopo i festeggiamenti di fine anno: i poveri.
Come da manuale, dovrei mettere qui in fila alcune manciate di cifre su quanti sono, quanto sono aumentati negli ultimi anni, origine e provenienza, struttura dei nuclei famigliari, fascia d’età eccetera, eccetera, ma non credo sia il caso. Basta cogliere fior da fiore da tutti gli istituti statistici e di ricerca, istituzionali, pubblici, privati, centri studi, organizzazioni no profit e umanitarie, e tutti i numeri più o meno convergono: un quarto della popolazione europea (123 milioni) è a rischio povertà o esclusione sociale; in Italia vivono in povertà assoluta più di cinque milioni di persone. Ma le parole sono leggere e la situazione è pesante. Per esempio sono molti di più di cinque milioni (per la precisione, secondo l’Istat, 9 milioni) quelli che non riescono a riscaldare decorosamente l’abitazione, cioè c’è molta gente molto povera che non riesce nemmeno ad entrare nelle statistiche dei poveri assoluti, sono poveri relativi, diciamo, si sistemano in un angolino delle classifiche e se ne stanno lì buoni buoni. E aumentano.
Intanto i poveri, poveracci, sono in prima fila loro malgrado nella battaglia della propaganda. Il festante “abbiamo abolito la povertà” di Di Maio ricorda da vicino il trionfale “abbiamo abolito il precariato” di Renzi, roba buona per il titolo del giorno dopo e tutti i sarcasmi degli anni a venire.
Interessante, però, come una strana figura di “povero” abbia invaso il dibattito pubblico, il chiacchiericcio da talk show, la teoria economica. Una situazione di disagio reale e diffuso è stata trasformata in macchietta, in grottesca caricatura da commedia all’italiana. Nel dibattito politico sul reddito di cittadinanza (a prescindere da cosa ne verrà fuori realmente), il principale problema è incrociare la parola “povero” con trucchetti di sopravvivenza alla Totò. Ci saranno i “furbi”, quelli che truccano l’Isee, quelli che aspettano la manna dallo Stato per girarsi i pollici o lavorare in nero, eccetera eccetera. Se un marziano sbarcasse qui senza sapere nulla e assistesse basito a un paio di talk show penserebbe che “povero” significa “creatura improduttiva e pigra del Sud che sta su un divano”. Divano è la parola che ricorre di più, una specie di immagine ormai proverbiale: il povero sta sul divano e aspetta assistenza.
Se guardate attraverso questa filigrana potete vedere molte cose. I grandi luogocomunismi della storia economica nazionale, per esempio. I terroni che non hanno voglia di lavorare e che ci invadono (detto mentre l’emigrazione interna faceva fiorire le fortune dei grandi industriali). Il mantenuto. Il sussidio. L’assistenzialismo, e insomma, signora mia, li paghiamo per non farli lavorare, seduti sul loro divano (ci mancherebbe).
Siamo sempre lì, insomma, alla colpevolizzazione del povero, che un po’ “non ha voglia”, un po’ “è colpa sua” (traduco: non si è sbattuto abbastanza) e un po’ fa il furbo per grattare qualche euro qui e là.
Ecco fatto: è bastato qualche mese di (sconclusionato) dibattito per risolvere in qualche modo il problema dei poveri, trasformati dai ricchi che ne parlano in pubblico in meri possessori di divani e potenziali truffatori.
Si perpetua così l’atavica diffidenza borghese per la povertà, e soprattutto si impedisce una seria riflessione sull’intero sistema economico. Se negli ultimi decenni i poveri sono aumentati come dicono tutti, e la loro distanza dai ricchi è diventata siderale, significa che il sistema non regge e non funziona, ma è un discorso che pare rischioso affrontare. Dunque, meglio continuare con la narrazione del finto povero che se ne approfitta: non costa niente e nasconde i poveri veri.
 Come sarà il 2019? Per prevedere i principali avvenimenti dell’anno nuovo ci siamo avvalsi di studi scientifici e ricerche avanzatissime, ma soprattutto ci siamo affidati alle interiora di pollo e ai fondi di caffè, tutte cose, queste ultime, reperite nei tweet di Salvini. Ecco quel che possiamo anticipare dell’anno che arriva senza spoilerare troppo per gli abbonati Sky, Netflix, Amazon, Tim Vision, Spotify, e pago pure il canone Rai.
Come sarà il 2019? Per prevedere i principali avvenimenti dell’anno nuovo ci siamo avvalsi di studi scientifici e ricerche avanzatissime, ma soprattutto ci siamo affidati alle interiora di pollo e ai fondi di caffè, tutte cose, queste ultime, reperite nei tweet di Salvini. Ecco quel che possiamo anticipare dell’anno che arriva senza spoilerare troppo per gli abbonati Sky, Netflix, Amazon, Tim Vision, Spotify, e pago pure il canone Rai.
Politica.L’abolizione della povertà rende gli italiani più garruli e spensierati, cominciano a vedersi i primi frutti delle riforme, per esempio apre la prima mensa della Caritas per gente che prima della legge di bilancio lavorava alla Caritas. Arriva (aprile) il reddito di cittadinanza, due cipolle, un pomodoro e un porro bio in confezione monouso.
L’anno si divide in due parti: prima delle elezioni europee (quando tutti si chiedono se dopo Salvini vorrà fare le elezioni politiche), e dopo le elezioni europee (quando Salvini vorrà fare le elezioni politiche).
C’è anche il congresso del Pd (marzo), evento un po’ oscurato dalla spedizione del duo Renzi-Calenda, che andando “oltre il Pd” si perderanno come Stanlio e Ollio ne “I figli del deserto”. Il dibattito nel movimento Cinque stelle sarà serrato e affronterà due temi: “Perché è tornato Di Battista?” e “Quando riparte Di Battista?”, ma non mancheranno l’elaborazione teorica e la visione strategica: Beppe Grillo annuncerà in un post (settembre) che entro il 2176 su Saturno si potrà produrre l’auto alimentata a urina. Berlusconi non pervenuto. Meloni, Bonino, Grasso agitati con occasionali precipitazioni, poco mossi gli altri mari.
Economia.A gonfie vele il turismo, alcune città d’arte istituiscono il numero chiuso, a Firenze (luglio) si potrà entrare solo esibendo una fidejussione di 40.000 dollari da spendersi in un week end. Il Comune userà i fondi per allontanare dal centro gli insolventi. Grave emergenza per il mercato dell’auto: secondo uno studio di Confindustria (ottobre), se tutti quelli che hanno comprato un’auto diesel di recente capiscono la cazzata e si suicidano, non potranno comprare un’auto ibrida. Si studiano incentivi. E lo spread? Benino, dai, ma deve stare attento agli zuccheri e bere meno.
Esteri.Pugno duro di Trump (febbraio), che affoga tre gattini nella fontana della Casa Bianca durante una conferenza stampa, ma il mondo è più tranquillo sapendo che Putin può colpirlo in ogni istante con un missile nucleare impossibile da fermare. La Cina annuncia (maggio) che si potrà riprodurre l’essere umano in laboratorio, ma rivela (giugno) che è uno stronzo come l’originale.
Ottobre, due speleologi belgi ritrovano la popolarità di Macron in una grotta 2.600 metri sotto l’Eliseo. In Libia le cose vanno un po’ meglio e comanda ……… (il lettore concluda la frase a seconda del mese).
Cronaca.La legge sulla legittima difesa rende tutti più sicuri, diminuiscono i femminicidi, ma aumentano i tragici incidenti: “Ho sparato pensando che fosse un ladro rumeno con la vestaglia di mia moglie”. Assolto. Un’inquietante statistica basata su tremila casi rivela (marzo) che i soffitti delle scuole crollano prevalentemente durante le ore di matematica e questo spiegherebbe il gap scientifico dell’Italia rispetto alla media europea. Sanguinosa strage di mafia a Cosenza (dicembre), il ministro dell’Interno annuncia la ferma reazione dello Stato fotografandosi con due cotechini fumanti nelle orecchie.
Costume e società.Fabrizio Corona tampona con la Bentley un pullmino di suore (marzo), si fidanza con la madre superiora (aprile), si lasciano (maggio), lei denuncia la scomparsa di una pala del Trecento (giugno), lui si difende in tivù: “Non faccio lavori manuali, figuratevi se rubo una pala!”). Elsa Fornero festeggia la sua milionesima ora in diretta tivù (settembre).
Cultura.Continua la riflessione su arte e linguaggio politicamente corretto: in America si vietano nei film (febbraio) le droghe, gli alcolici e la carne rossa. Si rinviene nei sotterranei del Vaticano (aprile) un gruppo marmoreo raffigurante Proserpina che testimonia contro Plutone per lesioni e sequestro di persona, l’attribuzione al Bernini è un po’ dubbia, dopo le analisi del materiale (pongo). Ottobre, buone notizie dall’editoria: un italiano su tre ha letto durante l’anno almeno un libro in lingua straniera con traduzione a fronte, ma erano le istruzioni del microonde. Annunciati (dicembre) nuovi finanziamenti per la ricerca e l’università: 27 euro e 40 centesimi da devolvere in due tranches a inizio 2020.
 La Tre cose ci preoccupano per il futuro: il riscaldamento globale, le tensioni con l’Europa, e il Salvini in versione natalizia. Mi perdonerete se mi concentrerò sulla più grave di queste crisi mettendo in guardia il consumatore di social media, il cittadino italiano, i capiredattori di turno durante le feste.
La Tre cose ci preoccupano per il futuro: il riscaldamento globale, le tensioni con l’Europa, e il Salvini in versione natalizia. Mi perdonerete se mi concentrerò sulla più grave di queste crisi mettendo in guardia il consumatore di social media, il cittadino italiano, i capiredattori di turno durante le feste.
Dunque avremo Salvini col panettone, Salvini col pandoro, Salvini che chiede “Mangiato troppo?, anch’io amici, bacioni!”. Non mancherà un nutrito capitolo Salvini e la famiglia(e), i bambini, i regali, l’aria di svagata eccezionalità e di lucine intermittenti. Essendo ormai la retorica presepista appaltata alla sora Meloni, si suppone che la comunicazione salviniana si orienterà più sul versante gastronomia&serenità, con opportune sviolinate ai “prodotti italiani”. Dovrà probabilmente consumare dolci secondo un suo speciale manuale Cencelli basato sui flussi di consenso (Nord per origine, ma anche al Sud si mangia benino, ma poi che buona la cucina del Centro Italia…), con il che è chiaro che tifiamo glicemia.
Non scoraggiatevi. Nell’ora più intima delle feste avremo forse un Salvini stivalato accanto a una volante di pattuglia: “Anche a Natale con chi lavora per la nostra sicurezza, amici! Faccio bene?”. Gli agenti infreddoliti avranno la faccia di chi pensa: porca puttana, già il turno rognoso a Natale, e in più questo qui, che palle! Poi Salvini se ne andrà col suo codazzo di famigli, fotografi e guru della comunicazione, ma questo non lo vedremo. Ci verrà forse risparmiato un Salvini Babbo Natale che consegna taser giocattoli ai figli dei vigili, ma non è detto che ci andrà così bene. Insomma, prepariamoci alle feste con questa spada di Damocle del Salvini che spiega a tutti che lui è come loro – come noi – che fa cose normali, che ambisce a una tranquilla vita di torroncini e piccole emozioni sotto controllo.
L’estate era stata un buon banco di prova, sempre mezzo nudo e sempre a tavola, ma al tempo stesso vigile e virile per quanto glielo concede il fisico pinguinesco. Da molti stupidamente considerato innovativo, il messaggio è sempre quello, l’antico simbolismo della canottiera di Bossi, riveduto e corretto: dove là c’era burbera e ruspante fierezza popolare della Lega ante-Trota, qui c’è l’epifania della medietà, un plasmarsi sulla statistica e sulla retorica dell’italiano medio, compreso lo sfruttamento pop degli affari di cuore, le feste comandate, lo spuntino di mezzanotte.
Si ride e si scherza, d’accordo, ma c’è un problemino serio, perché la stragrandissima maggior parte dell’iconografia su Salvini è prodotta e diffusa dallo stesso Salvini e poi ripresa dai media che la rilanciano: una specie di dépliant, un prospettino promozionale. In televisione: una marchetta. Quando le foto non sono selfie o non vengono dal costoso entourage (che paghiamo tutti), infatti, Salvini non sembra tanto “uno di noi”, come dice la sua narrazione.
L’italiano medio che Salvini vorrebbe vellicare con il suo sono-come-te non familiarizza con spacciatori condannati, per esempio, cosa che non dovrebbe fare un ministro dell’Interno, ma nemmeno un cittadino perbene. Insomma, il Salvini pubblico sempre accanto alle forze dell’ordine non può fare pappa e ciccia con delinquenti che le forze dell’ordine hanno attenzionato, seguito, intercettato e incastrato fino a sentenza (patteggiamento avvenuto). E’ una cosa che potrebbe ingenerare il sospetto che esistano due Salvini, uno formato social denso di cretinate e albertosordismi, e uno con frequentazioni poco consone al suo ruolo. Proprio per questo – perché urge riparare – ci si aspetta una recrudescenza del Salvini formato famiglia. E dunque questo è un piccolo avviso: pensateci, quando lo vedrete brandire il calice di prosecco: è solo la recita di Natale, e ci casca solo che ci vuole cascare.
 Dovendo fidarmi di qualcuno, poniamo tra Matteo Salvini, Vittorio Feltri e Anton Cechov sceglierei senza dubbio il grande scrittore russo: “Se c’è un fucile nel primo capitolo, prima o poi sparerà”. È una specie di regola, purtroppo confermata dall’esperienza umana: basta guardare le cifre americane dei morti per arma da fuoco per capire che ci sono troppi fucili nel primo capitolo, e che negli altri capitoli si raccoglieranno i cadaveri. Ma si sa, gli Stati Uniti esistono là come tragedia e qui come farsa: lo spray al peperoncino che ha scatenato l’inferno nella discoteca di Corinaldo è solo una caricatura delle armi da fuoco in tasca a tutti, ma come si è visto è in grado di provocare spaventose tragedie.
Dovendo fidarmi di qualcuno, poniamo tra Matteo Salvini, Vittorio Feltri e Anton Cechov sceglierei senza dubbio il grande scrittore russo: “Se c’è un fucile nel primo capitolo, prima o poi sparerà”. È una specie di regola, purtroppo confermata dall’esperienza umana: basta guardare le cifre americane dei morti per arma da fuoco per capire che ci sono troppi fucili nel primo capitolo, e che negli altri capitoli si raccoglieranno i cadaveri. Ma si sa, gli Stati Uniti esistono là come tragedia e qui come farsa: lo spray al peperoncino che ha scatenato l’inferno nella discoteca di Corinaldo è solo una caricatura delle armi da fuoco in tasca a tutti, ma come si è visto è in grado di provocare spaventose tragedie.
I più ridicoli tifosi delle armi libere e della difesa fai-da-te suonano la solita solfa: non sono le armi che uccidono, sono gli uomini che le usano. Bello. Vale anche per la bomba atomica: non è cattiva lei, poverina, ma lo stronzo che schiaccia il bottone. È la stessa cosa, papale papale, che ha detto Matteo Salvini, che nei ritagli di tempo tra l’attivismo in politica economica e la militanza nel Ku Klux Klan sarebbe addirittura ministro dell’Interno: “Se qualcuno abusa del mattarello o delle forbici non posso vietare i mattarelli o le forbici”. Ecco fatto. Assolta l’arma, non resta che insultare tutti gli altri: se c’è la strage è colpa dei ragazzi, anzi dei genitori che ce li mandano, anzi dell’ora tarda, anzi del cantante cattivo, anzi dei suoi testi, anzi… La pioggia dei luoghi comuni si fa diluvio, con lampi, fulmini e qualche tuono che rimbomba: “Noi da giovani eravamo meglio dei giovani di adesso”, dicono gli anziani, in un tripudio di vecchi tromboni.
E così a Corinaldo, come sempre succede, è andata in onda la colpevolizzazione delle vittime, in perfetta continuità con quello che si sente dire spesso nei casi di violenza sessuale: se la sono cercata. Vittorio Feltri, il patron del giornale che ha venduto in allegato pistole al peperoncino, usa la stessa logica, potrebbe allegare un bazooka e non ci sarebbe niente di male: basta non abusarne. Il ministro dell’Interno di cui sopra, peraltro, distribuiva spray al peperoncino nei suoi banchetti e quindi non stupisce la linea, rafforzata anche dal fatto che chi spara gli piace tanto, vedi legge sulla legittima difesa.
Intanto, dopo la tragedia di Corinaldo, emergono dettagli su dettagli da tutto il regno: si spara il peperoncino nelle discoteche per rubare portafogli e cellulari, si spara nelle scuole per vedere l’effetto che fa (in settimana già due o tre casi), ai concerti la cosa era già successa decine di volte. Insomma, tolto il tappo al vaso di Pandora viene fuori che lo spray al peperoncino è un’arma di difesa, ma che se volete derubare o tramortire qualcuno per la strada o in discoteca è un ottimo metodo: dopotutto non esiste arma di difesa che non sia anche arma d’attacco. E, per la cronaca, è vietato o venduto con grandi restrizioni nella maggior parte dei Paesi europei.
Ciò che si cerca di replicare, insomma, è la tradizione americana dell’essere tutti cowboy, una specie di privatizzazione della difesa: ognuno con i suoi mezzi, e di questo passo il problema non è “se”, ma “quando” avremo una Columbine italiana, a cui dovremo un giorno chiedere conto ai Salvini, ai Feltri e a tutti gli altri piccoli armigeri del Paese che soffiano sulla questione sicurezza. Diffondere massicciamente un’arma tra la popolazione, benedirla, esaltarla, venderla insieme a un giornale, farne programma politico, anche da persone che hanno ruoli istituzionali, è un calcolo cinico, un esplicito e interessato disegno di imbarbarimento che pagherà in termini di consenso. Poi, all’apparir del vero e al compiersi del disastro, si darà la colpa al cantante e più in generale ai “giovani”. Facile, no?
 Prima di tutto una precisazione. I tremila imprenditori che l’altro giorno a Torino si sono riuniti per dire sì alla Tav e a tutto il resto (grandi opere, medie opere, tagli alla manovra) non sono, come si è scritto con toni eccitati e frementi “Il partito del Pil”. Non rappresentano, come si legge in titoli e sommari “due terzi del Pil italiano e l’80 per cento dell’export”. Il Pil italiano, e anche l’export, lo fanno milioni di lavoratori che in quelle imprese sono occupati. Gente che da anni vede assottigliarsi il suo potere d’acquisto, mentre aumentano profitti e rendite, che assiste all’erosione dei suoi propri diritti, che va a lavorare su treni affollati come gironi infernali, che sta in bilico sul baratro della proletarizzazione, che teme ogni giorno un disastro, una delocalizzazione, una vendita ai capitali stranieri, una riduzione degli organici, che combatte ogni giorno con servizi sempre più costosi, che fa la parte sfortunata della forbice che si allarga – da decenni – tra redditi da lavoro e profitti. Il Pil italiano – come il Pil di tutti i paesi del mondo – lo fanno loro, ed è piuttosto incredibile che una platea di tremila persone venga più o meno, con pochissime sfumature, identificata con l’economia italiana senza nemmeno una citazione di sfuggita, un inciso, una parentesi, che ricordi i lavoratori.
Prima di tutto una precisazione. I tremila imprenditori che l’altro giorno a Torino si sono riuniti per dire sì alla Tav e a tutto il resto (grandi opere, medie opere, tagli alla manovra) non sono, come si è scritto con toni eccitati e frementi “Il partito del Pil”. Non rappresentano, come si legge in titoli e sommari “due terzi del Pil italiano e l’80 per cento dell’export”. Il Pil italiano, e anche l’export, lo fanno milioni di lavoratori che in quelle imprese sono occupati. Gente che da anni vede assottigliarsi il suo potere d’acquisto, mentre aumentano profitti e rendite, che assiste all’erosione dei suoi propri diritti, che va a lavorare su treni affollati come gironi infernali, che sta in bilico sul baratro della proletarizzazione, che teme ogni giorno un disastro, una delocalizzazione, una vendita ai capitali stranieri, una riduzione degli organici, che combatte ogni giorno con servizi sempre più costosi, che fa la parte sfortunata della forbice che si allarga – da decenni – tra redditi da lavoro e profitti. Il Pil italiano – come il Pil di tutti i paesi del mondo – lo fanno loro, ed è piuttosto incredibile che una platea di tremila persone venga più o meno, con pochissime sfumature, identificata con l’economia italiana senza nemmeno una citazione di sfuggita, un inciso, una parentesi, che ricordi i lavoratori.
A vederla dal lato politico, si direbbe che l’imprenditoria italiana cerchi rappresentanza e punti di riferimento. Come ha detto Maurizio Casasco (piccoli imprenditori), “Abbiamo bisogno di leader, non di segretari di partito”, ma già i primi commenti fanno notare che presto lo troveranno, e sarà ancora Salvini, l’uomo che sa dire sì e che già si era beccato un paio di mesi fa gli elogi sperticati del presidente di Confindustria Boccia.
Così la palla ripassa alla politica, ai 5stelle impantanati e al loro cannibale Salvini cui cedono su tutto (compresa la guerra ai poveri conclamata nel decreto sicurezza). Doppio risultato: si piange un po’, che è caratteristica statutaria degli imprenditori italiani, e si tira il pallone in tribuna, impedendo ancora una volta una riflessione proprio su di loro. Sicuri che quei tremila (80 per cento dell’export, due terzi del Pil) non abbiano colpe in tutto questo? Che non abbia funzionato niente, negli ultimi trent’anni, politica, economia, finanza, Stato, amministrazione, tranne loro, sempre perfetti e “motore dello sviluppo”? E’ un po’ incredibile, andiamo! Eppure negli anni di Silvio gli imprenditori italiani hanno avuto di tutto e di più, e negli anni del centrosinistra meglio ancora, dalla pioggia di miliardi del Jobs act al coltello dalla parte del manico nelle relazioni sindacali, come la possibilità di demansionare i dipendenti, per non dire dell’articolo 18.
Da almeno trent’anni, con piccole frenate e forti accelerazioni, la filosofia al governo sostiene la tesi che aiutando le imprese si aiutino anche i lavoratori, che se stanno bene gli imprenditori staremo bene tutti, che se la tavola è sontuosa, qualche briciola cadrà dal tavolo per i poveri. Questo, in trent’anni di sperimentazione, non si è verificato, anzi è successo il contrario, la precarizzazione è avanzata, fino al cottimo, fino all’algoritmo che gestisce i tempi di vita delle persone.
Gli imprenditori italiani, in definitiva, non strillano solo per la Tav, ma perché non hanno ancora una sponda sicura nel governo del paese. Nessuno che dica “meglio Marchionne dei sindacati”, per intenderci. E’ legittimo lo sconcerto e anche l’accorato appello, che confina col piagnisteo, che confina con le minacce, va bene, si chiama pressione politica. Ma partito del Pil no. Il partito del Pil, qui, sono milioni di italiani (e stranieri) che lavorano, e anche loro a caccia di qualcuno che li rappresenti in un Paese senza sinistra.
 Troppo osé. Scollacciata. Ma guarda che roba, signora mia. Bell’esempio per i nostri giovani! Dove andremo a finire? Pare si siano detti questo (e forse anche altro) i professori di qualche classe di scuola media di Ascoli Piceno. Dovevano andare a vedere il Così fan tuttedi Mozart con gli alunni, ma poi ha prevalso il buonsenso: no, no, troppo sesso, questa cosa di mettere alla prova la fedeltà delle fidanzate, anche solo per ridere, non va bene, potrebbe turbare i ragazzi. I quali ragazzi, chissà, saranno forse rimasti delusi (uh, niente opera, due ore di matematica, dannazione!), oppure sollevati (Uh, meno male! A teatro bisogna spegnere i telefonini e non si può nemmeno chattare un po’).
Troppo osé. Scollacciata. Ma guarda che roba, signora mia. Bell’esempio per i nostri giovani! Dove andremo a finire? Pare si siano detti questo (e forse anche altro) i professori di qualche classe di scuola media di Ascoli Piceno. Dovevano andare a vedere il Così fan tuttedi Mozart con gli alunni, ma poi ha prevalso il buonsenso: no, no, troppo sesso, questa cosa di mettere alla prova la fedeltà delle fidanzate, anche solo per ridere, non va bene, potrebbe turbare i ragazzi. I quali ragazzi, chissà, saranno forse rimasti delusi (uh, niente opera, due ore di matematica, dannazione!), oppure sollevati (Uh, meno male! A teatro bisogna spegnere i telefonini e non si può nemmeno chattare un po’).
Insomma, voi sapete che ci sono, acquattati e nascosti nelle pagine dei giornali, alcuni segnali della fine del mondo, e uno è questo: negare a un manipolo di quindicenni una delle cose più belle mai scritte nella storia del mondo perché “Troppo osé” (questo riportano i titoli, testuale), faccenda di corna e di intrighi amorosi. Sai che trauma per i nostri ragazzi, che magari sanno tutto della poetica Fedez/Ferragni, oppure delle palpitazioni di tronisti e troniste in tivù, per non dire delle più fantasiose categorie di Youporn. Peccato, perché la mirabile servetta Despina avrebbe potuto spiegare per bene le cose: “Una donna a quindici anni / dée saper ogni gran moda / Dove il diavolo ha la coda…”.
Ecco, meglio non saperlo. Quei due zozzoni di Mozart e Da Ponte stiano a casa loro. E anche Giuseppe Verdi non dorma troppo tranquillo, perché il sindaco di Cenate Sotto, tal Giosuè Berbenni, intima alla Scala di cambiare l’allestimento dell’Attilain programma (regista Davide Livermore, direttore Ricardo Chaily): c’è una scena che si svolge in un bordello, un’attrice che fa cadere la statua della Madonna, e questo è troppo, a Cenate Sotto non reggono il colpo..
Non è dato sapere se i prof con facoltà di sorveglianza morale che hanno negato Mozart ai loro studenti o il sindaco che prega di cambiare sceneggiatura a Verdi siano poi anche quelli che deplorano la decadenza culturale dei nostri tempi, l’ordinaria pornografia sentimentale della tivù del dolore o la faciloneria dei social, resta il fatto che Mozart no, non va bene, e rileggere Verdi nemmeno. Aspettiamo con ansia che si ritraggano inorriditi davanti alla Certosa di Parma, insomma, la zia innamorata del nipote, che tenta pure di farlo scappare di galera mentre quello, scemo, si innamora di un’altra signorina. Possibile invece che vada benissimo l’Otello: il nero che strangola la donna bianca è perfetto per i tempi che corrono, pare di vedere il tweet di Salvini: “Basta con questi negri che uccidono le nostre donne! Otello deve andare in galera nel suo paese! Ho ragione, amici? Bacioni!”. Va bene, cascano le braccia, siamo a un passo dal trattare da zoccola Anna Karenina, per non dire di quella signora Bovary, così annoiata dal noiosissimo marito, che cercava di spassarsela come aveva letto nei romanzi romantici (una buona ragione per vietarli, finalmente!).
Intanto, fuori dal teatro, lontano da Fiordiligi e Dorabella e dalle sconcezze mozartiane, i nostri ragazzi, così abilmente protetti dal comune senso del pudore (fosse anche quello di fine Settecento), possono continuare a bersi le millemila fidanzate di Corona, il gossip di palazzo tra Matteo ed Elisa, e tutta la sistematica fucilazione del pudore che ci regala la tivù mattina, pomeriggio e sera, oltre ai selfie autocelebrativi coi vivi e coi morti. Tutto scritto, suonato, cantato e recitato in pubblico, costantemente, ventiquattr’ore su ventiquattro, urlato a gran voce e presentato come commedia del costume contemporaneo. Mozart no, troppo osé, giocoso e scabroso, e poi, cazzo, bisognerebbe capirlo e farlo capire ai ragazzi, che fatica, eh!
 Incredibile quanto ci piacciono le rivolte quando le fanno gli altri, una passione, proprio. Leggendo le cronache dalla Francia, anche quelle più “legge & ordine”, traspare una sorta di invidia non detta, di ammirazione sottaciuta, come un’inconfessabile stima per una mobilitazione così spontanea e tenace. Non tanto per gli obiettivi della protesta dei gilets jaunes(che restano molto francesi e assai trasversali), quanto per la loro tenacia. Ci piace insomma il pensiero dei francesi che si incazzano, come da canzone del Maestro, ma ogni volta quel che si ammira è che lo fanno seriamente. Già capitò ai tempi del grande sciopero dei mezzi pubblici, quando si magnificò la solidarietà dei parigini, pur azzoppati nel loro spostarsi, con i lavoratori in lotta. Non scioperanti e utenti divisi, ma cittadini uniti, si disse, cronache che scaldavano il cuore, mentre se succede qui, anche un minimo sciopero dei treni, ecco le grida di allarme sull’Italia “paralizzata” e la prepotenza sindacale.
Incredibile quanto ci piacciono le rivolte quando le fanno gli altri, una passione, proprio. Leggendo le cronache dalla Francia, anche quelle più “legge & ordine”, traspare una sorta di invidia non detta, di ammirazione sottaciuta, come un’inconfessabile stima per una mobilitazione così spontanea e tenace. Non tanto per gli obiettivi della protesta dei gilets jaunes(che restano molto francesi e assai trasversali), quanto per la loro tenacia. Ci piace insomma il pensiero dei francesi che si incazzano, come da canzone del Maestro, ma ogni volta quel che si ammira è che lo fanno seriamente. Già capitò ai tempi del grande sciopero dei mezzi pubblici, quando si magnificò la solidarietà dei parigini, pur azzoppati nel loro spostarsi, con i lavoratori in lotta. Non scioperanti e utenti divisi, ma cittadini uniti, si disse, cronache che scaldavano il cuore, mentre se succede qui, anche un minimo sciopero dei treni, ecco le grida di allarme sull’Italia “paralizzata” e la prepotenza sindacale.
Insomma, ci piacciono molto la protesta, la rivolta e persino la sommossa (specie se ceto medio-oriented), a patto che non succeda qui, e se un qualsiasi movimento di protesta si azzardasse qui da noi ad occupare strade e autostrade o depositi di carburante, si griderebbe – destra, sinistra, sopra, sotto – all’eversione (non a caso il decreto sicurezza contiene gravi inasprimenti di pene per blocco stradale, per esempio).
E’ un bizzarro strabismo politico-culturale, tutto italiano, molto ipocrita, che abbraccia il pianeta. La marcia dei migranti dall’Honduras agli Stati Uniti è un altro caso di scuola. Una migrazione in piena regola, che riscuote ammirazione e pressoché unanimi consensi, almeno a sinistra. E’ una cosa biblica, contiene molto Garcia Màrquez, migliaia di persone che vanno a piedi, coi trolley e le valigie, i bambini e i nonni fino a Tijuana, e lì cominciano a bussare al muro per avere una vita migliore. Muy sentimiento, eh! Se invece succede qui la musica cambia un po’, niente più flauti andini e canzoni di protesta, cominciano i cori del non-possiamo-accoglierli-tutti, gli aiutiamoli-a-casa-loro (cfr: Salvini), e aiutiamoli-davvero-a-casa-loro (cfr: Renzi). Insomma, gli opposti minnitismi, e magari, come già si fece, accuse di “estremismo umanitario” a chi crede nell’accoglienza e magari la pratica. Ci piacciono i migranti degli altri, insomma, pieni di rimandi letterari, soddisfano un nostro bisogno di etica e ci ricordano vagamente cosa sarebbe la giustizia sociale. Perfetti, finché stanno dall’altra parte del mondo, fuori dai coglioni.
Ci piacciono molto anche i socialisti degli altri. Il caso di Alexandria Ocasio-Cortez conferma in pieno. Con grande attenzione, i media italiani hanno seguito l’ascesa della giovane democratica, fino all’arrivo al Capidoglio di Washington. Hanno persino lodato il suo dichiararsi esplicitamente socialista. Che brava, che coraggio, bene! Che bella la copertina del New Yorker! Tacendo però il dettaglio che se qui, qui da noi, emergesse una voce dichiaratamente socialista – più diritti economici, meno rendite, meno profitti, più reddito da lavoro più diritti agli immigrati, più scuola pubblica – verrebbe trattata come un appestato, affetto da novecentismo, bacucco, via, sciò, come si permette, lasci fare ai mercati, che la sanno lunga. Se dici “socialista” a New York sei un’esotica benedizione per i tempi nuovi che verranno, ma se lo dici qui ti lapidano perché “non aiuti le imprese” e qualunque idea di conflitto sociale pare obbrobriosa.
E’ uno strabismo anche sentimentale, perché, insomma, almeno a sinistra piace ancora l’impianto, chiamiamolo così, ideal-romantico della rivolta e della reazione all’ingiustizia, dei deboli che si ribellano al potente, ma solo in cartolina, e più è spedita da lontano e meglio è.
Cari tutti. Questa non è una canzone d’amore è un libro che ho amato molto. E’ il primo della serie di Carlo Monterossi (e Ghezzi, e Carella e Oscar Falcone…), uscito nel 2014, quindici ristampe in Italia, e ora esce in Spagna, per Salamandra Ediciones (gracias, amigos!). La traduzione è di Julia Osuna Aguilar, la copertina decisamente almodovariana… Insomma, la canciòn. Se passate da Barcellona, o Madrid, o in qualunque altro posto in terra di Spagna… Vabbé, molto contento. Qui la scheda del libro nell’edizione spagnola
 Quando arrivi a prendertela con i giornalisti vuol dire che hai esaurito tutte le altre scuse, e “lasciateci lavorare”, e “la gente non capisce”, eccetera eccetera, e sei arrivato finalmente al bar, dove vale tutto. Sia messo a verbale che per un politico attaccare la stampa è sempre un mezzo autogol e un segno di debolezza. E questo senza addentrarsi nella qualità dell’insulto: “infimi sciacalli” (Di Maio) non è granché, mentre “puttane” (Di Battista) è sgradevole anche per motivi che coi giornalisti non c’entrano niente. Si prova una certa nostalgia per le “iene dattilografe” di D’Alema, che sposava irridente perfidia e raffinatezza stilistica, e questo per dire che si peggiora ma non si inventa niente.
Quando arrivi a prendertela con i giornalisti vuol dire che hai esaurito tutte le altre scuse, e “lasciateci lavorare”, e “la gente non capisce”, eccetera eccetera, e sei arrivato finalmente al bar, dove vale tutto. Sia messo a verbale che per un politico attaccare la stampa è sempre un mezzo autogol e un segno di debolezza. E questo senza addentrarsi nella qualità dell’insulto: “infimi sciacalli” (Di Maio) non è granché, mentre “puttane” (Di Battista) è sgradevole anche per motivi che coi giornalisti non c’entrano niente. Si prova una certa nostalgia per le “iene dattilografe” di D’Alema, che sposava irridente perfidia e raffinatezza stilistica, e questo per dire che si peggiora ma non si inventa niente.
La categoria è balzata su come una bestia ferita, cosa che fa periodicamente con più o meno convinzione. Si è visto vibrare orgoglio professionale, alcuni hanno fotografato il tesserino per postarlo sui social, e in generale la risposta all’attacco scomposto dei 5stelle è stata piuttosto veemente. Insomma, giù le mani dalla libera stampa. Mi associo pienamente. Anche se a tratti nella partita non si distinguevano più due cose un po’ diverse tra loro: la difesa della libertà di stampa e la difesa di una corporazione.
Poi, quando sarà passato lo tsunami di indignazione, si potrà magari discuterne meglio, a partire da due o tre cosette.
La prima riguarda la politica: dire un giorno che i giornali sono morti e non contano più niente, e il giorno dopo attaccarli come potere ostile è una palese contraddizione (comune a tutta, o quasi, la politica). Significa che il famoso disegno culturale dell’intermediazione (il mito della rete per i grillini, ma in generale i social per tutta la politica) non sta funzionando granché. Renzi dettava la linea a colpi di tweet, ma intanto prendeva la Rai e curava i rapporti con i giornali, Salvini fa il fotomodello di se stesso e i media lo adorano. Nomine e promozioni sono terreno di battaglia. Insomma, disintermedia qui, disintermedia là, ma il parere della stampa ai politici interessa ancora parecchio.
Come dicono quelli bravi – ma sarà per consolarsi – bisogna trasformare le disgrazie in opportunità. Sarebbe bello che i giornalisti italiani, così bruscamente insultati, sfruttassero questo loro sussulto d’orgoglio e ne usassero la spinta propulsiva per riflettere un po’ su se stessi, sulla professione, sulle sue modificazioni. I dati sul precariato nella categoria fanno spavento, si scrive per otto euro, per cinque euro al pezzo, i giornalisti sotto i quarant’anni arrivano in media a sei-settecento euro al mese, c’è un vastissimo lumpen-proletariatdel lavoro intellettuale, che diventa sfruttamento e ricatto professionale. I giornalisti garantiti da un contratto e da uno stipendio decoroso sono ormai una minoranza, la norma è una specie di McDonald dell’informazione dove si friggono notizie a basso costo.
Poi, come se non bastasse, tutti i giornalisti hanno questo destino infame: sentirsi spesso dare lezioni di giornalismo da gente che non ha mai messo piede in una redazione, che non ne sa niente. Ma loro, i giornalisti, che nelle redazioni ci stanno, che conoscono la macchina e sanno come funziona, dovrebbero accorgersi che queste forme di sfruttamento, che allungano quasi a vita l’età del precariato, nuocciono alla professione, nella sua dignità, anche più dell’insulto del politico di turno in piena crisi di nervi.
“Perché non mi scrivi una bella pagina sulla meritocrazia? Te la pago sei euro e cinquanta!”. Ecco una buona metafora di come sta messo oggi il giornalismo italiano, e si può valutare se la sua perdita di qualità non sia dovuta anche a questo. Nel dibattito sulla stampa offesa, tutto questo non c’è: solo insulti, allarmi e grida d’orgoglio ferito, politici isterici, giornalisti indignati e morta lì. Peccato.
 E se ne avesse altre? Intendo: se la signora Isoardi avesse altre fotine da mostrarci? Se volesse trasportare da “collezione privata” a “pubblico dominio” altri scatti dell’attuale ministro dell’Interno? A quel punto avremmo un intero catalogo di immagini dedicate a Matteo Salvini: quelle che si fa lui (in settimana: con il mitra in mano, con la Madonna di Medjugorje, con la tuta della protezione civile, con la divisa dei pompieri, in giacca e cravatta dal presidente del Ghana…) e quelle che gli fanno gli altri, che non si sa mai. Insomma, non è giusto che un collezionista privato privi (appunto) il mondo di testimonianze artistiche così rilevanti. In un momento storico in cui il leader aspirante uomo forte (“Se governassi da solo…”, un classico) coincide in tutto e per tutto con la sua immagine mediatica, diffondere fotografie non autorizzate sarebbe un dovere civico, un contributo al dibattito politico culturale.
E se ne avesse altre? Intendo: se la signora Isoardi avesse altre fotine da mostrarci? Se volesse trasportare da “collezione privata” a “pubblico dominio” altri scatti dell’attuale ministro dell’Interno? A quel punto avremmo un intero catalogo di immagini dedicate a Matteo Salvini: quelle che si fa lui (in settimana: con il mitra in mano, con la Madonna di Medjugorje, con la tuta della protezione civile, con la divisa dei pompieri, in giacca e cravatta dal presidente del Ghana…) e quelle che gli fanno gli altri, che non si sa mai. Insomma, non è giusto che un collezionista privato privi (appunto) il mondo di testimonianze artistiche così rilevanti. In un momento storico in cui il leader aspirante uomo forte (“Se governassi da solo…”, un classico) coincide in tutto e per tutto con la sua immagine mediatica, diffondere fotografie non autorizzate sarebbe un dovere civico, un contributo al dibattito politico culturale.
Va detto che la prima puntata della soap ha mosso un po’ la trama: Salvini era così a corto di idee da farsi fotografare con una statua della Madonna di Medjugorje (che di solito è il penultimo gradino del vip in affanno), e un po’ di soft-core per i palati meno devoti serviva come il pane. Lui, peraltro, com’è noto, ribatte che “Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata”. Non male, detto da uno che si fece fotografare a letto vestito solo di una cravatta verde sulla copertina di un settimanale.
Ma sia, non è della già oltremodo dibattuta situazione Harmonydello sceriffo che si vuole parlare. O forse sì, ma in questo senso: il terreno del voyeurismo salvinista si allarga di un’altra zolla. Dopo le emergenze inventate, l’affanno da sciacallo sui casi di cronaca su cui cala come un avvoltoio se lo ritiene utile, tra un insulto agli intellettuali e il vorticoso cambio di costumi di scena, mancava l’irruzione nel privato, di più, nell’intimo. Dal palinsesto un po’ machista e un po’ albertosordiano del Nostro mancava il tassello del melodramma privato, una cosa da tivù popolare, anzi popolarissima: “E pensa, Maria, che gli stiravo il cappuccio del Ku Klux Klan, è uno stronzo, chiudi la busta”.
Insomma, che Salvini stia colonizzando ogni spazio di comunicazione disponibile è noto: forse lo vedremo che imbocca un cucciolo di foca, o sorridente sulla confezione dei cereali, o che ricorda severo che è ora di montare le gomme invernali. Salvini che è ovunque e in ogni luogo, insomma, con la statua della Madonna e col mitra, impegnato nella costruzione di quel rumore di fondo senza il quale sarebbe soltanto Matteo Salvini, un politico di lungo corso, molto ancien régime,sopravvissuto al terremoto dei partiti e diventato portabandiera della destra non più vergognosa di se stessa.
Come già si disse in questa rubrichina, il problema non è se, ma quando scoppierà questa bolla di fuffa elettronica che accompagna le gesta di Salvini. Già si nota una confusione tra il Salvini e il suo pupazzo, tra l’astuto politico e le sue varie caricature, girano le barzellette su Salvini, le parodie si sprecano. In sostanza, dietro l’apparente osanna delle masse, si comincia a intravvedere lo smottamento: Salvini che vorrebbe essere uomo forte, appoggiato alle proverbiali puttanate del Duce, che fa la faccia brutta davanti al crimine (purché commesso da immigrati), si confonde sempre più con il Salvini da trash televisivo, da pescatore della domenica, da indossatore di divise. Ci vorrà del tempo, perché il ridicolo è come il veleno, che ci mette un po’. Vedendolo sorridere pieno di sé mentre si recava sul luogo di una tragedia, molti hanno pensato che avesse sbagliato selfie, invece sono solo i piani che si intersecano: il pupazzo e il ministro non sono più distinguibili, e non è certo il puazzo il peggiore dei due.
 Andrà letta per bene e nei dettagli, la rivoluzionaria proposta contenuta nella manovra economica che promette un po’ di terra da coltivare per chi fa il terzo figlio. Già detta così pare bellissima, c’è un che di Via col ventoe al tempo stesso qualcosa di romanticamente sovietico: la terra ai contadini! Solo se hanno tre figli, anzi due ma promettono di fare il terzo. Siccome sono tempi in cui i paragoni storici si sprecano, spesso a sproposito, non dirò della ripopolazione delle campagne, delle paludi, del sacro suolo, eccetera eccetera, e nemmeno dei premi alle famiglie numerose. Mi limiterò a ricordare un precedente illustrissimo. Era il 1865 e, in America, il generale Sherman emanò un’ordinanza per donare a ogni ex schiavo, come risarcimento, 40 acri di terra e un mulo per ararla. C’era il trucco: era terra quasi sempre paludosa e incoltivabile, in brutte zone, il mulo non gliel’hanno mai dato, poco dopo ammazzarono Lincoln, cambiò tutto, e gli ex schiavi dovettero rendere le terre ai padroni bianchi. 40 acri e un mulo è un modo di dire, in America, che sottintende la fregatura storica che diventa, per l’appunto, proverbiale.
Andrà letta per bene e nei dettagli, la rivoluzionaria proposta contenuta nella manovra economica che promette un po’ di terra da coltivare per chi fa il terzo figlio. Già detta così pare bellissima, c’è un che di Via col ventoe al tempo stesso qualcosa di romanticamente sovietico: la terra ai contadini! Solo se hanno tre figli, anzi due ma promettono di fare il terzo. Siccome sono tempi in cui i paragoni storici si sprecano, spesso a sproposito, non dirò della ripopolazione delle campagne, delle paludi, del sacro suolo, eccetera eccetera, e nemmeno dei premi alle famiglie numerose. Mi limiterò a ricordare un precedente illustrissimo. Era il 1865 e, in America, il generale Sherman emanò un’ordinanza per donare a ogni ex schiavo, come risarcimento, 40 acri di terra e un mulo per ararla. C’era il trucco: era terra quasi sempre paludosa e incoltivabile, in brutte zone, il mulo non gliel’hanno mai dato, poco dopo ammazzarono Lincoln, cambiò tutto, e gli ex schiavi dovettero rendere le terre ai padroni bianchi. 40 acri e un mulo è un modo di dire, in America, che sottintende la fregatura storica che diventa, per l’appunto, proverbiale.
Ma qui c’è di più. La faccenda della terra distribuita per questioni di merito demografico (tre figli! Bravi, avete vinto un prato in Molise!) ha qualcosa di irresistibilmente satirico: con sei o sette figli ti fai un latifondo come ai tempi dei Viceré.
Ora immaginiamo la famigliola aspirante ceto medio che si arrabatta con due figli, stipendi precari, mutuo sul groppone, che si accinge a fare il terzo figlio, carica il camioncino come la famiglia Joad (Furore, John Steinbeck, 1939) e va dall’Oklahoma alla California in cerca di un pezzo di terra da coltivare. Molto suggestivo e letterario, molto fotografia seppiata della Grande Depressione. Forse un po’ meno affascinante dal punto di vista pratico, e poi bisognerebbe pensare allo sviluppo, andare avanti, programmare. Al quarto figlio la stalla. Al quinto figlio la trebbiatrice nuova. Senza contare alcune cosucce di non poco conto, come le condizioni dell’agricoltura italiana: uno va a coltivarsi i suoi 40 acri, e poi? Poi gli passano sotto il naso i camion delle arance raccolte col lavoro semischiavistico, il caporalato, la grande distribuzione e le sue aste al ribasso. Tutto questo senza nemmeno dover sparare a Lincoln.
In ogni caso si va a parare lì, all’aumento della natalità premiato come se fosse un donare braccia alla patria, una cosa già sbandierata dall’indimenticabile ministra Lorenzin. Naturalmente i legittimi titolari di due figli che si mettano in testa la balzana idea di fare il terzo ringrazieranno molto per l’idea, ma si ha come l’impressione che preferirebbero altri incentivi. Per esempio un asilo nido meno caro di una Porsche, servizi sociali adeguati, un welfare funzionante che permetta alle madri di lavorare a parità di salario con gli uomini, e altre cosucce consimili come magari tempi di lavoro che non siano dettati da un algoritmo. Dettagli. Cosucce. Ma va bene anche il prato in Molise, eh! Immagino che ci sarà un boom demografico senza precedenti e avremo migliaia di nuove aziende agricole, dove il neonato potrebbe occuparsi delle papere. E’ evidente che affidare tutto questo ben di dio a famiglie svogliate ed egoiste che si rifiutano di figliare oltre il secondogenito sarebbe diseducativo e non ripopolerebbe le campagne, mentre si sa che l’impero ha bisogno di braccia da restituire all’agricoltura. Magari un giorno si supererà questa visione agreste e littoria per arrivare ad incentivi meno avventurosi. Esempio: se fai il terzo figlio scuola gratis fino alla laurea per gli altri due. La butto lì per il ministro della Famiglia, se si scopre che il terzo figlio sono due gemelli al papà si restituisce l’articolo 18. Pensiamoci. Il mulo, magari, un’altra volta.
 Peccato che non siamo in un romanzo russo, dove per pagine e pagine si descrive in minuzia il carattere dei personaggi, sfumature, dettagli, sussulti, pieghe dell’anima. Qui si fa tutto in fretta, e per compiacere il gentile pubblico bisogna sbrigarsi. Così succede che la necessità di disegnare un mix di “carattere deciso” e “operazione simpatia” consegni politici, leader e aspiranti tali, statisti in pectore e vecchie glorie a un’escalation comunicativa piuttosto ridicola. Ma non importa, quel che conta è sembrare umani, empatici e simpatici, dire al pubblico: in fondo penso quello che pensate voi, sono come voi. Delle succinte misesestive di Salvini si è detto in abbondanza, e del resto questa dell’”operazione simpatia” è roba vecchia e si può dire più o meno che la inventò Silvio buonanima.
Peccato che non siamo in un romanzo russo, dove per pagine e pagine si descrive in minuzia il carattere dei personaggi, sfumature, dettagli, sussulti, pieghe dell’anima. Qui si fa tutto in fretta, e per compiacere il gentile pubblico bisogna sbrigarsi. Così succede che la necessità di disegnare un mix di “carattere deciso” e “operazione simpatia” consegni politici, leader e aspiranti tali, statisti in pectore e vecchie glorie a un’escalation comunicativa piuttosto ridicola. Ma non importa, quel che conta è sembrare umani, empatici e simpatici, dire al pubblico: in fondo penso quello che pensate voi, sono come voi. Delle succinte misesestive di Salvini si è detto in abbondanza, e del resto questa dell’”operazione simpatia” è roba vecchia e si può dire più o meno che la inventò Silvio buonanima.
Ultima preda di questa febbre del “sembriamo umani” parrebbe Carlo Cottarelli, il pacato sorvegliante degli sprechi e della spesa, elegante e gradevole come un buon chirurgo, che sa sorridere mentre dice: “Amputare!”. Lo percepivamo come una specie di calcolatrice vivente e invece, da quando va in tivù, eccolo spiritoso e sgarzolino. Rilascia tweet che esultano per il numero di followers (“Grazie a tutti! Ormai più che riempiamo lo Juventus Stadium. Il prossimo obiettivo è l’Olimpico di Roma, poi cercheremo di riempire San Siro”); e addirittura si abbandona al delirio adolescenziale (“Stasera vado a #chetempochefa. Mi perdo pure InterMilan. E poi che canto? C’è solo il surplus? Amalo pazzo surplus amalo? Chi non salta scialacquone è, è?”). Magari la famiglia ha chiamato un dottore. Magari il nipotino di nove anni gli ha fregato il telefono. Oppure, più probabile, è in corso un ridisegno del carattere (Basta solo numeri! Un po’ di normalità!) per la costruzione di una popolarità e poi – eventualmente – una “discesa in campo”.
Di solito dietro queste scelte spunta sempre uno di quei guru della comunicazione che fanno più danni vaiolo tra i Maya, ma non sappiamo se sia questo il caso, e magari Cottarelli, coerente con le sue spending review, fa tutto da solo.
Niente di nuovo, lo dico per rassicurare tutti. L’umanizzazione dei tecnici si è già vista, anche in modi esilaranti, con Mario Monti. Gli regalarono persino un cagnolino in diretta tivù, in modo che il pubblico facesse ohhh, stupito che lui non lo macellasse lì, sul posto. Insomma, il disegno del carattere, l’elaborazione di una figura ben modellata da presentare al pubblico, è una strana alchimia. Bisogna sembrare efficienti e capaci, ma anche un po’ persone normali, affidabili ma buontemponi, rigorosi e tosti, ma anche alla mano.
E poi, all’occorrenza, il carattere (dal greco: impronta) può servire alla rovescia, come alibi di tutto. Renzi ne ha parlato molto alla Loepolda (“Cari amici che criticate il carattere…”), riducendo la valutazione della sua devastante opera politica a semplici critiche al suo “carattere”. Lo ha fatto anche in un tweet in cui mostra la sporcizia alla periferia di Roma e chiosando: “Colpa del mio carattere anche questo?”. Piuttosto incongruo, ma evidente la linea di pensiero: l’unica colpa che si ammette è il temperamento, bon, basta lì, tutto il resto passa in cavalleria. Come se uno dicesse: “Ah, il conte Vlad, detto Dracula, soprannominato l’Impalatore? Uh, che caratteraccio!”.
Tutto questo fare e disfare di personalità multiple e caratteri mutevoli avviene, nell’epoca dei social, sotto gli occhi di tutti, si tratta per così dire di metamorfosi in pubblico e ognuno può leggerne i segnali, le sfumature, i salti di senso, gli aggiustamenti. Come gli antichi con le interiora di pollo o i moderni coi fondi di caffè, stando anche solo un po’ attenti si può leggere il futuro: Renzi si ritaglia la leggenda autoassolutoria del “caratteraccio”, Cottarelli si scalda a bordo campo.
 Guardo la mia piccola pila di multe regolarmente pagate e mi si apre il cuore. Ci sono un paio di autovelox (buste verdi), un paio di divieti di sosta del mio comune (buste bianche), poi quella volta che mi era scaduto il ticket del parchimetro, e poi la mia preferita: la multa presa mentre ero alle Poste a pagare una multa. Record. L’ho incorniciata, cioè, prima pagata, poi incorniciata. Osservo queste piccole madeleine del mio essere automobilista imperfetto – tutte pagate – alla luce della nuova pace fiscale e modifico la mia idea di stato di diritto: sono un coglione.
Guardo la mia piccola pila di multe regolarmente pagate e mi si apre il cuore. Ci sono un paio di autovelox (buste verdi), un paio di divieti di sosta del mio comune (buste bianche), poi quella volta che mi era scaduto il ticket del parchimetro, e poi la mia preferita: la multa presa mentre ero alle Poste a pagare una multa. Record. L’ho incorniciata, cioè, prima pagata, poi incorniciata. Osservo queste piccole madeleine del mio essere automobilista imperfetto – tutte pagate – alla luce della nuova pace fiscale e modifico la mia idea di stato di diritto: sono un coglione.
Fossero solo le multe.
Il problema, invece, è la semantica, la scelta delle parole, la costruzione delle formule. In un paese dove esiste un decreto, votato ogni anno, che si chiama Milleproroghe, infinito elenco di cose non fatte, trovare nuovi nomi fantasiosi per vendere vecchia merce come un semplice condono non è facile.
“Pace fiscale” è una buona soluzione. Intanto è in italiano (i governi precedenti l’avrebbero chiamato “Fiscal Love”) e poi descrive bene il clima da osteria, ehi, qua la mano, pare di vedere una locanda con vecchi contadini, una pittura dell’Ottocento. “Pace fiscale” presuppone che si chiuda una guerra, che tacciano i cannoni e si ritrovi una garrula cordialità tra chi non ha pagato e chi dovrebbe – leggi alla mano – fargli il culo. E’ una guerra a cui quelli che hanno regolarmente versato tutto, magari cristonando e negandosi altre cose, magari rimandando un acquisto perché la multa veniva prima, assistono mentre gli cascano le braccia. Cose tra loro, insomma, tra chi ha sgarrato (poco, la multa, ma anche parecchio, fino a 100 mila euro, in un Paese dove il reddito medio pro capite è di 27 mila), e chi cerca di incassare quel che può. Che c’entriamo noi che siamo in regola, a parte un retrogusto di fregatura?
Si dirà che è il ritornello che si sente ad ogni condono, quando si chiama in italiano (ah, i vecchi “concordati” di Silvio!) e quando si chiama in inglese (la Voluntary Disclosure, che pareva una categoria di Youporn). E’ vero in parte.
Divertente invece che sia così solerte nel perdonare, condonare e cancellare regole chi proprio in questi giorni si appella a regolamenti e cavilli d’altro tipo. La Lega, che voleva addirittura un tetto più alto per il suo condono, che tuona ad ogni passo contro la burocrazia che strangola il cittadino, usa la burocrazia per strangolare altri cittadini, purché stranieri. Le storie delle mense scolastiche di Lodi sono note: la burocrazia usata come cappio punitivo e guinzaglio corto, i moduli dai paesi d’origine, la guerra di scartoffie per negare diritti, una specie di tassa sull’articolo 3 della Costituzione mascherata da “rispetto delle regole”.
Il “debole-coi-forti-e-forte-coi-deboli”, che è la cifra dell’esplosione salviniana nel Paese, non poteva avere in un solo giorno descrizione più plastica: di qua si perdona chi ha sgarrato, si chiude un occhio, si tende la mano (pace!); di là, dalla parte dei nuovi italiani che lavorano qui, pagano le tasse qui, mandano i figli a scuola qui, ci si fa occhiuti e pedantissimi, chiedendo documenti impossibili e costosi per provare il gusto di un piccolo apartheid di paese (guerra!).
Per i bambini di Lodi, i migranti di Riace, i “negozietti etnici” (sic) si pretende ferreo rigore burocratico-amministrativo, spesso inventato lì per lì con intento punitivo, mentre per gli altri si mette una toppa ogni tanto, si perdona, si sana, si “mette in regola” con lo sconto. La vecchia barzelletta che la legge è uguale per tutti si aggiorna con “la burocrazia è uguale per tutti”, su base etnica. La doppia morale, insomma – legge e ordine, ma per chi dico io – diventa tripla. Tutto made in Salvini, con gli altri testimoni muti e inani, come la mucca che guarda passare il treno.
Tiro Mancino, di Charles Willeford è ri-uscito (dopo anni) da Feltrinelli. Ne parlo su TuttoLibri de La Stampa. La recensione qui sotto (cliccare)
 Pare dunque accertato che il famoso reddito di cittadinanza stia diventando un sudoku piuttosto difficile da risolvere, con parecchi difetti. Per esempio andrà solo agli italiani e a chi abita qui da dieci anni, che è come dire che chi vive qui, poniamo, da cinque o otto anni, manda i figli a scuola, paga le tasse (se non l’irpef, perché è sotto le soglie, tutte le altre) ed è in difficoltà, cazzi suoi. Poi c’è l’altra regola: ai poveri non si danno in mano contanti, come si fece invece per i ceti medi degli ottanta euro renziani. Meglio di no, quelli sono poveri, non sono abituati, poi chissà che ci fanno, coi soldi. E se scialano? Poi diventa centrale il funzionamento dei centri per l’impiego, quelle strutture che forniscono lavoratori precari al mercato e che traballano perché hanno troppo precari al loro interno (comma 22). Segue complicata struttura di pagamenti elettronici (si scivola verso la social card di Tremonti). E segue ancora, esilarante, la proposta dei sedicenti economisti della Lega per cui lo Stato dovrebbe in qualche modo tracciare le spese degli italiani che ricevono il sussidio: se comprano prodotti italiani in negozi italiani bene (alalà!), se comprano la stufetta coreana su Amazon no (questa è di Claudio Borghi, uno forte nel cabaret, finito, invece che a Zelig, alla Commissione Bilancio).
Pare dunque accertato che il famoso reddito di cittadinanza stia diventando un sudoku piuttosto difficile da risolvere, con parecchi difetti. Per esempio andrà solo agli italiani e a chi abita qui da dieci anni, che è come dire che chi vive qui, poniamo, da cinque o otto anni, manda i figli a scuola, paga le tasse (se non l’irpef, perché è sotto le soglie, tutte le altre) ed è in difficoltà, cazzi suoi. Poi c’è l’altra regola: ai poveri non si danno in mano contanti, come si fece invece per i ceti medi degli ottanta euro renziani. Meglio di no, quelli sono poveri, non sono abituati, poi chissà che ci fanno, coi soldi. E se scialano? Poi diventa centrale il funzionamento dei centri per l’impiego, quelle strutture che forniscono lavoratori precari al mercato e che traballano perché hanno troppo precari al loro interno (comma 22). Segue complicata struttura di pagamenti elettronici (si scivola verso la social card di Tremonti). E segue ancora, esilarante, la proposta dei sedicenti economisti della Lega per cui lo Stato dovrebbe in qualche modo tracciare le spese degli italiani che ricevono il sussidio: se comprano prodotti italiani in negozi italiani bene (alalà!), se comprano la stufetta coreana su Amazon no (questa è di Claudio Borghi, uno forte nel cabaret, finito, invece che a Zelig, alla Commissione Bilancio).
Insomma, come tradizione riformista nazionale ci siamo in pieno: una macchina senza ruote che si dovrà spingere in qualche modo. Si dirà che la preoccupazione maggiore è quella – sacrosanta – di ridurre al minimo abusi e furbetti, giusto. E del resto sul funzionamento della macchina che gestirà e distribuirà qualche soldo a chi finora è stato tenuto fuori da qualsiasi anche minima redistribuzione, i Cinque stelle si giocano gran parte della loro scommessa e l’osso del collo.
Dunque è comprensibile che qualche obiezione al sistema, sia più che sensata, ma purtroppo non è questo il tipo di opposizione prevalente. “Farlo è giusto e bisogna farlo bene” è un po’ diverso da dire “farlo è sbagliato”. Eppure la critica al reddito di cittadinanza (10 miliardi, quello che costarono gli ottanta euro, meno di quello che si spese per salvare le banche, meno di quello che ci costa disinnescare la mina Iva ogni anno) vola verso altri lidi. Ancora una volta prevale un’impostazione classista che unisce pensatori di estrazione culturale omogenea (per dire: Matteo Renzi e Flavio Briatore), secondo cui il reddito di cittadinanza paga la gente per stare sul divano invece di sbattersi, lavorare, darsi da fare, industriarsi. C’è, dietro questa impostazione teorica, il vecchio vizio borghese di considerare i poveri unici responsabili della loro povertà, e (di conseguenza) la povertà una colpa, vecchio ritornello adattato ai tempi, ma ennesima versione dell’antico e italianissimo “i meridionali (e i poveri) non hanno voglia di lavorare”.
Cosa sorprendente, molti di quelli che avanzano questo nuovo antichissimo refrain sono gli stessi che riflettono (?) sulla veloce automazione del lavoro, sulle frontiere della robotica. Sanno benissimo, insomma, che tra dieci o vent’anni, metà dei posti di lavoro non ci saranno più, e che i lavoratori sostituiti dalle macchine dovranno comunque mangiare qualcosa, si spera tre volte al giorno. Un qualche reddito-chiamatelo-come-voleteche sostituisca il reddito da lavoro, insomma, sarà inevitabile e sarà la scommessa dei prossimi decenni. Cavarsela con “Uh, li paghiamo per stare sul divano” non è solo banale e rivelatore del nulla teorico che ci circonda, ma anche miope nei confronti del futuro: presto stare sul divano senza lavoro sarà una situazione assai diffusa per moltissimi, respinti nella povertà dal famoso “mercato” per la cui gloria – maledetti – i poveri non si sbattono abbastanza. Loro e il loro divano.
 Con tutta la bella retorica sull’uscita dalla crisi, e la ripresina – dopo dieci anni di implacabile tosatura dei redditi dei ceti medio bassi – ecco che abbiamo un problemino. Muore, infatti, gran parte della cassa integrazione per le aziende in crisi o in cessazione di attività. Il che significa avere davanti la prospettiva di 140.000 (centoquarantamila!) lavoratori senza reddito, solo tra i metalmeccanici, cui si aggiungono altre categorie, tavoli, trattative, crisi, emergenze per un totale che nessuno sa calcolare ma che dovrebbe, alla fine dell’anno e nei primi mesi del 2019, sfiorare quota 200.000 (duecentomila!). Sono famiglie che rischiano di restare senza reddito, quindi di più o meno mezzo milione di persone che sentono la terra che cede, il pavimento che diventa fangoso, e avvertono spaventate uno scivolamento verso la povertà.
Con tutta la bella retorica sull’uscita dalla crisi, e la ripresina – dopo dieci anni di implacabile tosatura dei redditi dei ceti medio bassi – ecco che abbiamo un problemino. Muore, infatti, gran parte della cassa integrazione per le aziende in crisi o in cessazione di attività. Il che significa avere davanti la prospettiva di 140.000 (centoquarantamila!) lavoratori senza reddito, solo tra i metalmeccanici, cui si aggiungono altre categorie, tavoli, trattative, crisi, emergenze per un totale che nessuno sa calcolare ma che dovrebbe, alla fine dell’anno e nei primi mesi del 2019, sfiorare quota 200.000 (duecentomila!). Sono famiglie che rischiano di restare senza reddito, quindi di più o meno mezzo milione di persone che sentono la terra che cede, il pavimento che diventa fangoso, e avvertono spaventate uno scivolamento verso la povertà.
La questione è già stata approfondita dai leader politici, cioè approfondita come sanno fare loro, in scambi di contumelie di 280 caratteri, virgole e spazi compresi. Di Maio ha dato a Renzi dell’”assassino politico” per il Jobs act, Renzi ha risposto per le rime, eccetera eccetera. La solita seconda media con ragazzi difficili, che – immagino, ma sono quasi sicuro – produrrà in quelle 200.000 famiglie sull’orlo della povertà una notevole irritazione (eufemismo: saranno incazzati come cobra).
Al di là del disastro, che ora bisognerà evitare in qualche modo, va fatta una riflessione seria sulla sbobba che in questi anni ci hanno fatto mangiare, a pranzo e a cena, benedetta e santificata in una parolina inglese (e te pareva, la lingua di Shakespeare sembra la vaselina migliore quando si parla di lavoro in Italia): flexsecurity.
Per anni, più o meno dal 2009, quella della flexsecurityè stata la teoria liberista del lavoro, mutuata da suggestioni danesi (Pil una volta e mezzo il nostro, abitanti meno di un decimo), spinta dai pensatori liberal-liberisti, tradotta assai maldestramente in legge dal jobs act. Consiste, più o meno, nell’aumentare sia la flessibilità del lavoro (flex), sia la sicurezza sociale (security), con il geniale progetto, una specie di speranza con tanto di ceri alla Madonna, che la prima riesca più o meno a finanziare la seconda. Cosa che non è avvenuta.
Su colpe, responsabilità, omissioni, pezze da mettere al buco si vedrà, ma preme qui affrontare un aspetto della questione un po’ più teorico e (mi scuso) filosofico. Perché entra qui in gioco una grande tradizione italiana, che potremmo chiamare il trucchetto delle due fasi. Prima fase: si chiedono sacrifici e rinunce, limature e taglio di diritti, stringere i denti, tirare la cinghia. Ma tranquilli, è solo la prima fase, poi verrà la seconda fase e vedrete che figata.
Ecco, la seconda fase non arriva mai.
Qualcosa si inceppa. O si sono sbagliati i calcoli. O cade un governo. O cambia la situazione internazionale. O il mercato non capisce. O l’Europa s’incazza. Insomma interviene sempre qualche fattore per cui la fase uno si fa eccome, soprattutto nella parte dei diritti tagliati e del tirare la cinghia, e la fase due… ops, mi spiace, non si può fare, non ci sono i soldi, che disdetta.
Sono anni e anni che questo giochetto delle due fasi viene implacabilmente attuato sulla pelle dei lavoratori italiani, anni in cui gli si chiede di partecipare in quanto cittadini al salvataggio della baracca, rinunciando a qualcosa come garanzie o potere d’acquisto in cambio di un futuro in cui i diritti ce li avranno tutti – un po’ meno, ma tutti – e aumenterà il benessere collettivo. Mai successo. Ma mai.
 Forse non è corretto valutare la politica italiana come un semplice meccanismo di domanda e offerta, ed è sempre irritante considerare quel confuso miscuglio tra ideali e pratiche, strategie e tattiche, desideri e possibilità che è la passione politica come se fosse un titolo in Borsa, che sale, scende, si stabilizza, si impenna o crolla. Insomma, la cosa è più complicata, ma se per un attimo fingiamo che sia così – domanda e offerta – ne esce un quadro non proprio confortante.
Forse non è corretto valutare la politica italiana come un semplice meccanismo di domanda e offerta, ed è sempre irritante considerare quel confuso miscuglio tra ideali e pratiche, strategie e tattiche, desideri e possibilità che è la passione politica come se fosse un titolo in Borsa, che sale, scende, si stabilizza, si impenna o crolla. Insomma, la cosa è più complicata, ma se per un attimo fingiamo che sia così – domanda e offerta – ne esce un quadro non proprio confortante.
Prendi per esempio un elettore dei Cinquestelle, uno di quei dodici milioni – magari non militante, magari non ortodosso, magari uno di quei tantissimi che hanno messo lì il loro voto per cambiare qualcosa, vedere l’effetto che fa, punire la miserrima arroganza di quelli di prima – che si metta a cercare altre strade. Bene. Non c’è dubbio che lo vedremmo un po’ spaesato. L’effetto è quello di uno che si mette un proprio per non lavorare più sotto padrone e si ritrova un socio ingombrante, che fa tutto lui, che si intesta quote della società. Per quanto vaghe siano le aspirazioni e per quanto fumoso sia il grande disegno pentastellato, ritrovarsi con la possibilità di comprarsi un kalashnikov senza troppe scartoffie non faceva parte di quei sogni. Nemmeno ballarecheek to cheekcon un alleato che garantisce Silvio sui suoi sempiterni interessi, ovvio. E nemmeno passeggiare a braccetto con uno che spinge un condono epocale, una cosetta che era partita da quattro multe e arriva a perdonare grossi evasori (fino a un milione di euro, si dice). Supponiamo poi che questo elettore venisse dalla sponda democratica, intesa come tendenza anti-establishment ma anche antifascista. Si suppone che si troverà un po’ a disagio con l’amico dell’amico Orban, e chissà, magari, se l’elettore è una donna, guarderà con qualche fremito a quel Ddl Pillon oggi tanto sventolato da un legista che parlava di “stregoneria nelle scuole”, che dichiara la superiorità del “matrimonio indissolubile”, o dice “glielo impediremo” alle donne che vogliono abortire.
Insomma, pur capendo il gusto dell’imprevisto, qui gli imprevisti diventano un po’ troppi, allearsi così strettamente con Salvini è come comprarsi un doberman e scoprire che le chiavi di casa e il guinzaglio li tiene lui: il rischio è di finire a mangiare nella ciotola mentre il cane sta sul divano a guardare la tivù.
Ma, tornando al famoso discorso della politica come domanda e offerta, supponiamo che questo ipotetico elettore Cinquestelle – anche uno solo sui dodici milioni, ma credo più d’uno – cominci a guardarsi in giro per vedere se nel listino esista un’offerta migliore. Qui cominciano i guai veri: dove potrebbe andare? Sperimentata l’alleanza con la punta di diamante della destra, la tentazione sarebbe quella di guardare dall’altra parte, ma per trovare cosa? Un pasticcio di personalismi, ego in libertà, inviti per cene a quattro tra leader bolliti, poi rinviati e ritirati, per sopraggiunta overdose di ridicolo. Minacce da fumetto (“Non vi libererete tanto facilmente di me”, cfr. Renzi), mezze figure che reggono la coda a questo o quel capetto, grotteschi balletti sulla data del congresso, tweet che irridono l’avversario, pretese di competenza smentite dai fatti e dalla storia recente, e potrei andare avanti ore. Non ci vuol molto a capire che il nostro ipotetico elettore Cinquestelle un po’ deluso dall’alleanza con lo sceriffo chiacchiere-e-distintivo Salvini si trovi a disagio, con la prospettiva (il def, il reddito di cittadinanza divenuto bonsai, Silvio che rientra dalla finestra, propaganda sui poveracci…) che il disagio aumenti. Presto si troverà davanti alla solita domanda che spunta sempre: “Che fare?”, e ci troveremo intorno altre anime morte in cerca dell’unica cosa che oggi la politica non offre: fare politica.
Ho recensito per TuttoLibri de La Stampa Il sorriso di Jackrabbit, di Joe. R. Lansdale. Cliccare per leggere
Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo per ITV Movie è Patrizia Sartori.
 Ahi, Sudamerica, Sudamerica… Ci vorrebbe un Gabriel Garcia Màrquez in piena forma per raccontare del burbero ministro della Polizia e della Sicurezza che fa pubbliche dichiarazioni in sostegno della fidanzata e dei suoi cuochi in tivù, che trepida in camerino con la di lei mamma. C’è del ridicolo, sì, ma anche del tragico. E’ trasformismo da social: ve lo aspettate severissimo a sorvegliare i confini, ed eccolo tenero fidanzatino di Peynet. Ve lo aspettate paterno e rassicurante a pranzo, natura morta con mozzarella, ed eccolo ducesco e imperativo che apre le buste della Procura.
Ahi, Sudamerica, Sudamerica… Ci vorrebbe un Gabriel Garcia Màrquez in piena forma per raccontare del burbero ministro della Polizia e della Sicurezza che fa pubbliche dichiarazioni in sostegno della fidanzata e dei suoi cuochi in tivù, che trepida in camerino con la di lei mamma. C’è del ridicolo, sì, ma anche del tragico. E’ trasformismo da social: ve lo aspettate severissimo a sorvegliare i confini, ed eccolo tenero fidanzatino di Peynet. Ve lo aspettate paterno e rassicurante a pranzo, natura morta con mozzarella, ed eccolo ducesco e imperativo che apre le buste della Procura.
Quindi aggiungiamo alle grandi domande del presente anche questa, forse minore e laterale: quanto manca allo scoppio della bolla Salvini?
Inutile elencare i precedenti, che sono noti a tutti e mediamente tragicomici. Sono passati solo sette anni da quando sembrava che indossare il loden verde e prendere un treno fosse una specie di Risorgimento contro l’impero del grottesco e del cochon: Monti veniva dopo Berlusconi e sembrava la discesa dell’angelo moralizzatore. Due anni dopo nessuno poteva più vederlo nemmeno pitturato. Renzi, anche lui beneficiario di una bolla di consenso, ci affogò dentro facendo l’errore classico: credere alla propria propaganda. Stessa velocità supersonica, ciò che sembrava modernissimo e sorprendente aveva già rotto le palle due anni dopo, ci sono canzonette estive che durano di più.
E ora Salvini. Il cambio di stile nell’agiografia e nella comunicazione del capo è evidente: oggi abbiamo grigliate a torso nudo dove ieri avevamo elegantissime fotine seppiate del Giovane Statista, è una questione di target.
La bolla Salvini deve vedersela anche con un altro problema, che potrebbe accelerarne la fine: il fastidioso e perenne rumore di fondo che i media producono. La “questione Matera” ne è un buon esempio: Di Maio chiede a Emiliano qualcosa su Matera, subito gira la favola che non sa dov’è Matera. Poi si chiarisce tutto (Matera gravita sull’aeroporto di Bari, sarà capitale della cultura, anche la Puglia ci punta molto, eccetera), ma intanto la cosa gira. Esponenti dell’opposizione fanno battute, rilanciano una notizia falsa quando già si sa che è falsa, notizia falsa e notizia vera si intrecciano, tutto si mischia. Vero? Farlocco? Solo rumore.
Un caso al giorno, anche due, così, ogni giorno, un’ondata di surreale dietro l’altra, da ogni direzione e verso ogni bersaglio, poi la piccola risacca dei puntini sulle i, poi un’altra onda, e si ricomincia. La goccia che scava la pietra, e la pietra finisce che prima o poi si rompe i coglioni.
Tutto diventa rumore di fondo, e la bolla di Salvini finisce lì dentro. Sarà vero? Sarà falso? Che ha fatto oggi? Proclami razziali? Baci e abbracci? Rastrellamenti di migranti? Auguri alla ragazza? Minacce alla magistratura? Pollo arrosto? Salvini è orizzontale e riempie tutte le pieghe dell’esistenza, dal pubblico all’intimo, il crinale è molto stretto, il rischio di cadere nella caricatura di se stesso è inevitabile. “Salvini fa il bucato” e “Salvini riceve Orban”, diventano la stessa cosa, è un entertainer che per esistere deve stare perennemente in onda, questo sostiene i sondaggi nell’immediato, ma alla lunga logora.
I fatti saranno più testardi, la flat tax non ci sarà (per fortuna), la benzina la paghiamo più di prima, i migranti si rivelano ogni giorno di più un’arma di distrazione, gli alleati (alla buon’ora!) si mostrano infastiditi, “Io sono eletto, i giudici no” contiene dosi massicce di Berlusconi. Quando prevarrà la sensazione di un Salvini “chiacchiere e distintivo” la bolla scoppierà, ciò che all’inizio il grande pubblico guardava con simpatia canaglia comincerà a guardare con sospetto, e poi con stizza: ancora queste cose? Ancora ‘ste cazzate? La domanda non è se succederà, ma quando.
 Un fantasma si aggira per l’Italia (nota per Orfini: la citazione non è da una canzone di Pupo), è il fantasma del congresso Pd. Non c’è intervista a senatore, deputato, segretario, militante, elettore, cuciniere, maniscalco, simpatizzante del Pd che non contenga questa domanda: e il congresso? Lo farete? Quando? Dove? Chi saranno i candidati? Consapevoli che la democrazia ha bisogno di grandi momenti di confronto, il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Psichiatria ha elaborato alcuni scenari possibili.
Un fantasma si aggira per l’Italia (nota per Orfini: la citazione non è da una canzone di Pupo), è il fantasma del congresso Pd. Non c’è intervista a senatore, deputato, segretario, militante, elettore, cuciniere, maniscalco, simpatizzante del Pd che non contenga questa domanda: e il congresso? Lo farete? Quando? Dove? Chi saranno i candidati? Consapevoli che la democrazia ha bisogno di grandi momenti di confronto, il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Psichiatria ha elaborato alcuni scenari possibili.
La location.Già si litiga sul luogo che ospiterà il grande confronto tra renzisti e non renzisti Sarebbe ottimo celebrare il congresso in un posto dove il Pd ha vinto qualcosa negli ultimi tre anni, ma vai a trovarlo. Gli zingarettiani vorrebbero la capitale, i renziani preferirebbero Firenze, magari una di quelle vie centrali dove il sindaco Nardella ha vietato lo “stazionamento in piedi” per mangiare il panino. Non si escludono scenari più suggestivi, tipo un rifugio sulle Dolomiti, o addirittura un’isola deserta nel mar dei Sargassi. “Un posto dove nessuno ci conosce sarebbe ideale”, dice un deputato che preferisce restare anonimo. Il vantaggio sarebbe la vendita dei diritti di un nuovo format tv: l’Isola dei Fumosi.
Armi consentite.Sarà in ogni caso un confronto franco e senza infingimenti, per cui è quasi certo il divieto di introdurre armi da fuoco. Si potrà però portare il telefonino, il che autorizza a pensare che le aggressioni non mancheranno. Già è partito sul web un discreto linciaggio di Zingaretti da parte di ultras renziani; si prevede, durante il dibattito, una recrudescenza di accuse: dal furto di bestiame al cannibalismo, chi non si schiera con Renzi avrà la sua dose. Per chi volesse affrontare la discussione con armi analogiche e non digitali, consentite padelle in ghisa, olio bollente e cerbottane con dardi avvelenati.
I candidati.E’ ormai certo che da una parte ci sarà il governatore del Lazio Zingaretti, e dall’altra un pupazzo a caso scelto da Matteo Renzi, che ancora però non ha deciso. Tra i nomi che circolano ci sarebbero Richetti, Bonaccini e Minniti, un Salvini che non ce l’ha fatta. Le linee di pensiero sono però piuttosto chiare: da una parte chi vuole operare una decisa autocritica nel tentativo di recuperare parte degli elettori fuggiti; dall’altra chi accusa della sconfitta gli hacker russi, il meteo, il destino, l’oroscopo di Branko e Maga Magò.
Come si vota. Per tradizione, la conta si farà per alzata di mano. Non stupisce quindi l’accordo della fondazione Open con una grande azienda Biotech di Singapore per produrre entro la data utile un centinaio di delegati con tre braccia.
Sì, ma quando?Per ora il dibattito si concentra sulle date. Prima delle europee ma dopo Roma-Juve, dice qualcuno. Altri rilanciano: il secondo giovedì di marzo dalle 14 alle 14.30. I renziani più intransigenti spingono per aprire il congresso il 18 maggio, data di nascita dello zar Nicola II, un riformista che quei cattivi della sinistra-sinistra non lasciarono lavorare, e poi si è visto com’è andata.
Intrattenimento.Non di sola politica vive il delegato Pd. Al congresso non mancheranno momenti di svago, concerti, proiezioni e persino eventi sportivi. Molto atteso il duello di ketch nel fango tra Carlo Calenda e Michele Emiliano, finora disputatosi solo su twitter.
Lo slogan.Qui le previsioni si fanno difficili. Scartata l’ipotesi di ingaggiare un guru della comunicazione come Jim Messina, la componente renziana sta valutando frasi celebri dei più grandi miti del suo Pantheon: Emmanuel Macron, il senatore repubblicano appena deceduto John McCain, o Sergio Marchionne, l’amico degli operai. Alla fine si opterà per una soluzione più neutra, un semplice hashtag e una frase breve, tipo #Popcorncenèancora?
 C’è un certo sollievo nella fine dell’estate: l’afa sparisce, le zanzare se ne vanno, Salvini si riveste. Ma resta sempre qualcosa nell’aria, un sapore, un ricordo, un hashtag. Per esempio la gente torna in città, fa il pieno e paga la benzina come e più di prima, perché il tizio seminudo che aveva promesso come prima cosa di togliere le accise sulla benzina se n’è dimenticato. Così molti fanno il pieno bestemmiando, ma non contro lo smemorato dei selfie, il bevitore di moijto, il divoratore di mozzarelle, il guidatore di moto d’acqua, ma contro “i negri” che ci rubano il lavoro. Mah, sarà perché siamo distratti: stiamo osservando incantati, anche un po’ ipnotizzati, un ministro dell’interno che compare in ogni istante seminudo con le sue domandine: siete d’accordo? Siete come me? Vi piaccio? E’ un circolo vizioso di depressione. Dicono gli esperti di media che Salvini fa così per diffondere il messaggio: “Visto, italiani? Io sono come voi”. E’ così che subentra o scoramento: cazzo, siamo veramente così scemi? Crisi di identità. E anche miopia, perché le statistiche dicono che l’italiano medio non si fa un mese di vacanza ora al mare, ora ai monti, ora in barca, ora a cena, ora con la torta (la torta nella notte della strage di Genova, tra l’altro, tra canti e brindisi felici). Visto?, è come noi! Anzi, pure peggio, il che dovrebbe rassicurare sugli ampi margini di peggioramento dell’italiano medio.
C’è un certo sollievo nella fine dell’estate: l’afa sparisce, le zanzare se ne vanno, Salvini si riveste. Ma resta sempre qualcosa nell’aria, un sapore, un ricordo, un hashtag. Per esempio la gente torna in città, fa il pieno e paga la benzina come e più di prima, perché il tizio seminudo che aveva promesso come prima cosa di togliere le accise sulla benzina se n’è dimenticato. Così molti fanno il pieno bestemmiando, ma non contro lo smemorato dei selfie, il bevitore di moijto, il divoratore di mozzarelle, il guidatore di moto d’acqua, ma contro “i negri” che ci rubano il lavoro. Mah, sarà perché siamo distratti: stiamo osservando incantati, anche un po’ ipnotizzati, un ministro dell’interno che compare in ogni istante seminudo con le sue domandine: siete d’accordo? Siete come me? Vi piaccio? E’ un circolo vizioso di depressione. Dicono gli esperti di media che Salvini fa così per diffondere il messaggio: “Visto, italiani? Io sono come voi”. E’ così che subentra o scoramento: cazzo, siamo veramente così scemi? Crisi di identità. E anche miopia, perché le statistiche dicono che l’italiano medio non si fa un mese di vacanza ora al mare, ora ai monti, ora in barca, ora a cena, ora con la torta (la torta nella notte della strage di Genova, tra l’altro, tra canti e brindisi felici). Visto?, è come noi! Anzi, pure peggio, il che dovrebbe rassicurare sugli ampi margini di peggioramento dell’italiano medio.
Ora che viene l’autunno e che dovrà rivestirsi, cosa s’inventerà? Mi aspetto da un momento all’altro Salvini che riga la macchina del vicino che gli sta antipatico, che piscia in ascensore, che pesa due pere in meno al supermercato e le aggiunge al sacchetto dopo aver attaccato lo scontrino. Perché? Perché “è come noi”, cioè ci dice indirettamente che siamo delle merde.
Forte coi deboli (177 povericristi sequestrati su una nave) e debole con i forti (i Benetton gli vanno bene, basta che tirino fuori un po’ di soldi), Salvini apre un notevole problema ai suoi alleati di governo, quelli che hanno il 32 per cento e si comportano con lui come se avessero il 17, mentre lui ha il 17 e si comporta come se avesse il 32. I quali alleati di governo, i 5stelle, si affannano nella spasmodica ricerca di qualcosa che riesca a rubargli per un po’ la scena e i riflettori. E’ qui che impazza il dibattito: possibile che dodici milioni di elettori 5stelle siano tutti sdraiati sulla linea Salvini? Possibile che il ministro dell’interno faccia anche il ministro degli esteri, dell’economia, della sanità, dei trasporti e di tutto quanto? Ci vuole ancora molto perché i ministri 5stelle si accorgano che non sono “i negri” che gli rubano il lavoro, ma un ragazzotto a torso nudo che usa le frasi del Duce e lancia una provocazione via l’altra? Come se ne esce?
Ovvio che non può fare tutto questo da solo. Ha una nutrita pattuglia di balilla e piccole italiane che sostengono il suo pensiero debole. Esempio tipico, il vecchio, caro “prendili a casa tua” (sempre i famosi “negri”), con l’aggiunta che in Italia ci sono dieci milioni di poveri (che naturalmente i ritwittatori del tizio desnudo non si sognano nemmeno di “prendere a casa loro”). Così finalmente si scopre a cosa servono gli italiani sotto la soglia di povertà: a giustificare il sequestro di profughi torturati e violentati richiedenti asilo. In compenso, sempre per aiutare i poveri italiani, si propone la flat tax per tagliare le tasse ai milionari. Non fa una piega e chiude il cerchio: si sventolano i poveri per aiutare i ricchi. Quando i 5stelle si accorgeranno che il ragazzotto seminudo gli sta scavando la terra sotto i piedi e se li mangia sarà sempre troppo tardi: una vita passata a dire che uno vale uno e poi ecco che si scopre che il peggiore di tutti vale due, tre, quattro, e tutto al cocuzzaro. Amen
 La macchina del tempo esiste, è qui, funziona a meraviglia, la stessa meraviglia con cui si può leggere oggi un dibattito che andava fatto trent’anni fa, quello sulle privatizzazioni, sul meno-Stato-più-mercato, quello sui carrozzoni pubblici che, sostituiti dall’illuminata gestione dei privati, avrebbero dovuto diventare luccicanti carrozze di prima classe. Si potrebbe dire, pasolinianamente, “Io so”, ma non c’è bisogno di arrivare a tanto: basta un più modesto “io ricordo”. Ricordo molto bene (ahimé facevo già questo mestiere) le accuse a chi si opponeva alle privatizzazioni di tutto e di tutti. Le accuse di comunismo, di statalismo, di arretratezza e miopia riservate a chi si opponeva alle svendite di patrimoni pubblici e alle concessioni donate in allegria. Di contro, ricordo le odi al mercato che tutto sistema e tutto regola come per magia. C’è stato un periodo, nella nostra storia recente, in cui se solo ti azzardavi a dire che lo Stato doveva fare lo Stato e gestire i suoi beni (possibilmente con correttezza, senza assumere per forza i cugini dei cognati), venivi trattato come un VoPos della Germania dell’est posto a difesa del muro, un pericoloso comunista pronto a entrare nel Palazzo d’Inverno sfasciando i preziosi lampadari e sporcando i tappeti. Fu in quegli anni che si diffuse come l’epidemia di Spagnola l’uso indiscriminato della parola “liberale”. Tutto diventava liberale, così come tutto doveva diventare privato, e se qualcuno si metteva un po’ di traverso niente sconti: l’accusa terribile era quella di essere contro la modernità, reato gravissimo. “Statalista” suonava come “pedofilo”, come “brigatista”: pubblico ludibrio e risate di scherno. Non se ne fa qui una questione di schieramenti: destra e sinistra unite nella lotta, chi più chi meno, chi a suo modo, chi tentando di umanizzarlo e chi spingendolo al massimo dei giri, chi dicendo che andava regolato almeno un poco, chi diceva che era meglio lasciarlo libero e bello. Ma il pensiero unico di cui tanto si parla cominciò lì: il mercato non era una cosa discutibile, prendere o lasciare. Cadevano muri e ideologie, e ne rimaneva in piedi una soltanto: il mercato.
La macchina del tempo esiste, è qui, funziona a meraviglia, la stessa meraviglia con cui si può leggere oggi un dibattito che andava fatto trent’anni fa, quello sulle privatizzazioni, sul meno-Stato-più-mercato, quello sui carrozzoni pubblici che, sostituiti dall’illuminata gestione dei privati, avrebbero dovuto diventare luccicanti carrozze di prima classe. Si potrebbe dire, pasolinianamente, “Io so”, ma non c’è bisogno di arrivare a tanto: basta un più modesto “io ricordo”. Ricordo molto bene (ahimé facevo già questo mestiere) le accuse a chi si opponeva alle privatizzazioni di tutto e di tutti. Le accuse di comunismo, di statalismo, di arretratezza e miopia riservate a chi si opponeva alle svendite di patrimoni pubblici e alle concessioni donate in allegria. Di contro, ricordo le odi al mercato che tutto sistema e tutto regola come per magia. C’è stato un periodo, nella nostra storia recente, in cui se solo ti azzardavi a dire che lo Stato doveva fare lo Stato e gestire i suoi beni (possibilmente con correttezza, senza assumere per forza i cugini dei cognati), venivi trattato come un VoPos della Germania dell’est posto a difesa del muro, un pericoloso comunista pronto a entrare nel Palazzo d’Inverno sfasciando i preziosi lampadari e sporcando i tappeti. Fu in quegli anni che si diffuse come l’epidemia di Spagnola l’uso indiscriminato della parola “liberale”. Tutto diventava liberale, così come tutto doveva diventare privato, e se qualcuno si metteva un po’ di traverso niente sconti: l’accusa terribile era quella di essere contro la modernità, reato gravissimo. “Statalista” suonava come “pedofilo”, come “brigatista”: pubblico ludibrio e risate di scherno. Non se ne fa qui una questione di schieramenti: destra e sinistra unite nella lotta, chi più chi meno, chi a suo modo, chi tentando di umanizzarlo e chi spingendolo al massimo dei giri, chi dicendo che andava regolato almeno un poco, chi diceva che era meglio lasciarlo libero e bello. Ma il pensiero unico di cui tanto si parla cominciò lì: il mercato non era una cosa discutibile, prendere o lasciare. Cadevano muri e ideologie, e ne rimaneva in piedi una soltanto: il mercato.
Ora che anche fior di liberali ammettono che “alcune privatizzazioni” sono state fatte male, in fretta, con l’ansia di far cassa e senza alcuna strategia o prospettiva storica, con pochi controlli, con un orribile consociativismo tra chi concedeva e chi prendeva le concessioni, non c’è da provare nessuna soddisfazione: i buoi sono scappati, la stalla è stata spalancata per trent’anni, chiudere le porte ora sarà probabilmente una pezza piccola su un buco enorme. E anche questa concessione all’evidenza rischia di sembrare furbetta e funzionale: si ammette che qualcosa è andato storto per affermare, in sostanza, che il disegno è giusto ma c’è stata qualche sbavatura.
Intanto il famoso mercato lo abbiamo visto in azione: in trent’anni ci ha regalato un paio di crisi durate dieci anni ognuna, un restringimento dei diritti (non ultimo quello di passare un ponte senza pregare tutti i santi), una precarizzazione di massa, la proletarizzazione dei ceti medi e tutto il resto che sappiamo. Il tutto accompagnato – in Italia – dalla vulgata (oggi si direbbe “narrazione”) che il pubblico era antico e il privato moderno. Poi, oggi, si trasecola apprendendo dagli schemini dei giornali che in Germania le autostrade sono pubbliche e gratuite, per dirne una, e nessuno si sogna, lassù, di pensare ai Land tedeschi come a repubbliche staliniste pronte a fucilare i dissidenti o a mandarli in Siberia. Oggi pare che si possa ricominciare a parlarne, ma il timore è che lo si faccia solo perché bisogna rimettere a posto i guasti dei famosi privati. Insomma, privato quando c’è da incassare e pubblico quando c’è da rimettere insieme i cocci.
Un’intervista su quel che accade, dai barconi al fascio-salvinismo, su noi e loro, su come battere contrastare il razzismo. Fabio Poletti mi ha intervistato per Radici Online. Cliccare sull’immagine per leggere.
 Buon ferragosto, questa specie di Capodanno estivo dove tutti devono divertirsi per forza, tempo di pantagrueliche mangiate. Un giorno in cui il Paese intero ha facoltà istituzionale di comportarsi come una seconda media, il che, diciamolo, per molti è una promozione inaspettata. Solo alcuni gavettoni turberanno la giornata. Ecco i principali.
Buon ferragosto, questa specie di Capodanno estivo dove tutti devono divertirsi per forza, tempo di pantagrueliche mangiate. Un giorno in cui il Paese intero ha facoltà istituzionale di comportarsi come una seconda media, il che, diciamolo, per molti è una promozione inaspettata. Solo alcuni gavettoni turberanno la giornata. Ecco i principali.
Casapound invade la Polonia. Eccitati dalle cronache dei giornali che parlano di loro, gli arditi di Casa Pound commettono un grave errore: pensano di esistere veramente. Dopo averli visti ad Ostia dispiegare la loro geometrica potenza contro un paio di venditori di cocco fresco, le loro azioni sembrano in crescita: esattamente come novant’anni fa quando menavano i contadini per far contenti gli agrari. Ma ora questo non basta più e oggi festeggeranno il Ferragosto sempre in spiaggia, chiedendo ai bagnanti di sfilarsi le fedi dalle dita e regalare oro alla patria per costruire l’impero. Poi passeranno alle vie di fatto: prima la Polonia, poi Grecia e Albania, a spezzare reni qui e là. Per la campagna di Russia aspettano l’inverno, così potranno andare sul Don a meno quaranta gradi con le infradito, rispettando la tradizione fascista che li ispira. Complice l’estate, mostreranno al volgo spiaggiato i loro tatuaggi, soprattutto il volto di un signore pelato che venne fucilato mentre scappava in Svizzera con l’amante e qualche complice, che è un po’ come tatuarsi sul petto Wile Coyote.
Salvini mette la maglietta.Foto con mozzarella e senza mozzarella, con moto d’acqua e senza moto d’acqua, con fidanzata e senza fidanzata, con frittura di pesce e senza frittura di pesce, con mojito e senza mojito. Ma oggi Salvini ha deciso di stupire tutti e si è metterà una maglietta. Un vero peccato, perché le sue foto da un mese a questa parte erano l’unica occasione di vedere un topless (porta una seconda). Va detto: Salvini in maglietta (di solito usa magliette stampate da simpatizzanti nazisti) è una delusione: sembra un fesso normale invece di sembrare un fesso seminudo, tipo il buffone di cui sopra alla battaglia del grano. Continua però indefessa la sua battaglia di civiltà: cacciare dalle spiagge venditori di asciugamani e di collanine, mentre sulle spiagge di Calabria si può assistere a divertenti sparatorie tra mafiosi in mezzo ai bagnanti. Servirebbe un ministro dell’Interno, e invece abbiamo ogni giorno il paginone con miss Agosto Sovrappeso. Come gavettone agli italiani, niente male.
Il ritorno di Renzi. Tra i più riusciti gavettoni di questo Ferragosto c’è la terribile minaccia dell’altro Matteo: sta per tornare, forse si candiderà al congresso del Pd, perché è uno che non vuole lasciare il lavoro a metà e il 18 per cento gli sembra ancora troppo. Prima, però, farà qualche passaggio in tivù, per dire a tutti come lui, la Boschi e Lotti hanno rilanciato Firenze durante il Rinascimento, rendendola quella che è oggi: una città governata da Nardella. Dicono le cronache che per dispiegare la sua verve divulgativa affitterà la piazza principale del paese, dove spiegherà – prendendosene i meriti – le belle cose che fecero i Medici cinque secoli e mezzo prima di perdere il referendum istituzionale. E’ sicuro che, visto il suo documentario storico, tutti gli italiani torneranno ad essere innamorati di lui. Un auto-gavettone, insomma.
Lo sciopero dei padroni.Grande idea ferragostana del presidente di Confindustria Boccia, che minaccia una possibile mobilitazione di piazza degli imprenditori italiani. Si temono scontri. Oltre al fitto lancio di Rolex contro le forze dell’ordine (un classico) c’è forte preoccupazione per i costi dell’iniziativa. Qualcuno già propone di delocalizzare la manifestazione in Romania, Serbia o Albania, dove i foulard Hermès per coprirsi il volto durante gli scontri costano meno.
A proposito di propaganda e di fake news. Il pezzo su Tony Nelly pubblicato ieri su Il Fatto Quotidiano (lo leggete qui) ha avuto una rettifica, che metto qui sotto, come si deve ed è giusto fare. In pratica emerge che tutte le cose raccontate da Tony Nelly (si chiama Simone B.) sulla banca che non gli rinnova il contratto per colpa del decreto dignità sono stupidaggini inventate: se n’è andato dalla banca nel febbraio 2017, prima delle elezioni, quando il decreto dignità non esisteva. Una vera fake news, insomma, che però è stata usata in sede di propaganda (Ecco! Di Maio fa licenziare i lavoratori!). Spiace che chi ha messo in grandissima evidenza il caso, usandolo come caso di scuola, ci sia cascato con tutte le scarpe. Anche chi ha commentato (tifando per la banca contro il lavoratore, peraltro, pur di attaccare una norma che dice che bisogna assumere dopo 24 mesi di precariato e non dopo 36, incredibile) dovrà prendere atto che la bandiera che ha sventolato conteneva falsità grossolane. Il mio pezzo di ieri cominciava così: “Piccola storia di lavoro e propaganda, storia triste, ma anche istruttiva lezione sui media, minuscolo apologo su come va il mondo, o come lo si vorrebbe far andare”. Ecco, ora l’apologo è completo. Una lezione per chi (grandi giornali o semplici lettori) hanno preso un caso (falso) per sostenere una cosa che gli faceva comodo politicamente. A Simone B., nonostante il falso ideologico creato (con il suo tweet e con le successive interviste), auguro di trovare un lavoro al più presto, ma soprattutto di capire dove sta il nemico, senza fare lo zio Tom che sta con il padrone delle piantagioni. Istruttivo, parecchio.
 Piccola storia di lavoro e propaganda, storia triste, ma anche istruttiva lezione sui media, minuscolo apologo su come va il mondo, o come lo si vorrebbe far andare.
Piccola storia di lavoro e propaganda, storia triste, ma anche istruttiva lezione sui media, minuscolo apologo su come va il mondo, o come lo si vorrebbe far andare.
Dunque si parte da un tweet. Un giovane denuncia: perde il rinnovo del contratto (viene di fatto licenziato) per colpa di Di Maio e del decreto dignità. Tweet molto polemico (giusto: la polemica è un diritto inalienabile). In pratica è disoccupato per colpa delle (minima) riforma della legge sul lavoro. Ha quasi finito i ventiquattro mesi di contratti a termine e ora la legge dice che non si può rinnovare oltre (non trentasei mesi come prima) e che il lavoratore va assunto, ma quelli non lo assumono e interrompono la collaborazione. Il nome social del giovane è Tony Nelly, il che già fa un po’ ridere. Ancora più ridere è che diventi un caso nazionale grazie alle home page di grandi giornali che ne rilanciano l’accorata denuncia nonostante il nickname evidentemente irrisorio (giusto: irridere è un diritto inalienabile).
Insomma, Tony Nelly diventa in un giorno il simbolo del governo che cancella posti di lavoro, accompagnato dalla ola dei commenti indignati. Ecco Repubblicache corre a intervistare il ragazzo (si chiama Simone, ha 32 anni), che spiega: lavorava da due anni, doveva essere assunto, glielo hanno promesso, poi, quando è passato il decreto dignità, la sua responsabile l’ha convocato e gli ha detto che non lo avrebbero fatto perché “un’assunzione a tempo indeterminato rischierebbe di ingessare troppo l’azienda” (parole sue, virgolette e tutto).
Il messaggio è chiaro: stabilire che dopo 24 mesi in azienda uno deve essere assunto invece di farsi altre 12 mesi da precario ingessa le aziende. Vergogna! Uno già si immagina la scena, abbastanza strappacuore: il datore di lavoro che convoca il giovane, gli spiega che l’aziendina è piccola, che non può sopportare il peso di un altro contratto fisso, che gli spiace molto, ma è colpa del decreto Di Maio, e lo lascia per strada. Ma la faccenda non finisce lì. Tony Nelly (Simone) diventa una specie di bandiera, un caso di scuola di come la riduzione dei rinnovi dei contratti a termine sia una specie di cianuro per l’economia, la gente vuol saperne di più. Così ecco approfondimenti e interviste, e lo sventurato rispose. Si scopre che Tony Nelly lavora in un grande gruppo bancario, Cariparma Crédit Agricole, che sbandiera sui suoi siti di avere 52 milioni di clienti in 50 paesi del mondo. Riassumo: un gruppo bancario di dimensioni planetarie sarebbe ingessato dall’assunzione di un giovane che ha già lavorato per loro due anni, che forse avrebbe (da precario) lavorato anche il terzo anno, e invece no: rischio ingessamento, ciao ciao, avanti un altro precario per altri 24 mesi.
Tony Nelly, insomma, è una ciambella della propaganda non riuscita, venuta senza il buco, peccato. Sembrava un così bel caso di scuola e invece è diventato un boomerang, perché che una grande banca mondiale si “ingessi” assumendo uno che lavora per loro da due anni è un po’ incredibile. Dunque diciamo che il grande gruppo mondiale ha preso la palla al balzo e ha usato un decreto del governo come scusa, e che Tony Nelly, invece di prendersela col governo cattivo (che è cattivo per altri migliaia di motivi, ma non per questo) avrebbe tutte le ragioni per prendersela con il suo (ex) datore di lavoro. Invece prevale la sindrome dello Zio Tom: dalla sua capanna difende il padrone della piantagione. Fine della triste storia.
Naturalmente si augura a Simone-Tony Nelly di trovare un lavoro quanto prima, magari un lavoro vero, che non lo costringa a pietire rinnovi anno dopo anno. E anche, magari, che pensi un po’ più ai suoi diritti e meno ai poveri datori di lavoro che “si ingessano” se lo assumono, anche se hanno 52 milioni di clienti in 50 paesi del mondo.
 Il ministro del disonore Matteo Salvini, quello che cita Mussolini, nega l’escalation razzista nel paese, teorizza l’autodifesa a colpi di pistola, comunica come un troll provocatore, leone da tastiera di rara ignoranza ma con in mano il ministero della sicurezza, copre il paese di vergogna in tutto il mondo e ci deve quarantanove milioni di euro rubati dai soci suoi predecessori, è un sintomo grave della febbre italiana. Attenzione, non la causa della malattia, un sintomo. Ciò non significa sminuirne la portata: anche un feroce mal di testa è un sintomo, e infatti lo si combatte, ma un bravo medico non si limiterà a farvi passare il mal di testa con qualche aspirina, ne cercherà la causa in modo che il mal di testa non vi venga più.
Il ministro del disonore Matteo Salvini, quello che cita Mussolini, nega l’escalation razzista nel paese, teorizza l’autodifesa a colpi di pistola, comunica come un troll provocatore, leone da tastiera di rara ignoranza ma con in mano il ministero della sicurezza, copre il paese di vergogna in tutto il mondo e ci deve quarantanove milioni di euro rubati dai soci suoi predecessori, è un sintomo grave della febbre italiana. Attenzione, non la causa della malattia, un sintomo. Ciò non significa sminuirne la portata: anche un feroce mal di testa è un sintomo, e infatti lo si combatte, ma un bravo medico non si limiterà a farvi passare il mal di testa con qualche aspirina, ne cercherà la causa in modo che il mal di testa non vi venga più.
Salvini è il prodotto, confezionato con fiocchetti e bandierine tricolori (quella con cui il suo ex capo si puliva il culo), di tutti i cucchiaini di merda ingurgitati in anni e anni di storia italiana, di tattiche cretine, di strategie miopi e fascistogene che premiavano ricchi, benestanti e classi dirigenti a discapito di poveri, proletari e piccola borghesia. Il classismo implacabile e accuratamente innaffiato in decine di anni (e Berlusconi, e Monti, e Renzi… molte chiacchiere e molti distinguo, ma la curva delle diseguaglianze è rimasta perfettamente costante), ha acceso piccoli fuochi, e ora arriva Salvini a soffiarci sopra per mera convenienza politica e cinismo. Le classi dirigenti che ci hanno ammorbato per decenni con le loro parole d’ordine campate per aria, meritocrazia, competizione, mercato, liberismo, o negando qualunque dignità al conflitto di classe, o introducendo la favoletta bella che “siamo tutti sulla stessa barca”, industriali e lavoratori, start-up miliardarie e precari, finte cooperative e schiavi, hanno indebolito l’organismo, e ora che arriva il virus e non trova anticorpi, fingono preoccupazione.
Capisco che tirare in ballo la cultura, la letteratura, il grande cinema, al cospetto di coloro che ritengono gli intellettuali un ingombro fastidioso e privilegiato sia tempo perso. Ma va ricordato lo stesso che i migranti economici di Steinbeck che andavano dall’Oklahoma alla California venivano bastonati da sfigati poveracci come loro; e quando, in Mississippi Burning, l’agente federale Gene Hackman andava a fare il culo ai razzisti che linciavano i neri, non trovava agrari e latifondisti, ma povericristi spiantati e ignoranti come la merda. Sono proprio le basi, porca miseria: se hai vissuto nel continente del nazifascismo dovresti sapere già dalle elementari che il trucco per tener buoni i penultimi è renderli furiosi con gli ultimi e aizzarglieli contro. Questo è quello che sta facendo il ministro del disonore Salvini: portare taniche di benzina verso l’incendio, che arde già da un bel po’.
Ora, è vero, bisogna eliminare il sintomo. Lo si fa applicando coi fatti quello che per anni si è detto a parole, cioè contrastando la barbarie strada per strada, autobus per autobus, fila alla posta per fila alla posta. Zittendo quelli che credono di sollevarsi dalla loro condizione prendendosela con chi sta peggio di loro, invece di rivendicare reddito e diritti da chi sta meglio. Significa parteggiare in modo militante per chi cerca dignità, e non essere indifferenti o distratti quando qualcuno gliela vuole togliere. Intanto – non invece, intanto – bisogna ricostruire dalle basi. Che significa costruire davvero, non rimettere in piedi con il nastro adesivo strutture già crollate. Se Salvini e i suoi arditi sono un problema – lo sono – è perché le élite di questo paese hanno miseramente fallito, lavorando unicamente per la salvaguardia di se stesse e non per tutti quanti. Combattere loro e combattere Salvini è la stessa battaglia. Che sia lunga e difficile non è un buon motivo per non farla.
 Se si scava con pazienza, con tenacia, se si spostano come piccoli massi che ostruiscono lo scavo le cretinate feroci dei troll della rete, se si solleva con un paranco la massa inerte dell’agiografia obbligatoria; insomma se si va al nocciolo della faccenda, molto sotto la superficie del chiacchiericcio social o a mezzo stampa, si vedrà che le diverse valutazioni su Sergio Marchionne contengono un dibattito tutt’altro che banale. Il dibattito sul capitalismo – italiano e non – che si vorrebbe far passare per una querelle datata e novecentesca e che invece sta lì, a bruciare sotto la cenere fredda.
Se si scava con pazienza, con tenacia, se si spostano come piccoli massi che ostruiscono lo scavo le cretinate feroci dei troll della rete, se si solleva con un paranco la massa inerte dell’agiografia obbligatoria; insomma se si va al nocciolo della faccenda, molto sotto la superficie del chiacchiericcio social o a mezzo stampa, si vedrà che le diverse valutazioni su Sergio Marchionne contengono un dibattito tutt’altro che banale. Il dibattito sul capitalismo – italiano e non – che si vorrebbe far passare per una querelle datata e novecentesca e che invece sta lì, a bruciare sotto la cenere fredda.
Sono cose complicate e antiche, per esempio il conflitto tra capitale e lavoro, una cosuccia che non si è risolta negli ultimi duecento anni, da Karl Marx in poi, e che non si risolverà certo ora a colpi di tweet. Le fazioni, però, sono ben delineate: chi ringrazia Marchionne per aver applicato certi standard del capitalismo moderno – molta finanza, molte delocalizzazioni, molto globalismo, compreso portare la sede legale qui, la sede fiscale là, ma mai più in Italia. E chi, dall’altra parte, vede l’ammazzasette delle relazioni sindacali, i licenziamenti e lo sfoltimento della forza lavoro, la riduzione delle pause alla catena di montaggio per la mensa o per pisciare, la pretesa di fare un sindacato giallo e tagliare fuori dagli accordi chi combatte sul serio.
Per qualche anno, la questione è passata come un conflitto tra “moderno” e “antico”. Stupidaggini, perché il problema è ancora quello di capire se questa “modernità” ci piace e ci conviene o se piace e conviene a pochissimi. Per dire, nella gestione Marchionne oltre ventimila posti di lavoro in Fca sono evaporati: ventimila famiglie lasciate senza un reddito a fronte di una famiglia che ha salvato la baracca (gli Agnelli e successive modificazioni) e di alcune che hanno moltiplicato risparmi e investimenti (gli azionisti). Insomma, la vecchia, cara lotta di classe, che oppone chi ha molto e chi ha poco.
Al centro di questo dibattito di lungo respiro c’è un’emergenza costante e visibile a tutti, che è l’aumento delle diseguaglianze. Per dirne una e giocare con il paradosso, si ricorda che Valletta, storico amministratore delegato Fiat, negli anni Cinquanta, guadagnava come quaranta operai e Marchionne invece come più di duemila (vale anche per calciatori, divi di vario genere, eccetera eccetera). Cioè la forbice tra rendita e lavoro, tra profitti e salari si è allargata in modo indecente e inaccettabile, eppure accettata di buon grado anche a sinistra. Caliamo un velo pietoso sulle scempiaggini renziane a proposito di Marchionne e del marchionnismo, ma è certo che una corrente filosofica filopadronale è egemone da anni. L’idea un po’ balzana è che aiutando i ricchi (sgravi, favori, decontribuzioni, forse addirittura flat tax…) si aiutino, diciamo così, a cascata, anche i poveri. Che se la tavola dei ricchi è ben imbandita, qualche briciola cadrà sotto il tavolo, una manna per chi non ha niente, o poco.
Quando si fa notare che questo paradosso non ha funzionato, che i ricchi sono più ricchi e i poveri più poveri (vedere l’indice Gini sulla diversità, siamo in testa alle classifiche, per una volta), la risposta è standard: si allargano le braccia e si dice “è il mercato che governa il mondo”, intendendo una forza potente, libera e incontrollabile che decide le cose (è il terremoto, è lo tsunami, cosa vuoi farci) e che non può essere regolata. Ecco. Il nucleo, sotto la tempesta di reazioni alla fine dell’era Marchionne, è questo: il mercato è immutabile e incontrollabile come conviene a pochi, oppure si può governarlo come converrebbe a molti? Bella domanda, alla faccia della solita solfa sulla morte delle ideologie. Il resto – dalle agiografie agli insulti – è rumore di fondo.
 C’è grande attesa nel Paese per l’avviarsi (questa settimana) dell’iter della riforma della legittima difesa, e come su tutto quanto (immigrazione, giardinaggio, economia, lavori all’uncinetto, scienza aerospaziale, cucina vegana, creme solari, prodotti dop, miele biologico), la linea la detta il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sono i vantaggi di chi non lavora mai: può avere molti hobby. E’ noto il pensiero di Salvini: troppe rogne, processi, spese per avvocati, per chi ammazza a fucilate qualcuno che gli sta rubando un soprammobile in salotto. La lobby dei produttori e venditori di armi è naturalmente favorevole: un milione e 398.920 licenze per porto d’armi sembrano poche per un paese di sessanta milioni di abitanti, e l’Italia resta in posizione di inferiorità rispetto al Texas, dove sono armati anche gli embrioni, o luoghi pacifici come la Libia. Ecco alcune norme di buon senso che la riforma dovrebbe recepire.
C’è grande attesa nel Paese per l’avviarsi (questa settimana) dell’iter della riforma della legittima difesa, e come su tutto quanto (immigrazione, giardinaggio, economia, lavori all’uncinetto, scienza aerospaziale, cucina vegana, creme solari, prodotti dop, miele biologico), la linea la detta il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sono i vantaggi di chi non lavora mai: può avere molti hobby. E’ noto il pensiero di Salvini: troppe rogne, processi, spese per avvocati, per chi ammazza a fucilate qualcuno che gli sta rubando un soprammobile in salotto. La lobby dei produttori e venditori di armi è naturalmente favorevole: un milione e 398.920 licenze per porto d’armi sembrano poche per un paese di sessanta milioni di abitanti, e l’Italia resta in posizione di inferiorità rispetto al Texas, dove sono armati anche gli embrioni, o luoghi pacifici come la Libia. Ecco alcune norme di buon senso che la riforma dovrebbe recepire.
Sparare ai ladri in casa. Naturalmente si potrà sparare ai ladri in casa. Una norma un po’ ambigua perché non si capisce a casa di chi. “Ma a casa dei ladri!”, chiarisce subito Salvini. In pratica, il bravo cittadino italiano con un vicino rumeno, o straniero in generale, potrà bussare, aspettare che qualcuno apra e poi freddarlo sul ballatoio. Si tratta di un criterio allargato di legittima difesa, interpretato in chiave meno restrittiva. Se poi risulterà che il morto non era un ladro ma un’onestissima persona, l’imputato non avrà diritto al rimborso del proiettile, che dovrà pagare coi suoi soldi. “Norma troppo punitiva – dice Salvini – la cambieremo”.
Bonus pistole.Sull’esempio del bonus cultura, verranno consegnati ai giovani, al compimento del diciottesimo anno, dei soldi per acquistare armi da fuoco. C’è chi è scettico, perché non è facile mettere in campo controlli e verifiche. “E se poi scopriamo che con quei soldi si comprano un libro? – dice Savini – Norma da rivedere”.
Poligono diffuso.L’aumento del possesso di armi da parte di onesti cittadini che vogliono difendersi dalla criminalità sparando ai bambini che recuperano il pallone finito in cortile necessita un minimo di preparazione balistica. Ma istituire poligoni di quartiere (o di caseggiato, per le zone più popolose) potrebbe essere costoso. La riforma pensata da Salvini vorrebbe ribaltare il concetto e combattere la burocrazia. Basta iscrizioni, domande in carta da bollo, verifica dei documenti. Per allenare la mira, basterà aggirarsi nei dintorni di un campo rom, o di qualche centro per stranieri richiedenti asilo.
Ripresa economica. I benefici di una riforma che liberalizzi l’uso delle armi, come piacerebbe a Salvini e a quelli che le fabbricano, sono anche economici. A parte l’impennata di interventi nella sanità privata (si calcola che il numero di quelli che si sparano in un piede pulendo la Colt aumenteranno del 334 per cento), si prevedono ottime performance per il settore pompe funebri, fioristi, necrologi. La riforma avrà poi un effetto volano: sapendo che lo aspettano armato, anche il ladro di polli comprerà un’arma, innestando un circolo virtuoso per cui tra dieci anni uno dovrà andare in giro con portafoglio, telefono, chiavi della macchina, chiavi di casa, e Glock calibro nove. Torna il borsello.
Prima la famiglia. E’ nota la passione di Salvini per i valori famigliari, infatti ha avuto due o tre famiglie, piazzando sempre mogli e compagne in buoni posti di lavoro grazie alla politica. La riforma tanto caldeggiata guarda dunque alla famiglia con un occhio di riguardo: ammazzare la moglie, la fidanzata, la ragazza che vuole lasciarti, sarà più agevole e non si dovrà più ricorrere a mezzi primitivi come lo strangolamento. “L’ho ammazzata perché non voleva che mi sputtanassi tutto lo stipendio con poker e scommesse”, dopotutto, è legittima difesa.
Esce oggi in e-book il racconto Killer (la gita in Brianza). Era già uscito nell’antologia “Vacanze in giallo” (Sellerio, 2017), e oggi va in giro da solo, a prezzo politico (1.99 euro)
Una bella avventuriera, un cane di quelli tascabili. Tutto normale, no? Il Monterossi dice a Oscar Falcone: “Cos’è, adesso cerchiamo i cani scomparsi?”. Sì, d’accordo, ma poi la cosa si complica. E poi è un racconto fuori da Milano, nella misteriosa Brianza (i milanesi cercano di capirne i confini da secoli, per loro parte da Sesto San Giovanni e arriva alle isole Svalbard). In certi angolini, anche un piccolo omaggio al Gadda che… vabbé, insomma, lo dico: è uno dei racconti usciti finora che ho amato di più, mi sono divertito a scriverlo. Fate voi.
 Urge manuale di conversazione aggiornato per l’estate in società, un manualetto agile, di poche pagine, con gli insulti più à la pagee le loro nuove declinazioni. Un bugiardino che sia possibile sfogliare all’impiedi, persino con le mani bagnate, magari mentre si partecipa al linciaggio di un venditore ambulante sulla spiaggia perché “ci ruba il lavoro” (notoriamente, vendiamo tutti asciugamani e collanine). Ne proponiamo un piccolo sunto, segnalando che i lemmi e le espressioni idiomatiche che si usano a vanvera, a vanverissima e spesso addirittura a cazzo, sono numerose.
Urge manuale di conversazione aggiornato per l’estate in società, un manualetto agile, di poche pagine, con gli insulti più à la pagee le loro nuove declinazioni. Un bugiardino che sia possibile sfogliare all’impiedi, persino con le mani bagnate, magari mentre si partecipa al linciaggio di un venditore ambulante sulla spiaggia perché “ci ruba il lavoro” (notoriamente, vendiamo tutti asciugamani e collanine). Ne proponiamo un piccolo sunto, segnalando che i lemmi e le espressioni idiomatiche che si usano a vanvera, a vanverissima e spesso addirittura a cazzo, sono numerose.
Radical-chic.Termine nobile su cui aleggia una certa confusione data dai tempi. Vi risparmio l’etimologia e l’origine, Tom Wolfe e tutto il resto, veniamo agli usi quotidiani. Radical-chic è oggi, di norma, riferibile a chi non calzi ciabatte di cocomero e si vesta di domopak rubato al supermercato. Il dibattito è se debba prevalere la parte radical o la parte chic. Per essere radical, oggi, basta non amare Salvini o pensare che non si può lasciar morire la gente in mare, e tutto il resto è relativo, anche se siete radical come Don Sturzo. Quanto alla parte chic, si suppone dipenda dal reddito, e/o dagli orologi indossati, e/o dal cachemire d’inverno. E’ possibile dunque lanciare l’insulto praticamente a chiunque mangi due volte al giorno. In sostanza radical è chiunque abbia posizioni appena appena a sinistra del Ku Klux Klan e chic chiunque abbia una situazione economica privata che non lo spinge, per necessità, a scippare una vecchietta.
Sovranista. Insulto uguale e contrario, con una sostanziale differenza: che cosa vuol dire sovranista non lo sa nessuno. Teoricamente sarebbe una variante di “nazionalista”, o un abbellimento gentile del sempre attuale “porco fascista”. Ma sovranista fa in qualche modo intuire che uno si intenda di questioni internazionali, trattati, rapporti di forza, geopolitica avanzata. Poi, siccome spiegare tutte queste cose a un sovranista è difficile (di norma siamo ancora a ma-ti-ta, letto faticosamente tenendo il segno con il dito indice), si risolve con i simboli. E via bandierine accanto all’account: un disastro. Chi mette quella dell’Ungheria, chi quella dell’Irlanda. Ogni tanto si sobbalza esclamando: “Ah, perbacco, ecco un sovranista del Messico!”, invece è solo un pirla che ha sbagliato bandiera. I sovranisti di sinistra si distinguono perché accanto alla bandiera del Messico (o dell’Ungheria, o dell’Irlanda, o persino italiana, quando ci azzeccano) mettono la bandierina blu dell’Europa.
Buonista. Parola talmente inflazionata e lisa che non darebbe conto parlarne. In breve, serve a identificare chiunque abbia una posizione non goebbelsiana nei confronti del mondo. Se non vuoi che il ladro di polli sia impiccato sei buonista. Allo stesso modo se vuoi tirare un salvagente a uno che sta affogando. Ci limiteremo a dire che l’abuso di questo insulto è dettato dall’incattivimento collettivo e dal nervosismo indotto dall’insicurezza sociale, per cui il buonista sembra un nemico degli usi e costumi correnti. L’espressione “buonista” è ormai in fase discendente e si usa spesso a sproposito (tipo “Mussolini fino al ’38 è stato anche buonista”)
Rossobruno. Insulto di recente conio e faticoso adattamento alla situazione italiana. Dovrebbe indicare, teoricamente, uno che è di sinistra (rosso), ma anche un po’ fascio (bruno). Ammesso che esista qualcosa di simile in natura, il termine si è presto snaturato e viene usato dagli ultras di Renzi per indicare chiunque non abbia resistito all’avvento del fascismo nell’unico modo concesso dal loro pensiero binario: votando per Renzi. In generale chi usa l’insulto “rossobruno” si sente forbito, informato e colto – la cosa ammicca a riferimenti storici – il che, ricordiamo a tutti, non vuol dire intelligente.
 Il “decreto dignità” è un brodino che non curerà la polmonite cronica del mondo del lavoro italiano. Però è un brodino – somministrato tra mille pressioni per diluirlo ancora di più – che segue anni di martellate sugli alluci, quindi un passo avanti, un’inversione di tendenza.
Il “decreto dignità” è un brodino che non curerà la polmonite cronica del mondo del lavoro italiano. Però è un brodino – somministrato tra mille pressioni per diluirlo ancora di più – che segue anni di martellate sugli alluci, quindi un passo avanti, un’inversione di tendenza.
Non manca qualche simbologia: tra i primi provvedimenti del governo Renzi (“il più di sinistra degli ultimi trent’anni”, disse lo sventurato) ci fu il decreto Poletti, che era né più né meno uno schiaffone ai lavoratori precari. Tra i primi provvedimenti del governo SalviMaio – tragicamente a trazione leghista – c’è un attenuamento di quello schiaffone. Non c’è il ripristino dell’articolo 18, non c’è un vero superamento del Jobs act scritto e diretto nelle stanze di Confindustria. Però qualche ricaduta sulla vita reale sì, perché se ti licenziano da un impiego fisso devono almeno darti più soldi, perché chi assume a tempo determinato potrà farlo solo in certi casi, per meno tempo, e spiegando perché, e sono solo piccoli esempi. Non piccolissimi, se pensiamo a una famiglia dove uno perde il lavoro: avere come risarcimento una decina di stipendi invece che quattro e cinque (massino 36 invece di 24) fa una certa differenza, a pranzo e a cena, per qualche mese.
Anche nella comunicazione c’è qualche novità. Abituati da anni al cantar vittoria dei perdenti sui dati Istat dell’occupazione (la mia collezione sui tweet del Pd che inneggiano alla disoccupazione che scende tacendo del precariato che aumenta è ben fornita), sentiamo cantare i numeri che il poro Poletti cercava in tutti i modi di taroccare. Su 100 nuovi occupati, 1 ha un lavoro stabile, 4 si sono messi in proprio e 95 sono a termine. Insomma, non c’è niente da festeggiare o da sbandierare in quanto miracoloso, come facevano i rottamatori di se stessi.
A parte la piccola ma significativa inversione di tendenza (per cartina di tornasole si possono osservare le reazioni di Confindustria: come se gli avessero incendiato il garage), non resta che osservare l’orizzonte dove già si intuisce la presenza di un iceberg.
Il decreto dignità (mi permetto di suggerire nomi più sobri, ma questo è un dettaglio) va infatti decisamente in rotta di collisione con il pensiero salviniano, e questo sarebbe il minimo perché sappiamo quanto Salvini cambi pensiero come la biancheria (e forse più spesso, da “Padania is not Italy” a “Prima gli italiani”). Se si esce dai dettagli e si guarda ai blocchi sociali, invece il problema c’è: il primo provvedimento del governo è in controtendenza rispetto al pensiero dominante della destra che Salvini si è mangiata in un boccone. La manina del mercato, il liberismo che più che n’è e meglio è, la solita menata del “lacci e lacciuoli”, insomma la sempiterna litania padronale del “lasciateci fare il cazzo che vogliamo”. E non a caso le reazioni del mondo leghista sono gelide e anzi ostili, Salvini non è andato a una riunione sul provvedimento preferendo fare il pupazzo al Palio di Siena, la Meloni ha parlato di “ispirazione marxista” (come no, e gli alieni atterreranno giovedì) e gli industriali (e i loro giornali) hanno messo su il solito mugugno.
Se esistesse un’opposizione, cosa di cui c’è bisogno come del pane, tenterebbe di infilarsi in questa intercapedine che c’è tra le varie propagande (alcune schifose, come quella anti-umanitaria di Salvini) e i fatti. Vedere che nelle nuove norme sul lavoro c’è una crepa, infilarsi in quella crepa, allargarla, rendere le contraddizioni evidente e poi magari trasformarle in una vera divisione della maggioranza, una divisione di interessi, di blocchi sociali, di appartenenze: chi sta col lavoro, chi sta con capitale. Tutto questo, appunto, se ci fosse un’opposizione e non mangiatori di pop-corn e twittatrori compulsivi del “quando c’eravamo noi, caro lei”.
 A seguito delle indiscrezioni pubblicate dall’organo ufficiale del renzismo (Maria Teresa Meli) e riprese da molti giornali, secondo cui Matteo Renzi starebbe tentando il passaggio alla carriera televisiva, Il Fatto Quotidiano, è in grado di anticipare alcuni dei progetti allo studio nella cantinetta di Rignano sull’Arno, progetti complessi che prevedono anche la nascita di un giornale dedicato alle gesta catodiche dell’ex leader: Sorrisi e Cazzoni Tv. Ecco l’elenco.
A seguito delle indiscrezioni pubblicate dall’organo ufficiale del renzismo (Maria Teresa Meli) e riprese da molti giornali, secondo cui Matteo Renzi starebbe tentando il passaggio alla carriera televisiva, Il Fatto Quotidiano, è in grado di anticipare alcuni dei progetti allo studio nella cantinetta di Rignano sull’Arno, progetti complessi che prevedono anche la nascita di un giornale dedicato alle gesta catodiche dell’ex leader: Sorrisi e Cazzoni Tv. Ecco l’elenco.
Chef Matteo.Il fascino delle trasmissioni in cui si cucina, si mangia, si mostrano le eccellenze italiane sottoforma di rape e fagioli rarissimi è forte. Renzi pare deciso a ritagliarsi il ruolo del conduttore, ma anche del capo cuoco, ma anche del produttore, affidando alla famiglia l’approvvigionamento di materie prime, fatturate a parte. Il programma sarà strutturato con un lungo monologo del conduttore, la presentazione dei concorrenti, un altro lungo monologo del conduttore, l’inquadratura dei piatti (30 secondi) e una lunga conclusione del conduttore. Qualche problema tecnico pare turbare la messa in onda perché alcuni autori hanno deciso di abbandonare il progetto. Matteo non si è scomposto: “Via, via, andate a fare il vostro programmino del due per cento, noi faremo il quaranta”.
Miss Italia Dem. Non indifferente al fascino femminile, Renzi potrebbe condurre un concorso di bellezza che affianchi alle doti fisiche delle concorrenti anche altre qualità come affidabilità politica, culto del capo, obbedienza. I migliori tweet di Anna Ascani e Alessia Morani verranno mostrati in sovrimpressione. Il programma sarà itinerante e toccherà tutti i comuni conquistati dal Pd nelle recenti amministrative, cioè sarà di massimo due puntate. Già in lavorazione la serata di Arezzo, con una sicura vincitrice – Maria Elena Boschi – che porterà alla fine la fascia di Miss Stasulcazzo.
Sbam, il piacere della sconfitta.Affabulatore nato, divulgatore e costruttore di storytelling, Matteo Renzi ama raccontare i misteri dell’universo e i segreti naturali del nostro pianeta. Nella prima puntata, già in lavorazione, Orfini si occuperà del millenario enigma dei cerchi nel grano (“Dove sono finiti i nostri elettori?”. “Boh, cerchi nel grano”), mentre Scalfarotto sarà inviato a studiare le famose linee di Nazca che pare contengano un’analisi della sconfitta del Pd (infatti nessuno le ha ancora decrittate e a Nazca aspettano un congresso da 4000 anni). Non mancherà la solita domanda dei programmi di divulgazione scientifica: esistono gli alieni? E se esistono, sono stati almeno una volta alla Leopolda?
Coi vostri soldi. Consapevole che l’economia è un caposaldo della nostra società, Matteo Renzi pare deciso a svelarne i meccanismi anche ai profani, tra i quali spiccano gli esperti economici del Pd. In questo caso non ci sarebbe problema di autori recalcitranti, perché i testi sarebbero, come nel caso del Jobs act, affidati al centro studi di Confindustria. Qualche difficoltà nel reperite gli ospiti: Marchionne e Farinetti hanno declinato l’invito con un semplice sms alla produzione (“Renzi chi?”). Il pubblico in studio sarà composto da giovani millennials, pagati 0,25 centesimi ad applauso (massimo dieci applausi per non sforare il budget).
Pomeriggio Renzi. L’impegno di una striscia quotidiana che si occupi di vicende quotidiane, squartamenti, corna, delitti, casi umani, funerali e battesimi reali, matrimoni vip e guarigioni miracolose non spaventa Matteo Renzi. La luce bianca sparata in faccia, l’atteggiamento finto-umano del conduttore e i selfie con gli ospiti faranno il resto. Nella prima puntata, la cui scaletta è già definitiva, è prevista l’intervista a un imprenditore schiantato dal dolore perché costretto a licenziare i suoi operai, e del suo gesto umano di occuparne due o tre, pagati in nero, per lucidargli la Ferrari.
 Storiella vecchia ma sempre valida: sul tavolo ci sono dieci panini, il padrone se ne mangia nove, e poi ammonisce i lavoratori: attenti, che il rom vi frega il panino! E’ un giochetto vecchio come il mondo che paga sempre e porta le classi subalterne a vedere il pericolo sotto di loro e non sopra. Eppure non ci vuole un esperto di flussi di consenso per scoprire il gioco di Salvini: una sparata feroce e estremista, alti lai e lamentazioni di chi gli si oppone, una minima correzione di rotta per dire: lo avevate già fatto voi. Cos’ho detto di male?
Storiella vecchia ma sempre valida: sul tavolo ci sono dieci panini, il padrone se ne mangia nove, e poi ammonisce i lavoratori: attenti, che il rom vi frega il panino! E’ un giochetto vecchio come il mondo che paga sempre e porta le classi subalterne a vedere il pericolo sotto di loro e non sopra. Eppure non ci vuole un esperto di flussi di consenso per scoprire il gioco di Salvini: una sparata feroce e estremista, alti lai e lamentazioni di chi gli si oppone, una minima correzione di rotta per dire: lo avevate già fatto voi. Cos’ho detto di male?
Con una fava, due piccioni: si sposta l’asse del dibattito verso destra (perché non prendersela coi rom? Siamo rom, noi? No, e allora che cazzo ce ne frega?…) e al tempo stesso si fa passare chi si oppone per il vecchio un po’ bolso cane di Pavlov. Il cane di Pavlov, come al solito, ci casca con tutte le scarpe: quando leggi che quelli del Pd si vantano che loro sì avevano fermato i flussi migratori (stoppandoli in confortevoli lager libici), capisci che da lì non si esce, perché si pone un’infamia contro un’infamia e alla fine un popolo spaventato, impoverito, insicuro sul suo futuro, sceglie l’infamia peggiore perché gli sembra quella più tranchant e secca: via le Ong, schediamo i rom, i neri pussa via. La domanda da farsi è: chi riuscirà a fermare questa deriva? Chi si è inventato il daspo per i barboni (decreto Minniti, brutta fotocopia del decreto Maroni del 2008, quello delle “ordinanze creative” che dimostrò come anche i sindaci possono essere parecchio scemi)? Oppure chi oppose al grottesco “aiutiamoli a casa loro” delle destre una ridicola variante: “aiutiamoli davveroa casa loro” (cfr, Matteo Renzi).
Insomma, sia messo a verbale che è assai difficile opporsi al salvinismo, malattia analfabeta del fascismo, se sei mesi fa si dicevano – con altri toni e vestiti meglio – più o meno le stesse cose.
E questo riguarda chi sta in basso, cioè, i capri espiatori, variabili e numerosi, da additare al proprio pubblico plaudente: sei pagato tre euro l’ora, licenziabile a piacere, demansionabile, sfruttabile fino all’osso, ricattabile, umiliabile, ma lasci che qualcuno indirizzi la tua rabbia verso chi sta peggio e non verso chi sta meglio e ti sta derubando. Ti incazzi con un poveraccio che ruba un po’ di rame e ti dimentichi di quello che si è messo in tasca 600.000 euro in una notte grazie a una dritta di Renzi sulle banche popolari. Un classico
Grazie alle sue armi di distrazione di massa, e al cane di Pavlov che ci casca con tutta la ciotola di crocchini, di Matteo Salvini si finisce a guardare soltanto la vena nazional-manganellista, decisamente schifosa, ma che è solo una delle due fasi. L’altra fase, mentre si picchiano gli ultimi, è lisciare il pelo ai penultimi. L’ovazione ricevuta da Confcommercio, per esempio, chiosava un discorso di Salvini articolato come un semplice sillogismo. Uno: niente limite ai contanti. Due: via l’Imu per i negozi sfitti. Risultato dell’equazione: si affitteranno negozi in nero (contanti); negozi che ufficialmente risulteranno sfitti (quindi esentasse): questo sì che è un regalone, mica due detrazioni piazzate qui e là. E ancora una volta il piccolo Scelba lumbard potrà dire: cos’ho detto di male? Il tetto ai contanti non lo avevate alzato anche voi? Scacco matto.
Finché si starà a questo gioco, Salvini avrà davanti un’autostrada (senza autovelox) e chi non è d’accordo verrà ridicolizzato (compresi quelli che già si sono molto ridicolizzati da soli, travestendo da “gauchiste” politiche da destra liberale) oppure mangiato lentamente (una forza con 32 per cento che si fa comandare a bacchetta da uno col 17). Il cane di Pavlov abbaia, gli altri tutti contenti: il rom non gli ruberà più l’unico panino gentilmente lasciato sul tavolo dal padrone, contento come un agrario nel ’22.
 Se guardate bene il grande affresco dei narratori americani, degli autori noir che scavano nell’anima del lettore, vedrete che le pennellate più scure – disperatamente scure – le mette Elliott Chaze. Scrittore sopraffino e feroce, acuminato, implacabile, uno che i suoi personaggi li spoglia di tutto, li lascia soli a cavarsela nelle loro storie, in qualche modo li osserva come si guarda una formica annaspare in un bicchier d’acqua. Chaze (1915-1990) appartiene a quella genìa di narratori perfetti che hanno avuto meno fortuna di quanta ne meritassero, e va a onore di Mattioli 1885 l’averne rilanciato le opere: l’anno scorso con il mirabolante Il mio angelo ha le ali nere(1953) e oggi con questo La fine di Wettermark(1969), dolentissimo capolavoro, denso di ironia amara, concentrato di disincanto: un piccolo salmo in gloria della sconfitta umana.
Se guardate bene il grande affresco dei narratori americani, degli autori noir che scavano nell’anima del lettore, vedrete che le pennellate più scure – disperatamente scure – le mette Elliott Chaze. Scrittore sopraffino e feroce, acuminato, implacabile, uno che i suoi personaggi li spoglia di tutto, li lascia soli a cavarsela nelle loro storie, in qualche modo li osserva come si guarda una formica annaspare in un bicchier d’acqua. Chaze (1915-1990) appartiene a quella genìa di narratori perfetti che hanno avuto meno fortuna di quanta ne meritassero, e va a onore di Mattioli 1885 l’averne rilanciato le opere: l’anno scorso con il mirabolante Il mio angelo ha le ali nere(1953) e oggi con questo La fine di Wettermark(1969), dolentissimo capolavoro, denso di ironia amara, concentrato di disincanto: un piccolo salmo in gloria della sconfitta umana.
Cliff Wettermark, cronista e scrittore fallito rifugiatosi in una piccola cittadina del Mississippi, sa di aver lasciato il meglio dietro di sé, e ripensandoci non era nemmeno ‘sta gran cosa. Ora deve 600 dollari alla banca, ha smesso di bere (gli manca) e di fumare (gli manca), il matrimonio è una convivenza stanca senza più un briciolo di passione, e si scopre una macchia tra il naso e un occhio, probabilmente un cancro (prima reazione : “Non posso permettermi un cancro”).
Il piano inclinato della sconfitta, insomma, si vede da subito, anche nella magistrale descrizione della provincia americana di fine anni Sessanta, perché a Chaze bastano tre righe, due movimenti e un guizzo per fare anche dei personaggi minori, fossero pure semplici passanti, ritratti che sembrano vivi. Così conosciamo colleghi, poliziotti, direttori e cassiere di banca, un girotondo di “tipi” intorno al tipo nostro, il povero Wittermark, che però un giorno si accorge – ha dovuto scriverne in cronaca – di quanto sia facile rapinare una banca.
La maestria di Chaze si dispiega qui in modo perfetto: Wettermark non lo ami, non lo odi e non ti sta indifferente, ma dopo un po’, come per lui, tutto diventa pesante e fosco, si scivola, si sbanda. Non c’è rischio che Chaze crei un eroe, ma siccome è un campione vero rifugge anche la tentazione solita dell’anti-eroe. E le scene d’azione entrano in questo flusso, come separate eppure indistinguibili dalla vita normale: anche Wettermark, come il lettore, ha la sensazione che le cose – semplicemente – succedano. E’ un uomo solo, e farà tutto da solo: l’idea, il piano, la realizzazione. Wittermark non è un balordo né un delinquente, solo uno che vede che “si può fare”, e lo fa.
Chaze sa che la disperazione umana non è urlare e strapparsi i capelli, ma scivolare, appunto, verso il proprio destino. In poco più di 150 pagine (ma bella anche la prefazione del traduttore Livio Crescenzi) una vita singola, quella di Cliff Wettermark, diventa un bozzetto delle vite di tanti, di quelli alle prese con la sconfitta, con la fatica, il vuoto. E tutto con una nitida scrittura a strappi, a volte veloce come il migliore hard boiled, e poi più lenta e meditata, ma sempre precisa, netta, cattiva. I soldi, i dollari, i biglietti di banca come un’ossessione che prescinde dal valore, ma che è direttamente vita: “… in tutto il mondo la gente si sbatte da una parte e dall’altra con quei pezzetti di carta, e li dà via per avere sesso, automobili e barche e case, abiti, cibo, istruzione, li baratta con viaggi, e con quella roba costruisce chiese, casinò e bordelli…”. Wettermark non sogna tutto questo, ma i dollari li vuole lo stesso, gli servono. Il colpo di scena finale è stordente, niente sconti, niente appello. Il destino si compie, la fine di Wettermark, già scritta nel titolo, arriverà inesorabile a chiudere un noir nerissimo, bellissimo, un gioiello della letteratura americana, non solo di genere.
 La morte per fucilata alla testa di Soumaila Sacko, lavoratore maliano immerso nella cajenna dei ghetti per schiavi della piana di Gioia Tauro, rischia di scomparire dalle cronache in fretta. Ricordo un bellissimo film di Andrea Segre, Il sangue verde, trasmesso anche dalla Rai (i benemeriti di Doc3) che raccontava di Rosarno, la piana, le arance, la rabbia, la schiavitù, le condizioni disumane, l’ostilità della popolazione attorno. E’ un film del 2010, otto anni fa, che si riferisce a fatti orribili di quei tempi: schiavi neri sparati da padroni bianchi, il nostro Alabama, qui e ora.
La morte per fucilata alla testa di Soumaila Sacko, lavoratore maliano immerso nella cajenna dei ghetti per schiavi della piana di Gioia Tauro, rischia di scomparire dalle cronache in fretta. Ricordo un bellissimo film di Andrea Segre, Il sangue verde, trasmesso anche dalla Rai (i benemeriti di Doc3) che raccontava di Rosarno, la piana, le arance, la rabbia, la schiavitù, le condizioni disumane, l’ostilità della popolazione attorno. E’ un film del 2010, otto anni fa, che si riferisce a fatti orribili di quei tempi: schiavi neri sparati da padroni bianchi, il nostro Alabama, qui e ora.
Si direbbe, a leggere le cronache del “caso Soumaila”, che in questi otto anni niente sia cambiato: la ‘ndrangheta spadroneggia, le condizioni degli schiavi sono terribili, lo sfruttamento è inimmaginabile.
Per ora, purtroppo, la morte di Soumaila Sacko entra nel tritacarne delle schermaglie da social. Si nota che il ministro del lavoro non ha detto una parola (male), che lo sceriffo Salvini quasi nemmeno (ah, sì, ha detto che “l’immigrazione incontrollata…” eccetera, eccetera, la solita solfa). Dall’altro lato si ribatte con i “Ah, ve ne accorgete adesso!”, e “Voi cos’avete fatto?”. Insomma, stallo.
Eppure che si parli di Rosarno, di schiavi, di arance raccolte a cinquanta centesimi la cassa fa rimbombare la questione che tutti si pongono in queste settimane: che razza di governo abbiamo? La risposta è nota: aspettiamo i fatti! Ecco, i fatti di Rosarno potrebbero dare un’indicazione sui famosi fatti che aspettiamo tutti, con – che combinazione! – i due leader politici del governo che coincidono con i due ministeri interessati: Lavoro e Interno.
Ripristinare la legalità, oggi, significherebbe (oltre a catturare e processare l’assassino di Soumaila Sacko, ovvio), andare a verificare le cause di un così evidente sfruttamento. Mandare un centinaio di ispettori del lavoro, esperti dell’Inps, avvocati, meglio ancora se con la cravatta nera e la faccia di Gene Hackman in Mississippi Burning. Rivoltare insomma come un guanto un sistema economico che prevede la schiavitù. Il che significa alla fine liberare gli schiavi, cioè dargli una paga base accettabile, un posto dignitoso dove vivere, metterli in regola. Un ministro del lavoro che dica “Oh, cazzo, qui c’è la schiavitù, ma siamo matti?” non sarebbe malissimo, sempre se non si limitasse a dirlo.
Anche dal lato del muscoloso ministro dell’Interno teorico della ruspa, ci sarebbe un bel lavoro da fare. La ‘ndrangheta che sfrutta gli schiavi è anche quella che truffa l’Inps. Il meccanismo è: mano d’opera immigrata a basso costo, minima redistribuzione clientelare del reddito alla popolazione residente, affari d’oro. Il ministro dell’Interno ha una buonissima occasione per dire “E’ finita la pacchia” agli agrari della piana, a un sistema economico-politico che rende possibile profitti illegali e controllo del territorio. La narrazione degli “immigrati negli alberghi a 5 stelle” che fanno “la bella vita” su cui Salvini ha costruito le sue fortune, ne uscirebbe ammaccata assai se si smascherasse il sistema di potere (italiano) che crea le baraccopoli degli schiavi (immigrati). Non so perché, ma temo che invece si farà un po’ di “pulizia” (traduco: ulteriore repressione dei poveracci) e tutto andrà avanti come prima.
Aspettiamo i fatti, dunque, vediamo se nella terribile piaga di Rosarno la coperta verrà tirata più verso il welfare e il ripristino dei diritti umani e civili, o più verso il manganello, nel peggiorare ulteriormente la vita delle vittime. O se addirittura la coperta non sarà tirata per niente. In questo caso sarà un governo di piena continuità: proclami, riforme e fette di salame sugli occhi, salvo poi cascare dal pero quando se ne occupa la cronaca nera.
 Era dai tempi de La Stangata(1973), con Paul Newman e Robert Redford, che non si vedeva un pacco così accurato e perfetto tirato al pollo di turno. Detto che la distanza tra Salvini e Paul Newman è quella che separa Orio al Serio da Plutone, il pacco è riuscito alla grande, i 5Stelle imbufaliti sono rimasti lì come la mucca che guarda passare il treno, e Salvini fa l’asso pigliatutto e la damigella più corteggiata del reame: ballerà ancora con Silvio? Non lo sa, ci sta pensando. Civettuolo.
Era dai tempi de La Stangata(1973), con Paul Newman e Robert Redford, che non si vedeva un pacco così accurato e perfetto tirato al pollo di turno. Detto che la distanza tra Salvini e Paul Newman è quella che separa Orio al Serio da Plutone, il pacco è riuscito alla grande, i 5Stelle imbufaliti sono rimasti lì come la mucca che guarda passare il treno, e Salvini fa l’asso pigliatutto e la damigella più corteggiata del reame: ballerà ancora con Silvio? Non lo sa, ci sta pensando. Civettuolo.
Ci sono altre truffe famose, e una fa proprio al caso nostro: nel 1925 un tale Victor Lustig riuscì a vendere la Tour Eiffel a un commerciante di ferraglia, fingendosi funzionario governativo e dicendo che l’avrebbero presto smantellata. Quello fu così scemo da dargli 250.000 franchi (moltissimi), più una mazzetta per agevolare l’affare. Quando si accorse di essere stato truffato non sporse denuncia per evitare (lo dico in francese) la colossale figura di merda.
Ecco, credo che sarebbe un errore per i 5Stelle non denunciare il truffatore, cioè Salvini Matteo, di anni 45, noto alle cronache. E’ vero che ci sono mappe e cartine pubblicate dai giornali che ci dicono che se Matteo e Gigi si mettono insieme alle elezioni sbancano. Però un conto è fare un accordo di governo tra diversi, e un altro è spartirsi i collegi elettorali per vincere a man bassa. Cioè non si tratterebbe più di un “contratto” con due contraenti (uno decisamente più furbo dell’altro), ma di un accordo politico. Non denunciare il truffatore, e anzi mettersi con lui, produrrà delle crepe, dei mugugni e probabilmente degli smottamenti. Se così sarà, se Salvini romperà col centrodestra per inseguire il plebiscito, ci aspetta un’estate di terrorismo: e il mutuo? E lo spread? E che dirà Moody’s? Eh? Ci avete pensato?
Insomma, c’è lì davanti un trappolone ulteriore: dividere il Paese su un argomento (euro sì / euro no) che è più favoleggiato che reale (e anche piuttosto stupido), permettendo a Salvini di fare il difensore del popolo e della povera gente. Riassumo: quello che ha nel programma il più grande regalo ai ricchi che la storia ricordi, la flat tax, passerà per una specie di Robin Hood che ci difende dalle agenzie di rating. Se tutto va male (e tutto lo fa pensare) la contrapposizione sarà tra due destre economiche: quella dell’ennesimo regalo ai ricchi, alla rendita e al profitto di Salvini, e quella liberista, rigorista che esibirà in campagna elettorale i suoi carri armati: lo spread, il vostro mutuo, i severi moniti dalla Bce, lo spettro della Grecia, agitato come un fantasma nel castello che sta crollando, e il tradizionale “moriremo tutti”. Manca che scrivano Standard & Poor’s sulle bandiere, ma ci siamo quasi.
Staremo in mezzo a questi opposti estremismi costruiti ad arte, stritolati, a discutere e litigare su una cosa di cui nell’ultima campagna elettorale appena finita non si è parlato nemmeno per un nanosecondo.
Il rischio per i 5Stelle è di assistere a tutto questo basiti e sotto botta come quando ti muore un parente, e la bandierina del “ci hanno imbrogliato” – che sia riferita a Mattarella o a Salvini – non è mai un gran lasciapassare per il successo. La gente, in generale, pensa che il truffatore sia un bastardo, ma anche che il truffato sia un po’ fesso, e che se si è fatto fregare una volta ci cascherà di nuovo, che un po’ se lo merita.
In questo desolante scenario, chi volesse dire una moderata cosa di sinistra (che so: un welfare serio, una redistribuzione tra redditi da lavoro e rendite, una società diversa e migliore, fine della cuccagna per i grandi patrimoni) diserterà una battaglia che non lo riguarda, e in cui è evidente che perderà comunque. Si sentirà come la tartaruga liuto o il rinoceronte di Giava, cioè gente che non ha davanti a sé grandi prospettive, peccato.
 Diffidare delle frasi a effetto e delle iperboli senza rete dovrebbe restare la prima regola sotto ogni cielo. Così la vulgata di questi giorni sul “governo più di destra della storia italiana” vale la scempiaggine sentita nel 2014 (“Il governo più di sinistra degli ultimi trent’anni”, lo disse Renzi quando sembrava un golden boy). Insomma, formulette buone per il bar.
Diffidare delle frasi a effetto e delle iperboli senza rete dovrebbe restare la prima regola sotto ogni cielo. Così la vulgata di questi giorni sul “governo più di destra della storia italiana” vale la scempiaggine sentita nel 2014 (“Il governo più di sinistra degli ultimi trent’anni”, lo disse Renzi quando sembrava un golden boy). Insomma, formulette buone per il bar.
Il fatto però sussiste: sempre di liberisti si sta parlando (in qualche caso ultras); sempre di law and orderun po’ alla carlona si tratta (“Uno Stato dal volto spietato verso i deboli e i diversi”, cfr. Zagrebelsky), con in più il dono della flat tax: le tasse che scenderanno moltissimo per i ricchi, poco per il ceto medio e aumenteranno di fatto per i poveri, che non avranno sconti ma servizi più cari. Insomma, sì, dal punto di vista economico e sociale si configura un governo prepotentemente di destra, almeno a guardare a due fattori: aumento ulteriore delle diseguaglianze (flat tax) e manganellate più facili (il Salvini-Scelba della campagna elettorale), e si vedrà come la componente 5s saprà a vorrà attenuarle.
Detto della preoccupazione per il governo, toccherà prima o poi preoccuparsi per l’opposizione. Le due principali forze che ostacoleranno i disegni governativi, infatti, sono Forza Italia e Pd, e qui la depressione avanza (altro che psicofarmaci!). Forza Italia si conferma compagine basculante: il Riabilitato in mogano ha dato di fatto via libera al governo, rilasciando a Salvini una specie di lasciapassare. Si inalbererà per la giustizia (interesse privato), o per le aziende (idem), per il resto è un’opposizione che giocherà a bloccare due o tre cosette invise al sultano ma non farà mancare affettuose attenzioni (dopotutto, la flat tax la voleva anche Silvio, e te credo). Sentire oggi Brunetta allarmato per qualche punto di spread quando ha passato anni a dirci che l’aumento dello spread per cui venne cacciato il suo principale era un complotto, fa abbastanza ridere. Dunque Forza Italia farà un’opposizione “responsabile” (trad: pappa e ciccia).
Poi ci sarebbe il Pd, e peggio mi sento. Le premesse aventiniane (“senza di me”) parlavano di opposizione durissima, senza sconti, implacabile. Per ora siamo ancora alla lacrima facile e ai capri espiatori, e monta una risibile teoria secondo cui a far vincere i 5s sarebbe stata la stampa cattiva, i commentatori, i corsivisti, questo giornale, Landrù, Floris, Giannini e Belfagor. Poi si parla di una macronizzazione del povero Matteo Renzi, e si favoleggia di una union sacréecon Forza Italia per fare fronte comune al populismo. Cioè, se ho capito bene, i due cavalli di frisia di fronte al “populismo” sarebbero quello che inventato la tivù commerciale e quello che ha volantinato 80 euro alla vigilia delle elezioni.
Per ora si batte su alcuni punti come le competenze (detto da chi nel governo aveva Poletti e la Madia…), il pericolo del Salvinismo-scelbismo (detto da chi ha votato il pacchetto Minniti, fotocopia del pacchetto Maroni del 2008), i rischi per il debito pubblico (detto da chi l’ha aumentato molto più di altri).
Insomma, è stato faticoso trovare un governo, ma sarà ancora più faticoso trovare un’opposizione. E’ un fatto che le grandi riforme dell’era democristiana (una su tutte, il Sistema Sanitario Nazionale, 1974, Tina Anselmi santa subito) vennero fatte anche per un serio lavoro delle opposizioni (il Pci) e con una pressione delle piazze. Ora a sinistra non c’è il Pci e non ci sono le piazze, per le quali anzi negli ultimi anni certi pensatori renzisti à la Rondolino invocavano apertamente il manganello. Il problema è dunque “quale governo”, ma anche – e forse peggio per chi questo governo non lo sostiene – “quale opposizione”. In una democrazia non si tratta esattamente di un piccolo dettaglio.
 Quindici stragi di Piazza Fontana, tre stragi di Ustica, tre stragi di Bologna. Contateli come volete, in soli quattro mesi e mezzo i morti sul lavoro in Italia sono stati più di 250. Alla fine dell’anno si supererà di molto quota mille, cifre da guerra, da bombardamento a tappeto. La colata incandescente, la lastra d’acciaio, il gas venefico, il muletto che si ribalta. Il più giovane: 19 anni, il più vecchio: 59. Se fosse un popolo, quello dei lavoratori italiani, avremmo le risoluzioni dell’Onu, le diplomazie in fibrillazione, i grandi leader che lanciano appelli per, come si dice in questi casi, “fermare il massacro”. E invece sulle vittime da lavoro in Italia si dice poco e niente: i titoli di cronaca, il balletto dei numeri, qualche riflessione ad ampio raggio che lascia il tempo che trova. Ed è un tempo di merda.
Quindici stragi di Piazza Fontana, tre stragi di Ustica, tre stragi di Bologna. Contateli come volete, in soli quattro mesi e mezzo i morti sul lavoro in Italia sono stati più di 250. Alla fine dell’anno si supererà di molto quota mille, cifre da guerra, da bombardamento a tappeto. La colata incandescente, la lastra d’acciaio, il gas venefico, il muletto che si ribalta. Il più giovane: 19 anni, il più vecchio: 59. Se fosse un popolo, quello dei lavoratori italiani, avremmo le risoluzioni dell’Onu, le diplomazie in fibrillazione, i grandi leader che lanciano appelli per, come si dice in questi casi, “fermare il massacro”. E invece sulle vittime da lavoro in Italia si dice poco e niente: i titoli di cronaca, il balletto dei numeri, qualche riflessione ad ampio raggio che lascia il tempo che trova. Ed è un tempo di merda.
Statistiche: il più dodici per cento rispetto all’anno passato si spiega quasi sempre con la sospirata ripresa: si moriva un po’ meno perché si lavorava un po’ meno, ora sì che si ragiona, finalmente! Italia riparte!
Poi si passa ai perché: i controlli sono pochi, pochissimi, spesso inconcludenti (e nonostante questo il 60 per cento delle aziende controllate nell’edilizia risulta non in regola), il lavoro è più lungo e più scomodo, lo straordinario, quando non il cottimo, è la norma. La ricattabilità dei lavoratori – avendo il Jobs act legalizzato il demansionamento e facilitato i licenziamenti – è aumentata a dismisura: dire di no al padrone è diventato più difficile. Il caleidoscopio di appalti e subappalti ha fatto quasi scomparire del tutto i corsi sulla sicurezza.
Poi ci sono i motivi, per così dire culturali della questione. La retorica modernista per cui “gli operai non ci sono più” (anche se ne muoiono tre al giorno), le loro parole sono risibili e antiche: “lotta”, e giù a ridere; “sciopero”, e giù a pontificare col ditino alzato che non siamo più nel Novecento. Il sindacato come un sempiterno ostacolo alle sorti luminose e progressive del mercato, che meno lo regoli e meglio è, la costante mortificazione del lavoro operaio (ma anche contadino: si muore parecchio anche lì), considerato démodé e residuale, anche se siamo la seconda manifattura d’Europa.
Mischiate bene e avrete il cocktail micidiale che produce così tante vittime, aggiungete molte parti di ideologia liberista, quella storiella furba che se aiuti l’impresa (sussidi, sconti sui contributi, agevolazioni fiscali) aiuti anche i suoi lavoratori, cosa millemila volte smentita dai fatti, eppure ancora narrazione dominante.
Vista da quest’Italia dei cantieri e delle fabbriche, dall’Italia che va ai funerali dei suoi padri, mariti e fratelli caduti sul lavoro, l’Italia in primo piano in questi giorni – quella dei tavoli, delle trattative, del Pirellone, del balletto dei nomi, dei corazzieri davanti alla porta – sembra un luogo surreale. Di più, uno schiaffo, uno sberleffo.
Anni di ottundimento, di derisione delle lotte dei lavoratori (quelli che mettono il gettone del telefono nell’iPhone, questa non la scorderemo mai), di criminalizzazione dello sciopero (“Ecco! Scioperano al venerdì!”), di anarchia di mercato (“Troppi diritti! Mano libera!”) ci hanno portato qui: poco lavoro, cattivo lavoro, e puoi anche lasciarci la pelle.
Mentre osserviamo il soave balletto della politica da prima pagina, una cosa è chiara: non verrà da lì il cambiamento. Non verrà dalle riforme scritte e bilanciate con il manuale Cencelli delle convenienze. Se cambierà qualcosa sarà perché il conflitto riprende il suo posto nella dialettica politica del paese. In soldoni (lo dico male): sarà perché la gente si incazza e il tappo della pentola salta per troppa pressione. Speriamo presto, speriamo subito: è una cosa più urgente del nome del prossimo esimio professore che guiderà il governo.
 Il pasticciaccio brutto del Rosatellum ha prodotto il pasticciaccio brutto del Quirinale, che ha prodotto il pasticciaccio brutto del governo neutrale, che al mercato mio padre comprò. E via così finché ci riuscite, finché la fantasia vi assiste, auguri. Da un punto di vista umano e letterario, il cupio dissolviha il suo fascino sublime, c’è un lasciarsi andare lento, quasi un addormentamento, il torpore dell’ibernazione. E sbagliano mira molti commentatori che descrivono il paese nervoso e arrabbiato. Non è vero. Il paese è piuttosto disgustato e stupito, ha guardato per due mesi quella porta con due corazzieri al fianco come in una frenetica commedia di Feydeau: entra uno, esce l’altro, c’è il teatrino, ed ecco quell’altro ancora, altro teatrino, esce Tizio, entra Caio con il senatore Sempronio, esce Silvio che fa il suo vaudeville. Passa un’ora, ed ecco l’altro spettacolino con i contatti riservati, le chat, le telefonate segrete che restano segrete dieci minuti e te le ritrovi spiattellate sui giornali. L’indiscrezione di Renzi che chiama Salvini nella speranza che si formi un governo Lega-M5s pur di non scomparire (“terrorizzato dal ritorno alle urne”, scrive il Corriere) non l’avrebbe pensata nemmeno Buster Keaton. Silvio invece ripete a macchinetta la sua visione del mondo: quando mai uno sfigato qualunque che si trova a guadagnare quattordicimila euro al mese vota per mandarsi a casa? Si vola altissimo.
Il pasticciaccio brutto del Rosatellum ha prodotto il pasticciaccio brutto del Quirinale, che ha prodotto il pasticciaccio brutto del governo neutrale, che al mercato mio padre comprò. E via così finché ci riuscite, finché la fantasia vi assiste, auguri. Da un punto di vista umano e letterario, il cupio dissolviha il suo fascino sublime, c’è un lasciarsi andare lento, quasi un addormentamento, il torpore dell’ibernazione. E sbagliano mira molti commentatori che descrivono il paese nervoso e arrabbiato. Non è vero. Il paese è piuttosto disgustato e stupito, ha guardato per due mesi quella porta con due corazzieri al fianco come in una frenetica commedia di Feydeau: entra uno, esce l’altro, c’è il teatrino, ed ecco quell’altro ancora, altro teatrino, esce Tizio, entra Caio con il senatore Sempronio, esce Silvio che fa il suo vaudeville. Passa un’ora, ed ecco l’altro spettacolino con i contatti riservati, le chat, le telefonate segrete che restano segrete dieci minuti e te le ritrovi spiattellate sui giornali. L’indiscrezione di Renzi che chiama Salvini nella speranza che si formi un governo Lega-M5s pur di non scomparire (“terrorizzato dal ritorno alle urne”, scrive il Corriere) non l’avrebbe pensata nemmeno Buster Keaton. Silvio invece ripete a macchinetta la sua visione del mondo: quando mai uno sfigato qualunque che si trova a guadagnare quattordicimila euro al mese vota per mandarsi a casa? Si vola altissimo.
Insomma, il film è brutto e gli attori fanno schifo. E poi c’è la soap opera del Di Maio che cede terreno e lancia lusinghe al Salvini che però non può lasciare la corte di Arcore, segue melodramma, lacrime, patemi e sfuriate. Stendhal, ma scritto peggio.
Un governo “neutrale” (etimologia: “né dell’uno né dell’altro”) potrebbe essere una soluzione affascinante, qualche anonimo grand commiso “riserva della Repubblica” che non si fa troppo notare e che promette di farsi da parte dopo, rinunciando a eventuali candidature, “discese in campo” e mariomontismi consimili. Attori presi dalla strada che promettono solennemente di tornare sulla strada il giorno dopo. Mah, fingiamo di crederci.
Il punto più debole del cosìddetto governo neutrale è che non sarebbe per niente neutrale, perché dovrebbe trovare subito, al volo, in pochi giorni, una dozzina di miliardi per disinnescare la bomba dell’Iva. Trovare dodici miliardi non è una cosa neutrale, proprio per niente. Prenderli dalla sanità o dagli stanziamenti della difesa, per dire due estremi, sono cose molto differenti, che possono mandare a gambe all’aria qualunque neutralità. Ma comunque sia, alcune paroline già rimbombano: una è “mettere al sicuro i conti”, e l’altra (udite udite) è “manovrina”. Non sono cose che si possono fare in modo neutro, e mettiamoci pure la legge di stabilità che – il governo neutrale dovesse arrivarci vivo – è il vero atto politico di un governo, quello che decide dove si mettono e si tolgono i soldi.
E’ vero che nessuno degli attori in campo, né Di Maio, né Salvini, né i poveri Silvio e Matteo Renzi hanno detto dove prenderebbero questi soldi, e sarà una buona domanda da fare a tutti in campagna elettorale: magari per uno che sogna la flat tax al quindici per cento, ricordargli che deve trovare qualche spicciolo subito (12 miliardi, una manovra) frugando nelle tasche (nostre) sarebbe un buon bagno di realismo.
Non sfugge l’assurdità del voto in luglio, su cui già abbondano le freddure e i motti di spirito, che vuol dire altre schermaglie, posizionamenti, strategie da qui a tre mesi, e le due forze fino a ieri sull’orlo dell’accordo che si combattono in una specie di ballottaggio, e gli altri che temono l’estinzione con conseguenti crisi da panico e una sola certezza: il vaffanculo, questa volta, è autoinferto.
 Oggi è il 25 aprile e non è facile parlarne. Si festeggia la Liberazione dai nazifascisti e – contestualmente – l’ultima volta (73 anni fa) in cui il paese si è veramente alzato in piedi e ha scritto una pagina di storia di cui andare fieri. I buoni hanno cacciato i cattivi a schioppettate dopo averne viste e sopportate di tutti i colori, il dittatore è finito appeso come nelle fiabe o nelle rivoluzioni, si è riunito un Paese, è nata una buonissima Costituzione, molto avanzata per i tempi, e ancora oggi decente baluardo al nuovo (vecchio) che avanza. Ognuno ha il suo 25 aprile e se lo tiene stretto nonostante mala tempora currunt.
Oggi è il 25 aprile e non è facile parlarne. Si festeggia la Liberazione dai nazifascisti e – contestualmente – l’ultima volta (73 anni fa) in cui il paese si è veramente alzato in piedi e ha scritto una pagina di storia di cui andare fieri. I buoni hanno cacciato i cattivi a schioppettate dopo averne viste e sopportate di tutti i colori, il dittatore è finito appeso come nelle fiabe o nelle rivoluzioni, si è riunito un Paese, è nata una buonissima Costituzione, molto avanzata per i tempi, e ancora oggi decente baluardo al nuovo (vecchio) che avanza. Ognuno ha il suo 25 aprile e se lo tiene stretto nonostante mala tempora currunt.
I primi risultati su Google cercando “25 aprile” (sezione “notizie”, ora mentre scrivo) sono i seguenti: “25 aprile, chi apre e chi chiude tra le grandi catene”. “Che tempo farà nei ponti di 25 aprile e primo maggio”. Poi la solita querelle sui palestinesi con la kefieh (se possano o no andare alla manifestazione), e infine un’inchiesta giornalistica (a Pesaro) secondo la quale solo due studenti su dieci sanno cosa significhi la data. Chiosa (quinta notizia) un titolo de Il Giornale: “Il falso mito del 25 aprile. Un italiano su tre: che cos’è?”.
Eppure, oggi è il 25 aprile, e si festeggia. Non solo nelle grandi e piccole manifestazioni, ma in molti gesti di devozione popolare. Chi (esempio) ha mai fatto a Milano il giro delle lapidi dei partigiani fucilati, dove L’Anpi depone le corone con piccole volanti cerimonie, conosce un’intensità speciale, di quelle che rendono giustizia all’anniversario, che lo celebrano veramente.
Perché per anni ci hanno detto che ormai era soltanto retorica, discorsi vuoti, consuetudine, e invece no: nonostante il rischio di consunzione, la festa ha resistito, ed è ancora viva. Negli anni, i partigiani sono stati tirati di qua e di là per la giacchetta (disse un giorno la Boschi che “quelli veri” votavano sì al suo referendum), sballottati ora come figurine edificanti, ora come reliquie. Santificati e demonizzati. Il Pd milanese, che l’anno scorso alla manifestazione portò surreali bandiere blu, quest’anno sfilerà con le belle facce dei partigiani sugli striscioni, a segnalare che il 25 aprile è piuttosto elastico a seconda della bisogna, della tattica, dell’aria che tira.
E però si festeggia lo stesso, perché con tutto il discutere dotto e complesso su populismo, populismi e populisti, quella là, quella del 25 aprile, è stata la volta che si è visto veramente un popolo.
Dunque, ognuno ha il suo 25 aprile, e ognuno può mettere in atto gesti e trucchi per non farsi fregare dalle retoriche passeggere, dagli usi strumentali, dalle stupidaggini negazioniste.
Il mio metodo è di riprendere in mano, per qualche minuto, i volumi delle lettere dei Condannati a morte della Resistenza, e di andare a salutarne qualcuno. E poi torno sempre lì, da Giuseppe Bianchetti, operaio, 34 anni, di vicino Novara, fucilato dai tedeschi nel febbraio del ’44:
Caro fratello Giovanni,
scusami se dopo tutto il sacrificio che tu hai fatto per me mi permetto ancora di inviarti questa mia lettera. Non posso nasconderti che tra mezz’ora verrò fucilato; però ti raccomando le mie bambine, di dar loro il miglior aiuto possibile. Come tu sai che siamo cresciuti senza padre e così volle il destino anche per le mie bambine.
T’auguro a te e tua famiglia ogni bene, accetta questo mio ultimo saluto da tuo fratello
Giuseppe.
Di una cosa ancora ti disturbo: di venire a Novara a prendere il mio paletò e ciò che resta. Ciau tuo fratello
Giuseppe
Leggo questa lettera ogni anno, da anni, perché in quel “paletò” da andare a prendere a Novara insieme a “ciò che resta” mi sembra di vedere una dignità inarrivabile, con la parola “popolo” che si riprende il suo posto. Siamo stati anche questo, per fortuna e sì, bisogna festeggiare.
Emanuele Coen, de L’Espresso, ha visitato Milano insieme a qualche scrittore per vedere se c’è una narrazione un po’ difforme dalla propaganda corrente. E sì, c’è.
 Cari tutti. Follia maggiore si comporta molto bene, grazie a tutti quelli che l’hanno letto e a quelli che lo leggeranno, chi vuole dare un’occhiata a recensioni e interviste, le trova qui. Ricevo molti inviti di qui e di là per parlare del libro (grazie), ma ovviamente non posso andare ovunque… Metto qui sotto le prossime date (aprile, maggio, giugno), è possibile che l’elenco si allunghi, ma per ora queste sono quelle certe… Orari, luoghi, dettagli, se non presenti qui, saranno comunicati sulla pagina Fb e su twitter. Chi vuole prenda nota, ci vediamo lì.
Cari tutti. Follia maggiore si comporta molto bene, grazie a tutti quelli che l’hanno letto e a quelli che lo leggeranno, chi vuole dare un’occhiata a recensioni e interviste, le trova qui. Ricevo molti inviti di qui e di là per parlare del libro (grazie), ma ovviamente non posso andare ovunque… Metto qui sotto le prossime date (aprile, maggio, giugno), è possibile che l’elenco si allunghi, ma per ora queste sono quelle certe… Orari, luoghi, dettagli, se non presenti qui, saranno comunicati sulla pagina Fb e su twitter. Chi vuole prenda nota, ci vediamo lì.
23 aprile, 21.00, MILANO – Cooperativa la Liberazione, via Lomellina 14
5 maggio, 18.30, MACERATA– Macerata racconta – Teatro della Filarmonica
13 maggio, 14.30, TORINO– Salone del Libro Torino – Sala Gialla
17 maggio, 18.00, MILANO– Politecnico di Milano – Aula De Donato
19 maggio, 11.00, PIACENZA– Libreria Fahrenheit
28 maggio, 18.00, BOLOGNA- Biblioteca Salaborsa (con Paolo Nori)
2 giugno, 17.30, MANTOVA
5 giugno, 20.30, BERGAMO
8 giugno, TRICHIANA (BELLUNO) – BookFest
16 giugno, RAGUSA– Festival A tutto volume
 Dunque arriverà l’esploratore, mandato dal Colle. Mi piace immaginarlo con il casco coloniale e la tenuta color cachi, seguito dai portatori indigeni, che si addentra nella giungla, tra Salvini acquattati nell’ombra, grillini con le cerbottane e i dardi al curaro, Renzi immobili appollaiati a vedere la scena. Ci sarebbe anche Silvio, sì, il capotribù mattacchione, quello che rovina le cerimonie con una parola di troppo, tutti gli sorridono, ma non vedono l’ora di strappargli il cuore e gettarlo da una rupe. Ambientino amichevole, insomma.
Dunque arriverà l’esploratore, mandato dal Colle. Mi piace immaginarlo con il casco coloniale e la tenuta color cachi, seguito dai portatori indigeni, che si addentra nella giungla, tra Salvini acquattati nell’ombra, grillini con le cerbottane e i dardi al curaro, Renzi immobili appollaiati a vedere la scena. Ci sarebbe anche Silvio, sì, il capotribù mattacchione, quello che rovina le cerimonie con una parola di troppo, tutti gli sorridono, ma non vedono l’ora di strappargli il cuore e gettarlo da una rupe. Ambientino amichevole, insomma.
Cosa dovrebbe esplorare questo esploratore non è facile capire, ma possiamo fare delle ipotesi. Avvertenza: non aspettatevi grandi cose, il meraviglioso quiproquò di andare alle Indie e scoprire l’America non si ripeterà. Più facile che qualcuno riesumi vecchi talenti, come fece Stanley quando ritrovò Livingstone nel cuore dell’Africa: “Dr, Livingstone, I presume”. Tenetevi forte: potrebbe accadere con nomi che nemmeno lontanamente pensate, antiche personalità, vecchi garanti, sfingi della mediazione, alchimisti di maggioranze.
Si tratterà anche di una specie di esplorazione antropologica, di capire come abbia potuto Salvini, nel giro di una notte, passare dal Klu Klux Klan al sorriso rassicurante dell’uomo di governo in pectore ed essere preso sul serio. O come possa Di Maio uscire dalla sua trappola “O io o niente” ripetuta per settimane come un mantra autoipnotico. Ci vorrà un esploratore psicologo, ma di quelli bravi, anche per Berlusconi: la sua faccia quando dice “Matteo Salvini, il nostro leader” non ce l’aveva nemmeno Mimì nel quarto atto della Bohème, poverina. E quanto a quegli altri, quelli che sostengono che i loro elettori li hanno votati per vederli paralizzati e immobili, lì di dottori ce ne vuole un plotone intero.
E’ probabile che l’esplorazione venga condotta col pallottoliere, in modo da mettere insieme un numero sufficiente di persone, un certosino lavoro di oliatura, in modo che alcuni interessi, anche contrapposti, girino insieme in un delicato meccanismo, che nessuno alzi troppo i toni, e infatti si anela – tu pensa l’ampio orizzonte politico – la partenza del Di Battista per le Indie, o un arroccato silenzio del Silvio Ligneo Restaurato: non è il momento di intemperanze. In questo caso l’esploratore sembrerà più un mediatore di quelli che entrano in scena nelle rapine con ostaggi: “No, non posso darti un elicottero”, oppure: “No, la flat tax non è possibile, ma parliamo, avete fame? Come stanno gli ostaggi?”.
Forse l’esploratore riuscirà nel miracolo di trovare una specie di Eldorado, la terra di cui si favoleggia: un governo con dentro tutti, chi ha vinto, chi ha perso, chi vorrebbe ma non può, chi potrebbe ma non vuole, chi pensa ancora maggioritario in un sistema proporzionale, chi l’Aventino e chi aspetta di leggere il voto in Molise come fondi di caffè o interiora di pecora. In pratica si aprirebbe una specie di permanente campagna elettorale con ogni opposizione rappresentata al governo, gloriosa sintesi del Rosatellum: creato perché nessuno possa governare, potrebbe finire per far governare tutti, chi più, chi meno, in una specie di fratellanza governativa al cui confronto la corte dei Borgia era la famiglia del Mulino Bianco. Ma ammesso che l’esploratore riesca nel suo titanico compito di mettere d’accordo i capitribù, non si capisce il guadagno per gli indigeni: quella di cui si sta parlando, infatti, persino sottintesa e accettata da tutti, è una specie di eterna continuità che scolora le esigenze (ma anche le speranze, in molti casi le illusioni) del Paese. Un governo di tutti sarebbe infine l’esplorazione perfetta, la quadratura del cerchio, un drappello a cavallo, con gli elmi scintillanti e le armature e una grande bandiera al vento con la scritta “Abbiamo scherzato”.
 Non c’è bisogno di tornare alle Metamorfosi di Ovidio, la vecchia cara mitologia dove qualcuno, specie se dio, prima o poi diventava qualcun altro incasinando la trama. E nemmeno di svegliarsi scaraffoni come il Gregor Samsa di Kafka. Non c’è bisogno di arrivare a tanto, basta vedere la signora Isoardi che stira le camicie di Salvini: in poche settimane siamo passati dall’uomo-felpa all’uomo camicia-stirata, ogni epoca ha le metamorfosi che si merita.
Non c’è bisogno di tornare alle Metamorfosi di Ovidio, la vecchia cara mitologia dove qualcuno, specie se dio, prima o poi diventava qualcun altro incasinando la trama. E nemmeno di svegliarsi scaraffoni come il Gregor Samsa di Kafka. Non c’è bisogno di arrivare a tanto, basta vedere la signora Isoardi che stira le camicie di Salvini: in poche settimane siamo passati dall’uomo-felpa all’uomo camicia-stirata, ogni epoca ha le metamorfosi che si merita.
In quanto a mimetismo e travestitismo d’occasione, comunque, lo spettacolo è interessante, più antropologicamente che politicamente, ma insomma. Salvini si sforza di uscire dal ghetto bellicoso del guidatore di ruspe per sembrare istituzionale, con tutti i dettagli esilaranti di chi cerca di mettersi in panni non suoi. Ma attenzione a non ridere troppo, perché il messaggio dice molto (a parte la concezione della donna a vapore, ovvio): vero che si passa dal look contadino alla camicia, ma vero anche che gliela stira la fidanzata, mica come Silvio che probabilmente se le faceva stirare da una scuola di samba in topless. La signora Isoardi che stira le camicie di Salvini è l’equivalente della canottiera di Bossi, un’ostentazione di normalità popolare: vivo come voi, non ho domestici (a parte la fidanzata, ri-ovvio).
La metamorfosi di Salvini è dunque incompiuta, o in fase di precisazione, ma intanto può poggiare solidamente su una metamorfosi della narrazione che lo ha portato al successo (il suo successo, cioè battere Berlusconi nel centrodestra). Mentre la scena politica macina soprattutto indiscrezioni e retroscena (traduco: nessuno ci capisce ancora un cazzo), le cronache languono. Il grido emergenziale per l’immigrazione incontrollata si è placato, persino la cronaca nera sembra aver tirato un po’ il freno a mano. Di colpo, vengono meno le urla para-inferocite delle moltitudini (nove-undici persone) dietro una transenna che dicono “Ha stato il negro”, “Ha stato il zinghero”. Di colpo la signora che si allunga per urlare nel microfono dell’inviato che suo cugino ha subito due furti in casa è messa in sonno, forse anestetizzata e riposta in un magazzino, in attesa della prossima occasione.
Il tam-tam dei media sui media (è come il cinema sul cinema, un genere a parte) dice che le due voci più xenofobe e allarmiste delle tivù Mediaset (Belpietro e Del Debbio) perderanno la loro tribuna, un po’ perché Silvio li ritiene responsabili di aver portato acqua a Salvini, un po’ perché la missione è compiuta: lo spavento diffuso a piene mani può essere richiamato indietro come un cane.
Quella della destra non è l’unica metamorfosi in corso, ovvio. Lenta e dolorosa appare quella del Pd: l’idea che dal bozzolo ormai incartapecorito del renzismo nasca una nuova farfalla è suggestiva, ma decisamente naïf. E poi ci sarebbe la metamorfosi sua, di Renzi Matteo, che pensa, secondo molti, a fare da sé in un processo di macronizzazione che ancora non gli riesce, sarà il clima.
Quanto ai Cinque Stelle, la loro metamorfosi pare finora la più riuscita: dicono dopo le elezioni cose ancora vagamente simili a quelle che dicevano prima delle elezioni ed è già un record, ma la loro mutazione era iniziata per tempo, con molto anticipo, nel passaggio dai vaffanculo alla mise da statista, in cravatta e sorriso stampato anche nella vasca da bagno. Non è merito loro, probabilmente, ma demerito e strafalcione di chi ha passato anni a descriverli come aborigeni con l’anello al naso e la sveglia al collo, tutti microchip e scie chimiche, mentre ora possono vantare una assoluta, persino scialba e monocorde, normalità, appena increspata da qualche caratterista che dà colore alla scena.
Per gli appassionati di metamorfosi, comunque, è solo l’inizio. Un altro mesetto di sudoku quirinalizio ci darà qualche elemento più, stiamo pronti.
 Scuseranno i lettori se mi porto avanti col lavoro e parlo del 25 aprile. Me ne dà occasione anticipata il sindaco leghista di Cologno Monzese, Angelo Rocchi che ha firmato (insieme all’assessora alla cultura Dania Perego) il patrocinio per una bella rievocazione da tenersi tre giorni prima della festa della Liberazione: un campo di fanteria nazista ai giardinetti. Motivazione etico-didattico: mostrare la vita quotidiana durante la guerra, a Cologno Monzese. Intenso programma (lo leggiamo su un manifesto che raffigura due soldati tedeschi, uno dei quali, poverino, ferito): “Preparazione del rancio con ricette d’epoca”, bello. “Cerimonia consegna onorificenze”, commovente. “Racconti, miti e leggende del Nord intorno al fuoco”. No comment. Il tutto in divisa, per la precisione quella della Wehrmacht. Organizzazione dell’accurata ricerca storica, un gruppo che si fa chiamare 36 Fusilier Kompanie (era un allegro club di volontari austriaci delle SS).
Scuseranno i lettori se mi porto avanti col lavoro e parlo del 25 aprile. Me ne dà occasione anticipata il sindaco leghista di Cologno Monzese, Angelo Rocchi che ha firmato (insieme all’assessora alla cultura Dania Perego) il patrocinio per una bella rievocazione da tenersi tre giorni prima della festa della Liberazione: un campo di fanteria nazista ai giardinetti. Motivazione etico-didattico: mostrare la vita quotidiana durante la guerra, a Cologno Monzese. Intenso programma (lo leggiamo su un manifesto che raffigura due soldati tedeschi, uno dei quali, poverino, ferito): “Preparazione del rancio con ricette d’epoca”, bello. “Cerimonia consegna onorificenze”, commovente. “Racconti, miti e leggende del Nord intorno al fuoco”. No comment. Il tutto in divisa, per la precisione quella della Wehrmacht. Organizzazione dell’accurata ricerca storica, un gruppo che si fa chiamare 36 Fusilier Kompanie (era un allegro club di volontari austriaci delle SS).
Insomma, spero vi sarà chiaro che la politica non c’entra niente: si tratta di rievocazione storica, con i nazisti en travesti che fanno i “banchi didattici” con i ragazzini e le famigliole.
Nessuno verrà fucilato e appeso agli alberi con il cartello “banditen”, nessuno verrà deportato per l’occasione in quanto ebreo o dissidente, nulla verrà requisito alle famiglie del luogo per preparare il rancio “con le ricette d’epoca”, e gli abitanti di Cologno Monzese, assistito allo spettacolo, potranno andare a fare la spesa invece che patire la fame. In soldoni: come rievocazione storica fa schifo, si può dire che è un falso.
Puntuale il doveroso corollario di polemiche e proteste, perché vedere simpatici buontemponi vestiti da nazisti che spiegano ai ragazzini cos’era Cologno durante la guerra mette in effetti un po’ i brividi.
Poi, come al solito è arrivata la toppa, un po’ peggio del buco. Il solito arrampicarsi sugli specchi: cambiata la foto del manifesto, quasi identico il programma (manca la “cerimonia consegna onorificenze”, un vero peccato per quelle croci di ferro che non verranno distribuite agli astanti). Il sindaco Rocchi (la sua amministrazione è un po’ in bilico per beghe interne, ma ha il fermo sostegno di Casa Pound, rappresentata dall’ex capogruppo leghista) ha detto che c’è polemica su tutto ciò che non piace alla sinistra e che ai giardinetti ci saranno anche la Croce Rossa, i partigiani eccetera. Insomma, dentro tutti, polverone totale, testacoda grottesco e figuraccia.
Mancando tre settimane al 25 aprile, la ridicola situazione di Cologno Monzese potrebbe servire per qualche riflessione. Quella là, la Liberazione, la Resistenza, fu una faccenda abbastanza seria e drammatica che chiudeva un periodo storico terribile, che non merita pagliacciate. Quanto all’ipotesi didattica invece sì, un intento c’è. E si rimanda ai tempi antichi della Lega bossiana, quella dell’indipendenza, dove si organizzavano ogni due per tre rievocazioni storiche di superiorità padana: divertenti ricostruzioni medievali anche in paesi nati negli anni Cinquanta. Che la Lega sia passata dai cortei in costume celtico ai campetti con le mostrine delle SS è un dato di fatto che dà da pensare.
A protestare (giustamente) con il sindaco di Cologno Monzese c’è anche il Pd milanese, per dire, quello che l’anno scorso, il 25 aprile, si presentò in piazza con magliette blu, bandiere blu e cartelli blu con nomi improbabili (persino la collaborazionista Coco Chanel). Chissà, forse l’annuncio di un campetto nazi alle porte di Milano gli ha fatto recuperare lucidità, speriamo. Ma speriamo soprattutto che lassù a Cologno nessuno si faccia male, si scotti col rancio, o resti impigliato nel filo spinato. Il sindaco invita alla festa le famiglie e gli stranieri, che così impareranno la nostra storia, ma un po’ per fiction, senza rastrellamenti.
Più di trenta presentazioni in giro per l’Italia, tante librerie, grandi piccole, indipendenti. Da Roma a Bassano, da Torino ad Assisi… Grazie a tutti quelli che sono venuti, ai librai che hanno ospitato e organizzato, a quelli che hanno letto, scritto, recensito, intervistato, fatto domande o considerazioni varie (la rassegna stampa è qui). Follia maggiore si comporta molto bene, parlare coi lettori è sempre istruttivo. I prossimi appuntamenti saranno comunicati come al solito qui, sulla pagina FB, su twitter eccetera. Per adesso grazie a tutti.
 Ieri tutti i giornali del regno, e segnatamente i gradi giornali, hanno dedicato molte righe (anche due articoli) a un fatto straordinario: il presidente della Camera, nuovo di zecca, appena uscito dalla confezione e pronto per l’uso, ha preso l’autobus. Una notizia che incomprensibilmente non è comparsa sulla prima pagina del New York Times o di Le Monde, segno di stupido disinteresse internazionale per le cose italiane. Dunque ecco Roberto Fico sul bus, con tanto di ovvia fotografia (messaggio: “io prendo l’autobus”) e inusitato clamore. I pusher di moralette da corsivo in prima pagina hanno subito tuonato: demagogia! Poi hanno notato che secondo certi dati Fico non prende spesso l’autobus, ma più sovente il taxi, avendo speso l’anno scorso circa 2.800 euro in vetture pubbliche (che, diciamolo, in un anno non è una fortuna, ma ok, complimenti ai segugi della stampa, finalmente tornati cani da guardia del potere). Insomma, la questione si fa spinosa e potremmo chiamarlo “il giallo dell’autobus 85″. Perché a Fico, nei pensosi commenti, non si rimprovera – e ci sta – soltanto un tocco un po’ naïf di demagogia, ma anche una cosa più grave. Egli ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini, perché se un malintenzionato salisse sullo stesso autobus con una scimitarra, una bomba a mano o una mitraglietta Uzi per attentare alla vita del presidente della Camera, il suo comportamento (suo di Fico, non del coglione con la mitraglietta) metterebbe a rischio cittadini onesti che hanno preso – come Fico – l’autobus 85.
Ieri tutti i giornali del regno, e segnatamente i gradi giornali, hanno dedicato molte righe (anche due articoli) a un fatto straordinario: il presidente della Camera, nuovo di zecca, appena uscito dalla confezione e pronto per l’uso, ha preso l’autobus. Una notizia che incomprensibilmente non è comparsa sulla prima pagina del New York Times o di Le Monde, segno di stupido disinteresse internazionale per le cose italiane. Dunque ecco Roberto Fico sul bus, con tanto di ovvia fotografia (messaggio: “io prendo l’autobus”) e inusitato clamore. I pusher di moralette da corsivo in prima pagina hanno subito tuonato: demagogia! Poi hanno notato che secondo certi dati Fico non prende spesso l’autobus, ma più sovente il taxi, avendo speso l’anno scorso circa 2.800 euro in vetture pubbliche (che, diciamolo, in un anno non è una fortuna, ma ok, complimenti ai segugi della stampa, finalmente tornati cani da guardia del potere). Insomma, la questione si fa spinosa e potremmo chiamarlo “il giallo dell’autobus 85″. Perché a Fico, nei pensosi commenti, non si rimprovera – e ci sta – soltanto un tocco un po’ naïf di demagogia, ma anche una cosa più grave. Egli ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini, perché se un malintenzionato salisse sullo stesso autobus con una scimitarra, una bomba a mano o una mitraglietta Uzi per attentare alla vita del presidente della Camera, il suo comportamento (suo di Fico, non del coglione con la mitraglietta) metterebbe a rischio cittadini onesti che hanno preso – come Fico – l’autobus 85.
Ora diciamolo: la mossa di prendere l’autobus per andare a lavorare il primo giorno da presidente della Camera è certamente un filino demagogica e non vogliamo qui difendere o attaccare alcuno, né il presidente Fico, né i suoi accusatori, né i passeggeri dell’85 che hanno corso il mortale rischio di saltare in aria per colpa del Presidente della Camera. Alla fine è un enorme “chissenefrega” e così andrebbe archiviato. Eppure tocca ricordare alcuni precedenti. Quando, chiamato da Napolitano, Mario Monti corse a Roma per prendere l’incarico di Presidente del Consiglio e affrontare lo Spread a mani nude, il peana che i giornali gli riservarono derivava in gran parte di una straordinaria rivoluzione culturale: il Genio aveva preso il treno e – meraviglia e sgomento – lungo la banchina della stazione aveva addirittura trascinato da sé il trolley.
I lettori di interiora di pollo e fondi di caffè avevano allora preconizzato una nuova era. Si è visto. Altri divertenti saltimbanchi hanno imitato poi il gesto: foto su foto di Matteo Renzi in treno, in Smart (guidava Carbone, quello del “ciaone”, povera stella), in bicicletta, monopattino, parapendio, bob a due, bob a quattro e catamarano, per dire, mentre lui celiava “la mia scorta è la gente”. E si è visto anche lì.
Insomma, da anni abbonda la retorica del “lui non è come gli altri” legata ai mezzi di trasporto, e fa piacere che nel caso di Fico, finalmente, alla buon’ora, i pasdaran del commentino arguto, per una volta, non si siano fatti infinocchiare. Eh, no, a quelli lì non gliela si fa. Con la faccenda che “Uh, che bravo sa anche andare a piedi” ci sono cascati con tutte le scarpe con Monti, con Renzi, con Rutelli quando andava in motorino, ma con Fico dicono: basta, questa volta non ci fregate.
Non possiamo che rallegrarci per il repentino risveglio e la ritrovata verve “gentista”. Ma sì, proprio quella rimproverata per anni ai plebei grillini e ora in voga presso le élite. Insomma, Fico, faccia il piacere, non lo faccia più. Mette in allarme il paese, a rischio i poveri utenti dell’autobus 85 e soprattutto svela un meccanismo complesso della politica italiana: a fare i talebani si fa un po’ a turno, e ora tocca ai grandi giornali autorevoli e responsabili. Mah, sarà la famosa alternanza.
 Ora che da Tempe in Arizona sappiamo che il famoso algoritmo al volante può essere disastroso come l’ubriaco del paese che rincasa zigzagando, ci sentiamo un po’ meglio: forse non saremo tanto presto governati da macchine (che comunque, rispetto a chi ci governa da decenni è un’ipotesi suggestiva). Ma, come accade spesso, il cittadino comune non ha nemmeno la più pallida idea dei progressi che, a sua insaputa, sta facendo la ricerca in materia di automazione. Ecco il punto della situazione
Ora che da Tempe in Arizona sappiamo che il famoso algoritmo al volante può essere disastroso come l’ubriaco del paese che rincasa zigzagando, ci sentiamo un po’ meglio: forse non saremo tanto presto governati da macchine (che comunque, rispetto a chi ci governa da decenni è un’ipotesi suggestiva). Ma, come accade spesso, il cittadino comune non ha nemmeno la più pallida idea dei progressi che, a sua insaputa, sta facendo la ricerca in materia di automazione. Ecco il punto della situazione
L’auto a guida autonoma. La macchina che si guida da sola aveva molto impensierito le grandi compagnie assicurative: se nessuno mette più sotto nessuno, noi che fine facciamo? Angoscioso dilemma risolto a Tempe, Arizona, un problema di meno, vedi che la ricerca serve? Ora un’altra questione è al centro degli studi più avanzati: come si trova un parcheggio? Uber e Google stanno studiando una macchina a guida autonoma con mini-betoniera che spiana il marciapiede e ci disegna delle strisce, nei modelli più costosi munita di algoritmo-motosega per tagliare gli alberi e parcheggiare al posto loro. Quasi pronta la macchina-asfaltatrice per le buche. Qualche preoccupazione nei campus delle scuole americane per il timore di nuove stragi: “Oh, no! Hanno di nuovo sparato sui compagni?”. “No, hanno truccato la macchina di papà”.
Le opere pubbliche a guida autonoma. Segretissima sperimentazione tutta italiana, la Grande Opera a guida autonoma rivoluzionerà molti settori della vita pubblica. Si tratta di un algoritmo che valuta i progetti, le ricadute economiche, gli appalti, le concessioni pubbliche, e poi affida i lavori per grandi progetti infrastrutturali a un suo amico. Sarà una vera rivoluzione, perché il lavoro che oggi viene fatto da centinaia di politici, imprenditori, grandi cooperative, mediatori, facilitatori, traffichini, lobbisti, corrieri di banconote non segnate in piccolo taglio, sarà eseguito da una macchina. Grandi ricadute anche sulla magistratura, perché un algoritmo può sostenere lunghi interrogatori anche senza bere o mangiare e non è così scemo da consegnare valige di contanti al bar. Certo resterà un margine di errore umano, tipo ingegnere e assessore intercettati. “Lo interrogano da tre giorni, corriamo rischi, cumpà?”. “Ma no, tranquillo, l’algoritmo non parla”.
La moglie a guida autonoma. Ecco un caso in cui la sperimentazione sta andando malissimo. Il rivoluzionario algoritmo della moglie italiana dovrebbe prevedere nervi d’acciaio, capacità atletica e riflessi fulminei per evitare le pallottole dei mariti, lanci di pietre e stoviglie, assalti con armi da taglio e altre aggressioni, capacità che andrebbero rafforzate in caso di separazioni e divorzi, quando lui si presenta armato come Rambo perché “Cara, dobbiamo parlare”. Il mondo della ricerca è diviso e c’è chi chiede un cambio di prospettiva (“Perché non studiamo l’algoritmo del marito-meno-stronzo?”), ma per ora è soltanto un dibattito teorico (anche perché i finanziatori della ricerca sono tutti uomini).
Il Pd a guida autonoma. Non poteva mancare la politica tra le più avanzate ricerche sull’intelligenza artificiale. La sperimentazione fatta nel Pd negli ultimi anni è stata assai deludente. Coordinare segretario, adoratori della prima, seconda, terza ora, commentatori politici, titolisti e retroscenisti, arredatori di Leopolde, psicoanalisti, incapaci scrittori di riforme farlocche, e poi riprogrammarli perché diventino avversari della prima, seconda, terza ora, poi scrivere tutti i tweet, inventare gli hashtag… anche l’algoritmo alla fine si rompe i coglioni e vota per qualcun altro. La tecnologia allo studio è stata così deludente che l’algoritmo è stato momentaneamente disattivato. Le sue ultime parole: “Non abbiamo saputo comunicare le cose buone che abbiamo fatt….”
 Grazie a tutti quelli che sono venuti alle presentazioni di Follia maggiore fatte finora. Qui sotto le date dei prossimi giorni
Grazie a tutti quelli che sono venuti alle presentazioni di Follia maggiore fatte finora. Qui sotto le date dei prossimi giorni
Sabato 24 marzo – Suzzara, ore 18.00. Nebbiagialla Off – conversazione sul libro con Paolo Roversi (viale Zonta 6/a)
Domenica 25 marzo – Milano, ore 17.00. BookPride – presentazione di Follia maggiore con Ranieri Polese
Lunedì 26 marzo – Vicenza, ore 18.00. Libreria Gala (corso Palladio 11)
Martedì 27 marzo – Padova, ore 13.30. Fastbook (via Breda 26/F, Limena, incontro con i librai)
Martedì 27 marzo – Bassano, ore 18. Libreria Palazzo Roberti (via Jacopo da Ponte 24)
Mercoledì 28 marzo – Padova, ore 18. Libraccio (via Altinate 63)
Mercoledì 28 marzo – San Bonifacio (Verona), ore 20.45. Sala civica Barbarani (via Marconi 5)
 E’ un vero peccato che le pagine dell’economia, sui quotidiani italiani, siano così lontane da quelle della politica. E’ come fare un salto dal paese surreale al paese reale, come quando, usciti da teatro, si torna a casa, nella vita vera. All’inizio, per milioni di righe, ci becchiamo le contorsioni delle grandi manovre, le ipotesi, i retroscena. La crisi coniugale in atto nel centrodestra tra Salvini e Silvio Restaurato, o i Cinque stelle che mettono su una faccia istituzionale e fanno di tutto per mostrarsi i più democristianamente misurati. Del Pd, ormai sempre più simile a una rappresentazione de L’ispettore generale di Gogol’ non ha senso dire e contano soltanto il chiacchiericcio pettegolo e la spigolatura, al massimo la nuova cartografia delle correnti, con enormi mappe di zone misteriose dove campeggia la scritta Hic sunt renziones, e ci sono macerie. E poi c’è la più o meno raffinata analisi di cause e concause, cioè il “come siamo arrivati a questo punto”.
E’ un vero peccato che le pagine dell’economia, sui quotidiani italiani, siano così lontane da quelle della politica. E’ come fare un salto dal paese surreale al paese reale, come quando, usciti da teatro, si torna a casa, nella vita vera. All’inizio, per milioni di righe, ci becchiamo le contorsioni delle grandi manovre, le ipotesi, i retroscena. La crisi coniugale in atto nel centrodestra tra Salvini e Silvio Restaurato, o i Cinque stelle che mettono su una faccia istituzionale e fanno di tutto per mostrarsi i più democristianamente misurati. Del Pd, ormai sempre più simile a una rappresentazione de L’ispettore generale di Gogol’ non ha senso dire e contano soltanto il chiacchiericcio pettegolo e la spigolatura, al massimo la nuova cartografia delle correnti, con enormi mappe di zone misteriose dove campeggia la scritta Hic sunt renziones, e ci sono macerie. E poi c’è la più o meno raffinata analisi di cause e concause, cioè il “come siamo arrivati a questo punto”.
Ecco.
Per suggerire una lettura di primo livello, per chi ancora ha il novecentesco vezzo di collegare la politica ai bisogni reali delle persone, basterebbe dare un’occhiata anche veloce allo studio di Bankitalia su reddito, ricchezza, crescita e diseguaglianze. Qualche numeretto, qualche linea di grafico che va su e giù, ed ecco in due minuti il “come siamo arrivati fin qua”, spiegato bene.
Quasi 14 milioni di italiani vivono con meno di 830 euro al mese, uno su quattro. Sono più poveri i giovani (il 30 per cento ha meno di 35 anni), sono più poveri al Sud (40 per cento). Tra il 2006 e il 2016 (dieci anni in cui hanno governato un po’ tutti gli attori della pièce qui sopra, spesso intrecciati in amorosi sensi) il rischio povertà per i capifamiglia tra i 35 e i 45 anni è passato dal 19 al 30 per cento, che vuol dire che quasi una famiglia su tre teme lo scivolamento verso il proletariato, categoria numerosa di cui nessuno si occupa (nemmeno degni di 80 euro, per dire: troppo poveri).
L’indice Gini, quello che misura il tasso di diseguaglianza, è aumentato in dieci anni di un punto e mezzo. Questo significa che pochi ricchi sono diventati più ricchi e che molti poveri sono diventati più poveri. E questo è avvenuto con Prodi, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi e tutto il cucuzzaro, con buona pace i quelli che dicono che “serve stabilità”. Più stabili di così si muore: la tendenza è dritta come un fuso e premia la diseguaglianza.
Si dirà: la crisi, le circostanze, il contesto. Bene. E poi si scopre (sempre Bankitalia) che quando arriva una ripresina non la vede nessuno: nel 2017 il Pil è salito del 1,5 per cento, mentre alle famiglie è arrivato solo lo 0,7, la metà. Si capisce quindi il comprensibile astio di chi, in condizioni di sofferenza, non solo si vede arretrare, ma osserva altri avanzare, toccando con mano un’ingiustizia palese e offensiva. Si collabora alla ripresa, si lavora con meno diritti, con meno salario, con meno sicurezze, e poi quando la ripresa arriva (la più piccola in Europa) non si vedono nemmeno le briciole. Fa un po’ incazzare, specie poi quando vedi un partito asserragliato nelle zone ricche del paese e delle città, magnificare le sue politiche “di sinistra”, snocciolare numeri trionfali (e spesso falsi) sul lavoro dimenticandosi i working poors, cioè milioni di cittadini che, pur lavorando, restano poveri, anzi lo diventano di più. Con la destra, con il centrosinistra, con i tecnici, con i rottamatori, con i posati statisti, la diseguaglianza economica nel Paese è aumentata senza soste, costante, implacabile.
Poi naturalmente uno può anche appassionarsi alla segreteria Martina, alle manovre di Salvini, alle tattiche di Di Maio o agli appelli di Mattarella: è come leggere la rubrica “strano ma vero” sulla Settimana Enigmistica, deliziosamente insignificante.
 C’è qualcosa di peggio delle sconfitte e dello scoramento, delle bocciature e degli schiaffoni. E’ un mostro che si avvicina quatto quatto, allunga la manona e ti ghermisce: è il mostro del Ridicolo.
C’è qualcosa di peggio delle sconfitte e dello scoramento, delle bocciature e degli schiaffoni. E’ un mostro che si avvicina quatto quatto, allunga la manona e ti ghermisce: è il mostro del Ridicolo.
Ora, naturalmente, si può mettere in satira tutto, ma sarebbe fin troppo facile, è il guaio che si presenta quando l’originale suona più grottesco della caricatura.
E così il Renzi della conferenza stampa delle (non) dimissioni è inarrivabile. Se si vinceva il 4 dicembre… Se Mattarella ci mandava a votare… la colpa è sempre altrove, e lui fa la parte eroica di quello che offre il petto al plotone d’esecuzione, peraltro composto di complici, purché spari a salve.
Insomma, il Renzi-Napoleone è stato qualche giorno all’isola d’Elba dopo il referendum perso, è tornato, ma ora deve andare a Sant’Elena, e prende tempo come quelli che ci mettono mesi a far la valigia.
Ma dicevo: il ridicolo. Nulla è peggio che mostrarsi in un modo e risultare in un altro. E in quella stanzetta affollata di microfoni succedeva proprio questo: uno che si presenta pugnace e combattivo, credendosi John Wayne con la pistola spianata, e che invece sembra a tutti un concentrato di albertosordismo: a me è Mattarella che m’ha fregato… Si vincevo er referendum sa ‘n do stavo io? Frignone. Ridicolo, appunto.
E ridicola, cosa subito evidente a tutti i maggiorenti del Pd che gli hanno tenuto il sacco fino a tre minuti prima, anche la sostanza politica. Riassumendo: ecco il grande Leader che si dimette, ma pretende di dettare la linea, di gestire la transizione, di andare alle consultazioni al Quirinale. Insomma, l’assassino si costituisce va bene, gesto nobile, ma prima chiede di nascondere il cadavere, cancellare le impronte, farsi un alibi, accusare qualcun altro. E’ il rilancio del perdente, è il pugile che dopo aver perso per ko – quando le luci sono spente, gli spettatori andati via, l’avversario già al ristorante a festeggiare – grida a nessuno: ora ti faccio vedere io!
Non sa, e qualcuno dovrebbe dirglielo, che un politico dimissionario che va a fare delle trattative verrà guardato come un garzone di bottega, e chiunque potrà dirgli in ogni istante: “Su, su, ragazzo, non perdiamo tempo, mi faccia parlare col titolare”.
Oggi Renzi è tutto questo. I grossi calibri del Pd fingono costernazione, come se non conoscessero il soggetto, e resiste qualche giapponese nella giungla. Intanto, si segnala la scomparsa dei burbanzosi ragazzotti renzisti, quelli dello storytelling, della narrazione, del “Noi sentiamo il pensiero di Matteo Renzi prima che accada” (sic). Quelli delle grandi strategie di comunicazione e di racconto, ignorantissimi sacerdoti della disintermediazione, studiosi di scienza della comunicazione che non hanno capito né la scienza né la comunicazione. Quelli che ad ogni mossa del capo ne cantavano le gesta e che ora, senza più gesta, senza più capo, non sanno che fare, divagano, fanno i teorici dopo esser stati praticissimi cantori del nulla.
Il ridicolo, però, non perdona e non ha pietà. Vedere Matteo Renzi illividito che lancia le sue dimissioni con l’elastico, che minaccia invece di chiedere scusa, è un contrappasso enorme per chi inventò e brandì verso i nemici la parola “rottamazione”. La conferenza stampa prendeva ad ogni minuto le sembianze di una presa d’ostaggi: me ne vado, ma voglio dettare la linea politica per quando me ne sarò andato. Poteva far più ridere di così? Forse sì: avesse chiesto documenti falsi, un elicottero e una valigia di dollari sarebbe risultato più simpatico, ma la sostanza non cambia. Come Silvio, anche Matteo ha una modalità sola: quella della vittoria arrogante. Davanti alla sconfitta non è attrezzato, si distrae, dimentica che tutti una volta nella vita possono dire: “Dovrai passare sul mio cadavere”. Tutti, tranne il cadavere.
 Solo una manciata di ore ci separa dal fatidico 4 marzo, dalle maratone televisive, dagli exit-poll, dalle simulazioni, dalla nota giaculatoria “aspettiamo le prime proiezioni” e “aspettiamo i dati veri”. Ora pro nobis. Amen. Una legge elettorale che pare scritta in manicomio da uno che crede di essere Napoleone aumenterà la suspance.
Solo una manciata di ore ci separa dal fatidico 4 marzo, dalle maratone televisive, dagli exit-poll, dalle simulazioni, dalla nota giaculatoria “aspettiamo le prime proiezioni” e “aspettiamo i dati veri”. Ora pro nobis. Amen. Una legge elettorale che pare scritta in manicomio da uno che crede di essere Napoleone aumenterà la suspance.
Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblica alcuni consigli per limitare i danni al sistema nervoso centrale durante le dirette elettorali. Seguendo questi semplici consigli e rispettando i dosaggi dei medicinali prescritti sopravviverete alla notte del 4 marzo. Cioè, speriamo.
La spesa. Ricordiamo che le tonnellate di pop corn che ingurgiterete dovranno essere accompagnate da molta acqua. Evitare i superalcolici almeno fino ai primi dati ufficiali del Viminale o alla seconda proiezione di Pagnoncelli (è concessa un’eccezione quando compare la Meloni). Corde e nastro adesivo al reparto bricolage (poi capirete perché). Snack di ogni tipo, compresi quelli non ancora inventati. Una calcolatrice (reparto cancelleria) per quelli che volessero calcolarsi al volo, già al primo exit poll, il loro margine di guadagno con la Flat tax di Silvio, o quella di Salvini.
Postura. Se non avete uno di quei cuscini-collare che si usano per i lunghi viaggi aerei, procuratevi un foulard: vi servirà per tenere su la mascella nei momenti di sconforto. Il divano è sempre il luogo migliore per partecipare alla vita politica del paese così come emerge da queste elezioni, ma consigliamo di non stravaccarsi già dalle prime battute e aspettare i dati del maggioritario a Bologna. Raccomandazione importante per gli elettori Pd: occhio, ragazzi, non è che potete mangiare ansiolitici e antidepressivi come caramelle. Non più di due per ogni proiezione del maggioritario (per il proporzionale: ricordatevi i fermenti lattici e le vitamine).
Ospiti. Vi venisse mai in mente di inviare qualche ospite a vedere l’impareggiabile spettacolo delle dirette elettorali, il consiglio è quello di sceglierli bene: trovarsi all’improvviso in salotto un leghista che esulta agitando il rosario sarebbe micidiale per la vostra reputazione. Un ultras Cinque Stelle che balla sui tavoli o che precipita nel più tetro sconforto ululando alla luna allarmerebbe i vicini. Si consiglia una severa selezione all’ingresso, ma dovesse capitare l’incidente, usate le corde e il nastro adesivo che avete acquistato prima.
Psicologia di base. Non infierite sulle vittime. Se avete accanto qualcuno del Pd non dite quelle cose che sicuramente vi verranno in mente, tipo “Ciaone”, o quel delizioso “Ce ne faremo una ragione” che per anni è stata la parodia renzista del famoso “Me ne frego” del Ventennio. Stategli vicino, invece, consolatelo. Le tisane non funzionano, ma nei casi più gravi provate a dargli ottanta euro (insieme a Ansiolin 25 mg comprese, a stomaco pieno). Si consiglia di tenerli occupati (l’ideale sarebbe un Lego del ponte sullo Stretto, o un puzzle di 8.000 pezzi che ritrae la Serracchiani).
Combattere il torpore. Verso le cinque del mattino può insorgere una certa debolezza, rallentamento dei riflessi, torpore. Si consiglia, per restare svegli, di intavolare un’eccitante discussione sulla legge elettorale che bisogna fare al più presto, ma con quale maggioranza? Rivotare subito? No, giovedì prossimo. No in giugno. No in novembre. Nel caso la discussione decollasse, si consiglia di nascondere alla vista armi da taglio, il coltello del pane o quello che avete usato per la torta alla terza proiezione di Masia per il Senato.
Champagne. Confidiamo che non siate così folli da mettere in frigo una bottiglia di champagne. Nel caso, è più facile che vi servirà per varare un transatlantico che per festeggiare l’esito delle elezioni.
 Nell’ultima domenica preelettorale ecco Matteo nostro al centro del Consensodromo italiano per eccellenza, il Che tempo che fa di Fabio Fazio, luogo che esclude per vocazione ogni sorpresa o intoppo. E infatti: nessuna palla liftata, ogni domanda scartavetrata al millimetro per evitare spigoli, ottimo impiattamento. L’enterteiner di Rignano sa di avere una buona spalla e mette mano al repertorio. “Trump dà le armi agli insegnanti, e invece le armi degli insegnanti sono i libri”, dice quello che agli insegnanti ha dato la buonascuola. Vero che Fazio gli rovina per irruenza una battuta e lui è costretto a infilarla per forza senza i tempi giusti, ma è poca cosa (“La Flat tax è Babbo Natale e il reddito di cittadinanza è la befana”. Nota per gli autori di Renzi: essù, ragazzi!).
Nell’ultima domenica preelettorale ecco Matteo nostro al centro del Consensodromo italiano per eccellenza, il Che tempo che fa di Fabio Fazio, luogo che esclude per vocazione ogni sorpresa o intoppo. E infatti: nessuna palla liftata, ogni domanda scartavetrata al millimetro per evitare spigoli, ottimo impiattamento. L’enterteiner di Rignano sa di avere una buona spalla e mette mano al repertorio. “Trump dà le armi agli insegnanti, e invece le armi degli insegnanti sono i libri”, dice quello che agli insegnanti ha dato la buonascuola. Vero che Fazio gli rovina per irruenza una battuta e lui è costretto a infilarla per forza senza i tempi giusti, ma è poca cosa (“La Flat tax è Babbo Natale e il reddito di cittadinanza è la befana”. Nota per gli autori di Renzi: essù, ragazzi!).
Abituato a personalizzare quando vinceva, ora che rischia di perdere collettivizza molto, dice “noi del Pd”, e parla di sé solo per autoammonirsi (…”se no divento noioso”).
Sul fascismo calma piatta: e quando hanno sparato alla sua sede (oltre che a sei migranti, dettaglio) a Macerata, nessuno gli ha dato solidarietà. Nemmeno lui, peraltro, che non ha voluto manifestare a Macerata. Comunque non si lascia sfuggire l’occasione per mettere sullo stesso piano Potere al Popolo e Forza Nuova, prove di opposti estremismi che sono il cacio sui maccheroni dei centristi. Dopo aver detto che il suo bello è di non far promesse, promette più soldi a tutti “nel sociale”. Risultato mesto e mogio e un guizzo solo, ma involontario: lui all’anziano malato darà “Incentivi fiscali per morire nel suo letto”. Ah. Però!
L’introduzione dell’indice di Felicità permette finalmente di superare gli aridi calcoli del Pil. I soldi non sono tutto nella vita, ci sono anche piccole e grandi gioie come trovare parcheggio sotto casa (più 2 punti felicità), la radiografia senza brutte sorprese (più 15 punti felicità, ma vi aumentiamo il ticket), e la signorina del quarto piano che, contro ogni previsione, accetta l’invito a cena (più 75 punti, ma in questo caso vi raddoppiamo l’aliquota Irpef). A cinquant’anni dalla famosa invettiva di Bob Kennedy contro il Pil, abbiamo finalmente uno strumento che misura la felicità, un semplice algoritmo per cui risulta che il Buthan, per esempio, sia uno dei paesi più felici al mondo, anche se il Pil pro-capite è leggermente inferiore a quello di un disoccupato calabrese. Questo lo diciamo per i disoccupati calabresi: coraggio amici, su con la vita, ci sono ampi margini di miglioramento, se c’è gente felice con una capra e un etto di burro di yak, chi siete voi per lamentarvi?
Per i calcoli della misurazione della felicità interna lorda e della felicità pro-capite rimandiamo alle tabelle del ministero, ma è chiaro che in un sano paese liberista la felicità si paga. Così abbiamo studiato un complesso sistema di compensazioni per cui all’aumento della felicità si affianca una riduzione delle detrazioni nel Modello Unico. Siete felici perché è nato il bambino? Perfetto: vi raddoppiamo la rata dell’asilo nido. Tanto la felicità coi soldi non c’entra niente, vero?
Da parte nostra, ci impegniamo al rapido adeguamento della macchina amministrativa: creazione di un Ministero della Felicità, con otto sottosegretari, 42.000 dipendenti e provveditorati in tutte le province. Il cittadino è tenuto a comunicare entro giorni tre il momento di felicità conseguito (modulo Sf-23-D), aspettare la risposta (entro 60 giorni), farla vidimare in un altro ufficio, spedirla per raccomandata (allegando il modulo Gf-67-K) e pagare.
Dai, non siete felici?
 Tra le magie della campagna elettorale e gli incantesimi pronta cassa della propaganda, ecco l’ultimo genio della lampada. Strofina, strofina, e voilà: il ministro dell’Industria (2 punto 0, 3 punto 0, 4 punto 0, variare a piacere) che si trasforma in delegato Fiom e chiama “gentaglia” i dirigenti della multinazionale che va a fare i compressori in Slovacchia rovinando cinquecento famiglie. Carlo Calenda si è fermato un attimo prima di andare a tirare i sassi alle finestre, ma insomma: il messaggio è chiaro, un pugno sul tavolo, basta coi padroni che se ne approfittano. E’ davvero un caso di mimetismo strategico degno di animali come l’insetto-foglia o il polpo mimetico dell’Indonesia: all’avvicinarsi minaccioso delle elezioni, il fiero liberista diventa una specie di Di Vittorio, come tale salutato dai giornali, hurrà.
Tra le magie della campagna elettorale e gli incantesimi pronta cassa della propaganda, ecco l’ultimo genio della lampada. Strofina, strofina, e voilà: il ministro dell’Industria (2 punto 0, 3 punto 0, 4 punto 0, variare a piacere) che si trasforma in delegato Fiom e chiama “gentaglia” i dirigenti della multinazionale che va a fare i compressori in Slovacchia rovinando cinquecento famiglie. Carlo Calenda si è fermato un attimo prima di andare a tirare i sassi alle finestre, ma insomma: il messaggio è chiaro, un pugno sul tavolo, basta coi padroni che se ne approfittano. E’ davvero un caso di mimetismo strategico degno di animali come l’insetto-foglia o il polpo mimetico dell’Indonesia: all’avvicinarsi minaccioso delle elezioni, il fiero liberista diventa una specie di Di Vittorio, come tale salutato dai giornali, hurrà.
Che Calenda sia incazzato ci sta, non c’è niente di più sfiancante di gente (“gentaglia”) che “si siede a un tavolo” e poi fa quel che vuole. E divertente è anche l’assenza totale dal dibattito del ministro del Lavoro, uno che andava bene per truccare i dati sul Jobs act, e teorizzare il trasporto di verdura in cassette come scuola di vita, bene, grazie, il suo l’ha fatto.
Un po’ meno divertente, specie per chi ci rimane stritolato in mezzo, è il maledetto mondo reale. Di aziende che si insediano (magari rilevando qualche disastro e passando per salvatrici della patria), prendono soldi, agevolazioni e incentivi pubblici, e poi fanno quello che gli pare, è piena la storia recente del paese. Chi compra e scappa con gli impianti, chi trasferisce le produzioni dove conviene di più, chi disattende accordi e contratti. Da anni e anni i lavoratori italiani (e parliamo di quelli con un contratto, pensa gli altri!) vivono in uno stato di agitazione perenne, di allarmata insicurezza. Le crisi diventano vertenze, e diventano “tavoli”, e diventano “trattative”, e diventano “interventi” e poi, passano sei mesi, passa un anno, ecco che si riparte (quando va bene) con meno lavoratori, o salari più bassi, o condizioni di lavoro peggiorate, coi sindacati quasi sempre costretti a ingoiare rospi e a gioire per il “meno peggio” raggiunto.
Si dirà: è il mercato bellezza.
Ma è anche interessante andare a vedere come nell’ultima legislatura (cinque lunghi anni) si è risposto a questa insicurezza di massa, a questo timore-tremore che si può perdere il lavoro da un momento all’altro. In buona sostanza, i lavoratori italiani sono stati irrisi costantemente e con regolare pervicacia. Prima con la favoletta bella della disintermediazione, poi evocando il vecchiume delle battaglie sindacali (“Mettono il gettone nell’iPhone”, il più volgare schiaffo ai lavoratori mai arrivato dal giovane segretario Pd in trance agonistica). Poi si innestò una guerra generazionale, indicando i lavoratori assunti come indecenti privilegiati. Poi fu il turno della legge sul lavoro col nome inglese, scritta a quattro mani con Confindustra (due mani di Confindustria, le altre due di Confindustria), il tutto con l’aggiunta dei ricami teorici-filosofici del sor Poletti, quello che “per trovare lavoro è meglio giocare a calcetto che mandare il curriculum”. Lo stesso Renzi, ma sì, lo statista, incontrava il capo di Amazon e lo definiva “un genio”, ma ammetteva poi in tivù – in occasione di uno sciopero ad Amazon – di non conoscere le condizioni di quei lavoratori. Indicare ad esempio i padroni come nuovi signori rinascimentali, coprirli con miliardi di incentivi, stargli accanto quando brillano per catturare un po’ del riflesso: questo è stato fatto in questi anni (e soprattutto nei nefasti mille giorni di Renzi). E ora, a dieci giorni dalle elezioni, ecco un membro del governo sbottare come un Cobas inviperito. Che spettacolo!
Il mio amico Mauro Zambellini, vecchio compagno di avventure al Mucchio Selvaggio, una vita fa, mi ha intervistato per il Buscadero, un giornale che a noi dylaniani, beh… Bella intervista, grazie (pdf)
 Piccola proposta di decenza per quel che resta della campagna elettorale: una moratoria sulla cronaca nera. Almeno sulle vittime, almeno sui morti, e morti male, su cui stampa e tivù si avventano come una nuvola di mosche. Sappiamo tutti che da qualche anno il dibattito politico sembra una seconda media di bambini difficili. Rimproverare cazzate all’avversario sembra l’unico argomento: ad ogni critica si può sempre rispondere: e allora il Pd? E allora i 5Stelle? E allora Silvio?: un battibecco che sta evolvendo, e ora si occupa di sangue.
Piccola proposta di decenza per quel che resta della campagna elettorale: una moratoria sulla cronaca nera. Almeno sulle vittime, almeno sui morti, e morti male, su cui stampa e tivù si avventano come una nuvola di mosche. Sappiamo tutti che da qualche anno il dibattito politico sembra una seconda media di bambini difficili. Rimproverare cazzate all’avversario sembra l’unico argomento: ad ogni critica si può sempre rispondere: e allora il Pd? E allora i 5Stelle? E allora Silvio?: un battibecco che sta evolvendo, e ora si occupa di sangue.
Il solito beneamato trucchetto della “sicurezza” è una fuoriserie che la destra lucida e mette in moto ad ogni elezione, una specie di jolly da giocare nella partita della propaganda. Il Pd ci casca con tutte le scarpe, un classico, i 5Stelle si occupano di bonifici. Accanto alla (strabiliante, in effetti) disposizione emotivo-elettorale delle forze in campo, serpeggia nel paese una specie di tifo da stadio su morti e feriti, una specie di pallottoliere di carnefici e vittime. Se il marocchino ubriaco investe con la macchina la vecchietta sulle strisce pedonali, ecco immediatamente che la povera vittima diventa una bandiera della Lega. Al contempo, può accadere che un italiano, sbronzo pure lui, metta sotto un ragazzino nero, ed ecco riequilibrato il conto. Come se due ingiustizie, due tragedie, potessero pareggiarsi sul filo della propaganda. Ad ogni schifezza del male umano corrisponde una schifezza uguale e contraria. Segue polemicuccia. Erano gli albanesi. Ma no, quell’altro allora che era italiano? Ecco, le bestie nigeriane! E il tramviere di Milano, allora? Una gara a perdifiato per cui davanti a un fatto di sangue la prima domanda che si fa non è “come sta la vittima?” o “L’hanno preso?”, ma “Era straniero?”, “Era italiano?”.
La pietà su base etnica, la vita (e la morte) della gente che diventa un tassello della narrazione tossica.Una dialettica politica basata sul rimpallo, sull’arte più o meno sarcastica di rinfacciarsi errori e stupidaggini a vicenda è arrivata alla frontiera dei morti e dei feriti, gente con la vita spezzata del tutto, famiglie di cui cambia il destino.
Non è difficile immaginare lo screening quotidiano delle pagine di cronaca nera dello staff di Salvini: cercare il caso del giorno per portare un’altra tanica di benzina verso l’incendio. E altrettanto spaventosa è a volte la risposta politica: si cerca il caso uguale e contrario, in un rimpallo di vittime che ha qualcosa di osceno. In una gara spesso sporca e truccata, che trasuda malafede: chiunque abbia parlato degli innocenti sparati dal fascista di Macerata si è sentito rimpallare: perché non dici della povera Jessica? Tutto si mischia, tutto serve alla causa, senza alcun rispetto: delle vittime non gliene frega niente a nessuno, ci sono quelle che servono e quelle che servono meno. Il dolore che resti privato, qui serve usare la sua caricatura in pubblico
Inutile dire: in questo sconcio ping pong si scontrano due posizioni ideologiche. I razzisti xenofobi pancia a terra per dimostrare che l’immigrazione porta violenza e reati (anche con molte fake news, scemenze inventate, accuse false); gli altri fanno notare con ragione che i delinquenti sono anche bianchi, italiani, e anzi le statistiche confermano che sono molto più numerosi (si pensi soltanto alle violenze in famiglia dove “prima gli italiani” rasenta il novanta per cento).
Ma per quanto siano definiti i campi, e per quanto torti e ragioni siano evidenti, resta un grande disagio per questo giocare con le figurine dei morti ammazzati, per questa vergognosa caricatura di giustizia salomonica per cui un benzinaio rapinato dall’albanese si elide col gioielliere che spara al ladro. Una vera dance macabre, intorno a tutti noi.
Radio Popolare, si sa, per me è come casa. Il direttore, Michele Migone mi ha invitato a parlare di Follia maggiore. E di altro, naturalmente. Qui sotto, per chi vuole
Qui l’intervista di Bruno Ventavoli per Tutto Libri su La Stampa tv
 Non ci vuole una fantasia particolare, o chissà quale slancio romanzesco per vedere la scena, dunque si può provare senza nemmeno chiudere gli occhi. Frau Angela Merkel, saputo che un pistolero nazista sparacchia per la strada agli immigrati neri (a Dresda, o Francoforte, o Monaco, fate voi), fa la sua sacrosanta dichiarazione ai media, poi prende la sua borsetta da sciura Pina e va all’ospedale, stringe le mani ai feriti, chiede come va, incontra i medici e insomma in poche parole, senza dire proprio queste precise, comunica alla Germania e al mondo: io, io Repubblica Tedesca, sto dalla vostra parte, e non da quella di chi vi spara.
Non ci vuole una fantasia particolare, o chissà quale slancio romanzesco per vedere la scena, dunque si può provare senza nemmeno chiudere gli occhi. Frau Angela Merkel, saputo che un pistolero nazista sparacchia per la strada agli immigrati neri (a Dresda, o Francoforte, o Monaco, fate voi), fa la sua sacrosanta dichiarazione ai media, poi prende la sua borsetta da sciura Pina e va all’ospedale, stringe le mani ai feriti, chiede come va, incontra i medici e insomma in poche parole, senza dire proprio queste precise, comunica alla Germania e al mondo: io, io Repubblica Tedesca, sto dalla vostra parte, e non da quella di chi vi spara.
Già che ci siamo, spostiamo l’immaginazione un po’ più a ovest, in Francia. Ed ecco Monsieur l’Empereur Macron che mette su quella sua ghigna napoleonica, pancia in dentro, petto in fuori, scarpe lucide. Dichiara che questo in Francia non può succedere e va all’ospedale, dove stringe presidenzialmente la mano alle vittime. Chiede delle condizioni di salute dei feriti, poi ricorda al mondo che la Francia è vicina alle vittime e le aiuterà in ogni modo.
Sipario.
Ognuno veda le differenze con la situazione italiana, dove il testacoda è semplicemente da brividi. Non solo nessuna figura istituzionale è andata a visitare gli innocenti colpiti. Ma per due giorni, dopo che un pazzo (mah!) fascista si è messo a sparare per la strada come un qualunque terrorista dell’Isis, il dibattito si sviluppa su questi arguti temi. Uno: non si spara alla gente per la strada. Due: Beh, però, se uno è esasperato, dai, si può capirlo. Il tutto con decine e decine di sfumature, nuances, minuscoli slittamenti di colore. In poche parole: Salvini a reti unificate, un’accettazione profonda del suo discorso, il trionfo della narrazione fascio-leghista. Persino davanti a sei feriti innocenti in un raid terroristico, la vulgata prevalente sul tema dell’immigrazione è ancora quella di Salvini. Qualunque altro leader mondiale, anzi della Galassia, anzi dell’Universo, compaia in una foto mentre stinge la mano a quello che poi andrà in giro a sparare per la strada, avrebbe la carriera troncata. Salvini no, Salvini guadagna punti nei sondaggi.
Il capo del Pd, si legge sui giornali, “ha ascoltato con preoccupazione gli esperti di marketing elettorale”. Urca. Poi ha deciso per la linea morbida e la solita richiesta di sicurezza: più Polizia, più Carabinieri. E del resto la sua sudditanza all’impianto salviniano era già stata dichiarata con un “aiutiamoli a casa loro” da manuale. Silvio buonanima si è messo a rincorrere Salvini praticamente sostenendo che se la gente spara per strada agli stranieri è perché ci sono gli stranieri, e lui li manderà via. I cinque stelle hanno fischiettato e parlato d’altro, non essendo perfettamente al corrente di quel che pensa la loro base elettorale.
Intanto, le vittime dello jihadista della Lega, quelli che stavano andando a lavorare, o aspettavano l’autobus, o tornavano a casa e che sono finiti sparati da uno che leggeva il Mein Kampf, lo Stato italiano lo hanno incontrato. Poliziotti che sono corsi sul posto, guidatori di ambulanze, infermieri, medici, caposala che ti portano il brodino dopo l’operazione. Insomma hanno visto la parte migliore dello Stato, i gradini bassi, la manovalanza che ti ferma l’emorragia e ti prepara la flebo, i vituperatissimi “lavoratori statali”. Mentre i vertici, dello Stato, si sono comportati come davanti a un normale caso di cronaca nera, insomma hanno fatto di tutto perché il primo vero attacco terroristico in Italia scivolasse via come una specie di incidente stradale. Belle parole, fermi proclami, poi via, a fare gli aperitivi elettorali, con la paura di perdere qualche voto o la preoccupazione di sciacallare il meglio possibile per guadagnarne.
 Bene, Follia maggiore, è partito molto bene, ora bisogna corrergli dietro… Metto qui sotto un po’ di date già fissate per febbraio e marzo: presentazioni, incontri, chiacchierate… incontrare i lettori è sempre un piacere. E’ possibile che si aggiunga qualche appuntamento (sarete avvertiti per tempo qui, sulla pagina FB, su Twitter), ma insomma, il catalogo è questo.
Bene, Follia maggiore, è partito molto bene, ora bisogna corrergli dietro… Metto qui sotto un po’ di date già fissate per febbraio e marzo: presentazioni, incontri, chiacchierate… incontrare i lettori è sempre un piacere. E’ possibile che si aggiunga qualche appuntamento (sarete avvertiti per tempo qui, sulla pagina FB, su Twitter), ma insomma, il catalogo è questo.
Approfitto per ringraziare tutti quelli che mi invitano, le librerie, le biblioteche, i circoli di lettura. Più avanti vedremo di fare quello che si può, perché andare ovunque non posso, ma si può sempre tentare.
Per ora grazie a chi è venuto alle prime presentazioni, a chi verrà alle altre e, in generale, a tutti: non soffro di feticismo da classifica, ma fa piacere che il libro si muova bene e – per i commenti ricevuti fin’ora – che piaccia a chi lo legge.
Anche il Monterossi è molto contento e vi saluta
FEBBRAIO
Venerdì 2 – Nerviano, ore 21, Biblioteca Alda Merini (piazza Manzoni)
Sabato 3 – Vimercate, ore 17, libreria Il Gabbiano (Piazza Giovanni Paolo II)
Mercoledì 7 – Torino, ore 18, Circolo dei lettori (via Bogino 9)
Sabato 10 – Milano, ore 11.30, Auditorium Radio Popolare (via Ollearo 5)
Sabato 10 – Milano, ore 18, Il Libraccio Bovisa (via Candiani 102)
Lunedì 12 – Bologna, ore 18, libreria Coop (via Orefici)
Martedì 13 – Novate Milanese, ore 21, Milano Zafferano, Biblioteca comunale (Largo Fumagalli 5)
Sabato 17 – Voghera, ore 18, Libreria Ubik (via Emilia 104)
Domenica 18 – Abbiategrasso, 0re 10.30 Castello Visconteo (piazza Castello)
Lunedì 19 – Milano, ore 18, firmacopie alla libreria Hoepli (via Hoepli)
Sabato 24 – Roma, ore 12, Libreria Nuova Europa – I Granai (via Rigamonti 100)
Sabato 24 – Roma, ore 18, Libreria Scuola e Cultura (via Ugo Ojetti 173)
MARZO
Sabato 3 – Courmayeur – Una Valanga di Libri
Lunedì 5 – Lecco, ore 18 – La libreria volante (via Bovara 30)
Sabato 10 – Biella, ore 18 – Libreria Giovannacci (via Italia 14)
Sabato 17 – Assisi, Tra_me, Giallo Fest
Sabato 24 – Suzzara, ore 18, Piazzalunga Cultura, Biblioteca Comunale (via Zonta)
Domenica 25 – Milano, Book Pride
 Mettiamola così: avete noleggiato una macchina, avete fatto il diavolo a quattro per averla, l’avete usata per tre anni abbondanti e ora che la riportate al noleggiatore ha le portiere rigate, una crepa nel parabrezza, le gomme tagliate, un parafango che pende, e la radio non va. Più o meno è quello che ha fatto Matteo Renzi col Pd, partito dalla fiammante fuoriserie del 40 per cento alle Europee, è arrivato a combattere come un fante sulla linea del Piave del 25 per cento, se il Signore gliela manda buona.
Mettiamola così: avete noleggiato una macchina, avete fatto il diavolo a quattro per averla, l’avete usata per tre anni abbondanti e ora che la riportate al noleggiatore ha le portiere rigate, una crepa nel parabrezza, le gomme tagliate, un parafango che pende, e la radio non va. Più o meno è quello che ha fatto Matteo Renzi col Pd, partito dalla fiammante fuoriserie del 40 per cento alle Europee, è arrivato a combattere come un fante sulla linea del Piave del 25 per cento, se il Signore gliela manda buona.
Su quei numeri, gli italiani si sono visti costruire un’epopea, una mitologia, ne hanno subito ad ogni passo la ripetizione ossessiva. Il refrain del 40 per cento (da accoppiare a “ottanta euro”) è ormai parte delle nostre vite come certe canzoni estive che abbiamo canticchiato tutti per un mese e poi puff, via, sparite. Anche il 25 per cento è un numero che torna, perché è quello che prese Bersani quando “non vinse” le ultime elezioni. Una percentuale che Renzi e renzisti irrisero in tutti i modi, facendone oggetto di scherno e di sarcasmo… “Noi non siamo quelli del 25 per cento!”, diceva ieri quello che oggi spera di arrivare al 25 per cento. Testacoda, vertigine.
La frasetta che Renzi sfodera a questo punto è “senza aver subito una scissione”, che significa che sì, vabbé, prende poco come fece Bersani, ma con lui sono stati cattivi e alcuni se ne sono pure andati e quindi anche se prende sei e come se fosse un otto più. Ci sta dicendo che il suo 25 è come un 40, in questi casi, come si dice, conviene non contraddirlo, tutti abbiamo avuto in classe, in seconda media, uno così.
Quel che più stupisce, però, è il totale ribaltamento delle prospettive politiche. Renzi partiva per fare un partito maggioritario, di governo monocolore, solido, quasi un presidenzialismo (con lui presidente, ovvio), con tutte quelle scemenze che sappiamo, tipo “si sa chi vince la notte delle elezioni” eccetera, eccetera. E ora, apertamente, teorizza una specie di craxismo equilibrista, calcolando che se resta vivo (il famoso 25 per cento) potrà gestire il complesso bilancino dei poteri per non perdere aderenza, per non arretrare ancora. Quelli che volevano l’Italicum, con premio di maggioranza assurdo per governare senza se e senza ma, ora fremono per entrare nel circo dei se e dei ma, delle trattative, dei bilanciamenti, dei do ut des. E’ più o meno quello che la retorica renzista chiamava “la palude”. Basta con la palude, dobbiamo uscire dalla palude, io vi porterò fuori dalla palude…, detto da quello che oggi affida la sua sopravvivenza alla palude di qualche larga intesa.
Va bene, il cinismo della politica non ci stupirà, anzi, come italiani abbiamo qualche master in materia. Però rimane sempre strabiliante come un partito possa fare una politica – rivendicandola e rivestendola ossessivamente di propaganda – e poi farne un’altra, diversa, opposta, negata fino a un minuto prima, sbeffeggiata per anni. E come questo possa farlo lo stesso leader, la stessa persona. E ancor più strabiliante è che possano votarlo gli stessi elettori, che siano antichi elettori del Pd o entusiasti nuovisti, quelli che già facevano tenerezza ai tempi del “Con Renzi si vince”, quelli che si illudevano di mirabolanti modernità e che ora si trovano a sperare – con lo stesso leader che predicava il contrario – nella vecchia, deplorevole, trita logica dell’ago della bilancia.
Per disegnare la parabola del renzismo, insomma, non serve aspettare il 5 marzo. Con il fiero propugnatore dell’abolizione del Senato che si presenta da senatore, si svela anche ai ciechi che il fine ultimo del renzismo è il mantenimento in vita del renzismo, una sedia al tavolo da poker delle alleanze e delle mediazioni, e dopo si vedrà. Un po’ poco per gli arditi giovanotti che volevano cambiare tutto, oggi aggrappati come naufraghi alla speranza che non cambi nulla.
 E’ passata una settimana da quando il ministro dell’interno Minniti, ha annunciato la rivoluzionaria invenzione di un red button per denunciare le fake news sul sito della polizia. Per prima cosa occupiamoci della traduzione: red button uguale bottone rosso; fake news uguale notizie false, ok, possiamo incominciare.
E’ passata una settimana da quando il ministro dell’interno Minniti, ha annunciato la rivoluzionaria invenzione di un red button per denunciare le fake news sul sito della polizia. Per prima cosa occupiamoci della traduzione: red button uguale bottone rosso; fake news uguale notizie false, ok, possiamo incominciare.
L’iniziativa, di cui si sono occupati tutti i giornali, le radio, le tivù, il web, i commentatori, gli esperti (e quasi tutti per dire che è una cazzata), è stata presentata come risposta al pericoloso allarme sociale delle bufale online, “con specifico riguardo al corrente periodo di competizione elettorale” (il virgolettato è nel comunicato ufficiale). Insomma, se durante tutto l’anno leggiamo ovunque che gli immigrati hanno la jacuzzi nell’hotel a cinque stelle, va bene, ma se durante il “periodo di competizione elettorale” leggiamo che la Boldrini va al cinema con un killer uzbeko tatuato, allora allarme rosso, anzi red button.
Non starò qui a ripassare il rosario delle reazioni, più o meno colte e articolate, sul fatto che la polizia si metta a controllare se una notizia è vera o no (il comunicato parla di “contronarrazione istituzionale”): Orwell l’abbiamo letto tutti. Vorrei invece inviare un messaggio di sincera solidarietà alla “task force di esperti” che “in tempo reale, 24 ore su 24, effettuerà approfondite analisi” per scoprire se una notizia è falsa. Cioè qualche sovrintendente di polizia, magari alle quattro del mattino, salterà sulla sedia in seguito a denuncia (leggi schiacciamento di red button): “Porca miseria! Non è vero che la Boldrini è andata al cinema con il killer uzbeko!”. Presto, attiviamoci presso il provider! Come dicevo, massima solidarietà.
Ma siccome di teoria dei mass media, di contrasto alla fake news, di Minniti entusiasta come Louis De Funés si è già detto, conviene occuparsi dell’attuazione del piano red button. Come va? Quante denunce? Di che tipo? “Il jobs act funziona” è una fake news che si può denunciare col bottone rosso? Se quella della democrazia turbata e deviata dalle bufale è una vera emergenza nazionale sentita dalla popolazione, cosa dicono gli utenti, i cittadini indignati che segnalano bufale?
Nessuna traccia. Niente. Zero. Nella sezione Faq (le domande più frequenti degli utenti) non c’è la ressa per chiedere come comportarsi davanti a una bufala. C’è chi chiede se deve fidarsi della banca online, chi invoca chiarimenti su consegne e ritiri di pacchi e chi chiede consigli: “Ho trovato su un portale e-commerce, un computer ad un prezzo vantaggiosissimo, è un affare o una truffa?”. Ah, saperlo! Un catalogo molto divertente e molto naïf di italiani alle prese con la rete (alcune domande sono vecchie di anni), preoccupati dal pop-up che si aprono, dal rischio che qualcuno gli freghi le password o dalle bolle di consegna, ma nessuno che chiede come comportarsi davanti a una bufala in rete. Informazioni su provvedimenti presi, richieste di smentite, accertamenti in corso, indagini aperte: niente. Nella sezione “notizie”, niente pure lì: le uniche notizie del gennaio 2018 sul bottone rosso riguardano il fatto che esiste il bottone rosso, comunicato ufficiale, inaugurazione di Minniti e basta. Eppure sarebbe interessante – nell’unica democrazia al mondo che fa controllare la verità alla polizia – sapere quante bugie si siano finora smascherate, quanto inquinamento dell’opinione pubblica si è evitato e quanti untori di falsità sono stai colti sul fatto nella prima settimana di attività di contrasto a un problema così pressante ed emergenziale per il cittadino. Siccome la premessa è che in periodo elettorale aumentano le bufale, non vorremmo scoprire che il red button è una di quelle, nel qual caso potremo sempre cliccare sul red button e ricominciare tutto daccapo, tipo gioco dell’oca.
 Sconsiglierei tutti – segnatamente i politici in campagna elettorale – a giustificare le proprie cospicue puttanate usando l’argomento del “lapsus”, così come ha fatto Attilio Fontana, aspirante governatore dei lombardi di razza bianca. Dopo la forbita frase sulla difesa della suddetta razza bianca, il Fontana è corso argutamente ai ripari dicendo: “E’ stato un lapsus, un errore espressivo”. Capita, eh. Il lapsus è uno scivolamento, un piccolo errore di comunicazione dal cervello alla bocca, o alla mano, se state scrivendo, insomma, un piccolo refuso delle sinapsi. E questo fino al 1901, cioè quando il signor Sigmund Freud (ebreo, Fontana non se lo lasci scappare come lapsus con quelli di Casa Pound) ci ha spiegato che il lapsus è una specie di bollicina tipo champagne che emerge dall’inconscio, un rimosso che viene a galla. Insomma, dopo il 1901, l’opinione prevalente e universalmente accettata è che dire “è stato un lapsus” equivale a dire “lo penso veramente, nel profondo”.
Sconsiglierei tutti – segnatamente i politici in campagna elettorale – a giustificare le proprie cospicue puttanate usando l’argomento del “lapsus”, così come ha fatto Attilio Fontana, aspirante governatore dei lombardi di razza bianca. Dopo la forbita frase sulla difesa della suddetta razza bianca, il Fontana è corso argutamente ai ripari dicendo: “E’ stato un lapsus, un errore espressivo”. Capita, eh. Il lapsus è uno scivolamento, un piccolo errore di comunicazione dal cervello alla bocca, o alla mano, se state scrivendo, insomma, un piccolo refuso delle sinapsi. E questo fino al 1901, cioè quando il signor Sigmund Freud (ebreo, Fontana non se lo lasci scappare come lapsus con quelli di Casa Pound) ci ha spiegato che il lapsus è una specie di bollicina tipo champagne che emerge dall’inconscio, un rimosso che viene a galla. Insomma, dopo il 1901, l’opinione prevalente e universalmente accettata è che dire “è stato un lapsus” equivale a dire “lo penso veramente, nel profondo”.
Cosa che peraltro Fontana dice nella riga dopo: “E’ stato un lapsus, ma sia ben chiaro che il concetto espresso lo difendo e lo difenderò sempre”. Se ne deduce che questo signor Fontana è un uomo pienamente risolto: il suo inconscio è balzato fuori come un tigrotto della Malesia e lui ora lo accetta con sconfinata consapevolezza, tipo: ho detto una cazzata, ma volevo proprio dirla. Sarà l’aria di Varese.
Ognuno può fare prove e esperimenti nel privato, a suo rischio e pericolo. Se dal macellaio vi scappa detto “Lei è proprio un ladro, signor Gino”, sarà poi difficile argomentare che non lo pensavate veramente, ma che sì, insomma, il concetto è quello. Se dite a Tizio: “Ti ho sempre amato, Caio”, capirete subito che giustificarsi con “è stato un lapsus” è una notevole aggravante della vostra già infelice posizione. E’ ovvio che dopo il logoramento di tanti refrain politici per cavarsi dai guai – i “sono stato frainteso”, “a mia insaputa”, “è una frase fuori contesto”, eccetera eccetera – servisse qualcosa di nuovo, una scappatoia che suonasse un po’ inedita. Ecco, avvisiamo i vari Fontana che “lapsus” non è la soluzione adatta, e nemmeno tanto innovativa, dato che ne scriveva già il Metastasio nel 1744: “Voce del sen fuggita / Poi richiamar non vale”.
Naturalmente c’è qualcosa di peggio, e cioè – attribuendo per un attimo al candidato governatore Fontana un certo acume politico – un calcolo cinico, uno di quei machiavellismi italiani che fanno della politica, qui e ora, un posto abbastanza mefitico. Rivelando il suo desiderio di difendere “la razza bianca” ha parlato ai suoi (che sono d’accordo), e per gli altri, per i moderati che lo voteranno turandosi tutto il turabile oltre al naso, ha messo su la scenetta dell’errore espressivo, che è la tipica cosa incredibile a cui un elettore un po’ disonesto con sé stesso può anche credere. Anche in questo caso, altro che lapsus!, si tratterebbe di un doppio binario morale, come se un imbianchino austriaco dicesse ai suoi fanatici in birreria: “Invaderò la Polonia”; e a tutti il giorno dopo: “Ma no, scherzavo”.
Il tutto – lapsus, gaffes e controgaffes, supercazzole, stupidaggini e rivendicazioni di razzismo – condito da un continuo sottofondo di allarme, induzione alla paranoia di massa, paura indotta. Lo stesso Fontana che dice serafico e sprezzante del ridicolo: “Non possiamo accogliere un miliardo di persone”, lasciando intendere che un settimo della popolazione del pianeta voglia trasferirsi a Cernusco Lombardone (per farsi governare da lui, nel caso). O San Silvio Restaurato che parla di “mezzo milione di migranti in Italia per delinquere”. Un piccolo messaggio ai “moderati”. Poi, dall’alto della sua esperienza di condannato per frode fiscale e agitando i misteriosi fogli protocollo, riprende a parlare di fisco.
Qui sotto l’intervista di Loretta Cavaricci per Achab, il settimanale di libri del Tg2 (lo so, lo so, non bisogna andare in tv eccetera eccetera)
 Valorizzare il nostro patrimonio culturale richiede idee innovative, coraggio, spirito di sacrificio, soprattutto sacrificio per i visitatori che restano fuori da un museo perché dentro c’è un evento per ricchi. Dopo le cene private per vip alla Tod’s Arena of Rome (già Colosseo, magari avete presente), le tavolate per vip della Ferrari su Ponte Vecchio a Firenze, le nozze vip alla Reggia di Caserta, bisogna diversificare l’offerta. E’ vero che c’è stata una popolare lezione di pilates al Museo Egizio di Torino, con gente che sudava e si agitava davanti alla Dea Sekhmet che non vedeva tanti pirla tutti insieme dal 3600 avanti Cristo, ma si può fare meglio.
Valorizzare il nostro patrimonio culturale richiede idee innovative, coraggio, spirito di sacrificio, soprattutto sacrificio per i visitatori che restano fuori da un museo perché dentro c’è un evento per ricchi. Dopo le cene private per vip alla Tod’s Arena of Rome (già Colosseo, magari avete presente), le tavolate per vip della Ferrari su Ponte Vecchio a Firenze, le nozze vip alla Reggia di Caserta, bisogna diversificare l’offerta. E’ vero che c’è stata una popolare lezione di pilates al Museo Egizio di Torino, con gente che sudava e si agitava davanti alla Dea Sekhmet che non vedeva tanti pirla tutti insieme dal 3600 avanti Cristo, ma si può fare meglio.
Così abbiamo deciso (io, Frank Tre Dita e uno che non vuole dire il nome) di aprire un’agenzia per offrire eventi ai grandi musei italiani.
Il piano è questo: organizzare una cazzata davvero enorme, suscitare un po’ di polemica sui giornali (le solite cose, i moderni, smart, innovativi e pop favorevoli, e due sfigati intellettuali pallosi contrari) e poi aspettare buoni buoni vicino al telefono che chiamino direttori di musei, gallerie, dimore storiche, monumenti per chiedere cazzate ancora più enormi.
Cominciare con un bel concorso “Miss maglietta bagnata” alla galleria Borghese di Roma, per esempio sarebbe già un buon inizio: si valorizzerebbero così alcuni lavoretti del Bernini. Una bella sagra per famiglie, in un clima spensierato, non come adesso che c’è gente che guarda le statue (tutte bianche, tra l’altro! Ma non potremmo farle colorare ai bambini?).
Naturalmente bisognerà legare gli eventi alla cultura del territorio, ovvio, che è una cosa che si dice sempre, piace a tutti e attira sponsor. Quindi, pagando una certa cifra, si potrà fare la festa del prosecco bersagliando con i tappi un Canaletto, perché no? Ci spiegheranno (dopo) che i soldi così incassati serviranno al museo (magari a restaurare il dipinto).
E’ evidente a chiunque che noleggiare un monumento nazionale per sposarsi o un museo per una cena non è a buon mercato. Punteremmo dunque sulle grandi aziende lanciando il connubio arte-convention aziendali: decine di manager in trance motivazionale nelle sale degli Uffizi, o alla pinacoteca di Brera. Quanto al Colosseo, si è vagheggiato di megaconcerti o opere liriche, sottovalutando le grandi potenzialità economiche che offrirebbe una gara di motocross (nello splendido scenario, ecc. ecc).
Puntare sugli sceicchi è complicato: bisogna coprire le parti intime di molte statue (già fatto davvero, a Firenze, nel 2016, per la visita del presidente iraniano a Matteo Renzi ) ed è costoso. Con gli oligarchi russi invece si va sul sicuro, pagano bene e non stanno a guardare tanto per il sottile, al massimo si possono lamentare se affittano Pompei per qualche giorno e poi si lamentano che è tutta rotta.
Insomma, tutti i segnali ci dicono che quello di affittare i nostri tesori (nostri nel senso di “di tutti noi”) a chiunque sventoli un po’ di soldi è un grande business in espansione e i miei soci già scalpitano e insistono per installare qualche slot machine davanti al Cristo del Mantegna (“sennò è un mortorio”).
Una fitta ragnatela di contrattazioni si svilupperebbe aiutando il mercato, fissando prezzi e gestendo prenotazioni. Il compleanno di un banchiere nella valle dei templi ad Agrigento, per dire, potrebbe valere come una merenda per vip al Pantheon, poi l’importante è inventarsi qualche scemenza per dire che così si valorizza la cultura, si guadagnano soldi per la cultura e si fa conoscere la cultura. Giusto. E una volta aiutata la cultura affittando musei, monumenti e pinacoteche a privati, aziende, milionari, finalmente, visitando la Reggia di Caserta, qualcuno potrà dire ammirato dalla magnificente bellezza: “Ah, è qui che si è sposato Pino? Minchia!”
 Come mi pare d’aver già detto (ahahah), giovedì 11, tra due giorni, esce Follia maggiore (Sellerio), il nuovo romanzo con Carlo Monterossi, Oscar Falcone, i sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella, insomma tutta la banda. Ci saranno incontri e presentazioni, ovvio, e saranno comunicati per tempo, qui e sugli altri social.
Come mi pare d’aver già detto (ahahah), giovedì 11, tra due giorni, esce Follia maggiore (Sellerio), il nuovo romanzo con Carlo Monterossi, Oscar Falcone, i sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella, insomma tutta la banda. Ci saranno incontri e presentazioni, ovvio, e saranno comunicati per tempo, qui e sugli altri social.
Intanto, ecco due o tre appuntamenti nei giorni dell’uscita, non vere presentazioni, ma, come dicono quelli che se ne intendono, “firmacopie”, due chiacchiere, qualche saluto ai lettori in librerie indipendenti che mi sono care. Ecco il mini-calendario dei primi giorni.
Giovedì 11, alle 17, al Mio libro (via Sannio 18, a Milano)
Giovedì 11, alle 18.30, alla Libreria Centofiori (piazzale Dateo 5, a Milano)
Venerdì 12, alle 18.30, alla libreria Tarantola (piazza martiri di via Fani 1, Sesto San Giovanni)
Vi aspetto. Per le altre presentazioni e chiacchierate qui e là sul nuovo romanzo, comunicherò per tempo.
 Campo minato e suggestione irresistibile. Sublime tentazione del nonnesco “Ah, vi lamentate, ma una volta si stava peggio!”, e rischio di retorica in agguato. C’è tutto questo – e altro ancora – nell’arte di maneggiare i paragoni storici. Così quando il presidente Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha ricordato che a marzo voteranno per la prima volta i ragazzi del ’99 (inteso come 1900) e ha tracciato un sottile paragone con i ragazzi del ’99 (inteso come 1800) che vennero mandati nelle trincee della Grande Guerra, la sensazione è stata quella di camminare su un terreno insaponato.
Campo minato e suggestione irresistibile. Sublime tentazione del nonnesco “Ah, vi lamentate, ma una volta si stava peggio!”, e rischio di retorica in agguato. C’è tutto questo – e altro ancora – nell’arte di maneggiare i paragoni storici. Così quando il presidente Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha ricordato che a marzo voteranno per la prima volta i ragazzi del ’99 (inteso come 1900) e ha tracciato un sottile paragone con i ragazzi del ’99 (inteso come 1800) che vennero mandati nelle trincee della Grande Guerra, la sensazione è stata quella di camminare su un terreno insaponato.
Sottotesto: le cose non vanno benissimo, ma ricordatevi che oggi avete diritto di voto, pace, Youtube e telefonini, mentre cento anni fa, alla vostra età, si andava a morire per la patria (ultima vittoria registrata dai libri di storia, peraltro). Paragone storico giustificato solo dall’assonanza dalla data, ovviamente, perché tutto il resto c’entra – senza polemica e anzi con un po’ di leggero divertimento – come i cavoli a merenda. Un po’ come dire, ehi, ragazzi del ’99, pensate che culo che avete oggi che potete alzarvi alla mattina e andare a votare, mentre i ragazzi del 3099 avanti Cristo passavano le loro giornate a scheggiare le pietre per fabbricare frecce e andavano a cacciare i mammut senza nemmeno il jobs act o l’alternanza scuola-lavoro.
Beh, in effetti, a vederla così, è un bel salto in avanti.
Anche i ragazzi del 1609 ebbero i loro rovesci del destino: nemmeno il tempo di compiere diciotto anni ed ecco la peste, quando si dice la sfiga. Per non parlare dei ragazzi del 1879, che a diciott’anni si misero in mente la balzana idea di chiedere diritti, lavoro e socialismo e vennero falciati, a Milano, dalle mitragliatrici di Bava Beccaris…
Ok, ok, si sta meglio adesso: il vecchio trucco di consolarsi con le sfighe del passato funziona sempre. Nel 1979, per esempio, questo articolo l’avrei scritto con la macchina da scrivere, nel 1909 a mano con il calamaio, nel ’99 avanti Cristo su fogli di papiro e prima ancora sulle tavolette di cera, che poi spedirle al giornale, sai che casino.
Dei ragazzi del ’99, quelli ricordati con orgoglio nazionale da Mattarella, tra l’altro, si ricorda il successo a Vittorio Veneto (un micidiale contropiede alla Ronaldo, dopo Caporetto), insomma, li si ricorda perché contribuirono a una vittoria, mentre si potrebbe anche ricordare che furono mandati in trincea a calci nel culo, obbligati, coscritti pena la galera per diserzione, persino molti ragazzi del ’99 per cui l’Italia, il re, Trieste, erano faccende lunari e lontanissime. Di quei ragazzi si ricorda il risultato finale (vittoria!) ma quasi mai le angherie subite, le rivolte contro i propri stessi ufficiali (leggere Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, strepitosa cronaca di quei massacri), persino la satira (“Il general Cadorna / ha detto alla regina / se vuoi veder Trieste / guardala in cartolina”).
Dicono i sondaggi che i ragazzi del ’99, intesi come Novecento, andranno a votare se va bene nel trenta per cento dei casi, uno su tre, e questo perché non si può obbligarli come si fece, mandandoli in trincea, con quelli di cent’anni fa. Il paragone, insomma, non regge. Ai ragazzi del ’99, anche se vinsero, non andò poi benissimo: se sopravvissuti alla grande mattanza del 15-18 ebbero poi 39 anni alla data delle leggi razziali, e dai 40 ai 45 nella seconda guerra mondiale. Come viatico per il futuro, diciamo, il Carso non fu granché, speriamo che le elezioni del 4 marzo, come portafortuna, funzionino un po’ meglio.
Usare la storia passata per consolarsi dell’oggi rimane però una tentazione troppo forte. Parlo di nonni, genitori a corto di argomenti, professori convinti che oggi si stia meglio di ieri e che domani si starà meglio di oggi (cosa decisamente smentita dall’andamento dell’economia, che certifica i figli oggi meno sicuri e fiduciosi dei loro padri ieri). Insomma giocare col passato per dire del presente è affascinante, ma non funziona sempre, anzi. I ragazzi del ’99 (inteso come Novecento), pur disoccupati, sottopagati, precari, incerti sul futuro, spronati a lavorare gratis perché “fa curriculum” stanno meglio dei ragazzi del ’99 (inteso come 1100) che partirono per la quinta crociata e finirono spesso sbudellati dagli infedeli. Innegabile. Che un giovane operatore di call center oggi stia meglio di Pietro Micca (specie dopo l’esplosione) è difficilmente contestabile, così come uno che partecipa al concorso per aspiranti bidelli o infermieri (tipo: ottomila concorrenti per tre posti disponibili) sia meno disperato di un adolescente precolombiano all’arrivo di Pizarro è abbastanza evidente. Però è un po’ troppo facile.
Risultato: non è vero che si stava meglio quando si stava peggio, no, no, si stava proprio peggio, e adesso si sta benone e andate a votare che fa bene alla salute.
Quanto ai ragazzi del ’49 (inteso come 900), che compirono diciott’anni nel 1968 e assistettero e parteciparono a un tentativo di cambiare gli equilibri del mondo, sognavano la “fantasia al potere” e altre amenità che oggi sembrano lontane come una carestia nell’anno Mille o una guerra nel Medio Evo. La fantasia chissà dov’è (maddai! Un’app ci sarà di sicuro, no?), ma il potere è ancora lì, sempre lui, anche quando è sereno, tranquillo, rassicurante, un po’ noioso, a dirci di non lamentarci troppo, perché cent’anni fa si stava peggio, signora mia!
Giovedì prossimo (11 gennaio) esce Follia maggiore. Qui l’intervista di Annarita Briganti su Repubblica Milano.
 Giusto perché non è ancora finito il tempo dei bilanci sul 2017, annus horribilis, ecco un dato che può generare lo sfavillante ottimismo di cui ci dicono ci sia gran bisogno. Su con la vita! I 500 uomini più ricchi del pianeta nel 2017 si sono messi in tasca giusti giusti mille miliardi di dollari, con un incremento del 23 per cento rispetto all’anno prima e insomma, non facciamola lunga: si certifica, nell’anno dei Signori 2017, che per diventare ricchi la cosa migliore è essere già molto ricchi.
Giusto perché non è ancora finito il tempo dei bilanci sul 2017, annus horribilis, ecco un dato che può generare lo sfavillante ottimismo di cui ci dicono ci sia gran bisogno. Su con la vita! I 500 uomini più ricchi del pianeta nel 2017 si sono messi in tasca giusti giusti mille miliardi di dollari, con un incremento del 23 per cento rispetto all’anno prima e insomma, non facciamola lunga: si certifica, nell’anno dei Signori 2017, che per diventare ricchi la cosa migliore è essere già molto ricchi.
La forbice della diseguaglianza non solo non si chiude, ma si apre a dismisura, in un’annata d’oro per i miliardari. Il primo della lista, Jeff Bezos, il capo di Amazon, ha incrementato la sua fortuna del 34 e passa per cento, ora è vicino ai 100 miliardi di dollari (99,6, per la precisione, cioè per arrivare a 100 gli mancano solo 400 milioni di dollari, suggerisco di aprire una sottoscrizione). Lo inseguono Bill Gates e Warren Buffet, staccati di una manciata di miliardi (91 e 85). Il primo europeo è in sesta posizione, ed è quel Bernard Arnault, francese, che vende lusso a tutti, cioè di sicuro ai suoi 500 colleghi della classifica degli uomini più ricchi del mondo. Più ricchi che nel 2016, anno in cui erano diventati più ricchi che nel 2015, anno in cui… Potete tornare indietro un bel po': nei dieci anni della crisi è gente che non si è mai fatta mancare il segno più.
Ma sì, ma sì, sono classifiche che lasciano il tempo che trovano. L’indignazione generica del momento e poi basta.
Eppure – lo dico, male, un po’ rozzamente, perdonate – queste classifiche potrebbero mettere qualche idea in testa. Per esempio che lì dentro potrebbero annidarsi i famosi soldi che non ci sono mai. Ritornello costante di ogni governo più o meno o para-liberale (non solo italiano) quando si parla di servizi e diritti è “sì, sarebbe giusto, ma non ci sono i soldi”. Ora con tutti i soldi che ti fanno ciao ciao con la manina dalle classifiche (mille miliardi di dollari in più in un anno), direi che i soldi ci sono, invece, e pure tanti, e si sa anche chi li ha in tasca.
E’ noto il ritornello liberista, che sono in realtà due. Il liberista classico dirà che ci pensa il mercato e che se uno ha cento miliardi di dollari in tasca e un suo dipendente fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, pazienza, che ci vuoi fare, è il mercato. Poi c’è il liberista moderno, smart e di sinistra, quello che dice uh, che bello i ricchi diventano più ricchi, e così anche chi lavora per loro sarà più felice. E’ un classico da Tony Blair in poi: la convinzione che se aiuti i padroni automaticamente aiuti anche i lavoratori. Una teoria interessante, che però cade un po’ a pera appena si guardano i numeri, perché i famosi padroni guadagnano mille miliardi in un anno, e i famosi lavoratori – pardon – una cippa di cazzo. Peggio: si sentono ripetere ogni giorno che i tempi sono cambiati e che devono cedere terreno e diritti. E quando la grande politica, i grandi leader mondiali (e anche i piccoli di casa nostra), parlano di diseguaglianze e di come combatterle, tendono a parlarne con Jeff Bezos e Bill Gates più che con quelli che spostano pacchi e scrivono software.
Gli anni della crisi, che hanno messo in ginocchio il ceto medio e proletarizzato tutti gli altri, in molti paesi e più che altrove in Italia, sono stati anni benedetti soltanto per i ricchi, coronati dal boom del 2017.
Naturalmente né la storia né la geopolitica, né l’economia si fanno con l’aritmetica, ma non è difficile fare due più due e capire che i soldi che mancano qui (al lavoro) sono finiti là (al profitto e al capitale), in misura eccessiva rispetto a qualsiasi decenza. Farsi rendere un po’ di quei soldi – e non soltanto in metafora – dovrebbe essere al primo punto di ogni programma che osasse chiamarsi “di sinistra”.
 Compulsati gli astri, letti attentamente i fondi del caffé, i tarocchi, le offerte speciali e le tabelle Istat, possiamo azzardare qualche previsione sul 2018, un anno pimpante e con molti cambiamenti, la luna in Saturno e l’influenza di Giove in aumento. In aumento da gennaio anche luce, gas, tariffe autostradali, trasporti, ticket sanitari e tutto quello che può umanamente aumentare. Insomma, il 2018 non è ancora arrivato e già gli dobbiamo dei soldi, spiace per il dettaglio prosaico.
Compulsati gli astri, letti attentamente i fondi del caffé, i tarocchi, le offerte speciali e le tabelle Istat, possiamo azzardare qualche previsione sul 2018, un anno pimpante e con molti cambiamenti, la luna in Saturno e l’influenza di Giove in aumento. In aumento da gennaio anche luce, gas, tariffe autostradali, trasporti, ticket sanitari e tutto quello che può umanamente aumentare. Insomma, il 2018 non è ancora arrivato e già gli dobbiamo dei soldi, spiace per il dettaglio prosaico.
Passiamo alle cose serie. Nel 2018 si vota un po’ dappertutto: in Russia dove si sa chi vince (Putin) e in Italia dove si sa chi perde (uno di Rignano che già sta tentando di dare la colpa a Putin). Gli italiani arriveranno al 4 marzo con i nervi a brandelli, stremati per tutte le cazzate sentite in campagna elettorale, e si sveglieranno il 5 marzo di nuovo in campagna elettorale perché nemmeno si riuscirà a capire chi ha vinto (ma tranquilli: chi ha perso sì).
Poi si voterà anche in molte regioni, tra cui Lombardia e Lazio, per cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che un italiano medio vive in campagna elettorale per oltre 358 giorni all’anno, e che sarebbe più sano mangiare il polonio col cucchiaio da minestra.
In febbraio la Nasa dirà la sua su dove candidare Maria Elena Boschi: allo studio l’ipotesi Plutone, almeno nel proporzionale.
In marzo, l’Ocse definirà “assai remota” la probabilità che Berlusconi possa mantenere le promesse elettorali fatte nell’ultimo comizio in tv: due Porsche a famiglia (una cabriolet) e un giacimento di diamanti in Centrafrica per ogni figlio maggiorenne non sarebbero sostenibili per l’economia del paese.
In aprile la legge elettorale italiana, detta Rosatellum, sarà esposta al Moma di New York, principale attrazione della grande mostra sul surrealismo contemporaneo.
In giugno Donald Trump proclamerà la nuova capitale di Israele, Gaza.
In luglio la presidenza dell’Unione Europea toccherà all’Austria, che subito donerà passaporti austriaci a tutti i clienti dei locali di lap dance di Strasburgo e Bruxelles, purché di comprovata discendenza ariana.
Due cose terribili che succederanno nel 2018, non crediate di scamparla. La prima saranno i mondiali senza l’Italia, non tanto per gli appassionati di Mondiali, che Ghana-Uruguay se la vedevano lo stesso, ma per tutto il chiacchiericcio su “se c’eravamo noi”, “calcio metafora del Paese”, eccetera eccetera. Insomma, saremo sommersi dalla retorica da bar applicata al pallone l’unica fottuta volta nella storia del mondo che noi – intesi come Italia – non giochiamo a pallone.
Restando alle specialità nazionali e alla sociologia da sala biliardo, gli italiani nel 2018 saranno particolarmente afflitti da riflessioni, analisi, commemorazioni e ricordi in occasione cinquantenario del ’68. Due le principali fazioni: le destre passeranno mesi a buttare merda sul maggio francese attribuendogli tutti i mali del mondo, compresi il Vajont e l’alopecia (Feltri in un editoriale proporrà di cancellare l’anno 68 da tutti i secoli fino al Tremila); le sinistre scongeleranno i loro talenti migliori che “hanno fatto il 68″, tutta gente che oggi starebbe alla destra di De Gaulle.
Mode culturali: si consolideranno tendenze già in corso, tipo il tri-laureato che va a fare il pastore di pecore retribuito in caciotte, salutato dai giornali come “la scelta coraggiosa di…”, e i libri sui figli, su quanto sono stronzi, sdraiati, fancazzisti, interconnessi e istupiditi dal cellulare i figli di famosi giornalisti che fanno i soldi scrivendo dei loro figli.
La crisi economica allenterà la sua presa dopo dieci anni esatti, anniversario che sarà celebrato nelle discoteche di Briatore e nelle code alla Caritas. Lunghe file anche alla Renzisti Anonimi. Ai talk show si parlerà molto della crisi dei talk show, forse Draghi smetterà di stampare soldi per tutti e i titoli “Oddio! C’è poca inflazione” verranno corretti in “Aiuto! C’è troppa inflazione!”.
E’ tutto, mi raccomando le rate del mutuo, buon 2018, poteva andare peggio, ma ora non mi viene in mente come.
Va bene, sì, sarebbe una specie di annuncio ufficiale. L’11 gennaio esce in libreria il romanzo nuovo, Follia maggiore. E’ il quinto romanzo per me e per il Monterossi, Torto marcio è andato molto bene (tutta la rassegna stampa la trovate qui), è piaciuto, questo mi fa piacere.
Ora Carlo Monterossi, ammaccato come sa essere lui, casca in un’altra avventura, di cui naturalmente non posso dire niente… solo che c’è un omicidio, che come tutti gli omicidi non è giusto, che c’è un discorso dei rimpianti, che il Monterossi guarda il blues da vicino, che le cose che abbiamo avuto non le riavremo più. Ci sono i poliziotti e i balordi, c’è un vecchio che conta il tempo che gli rimane e vuole coltivare in pace le sue ossessioni, c’è il ceto medio sull’orlo del baratro, c’è una ragazza che si gioca il tutto per tutto soltanto con la sua voce… Insomma, c’è tutto quello che serve perché Carlo Monterossi sia costretto a fare i conti con le vite degli altri, e quindi con la sua. Oscar Falcone indaga, Il sovrintendente Ghezzi e Carella pure, le piste si confondono, ma… Insomma, mi scuserete, ma è anche un giallo, quindi…
Il libro esce l’11 gennaio. Il titolo – Follia maggiore – viene da un’aria de Il Turco in Italia di Gioachino Rossini (forse leggendo capirete perché).
Come sempre, grazie a Sellerio, a tutti quelli che hanno letto, lavorato, pensato, che hanno dato consigli, che hanno seguito il nuovo libro: è sempre un’avventura… Ne parleremo, dopo. Per ora segnatevi la data.
Follia maggiore, Sellerio editore, 390 pagine, 15 euro
 L’elenco delle persone importanti con cui Maria Elena Boschi ha parlato di Banca Etruria verrà pubblicato a dispense: sono centoottantasei volumi di quattrocento pagine l’uno, elegantemente rilegati, ma consiglio di tenere un po’ di posto nella libreria per quando usciranno gli aggiornamenti, come una volta l’Enciclopedia Britannica. Tutti gli incontri sono stati smentiti dall’interessata, anche con roboanti annunci di querele. Nella grande opera non mancano spunti storici, di costume, le ricostruzioni testimoniali, alcune tavolette di cera, papiri, molti sms, che – come dice la stessa Maria Elena al Corriere – lei cancella raramente e quindi può usare per sputtanare o intimorire qualcuno di qui e di là, se dovesse servire.
L’elenco delle persone importanti con cui Maria Elena Boschi ha parlato di Banca Etruria verrà pubblicato a dispense: sono centoottantasei volumi di quattrocento pagine l’uno, elegantemente rilegati, ma consiglio di tenere un po’ di posto nella libreria per quando usciranno gli aggiornamenti, come una volta l’Enciclopedia Britannica. Tutti gli incontri sono stati smentiti dall’interessata, anche con roboanti annunci di querele. Nella grande opera non mancano spunti storici, di costume, le ricostruzioni testimoniali, alcune tavolette di cera, papiri, molti sms, che – come dice la stessa Maria Elena al Corriere – lei cancella raramente e quindi può usare per sputtanare o intimorire qualcuno di qui e di là, se dovesse servire.
Già in alcune necropoli etrusche sono state rinvenute iscrizioni e figure evocative che rivelano l’incessante zelo di Maria Elena Boschi. Su monete e vasellame si ritrova spesso l’effigie di questa donna bionda che tenta di vendere a tutti una banca fallita. Alcuni storici del primo secolo avanzano l’ipotesi che le ultime parole di Giulio Cesare non fossero dedicate al tradimento di Bruto, ma alla visita di una misteriosa dama, per cui prima di spirare pare abbia detto: “Oh, no, ancora quella che vuol vendermi banca Etruria!”.
Per questioni storiografiche è difficile tornare più indietro nel tempo, anche se in alcune pitture rupestri si vede chiaramente una donna che offre una banca decotta in cambio di sette pelli di mammuth, due punte di freccia e il segreto del fuoco.
Per venire a tempi più vicini, sembra che intorno al 1530 Cortés, deciso a sterminare gli Aztechi, avesse con sé una determinatissima conquistadora che lo consigliava: “Aspetta, Hernàn, prima del vaiolo proviamo a smollargli banca Etruria”. Non si sa come andò a finire, cioè se la scomparsa di alcune civiltà precolombiane vada addebitata anche a questa misteriosa spacciatrice di banche, in ogni caso lei ha tutti gli sms di Montezuma e se serve li mostrerà alla stampa.
Il Medioevo è sicuramente il periodo più difficile da ricostruire: i funzionari delle agenzie, authority, banche centrali, ministri del tesoro, consiglieri cambiavano spesso. Le testimonianze si fanno numerose, confuse, contraddittorie e sono molte le domande che restano senza risposta. Corrisponde a verità che il rogo di Giovanna d’Arco fosse alimentato, oltre che da fascine di legna, da prospetti per gli azionisti di banca Etruria? E’ vero che Bonifacio VIII era interessato all’offerta?
Di sicuro c’è che Maria Elena Boschi contattò Luigi XVI – anche grazie alla mediazione del gentiluomo uomo di corte Verdini – e che la trattativa stava per andare in porto: banca Etruria in cambio di un bilocale a Parigi, due cavalli alsaziani e un servizio di porcellane custodito a Versailles, ma quei gufi della rivoluzione francese fecero saltare l’accordo.
Pochi sanno che la famosa foto di Yalta, quella con Roosevelt, Churchill e Stalin, è un abile montaggio, e dall’inquadratura è stata cancellata Maria Elena Boschi che offriva banca Etruria al nuovo ordine mondiale. Roosevelt e Churchill non ci cascarono nemmeno per un secondo, ma Stalin ci fece un pensierino inaugurando così la tradizione dei comunisti che dicono speranzosi: “Abbiamo una banca?”. Poi non se ne fece nulla per colpa della guerra fredda. Quanto ai verbali e ai documenti custoditi nell’Area 51, in Nevada, sono secretati, ma qualcosa trapela, e sembra che una giovane donna abbia chiesto agli alieni di acquisire banca Etruria, ma senza fare pressioni.
Gli storici, com’è ovvio, studiano alacremente i molti volumi dell’opera, e cercano riscontri, anche se per una ricostruzione dei fatti sarebbero di grande importanza i numerosi sms “del mondo del credito e del giornalismo” che Maria Elena Boschi, come se fosse un avvertimento, dice di conservare.
I raccontini stanno molto bene, grazie. Sono dodici racconti gialli, belli, con un piccolo giallo dentro, nascosto tra i gialli. Qui c’è la recensione/pagella di D’Orrico sulla Lettura del Corriere della Sera. Non c’è il Monterossi, nel racconto (mese di giugno), ci sono i due killer che qualcuno ricorderà nella Canzone, il biondo e quello con la cravatta. Per il Monterossi, il Ghezzi e gli altri amici, se poi sono amici, bisogna aspettare gennaio. Come accade da duemila anni, per leggere, basta cliccare sull’immagine.
 Fare una legge elettorale (e imporla con il voto di fiducia) che premia le coalizioni senza avere una coalizione, ci pone di fronte a un magnifico esempio di situazionismo autolesionista estremo. Un po’ come ordinare un cappuccino ma senza tazza, e poi dire: che problema c’è?, si può sempre leccarlo dal bancone del bar.
Fare una legge elettorale (e imporla con il voto di fiducia) che premia le coalizioni senza avere una coalizione, ci pone di fronte a un magnifico esempio di situazionismo autolesionista estremo. Un po’ come ordinare un cappuccino ma senza tazza, e poi dire: che problema c’è?, si può sempre leccarlo dal bancone del bar.
A leggere i retroscena, anche quelli più amici, anche quelli dei giornalisti embedded che sanno sempre (e ci spiegano) cosa dice “Renzi ai suoi”, la preoccupazione nelle file del Pd si sta tramutando in panico e la rincorsa a creare liste parallele, di sostegno, civetta, o a imbarcare chiunque abbia soltanto, anche lontanamente, una parvenza di istinto per l’alleanza è frenetica. Ad oggi, sembrerebbe, il tabellone “arrivi” è piuttosto striminzito, molto diverso dal fitto tabellone “partenze”. Ma muniamoci di microscopio e vediamo il dettaglio.
Ad affiancare la corsa solitaria del Pd per formare una solida coalizione ci sarebbero (a sinistra) i Verdi e Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. E’ una mossa sorprendente che promette grande stupore tra gli elettori e assicura una reazione di speranzosa sorpresa: ah, esistono ancora i Verdi, maddai! Ripresisi dallo stupore, secondo i calcoli dei geni del Nazareno, milioni di italiani si precipiterebbero a votare per la coalizione Pd perché ci sono i Verdi. Qualche appeal in più potrebbero avere Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, altra gente per cui non c’è esattamente la fila fuori dai negozi. Quindi ci sarebbe una lista dal suggestivo nome di Più Europa a sostenere il cristallino europeismo di Matteo Renzi, uno che mette e toglie le bandiere dell’Europa dalle sue scenografie (metti la cera, togli la cera) a seconda delle contingenze del momento e di quello che gli sussurrano gli esperti di comunicazione. So cosa state pensando: con i Verdi e il loro 0,1 per cento a sostegno del partito che salutò con battimani e insulti (“ciaone”) la vittoria delle trivelle, e l’ottima Bonino a caccia di firme, non saranno troppo sbilanciati a sinistra (ahahah)? Bene, ecco in soccorso la pattuglia centrista: si valutano come sicuri nella grande coalizione che puntava al 40 per cento, poi più realisticamente al 30, poi più realisticamente al 25, poi… (coraggio, mancano mesi), figure di spicco istituzionali come Beatrice Lorenzin e Pieferdinando Casini. La prima, firma autorevole di tutti i massicci tagli alla sanità degli ultimi anni, il secondo eterno revenant della Repubblica, attualmente impegnato nella Commissione d’inchiesta sulle banche, già passato (vado a memoria non avendo sottomano un pallottoliere) da Dc, Ccd, Udc, Ncd, Polo delle Libertà, Casa delle Libertà, Scelta Civica, Unione di Centro. Gli mancano solo la Triestina Calcio e i sommozzatori moderati e le ha fatte tutte: un’ottima spiegazione di cosa significhi “rottamazione”. A completare il quadro delle truppe a sostegno del renzismo arriva per fortuna anche Fabrizio Cicchitto, cioè si punta tutto su una categoria di elettori finora poco rappresentata, quelli che soffrono di amnesia e hanno la memoria del pesce rosso: Cicchitto? Finalmente un nome nuovo!
Dunque riassumendo, il Pd renzista che fino a ieri si vantava di consensi al quaranta per cento (vero, preso alle Europee nel Mesozoico, e finto, quello di chi ha perso il referendum costituzionale) si troverebbe oggi quotato a un venticinque tendente al venti e aggrappato a volti nuovi come Casini e Cicchitto, il che equivale a usare come salvagente un’incudine in ghisa. Ai volenterosi coalizzanti, poi, bisognerà promettere posti, seggi più o meno sicuri (sempre meno, tra l’altro), togliendoli alle componenti interne che già mugugnano e si agitano per la fifa di restare fuori dal gioco, ad assistere dal divano, la notte degli scrutini, ad un altro grande successo di Matteo Renzi.
 Depositata da un notaio e alla Camera di Commercio, ecco la “Tabella retributivo-risarcitoria del cittadino in campagna elettorale”. In sostanza, un tariffario che dovrebbe rimborsarci in moneta sonante per tutte le cazzate che sentiremo da qui alla data del voto. Si tratta di una comprensibile autodifesa del cittadino e di una sacrosanta redistribuzione delle risorse economiche tra chi dice molte enormi stupidaggini per avere qualche voto in più e chi è costretto ad ascoltarle. Ecco il tariffario.
Depositata da un notaio e alla Camera di Commercio, ecco la “Tabella retributivo-risarcitoria del cittadino in campagna elettorale”. In sostanza, un tariffario che dovrebbe rimborsarci in moneta sonante per tutte le cazzate che sentiremo da qui alla data del voto. Si tratta di una comprensibile autodifesa del cittadino e di una sacrosanta redistribuzione delle risorse economiche tra chi dice molte enormi stupidaggini per avere qualche voto in più e chi è costretto ad ascoltarle. Ecco il tariffario.
Bufala semplice, 1 euro – Per la fruizione stupefatta delle scemenze più grosse (esempio: Boschi al funerale di Riina, Kyenge contro i mercatini di Natale, le spose bambine vendute in Veneto, i migranti con il virus ebola, aggiornare a piacere), il cittadino avrà diritto a un euro di rimborso per ogni scemenza letta o sentita.
Polemica sulla bufala, 2 euro – Lo spazio riservato alla denuncia di una scemenza grossa è solitamente il doppio o il triplo di quello occupato dalla bufala stessa. A volte se ne parla per giorni, con il deprimente risultato di diffondere ancora di più la notizia falsa. Il cittadino ha diritto a due euro di rimborso.
Algoritmo, 3 euro – La parola algoritmo, che vuol dire né più né meno calcolo, ma fa più figo, viene usata a vanvera per ogni questione umana e sovrumana, dai turni dei lavori più sfigati (mi spiace, ha deciso l’algoritmo) all’accertamento delle notizie (è vero, lo dice l’algoritmo). Il cittadino che presenti le dovute pezze d’appoggio avrà diritto a 3 euro per ogni volta che ha sentito pronunciare o letto la parola “Algoritmo”.
Riduzione delle tasse, calcolo percentuale – Il cittadino avrà diritto a una somma in contanti pari a un terzo della riduzione delle tasse promessa in campagna elettorale. Esempio: avete l’Irpef al 43 per cento e ve la promettono al 20, quindi potrete incassare una cifra pari a un terzo del 23 per cento in meno di tasse che vi promettono. Il meccanismo è complesso, ma dovrebbe indurre, se correttamente applicato, a scoraggiare o ridimensionare tutte le promesse farlocche sulla riduzione della pressione fiscale. Il rimborso verrebbe erogato di tasca propria da chi ha fatto la promessa.
Bonus, 8 euro (massimo 80) – Il cittadino riceverà otto euro, in contanti o accredito in conto corrente, per ogni volta che sentirà promettere un bonus. Un bonus per chi ha figli, per chi vuole farli, per i malati che non occupano posti in ospedale. Bonus per gli idraulici biondi, per le partite Iva che sanno sciare o per ventiseienni che vanno a lavorare in bicicletta. La promessa di bonus, detrazioni, mance e una tantum è così massiccia che costringe a mettere un tetto a questa importante voce del tariffario: non oltre dieci richieste di rimborso, per un massimo di 80 euro.
Ponte sullo stretto, 100 euro – Chiunque, in campagna elettorale, tiri fuori ancora una volta l’annosa questione del Ponte sullo Stretto di Messina dovrà versare al cittadino, entro ventiquattrore, cento euro in banconote non segnate di piccolo taglio. Si tratta di un risarcimento minimo rispetto all’immenso sfrangimento di zebedei che la promessa sul Ponte rappresenta da almeno venticinque anni, ma si spera abbia un effetto deterrente.
Rivoluzione liberale, 120 euro – Il cittadino ha diritto a un rimborso di 120 euro in contanti (no buoni pasto, no voucher) per ogni volta che sentirà pronunciare la frase “rivoluzione liberale”.
Un milione di posti di lavoro, 200 euro – Siccome secondo l’Istat siete occupati anche se lavorate un’ora alla settimana per quattro euro, la formula “un milione di posti di lavoro” (promessi, sbandierati o ipoteticamente raggiunti) è destituita di ogni fondamento e suona anche come una discreta presa per il culo. 200 euro in contanti o in carta prepagata ad ogni cittadino che la senta pronunciare più di due volte in un mese.
 Esce oggi in tutte le librerie del regno Un anno in giallo, la nuova raccolta Sellerio con dodici dei suoi autori (532 pagine, 16 euro). Un mese per uno. Vale la pena, ve lo dico subito. I nomi sono questi: Simonetta Agnello Hornby, Esmahan Aykol, Andrea Camilleri, Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Fabio Stassi.
Esce oggi in tutte le librerie del regno Un anno in giallo, la nuova raccolta Sellerio con dodici dei suoi autori (532 pagine, 16 euro). Un mese per uno. Vale la pena, ve lo dico subito. I nomi sono questi: Simonetta Agnello Hornby, Esmahan Aykol, Andrea Camilleri, Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Fabio Stassi.
Inutile dire che è un grande onore stare in cotanta compagnia: Manzini e Malvaldi sono amici e ci siamo presentati a vicenda all’ultimo BookCity, divertendoci un bel po’, altri sono autori sempre letti e amati come Alicia Giménez-Bartlett, per non dire poi di Mastro Camilleri, ovvio. E i racconti, in qualche caso sono vere short-tories, del quasi-romanzi, ecco.
Io ho scelto il mese di giugno, a Milano, e il racconto si intitola Doppio misto. Ora non starò qui a dirvi quelle cose che dicono gli scrittori, cioè che scrivere un racconto è difficile perché tutto – trama, dialoghi, caratteri – è più concentrato, però una cosa la voglio dire: è difficile perché tutto è più concentrato.
A parte questo, non ci troverete Carlo Monterossi, perché aveva da fare con il prossimo romanzo. Però è una bella storia di morti ammazzati o anche no, questo non posso dirvelo. Sappiate che a guidare le danze (danse macabre!) ci sono quei due killer che forse ricorderà chi ha letto Questa non è una canzone d’amore. Vorrei dirvi i nomi, ma non li so, e non li sa nemmeno la questura, ovvio. Comunque “il biondo e quello con la cravatta” è più che sufficiente, fidatevi.
Spero che vi divertiate voi a leggere come mi sono divertito io a scrivere, così siamo pari. Come al solito, fate sapere.
 Per mia leggerezza, colpa e distrazione (mi scuso) ho vissuto fino alla mia veneranda età senza essere a conoscenza dell’esistenza della Federanziani, mi scuso e corro a iscrivermi. Se ora so che esiste, è perché Silvio Berlusconi ha inviato un videomessaggio (“cari coetanei…”) a un qualche convegno della Federanziani per dire che lui farà molto per gli anziani. Ha detto anche che lui finanzia studi e ricerche perché si possa vivere fino a 125 anni, che è possibile, di non buttarsi giù e di non fare quella faccia, la vita comincia a novant’anni. Comprensibile la gioia alla Federanziani, perché se fosse vero, alla lunga, potrebbe avere più iscritti del partito comunista cinese.
Per mia leggerezza, colpa e distrazione (mi scuso) ho vissuto fino alla mia veneranda età senza essere a conoscenza dell’esistenza della Federanziani, mi scuso e corro a iscrivermi. Se ora so che esiste, è perché Silvio Berlusconi ha inviato un videomessaggio (“cari coetanei…”) a un qualche convegno della Federanziani per dire che lui farà molto per gli anziani. Ha detto anche che lui finanzia studi e ricerche perché si possa vivere fino a 125 anni, che è possibile, di non buttarsi giù e di non fare quella faccia, la vita comincia a novant’anni. Comprensibile la gioia alla Federanziani, perché se fosse vero, alla lunga, potrebbe avere più iscritti del partito comunista cinese.
Tra le promesse di Silvio che fanno esplodere l’anzianometro c’è quella della pensione minima a mille euro e l’annuncio che verrà istituito – lui regnante di nuovo – un ministero della terza età, anche se non ne spiega bene le mansioni. E’ lui, è lui, lo riconosciamo tutti. E’ il vecchio, caro Silvio, l’animatore di Villa Arzilla, quello che prometteva le dentiere gratis. Insomma, rieccolo, stupore e meraviglia. Come in quel libro di Stephen King dove uno attraversa un muro e si ritrova nel 1963, ecco, solo che qui lo fanno sessanta milioni di italiani, e senza nemmeno cercare il passaggio segreto si ritrovano all’inizio degli anni 2000, con i teatrini già visti e deplorati per decenni.
Ma insomma, del miracolo del Silvio risorto si è già detto in abbondanza: a furia di flebo come i patti del Nazareno, leggi elettorali fatte apposta per farlo uscire dal sarcofago e altre strizzatine d’occhio, ora è qui e dovremo ascoltarlo. E infatti già girano le sue rutilanti proposte, tra le quali brilla quella sulla flat-tax, cioè un’aliquota uguale per tutti, ricchi e poveri. Si favoleggia, a fine legislatura silviesca, quindi intorno al 2023, un’Irpef al 20 per cento, ripetendo la favoletta antica che se le tasse fossero basse tutti le pagherebbero. Ritornello antico che vuole dire soprattutto una cosa e lancia un messaggio preciso: sì, io le tasse al 20 per cento le pagherei, ma così…
Sfugge naturalmente a Silvio l’esistenza di un dettaglio come la Costituzione Italiana che dice (art. 53) che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Certo, si sa che la Carta non è il suo primo pensiero, ma uscire dal sepolcro e come prima cosa fare una proposta anticostituzionale contiene comunque una certa dose di paradosso. Ci sarebbe poi il dettaglio accessorio dell’allargamento della no tax area fino a 12.000 euro. In soldoni, insomma, il messaggio di Silvio è sempre quello: più soldi per tutti ma pagando meno tasse, poche e uguali per tutti, che è esattamente il contrario dell’eguaglianza. A molti è sfuggito un dettaglio raccapricciante, e cioè che nella sua ansia detax, nella trance agonistica del ritorno in pista, Berlusconi – oggi abbellito da inserti in mogano e con il toupé stile prato all’inglese – abbia proposto anche l’abolizione di tasse già abolite totalmente o parzialmente, come quella sulla casa o la tassa di successione. Insomma il programma di Silvio revenant è già ora, alle prime schermaglie della campagna elettorale, un monumento glorioso al conflitto di interessi: meno tasse per i ricchi in generale (e lui è ricco assai), niente tasse per i ricchi che lasciano grosse eredità (categoria in cui rientra in pieno). Insomma, mentre altri aspiranti omini forti cercano pietosamente di riaffermarsi dicendo “sono cambiato”, la forza di Silvio è di non essere cambiato per niente, e questo dà da pensare. Dopotutto, il ritorno in auge di roba simile spiega bene l’assoluto fallimento di chi doveva consegnarlo per sempre al passato e ha finito per dirgli “alzati e cammina”.
 Dunque, qui le date di Torto marcio a Bookcity, la grande rassegna milanese dedicata ai libri. Ancora presentazioni di Torto marcio (con grande gioia perché lo presenta insieme a me Malvaldi), ma anche altre cose (con Antonio Manzini tocca a me fare il bravo presentatore). Insomma, un week end giallo davvero. Date e orari
Dunque, qui le date di Torto marcio a Bookcity, la grande rassegna milanese dedicata ai libri. Ancora presentazioni di Torto marcio (con grande gioia perché lo presenta insieme a me Malvaldi), ma anche altre cose (con Antonio Manzini tocca a me fare il bravo presentatore). Insomma, un week end giallo davvero. Date e orari
Sabato 18 novembre, ore 16.30 – Presentazione di Torto marcio insieme a Marco Malvaldi – palazzo Morando, via Sant’Andrea 6
Sabato 18 novembre, ore 21 – Presentazione di Torto marcio a Cernusco sul Naviglio (Villa Fiorita, via Guido Miglioli)
Domenica 19 novembre, ore 16 – Presentazione di Pulvis et umbra di Antonio Manzini. Qui faccio il presentatore – Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6
 Qui non si parla di politica. Si parla di parole, di un certo modo di metterle in fila, cioè, insomma, in soldoni, di stile e di retorica, e quindi va bene, mi arrendo: si parla di politica.
Qui non si parla di politica. Si parla di parole, di un certo modo di metterle in fila, cioè, insomma, in soldoni, di stile e di retorica, e quindi va bene, mi arrendo: si parla di politica.
Mentre infuriano (mah!) la polemica e la discussione su quel che ha detto Renzi alla direzione del suo partito, sulle presunte aperture a sinistra, sulle presunte strategie, sulle presunte medaglie che lui crede di meritarsi e gli altri non gli appuntano al petto, una sola cosa ha fatto fare il salto sulla sedia. Si tratta di una frasetta innocente, quella sul “futuro che è una pagina bianca”, balzata fuori dal contesto come un pupazzo a molla. Da anni siamo abituati a questo florilegio di frasette, sospiri para-poetici, baricchismi, costruzioni retoriche da diario delle medie, quindi nessuna sorpresa. Anzi sì, invece, molta sorpresa che ancora non si sia capito, nel bunker del Nazareno, quanta irritazione suscitino nell’ascoltatore. Si tratta di un fastidio fisico, come un prurito improvviso, dovuto a una ormai conclamata crisi di rigetto. Naturalmente si è scritto molto sulla poetica renziana, interi trattati e antologie, collezioni e faldoni pieni di esempi del ben noto stile. E si badi bene che non è invenzione nuova: lo stilnovo renzista si congiunge abbastanza bene allo stilvecchio veltronico, quello di “Il dolore non è un ciao”, ermetismo lisergico.
Dunque siamo nella tradizione letteraria (e politica, che è peggio) del nullismo, una corrente quasi pittorica, che sistema con due pennellate spesse e coprenti i difetti del disegno e gli errori di prospettiva: la riforma ci è venuta uno schifo, vabbé, diamogli una pennellata con qualche frasetta cretina. Qualcosa che potrebbe andare bene come claim pubblicitario per un’auto ibrida, o per un telefono nuovo, tipo “Il futuro è qui”, o “Apriamo le porte al futuro”. E questo da anni. Così può capitare (è capitato) che un italiano di quelli che escono (?) da dieci anni di crisi con le ossa rotte e le poche certezze frantumate, meno diritti, meno prospettive, si senta dire da chi lo governava e pretende di governarlo ancora amenità come: “la bellezza è la chiave di lettura dei prossimi anni”.
Poi ditemi che non fa incazzare.
Silvio Berlusconi, uno che se ne intende, è stato oltre vent’anni sulla scena politica ripetendo ogni giorno che lui non era un politico. La stucchevole retorica progressista della frasetta a effetto cerca di fare subdolamente la stessa cosa: sì, siamo costretti, ahinoi, a fare la politica spicciola (sbuffando), ma quello che ci interessa sono i grandi temi dell’umanità. Così si impastano strambi intrecci semantici con le parole “speranza”, “futuro”, “bellezza”, “riparte”, “avanti”, sempre uguali e sempre strampalati nella costruzione. Scemenze, insomma, che subito partono come il tam tam delle tribù del Borneo, rilanciati da colonnelli e marescialli, giù giù fino alla truppa. Pessima letteratura in pillole per non-lettori diffusa (o derisa, fa lo stesso) come una filodiffusione in sottofondo, quasi non udibile, ma pervasiva, come la musica che si sente negli ascensori, o prima del decollo in aereo: tranquillizza, e non vuol dire niente.
Il fastidio del cittadino (di destra, sinistra, centro, populista, sinistra bersaniana, incazzato generico ascendente cinquestelle, e tutti gli altri) è ormai palpabile, accompagnato dalla netta sensazione di essere preso per il culo. Ogni azione ha la sua poetica e le parole per dirlo, ma stupisce come le piccole elegie tascabili del renzismo siano tramontate in fretta, passate di moda, si siano logorate e abbiamo mostrato la loro sublime inconsistenza, insieme alle politiche di chi le declama. Il fallimento delle cose e il fallimento delle parole sono un po’ la stessa cosa. Lo sapevamo già, ma al poeta del Nazareno piace ripeterlo all’infinito.
 Io ve lo dico: se ci mettiamo a vendere le spillette con scritto “Mai stato renziano” facciamo i soldi. Fate conto di metterle allo stesso prezzo delle primarie, due euro l’una, e sono cifre importanti, abbastanza per avviare un percorso imprenditoriale basato sulla cessione beni e servizi per chi vuole derenzizzarsi. Ecco i principali servizi offerti dalla nostra azienda.
Io ve lo dico: se ci mettiamo a vendere le spillette con scritto “Mai stato renziano” facciamo i soldi. Fate conto di metterle allo stesso prezzo delle primarie, due euro l’una, e sono cifre importanti, abbastanza per avviare un percorso imprenditoriale basato sulla cessione beni e servizi per chi vuole derenzizzarsi. Ecco i principali servizi offerti dalla nostra azienda.
Tweet predatati. Può capitare che qualcuno chieda prove provate del vostro non essere mai stati renziani. Di solito in questi casi si esibisce un tweet del 2014, o un post del 2015, si cita una vecchia battuta sulla Leopolda. Se non siete in possesso di pezze d’appoggio, la nostra azienda vi fornisce tweet e post di Facebook predatati, critici o ironici, con cui accreditarvi. La cancellazione di vostri vecchi tweet inneggianti a “Matteo che vince” è disponibile con un piccolo supplemento. Maggiorazione del dieci per cento per i tweet su “Quanto è brava Maria Elena”.
Renzisti anonimi. Il percorso di recupero personale può essere lungo e faticoso. Oltre alle riunioni, in cui ognuno racconta la sua storia, i motivi che l’hanno portato al renzismo e le ragioni per cui vuole smettere, sono possibili colloqui individuali, nei casi più gravi saranno presenti una suora e un esorcista (tariffa da concordare).
Biglietti del treno. Siamo spiacenti, la nostra azienda risolve molti problemi ma non può fare miracoli. Se siete tra quelli che hanno pensato che il treno di Renzi era una buona idea, le vostre probabilità di recupero e guarigione sono troppo basse, quindi niente rimborso.
Cancellazione selfie. Vi siete fatti un selfie con Renzi? Comparite plaudenti sotto il palco da cui parla? Sono ricordi che un uomo vuole cancellare, e anche una donna. Tecnicamente non è difficile, basta un piccolo fotomontaggio per sostituire le fattezze di Matteo con quelle di chiunque altro, il cicciottello della seconda B, oppure il collega d’ufficio che scrocca troppi caffè alla macchinetta. Qui le tariffe variano: se di quella foto vi siete vantati con gli amici dovremo raggiungerli uno per uno e potrebbe costarvi caro. Non si accettano carte di credito.
La strage dei cugini. Quante volte per sostenere una riforma renzista avete tirato in ballo vostro cugino? “Il jobs atc funziona, perché mio cugino l’hanno assunto!”, oppure “Mio cugino cerca un cameriere e non lo trova!”, o anche: “Il figlio di mio cugino si trova tanto bene con l’alternanza scuola-lavoro!”. Sappiamo che il più delle volte si trattava di cugini immaginari, ma nel caso fossero cugini veri, potrebbero lasciarsi sfuggire che non vi hanno mai detto quelle scemenze. Testimoni pericolosi, insomma. La nostra azienda si propone di eliminarli discretamente, facendolo sembrare un incidente. In questo caso la tariffa è piuttosto alta, ma si può discutere uno sconto-quantità. Supplemento per i cognati.
Certificazioni. Purtroppo la normativa Ue ci obbliga a un complesso sistema di certificazioni. Per fare qualche esempio: il codice Ue34-71-J indica chi ha smesso di essere renziano dopo i tagli alla sanità, mentre Ue61-12-F indica chi ha smesso dopo il referendum sulle trivelle. E’ un lavoro complesso e costoso, ma vi mette al riparo da brutte sorprese future. Disponibili le pergamene da appendere in ufficio con la dicitura “Non più renzista dal…” (Esempio: Non più renzista dal gennaio 2016, “Mps è risanata, ora investire è un affare”, codice Ue57-83.Y). Visitate il nostro negozio di cornici.
Assistenza. Il nostro centralino è sempre in funzione per qualsiasi chiarimento e l’ufficio commerciale valuta sconti per gruppi numerosi di gente che si è sbagliata e sente il bisogno di un percorso di riabilitazione, tipo Confindustria, Rai, gente che scrive su Il Foglio. Sconti e convenzioni con chirurgi plastici per chi “ci ha messo la faccia”.
 Quello che so io di Pietro Cheli non è molto interessante. In ogni caso non come era interessante lui, ma si sa com’è quando uno se ne va: si cercano le parole e vengono fuori solo quelle buone, un po’ di retorica e un po’ di nostalgia. Pietro Cheli non merita queste stupidaggini, lui stesso avrebbe sbottato uno dei suoi tonanti “Belìn, che palle!”.
Quello che so io di Pietro Cheli non è molto interessante. In ogni caso non come era interessante lui, ma si sa com’è quando uno se ne va: si cercano le parole e vengono fuori solo quelle buone, un po’ di retorica e un po’ di nostalgia. Pietro Cheli non merita queste stupidaggini, lui stesso avrebbe sbottato uno dei suoi tonanti “Belìn, che palle!”.
E’ stato il mio capo al Diario della settimana, quando si andava a “portare il pezzo” anche se lo si era già mandato per mail, così, per fare due chiacchiere di tutto e di niente, e per vedere cos’aveva da dire Pietro. Che era una specie di miniera, un orco buono circondato da pile di libri in ordine precario. Da lì, come dalle cene in cui mangiava come Pantagruel e raccontava come Fo, te ne andavi sempre con una carrettata di aneddoti, racconti che potevano andare dal Genoa alla letteratura, dal pettegolezzo alla critica del testo. Un corpo così pesante e così tanta leggerezza, sembrava un miracolo. E poi, Pietro Cheli sapeva tutto e leggeva tutto, ed era di una curiosità spaventosa: morbido come un piumino – un piumino bello grosso – e anche acuminato come uno scalpello da ghiaccio, mica uno che mediava. Era un enorme fratello tricheco capace di dolcezza e di ironia.
Quando mi chiamò dopo l’uscita del mio primo romanzo, la Canzone, mi fece molti complimenti, ma più che contento ero sollevato: Pietro poteva anche dirti senza problemi che avevi scritto una cagata e, sapendo questo, i suoi complimenti valevano doppio. Poi arrivava alla presentazione con il libro tutto pieno di appunti, segni a matita, sottolineature, segni di pagina: “L’avevo già letto, ma l’ho riletto stanotte”. Gli erano piaciuti anche gli altri (“Belìn, quanto scrivi!”), e io avevo sempre la sensazione di essermi sottoposto a una specie di benedizione: se Pietro Cheli dice che va bene, allora va bene, e comunque non metteva conto parlarne, perché era già passato ad altro, altri aneddoti, altre storie, altri libri letti, dischi o concerti sentiti. Ecco, io me lo ricordo così, un fiume in piena che ti contagiava con tutto quello che aveva contagiato lui. Ora fa male pensarlo. Fa male pensare ad Alba, amica trentennale, sister in rock dai vecchi tempi de l’Unità, che rimane senza il suo Pietro. Come tutti noi, ma lei di più, e un abbraccio come quello – così gigantesco – deve mancare in modo intollerabile.
E’ uscito (Quodlibet edizioni) Sportivo sarà lei, una raccolta di scritti, appunti, racconti eccetera di Beppe Viola. Qui la recensione su Tutto Libri de La Stampa
 Scrivere di Beppe Viola è un po’ complicato, perché alla fine ti tocca scrivere di quelli che fanno gli spiritosi, di quelli che si venderebbero la casa per una buona battuta e anche di quelli (lui) che sapevano guardare il mondo come se fosse quello che è: un posto di matti. Così questo “Sportivo sarà lei” edito da Quodlibet (che un paio d’anni fa aveva ristampato “Vite vere compressa la mia”, un classico di Viola) sembra una trappola, che ti tira dentro, ti risucchia nella nostalgia canaglia.
Scrivere di Beppe Viola è un po’ complicato, perché alla fine ti tocca scrivere di quelli che fanno gli spiritosi, di quelli che si venderebbero la casa per una buona battuta e anche di quelli (lui) che sapevano guardare il mondo come se fosse quello che è: un posto di matti. Così questo “Sportivo sarà lei” edito da Quodlibet (che un paio d’anni fa aveva ristampato “Vite vere compressa la mia”, un classico di Viola) sembra una trappola, che ti tira dentro, ti risucchia nella nostalgia canaglia.
Va bene, leviamoci il pensiero: Milano non è più quella Milano là. Non c’è più Jannacci, né il Derby, né Dario Fo, non c’è più nemmeno la nebbia, i calciatori sono pettinati da pirla e nessuno di loro si presterebbe a fare un’intervista in tram. Eccetera eccetera. Però bisogna anche dire che parlare di Beppe Viola con il registro della nostalgia non va bene per niente, è troppo facile e soprattutto gli fa un torto grande: di Beppe Viola, oggi non bisogna invidiare quello che vedeva, ma come sapeva vederlo. Insomma, non il panorama, ma gli occhiali.
Diviso in capitoletti agili, il libro somiglia all’autore: un po’ di qua e un po’ di là, mai fermo un momento, un po’ (un po’ tanto) cronista sportivo, un po’ cabarettista, un po’ poeta a suo modo, con quel tanto di romanticismo che ci mette uno quando va alle corse dei cavalli e torna a casa con le tasche vuote – ma è stato bello lo stesso. Articoli pubblicati e non, racconti lasciati nei cassetti, pezzi di vita, di Milano, lezioni di biliardo, strofe scartate da Quelli che, calcio e altri sport sparpagliati, pillole di scrittura sopraffina: “C’ho via una gamba da quando ho fermato il tram in viale Porpora. Il pallone però l’ho salvato anche se adesso non mi serve”. Per dire – ma è solo un esempio tra mille – della poetica dei desperados à la Jannacci.
C’è da ridere, insomma, ma con quel ghigno che dice che non c’è niente da ridere, e si ride lo stesso.
Bella l’introduzione della figlia Marina Viola (che ha scritto anche un bel libro su papà, “Mio padre è stato anche Beppe Viola”, Feltrinelli, 2013), bella, commovente, la postfazione di Giorgio Terruzzi, che di Viola fu tanto complice da volergli bene come a un padre, e buona anche la divagazione di Marco Pastonesi sul giornalismo, o su come lo intendeva Beppe. Però, alla fine, il libro è tutto suo, del Beppe Viola, o meglio della sua cosmogonia milanese, quando non si era ancora così colti e snob da chiamare “situazionista” uno che lavorava alla Domenica Sportiva, ma trovava il modo di scrivere tanto, e bene, dalle canzoni alle sceneggiature, dalle cronache ai racconti, anche se si capisce che preferiva l’ippodromo, e quindi scriveva molto anche di cavalli e del vero motivo per cui esistono i cavalli: quelli che ci scommettono sopra.
Lette le duecentotrenta e passa pagine, riso il giusto, ricordato il giusto, percorso in lungo e in largo il mondo dall’ufficio 341 della Rai di Milano (dove capitava di incontrare “vecchi amici, ex collaboratori Rai, compagni di scuola, pittori illustri, aspiranti giornalisti, comparse della Tv, uscieri, reduci del ’15-’18, spogliarelliste e via dicendo”), fino a San Siro, inteso come stadio, o fino all’epica di via Lomellina, quello che rimane è lo stupore. Stupore dello stupirsi di niente, delle vite normali, della fauna che ci circonda e che si permette di avere una vita sua. Storie di uomini che non prendono niente sul serio e per i quali – quindi – è tutto maledettamente importante.
E dunque quello che ci lascia Beppe Viola – anche in questi scritti raccolti come reliquie dagli amici – è una sopraffina capacità di vedere l’umano, di capirlo e di riderne, e non c’è dubbio che Viola – morto a 42 anni nell’82 – lo faceva senza dissociarsene, anzi mischiandosi volentieri ai suoi mille e mille personaggi e diventando uno di loro. Del resto, a uno che quando la figlia fa una scemenza a scuola manda l’amico Jannacci a parlare col preside non si può chiedere di meno. E quanto ai bilanci, lasciamo perdere: “Ho quarant’anni, quattro figlie e la sensazione di essere preso per il culo” basta e avanza, perché tra il magone e lo sghignazzo la distanza è brevissima, e lui la percorreva tutta, di corsa.
 Torto marcio è uscito quasi un anno fa (era gennaio), ne ho parlato ovunque in lungo e in largo, è sempre un piacere incontrare i lettori. Ecco le ultime presentazioni… in zona Milano (anche a Book City) e fuori. Insomma, chi vuole… ci vediamo lì.
Torto marcio è uscito quasi un anno fa (era gennaio), ne ho parlato ovunque in lungo e in largo, è sempre un piacere incontrare i lettori. Ecco le ultime presentazioni… in zona Milano (anche a Book City) e fuori. Insomma, chi vuole… ci vediamo lì.
ASTI – Sabato 11, ore 18 – Fuori luogo, piazzale G. Pasta
OPERA – Lunedì 13, ore 21 – Biblioteca di Opera, via Gramsci 21
MILANO – BOOKCITY – Sabato 18. Ore 16.30 – Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6
CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Sabato 18, ore 21 – Villa Fiorita, via Miglioli angolo via Gobetti
MILANO – FONDAZIONE PIRELLI – Lunedì 20. Ore 18.30 – Viale Piero e Alberto Pirelli 25
 L’etimologia non è chiarissima, quindi da dove arrivi la parola “mancia” non lo sappiamo esattamente. Però è affascinante una delle ipotesi: era la manica del vestito che la dama donava, si suppone con sorridente leggiadria, al cavaliere vincitore del torneo, una cosa che fa tanto Medio Evo, tavola rotonda, amor cortese e legge di stabilità italiana ai tempi dei bonus.
L’etimologia non è chiarissima, quindi da dove arrivi la parola “mancia” non lo sappiamo esattamente. Però è affascinante una delle ipotesi: era la manica del vestito che la dama donava, si suppone con sorridente leggiadria, al cavaliere vincitore del torneo, una cosa che fa tanto Medio Evo, tavola rotonda, amor cortese e legge di stabilità italiana ai tempi dei bonus.
La teoria economica renzista – che si condensa nella formula “tenga, buonuomo, si faccia una birretta” – si dispiega in tutta la sua potenza nella legge di bilancio in discussione in questi giorni: non c’è categoria, ordine, gruppo, settore, sottosettore, arte minore, che non sia oggetto di piccole regalie, bonus, piccole o grandi detrazioni. E’ una specie di fiera di paese in cui si dona qualcosa a qualcuno, tutto a termine e a scadenza: gli ottanta euro anche a chi è un po’ più ricco – e questo per non toglierli a chi ha avuto un aumento atteso da secoli, come gli statali – gli sconti contributivi a chi assume gente sotto i 35 anni, poi sotto i 30, però in certe regioni di più, in altre di meno. I pendolari potranno scaricare dall’imponibile il costo dell’abbonamento al treno. Che è come dire: ok, amico, viaggi su un carro bestiame che arriva in ritardo, ma ti offro il caffè. Chi si fa il giardino pensile avrà delle detrazioni (giuro).
Sì, in effetti c’è qualcosa di medievale. E già si immaginano al lavoro i solerti compositori di bonus: se assumi un diciottenne dell’alternanza scuola-lavoro in Molise per fargli fare il giardino aziendale, praticamente ti coprono d’oro, è come vincere al Lotto.
Quindi diciamo che – nel paese europeo con i salari più bassi e la più alta età pensionabile – la legge finanziaria è una specie di patchwork di pezze messe su un tessuto liso. I giovani non lavorano? Ecco un regalo alle aziende se ne assumono un po’, o almeno si spera, sapendo che smetteranno appena cessa il bonus, come Jobs act insegna. I millennials ci schifano? Ecco il bonus per quelli che compiono diciott’anni, indiscriminatamente, con buona pace della lotta alle diseguaglianze. Tutto con la scritta ben evidente: “Scade tra un anno, al massimo due”. Per chi fosse interessato e possedesse una squadra di calcio, c’è la prebenda anche per chi fa giocare i calciatori del vivaio, per dire. Insomma, un po’ di mance, bonus, gentili omaggi, aiutini, ma poca roba, alla fine. Per i poveri veri, per esempio, ci sono un po’ di briciole, (più o meno mezzo miliardo), verniciati con la scritta “coesione sociale” (ahahah!), ma in compenso spendiamo quasi sedici miliardi per non fare aumentare l’Iva. E’ un buon prezzo, se si pensa che dovremo beccarci anche la narrazione spocchiosa dell’ “abbiamo diminuito le tasse”, cioè abbiamo pagato tasse per non aumentare le tasse, che è un po’ come il rapinatore volesse una medaglia perché non spara agli ostaggi.
Ora assisteremo alla battaglia degli emendamenti, delle modifiche, degli aggiustamenti, una specie di mercato rionale in cui lobby grandi e piccole lavoreranno per ampliare la loro mancia, e ridurla a qualcun altro: successi e sconfitte del grande suk saranno sbandierati in campagna elettorale. “Ehi! Abbiamo concesso detrazioni alle vecchiette con un barboncino bianco!”, oppure: “Mai così tanti idraulici biondi sotto i ventinove anni assunti grazie alle nostre politiche!”. Tutta fuffa, naturalmente, l’anno prossimo ricomincerà la rumba: bisognerà spendere ancora molti miliardi per non far aumentare l’Iva e resteranno le briciole (quasi tutto a deficit, ovvio) per mettere le solite pezze, distribuire un po’ di soldi a pioggia – soprattutto alle imprese – a seconda delle convenienze, dei sondaggi o delle varie emergenze. Poi, quando qualcuno chiederà riforme strutturali o un vero intervento economico gli si dirà: “Ma come! Se ti ho appena dato la mancia!”
 Quindi il Veneto ai veneti, va bene. I soldi del Veneto restino in Veneto, ok. E lo decidono i veneti, che è abbastanza comodo. E’ come riunire la famiglia e dire: basta, ora i soldi che guadagniamo li teniamo qui, nonno vai tu a dirlo all’Agenzia delle Entrate! Parliamo di tanti soldi, per inciso, più o meno quindici miliardi (il solo Veneto), che è poi quello che spendiamo ogni anno per non fare aumentare l’Iva a orologeria piazzata da Renzi sotto il culo di ogni governo da qui a qualche anno. Per la Lombardia siamo più o meno al doppio: 30 miliardi (anche se Maroni dice 50, punto, punto e virgola, due punti a capo, fa’ vede’ che abbondiamo!). Naturalmente è una semplificazione, perché di mezzo ci sta la Costituzione, poi le leggi, i rapporti di forza, la politica, eccetera eccetera, ma insomma, è probabile che molti che sono andati a votare – o a cliccare su un tablet, disastro – si siano figurati le Dolomiti finalmente placcate oro o le Rolls Royce in car sharing a Cernusco Lombardone. E vabbé.
Quindi il Veneto ai veneti, va bene. I soldi del Veneto restino in Veneto, ok. E lo decidono i veneti, che è abbastanza comodo. E’ come riunire la famiglia e dire: basta, ora i soldi che guadagniamo li teniamo qui, nonno vai tu a dirlo all’Agenzia delle Entrate! Parliamo di tanti soldi, per inciso, più o meno quindici miliardi (il solo Veneto), che è poi quello che spendiamo ogni anno per non fare aumentare l’Iva a orologeria piazzata da Renzi sotto il culo di ogni governo da qui a qualche anno. Per la Lombardia siamo più o meno al doppio: 30 miliardi (anche se Maroni dice 50, punto, punto e virgola, due punti a capo, fa’ vede’ che abbondiamo!). Naturalmente è una semplificazione, perché di mezzo ci sta la Costituzione, poi le leggi, i rapporti di forza, la politica, eccetera eccetera, ma insomma, è probabile che molti che sono andati a votare – o a cliccare su un tablet, disastro – si siano figurati le Dolomiti finalmente placcate oro o le Rolls Royce in car sharing a Cernusco Lombardone. E vabbé.
In ogni caso, delle deleghe, del grado di autonomia del lombardo-veneto, del “padroni a casa nostra” (intanto i padroni veri ridono) si parlerà più avanti, non certo ora con un governo in fase terminale, aggrappato ai voti di Verdini come ai tubi dell’ossigeno, che deve portare a casa la legge elettorale. No, per ora si vedono solo gli effetti collaterali, e cioè tre Leghe Nord diverse, come se qualcuno avesse bagnato i Gremlins dopo mezzanotte e quelli si sa che – plop – si moltiplicano.
Dunque c’è la Lega di Zaia, che si scopre uomo operativo e deciso, tanto che qualcuno lo indica come anello di congiunzione elettorale tra la scimmia e il miliardario, cioè tra Salvini e Silvio. Però più che fare la battaglia della Lega, Zaia fa la battaglia del Veneto, e butta lì la sua proposta (Veneto regione autonona) senza nemmeno parlarne con Maroni, che infatti fa la faccia della mucca che vede passare il treno. Diciamolo: tra i due vincitori, Maroni è quello che sembra il fratello scemo: meno affluenza, scrutatori con le flebo fino alle quattro del mattino, risultati col lanternino, mentre in Veneto votavano con il vecchio metodo. Lo strabiliante digitale lombardo, battuto dall’analogico Veneto. Che oltretutto, e suona come uno sberleffo, prende delle decisioni senza dirgli niente. La Lega di Zaia, insomma, sembra vincente sulla Lega di Maroni. Anche perché Zaia riceve offerte da Roma e dice “resto qui”, mentre a Maroni non offre niente nessuno e deve dire “speriamo che resto qui”.
Poi c’è la terza Lega, che è quella di Salvini, prevalga la pietà. Il ragazzo, impegnato nel difficile salto carpiato di prendere voti al centro e al sud pur chiamandosi Lega Nord, dovrà andare a Napoli, a Palermo, a Bari, a Roma, a dire che no, cari, non è come sembra, posso spiegarvi… Insomma, un po’ difficile, e quindi si continuerà sulla stessa strada: Salvini sempre in tivù che fa la propaganda della Lega (gli stranieri nei ristoranti stellati e gli italiani alla Caritas, la solita solfa), e le regioni del nord che fanno la vera politica della Lega, quella dei soldi e dei poteri.
Siccome si parla spesso delle liti a sinistra, che sono il grande romanzo tragicomico del paese da almeno un trentennio, si metta almeno agli atti che a destra non sono poi così uniti. C’è Silvio, eterno revenant come in una fiction sugli zombi a New Orleans, due o tre Leghe Nord, un po’ di patrioti del “quando c’era lui”, i sovranisti antieuropeisti, ma anche il presidente del parlamento europeo. Un bel casino, insomma, anche tenuto conto che andranno quasi certamente a governare con quel che resta del Pd che nel frattempo, anche sul referendum (vero o presunto) del nord non ci ha capito niente: come mettere un camaleonte su una tela scozzese, si confonde un po’, poveretto.
 Ora che per sapere dove si trova Matteo Renzi basta consultare l’orario dei treni, è forse il momento di fare il punto sulla situazione sentimentale del nostro eroe, impegnato in questi giorni in una faticosa riconquista. Siamo a un passo dal canto medievale, con il principe che corre lancia in resta alla riconquista dell’amata (la smorfiosa principessina Sinistra), sempre che l’amata dimentichi tutti gli schiaffoni ricevuti, di essere stata rinchiusa nella torre, di essere stata derisa e umiliata davanti alla corte, periodicamente abbandonata, tradita con Verdini, e altro ancora.
Ora che per sapere dove si trova Matteo Renzi basta consultare l’orario dei treni, è forse il momento di fare il punto sulla situazione sentimentale del nostro eroe, impegnato in questi giorni in una faticosa riconquista. Siamo a un passo dal canto medievale, con il principe che corre lancia in resta alla riconquista dell’amata (la smorfiosa principessina Sinistra), sempre che l’amata dimentichi tutti gli schiaffoni ricevuti, di essere stata rinchiusa nella torre, di essere stata derisa e umiliata davanti alla corte, periodicamente abbandonata, tradita con Verdini, e altro ancora.
Del resto, inventarsi una legge elettorale che premia le coalizioni senza avere nessuno con cui coalizzarsi denota un certo sprezzo del pericolo, tipico di certi cavalieri delle fiabe, per cui recuperare la sinistra diventa una specie di mossa obbligata: l’amata non è amata per niente, anzi al nostro eroe sta parecchio sulle palle, ma bisogna riconquistarla lo stesso. “Cambio di strategia”, “indubbiamente una svolta”, ci dice il Corriere della Sera annunciando la nuova Chanson de Matteo. Ecco alcuni consigli, e le cose che possono andare storte.
Mandare fiori. E’ una mossa scontata ma fa sempre piacere. Purtroppo le reazioni non sono univoche. D’Alema è allergico, Bersani dice “Non fiori ma opere di bene, tipo togliere il ticket sulla sanità”, Civati fa un convegno coi verdi sulla floricoltura. Sul bigliettino ci doveva essere scritto, “Cara, vediamoci, parliamo”, invece l’ha scritto Ernesto Carbone e insieme alle rose è arrivato: “Ciaone”. Pensarne un’altra, subito!
L’invito a cena. Cosa c’è di meglio che parlarsi guardandosi negli occhi? Peccato che alla cena di riconciliazione, Matteo stia tutto il tempo attaccato al cellulare cercando citazioni colte per far colpo. Dopo aver citato De Maistre, il film Dunkirk, Recalcati, Tom & Gerry, Obama e Rita Pavone se ne andrà dimenticandosi di pagare il conto. Dannazione! Ritentare!
Il week end a Parigi. Quella che rimane l’arma fine-di-mondo della riconquista amorosa va maneggiata con cura. Andiamo, chi non cederebbe a un fascinoso fiorentino passeggiando sul lungosenna, mano nella mano tra le viuzze romantiche del quartiere latino? “Ah, proprio vicino a dove insegna Enrico Letta!”, dice Bersani, e così scappa tutta la poesia. Ognuno torna nel suo albergo, solo e triste. Provarne un’altra, subito!
Posti in lista. Più dei fiori, più dei gioielli, ecco un omaggio che dovrebbe funzionare. Una manciata di posti in lista per l’amata che fa la preziosa e non vuole tornare. Del resto dopo aver piazzato i fedelissimi, i millenials offerti da un’agenzia specializzata, gli yesmen, Veltroni perché è andato al compleanno, soci e amici, qualche posto per la sinistra in collegi in cui si perde di sicuro si troverà. E’ come regalare vetri di bottiglia in una scatoletta con scritto Tiffany, ma magari qualcuno ci casca.
Se no vince la destra. Secondo alcuni esperti, è la frase amorosa che funziona meglio, anche più di “Ti ho sempre amato” e “Per me esisti solo tu”. Siamo alla fase “in ginocchio” della riconquista amorosa, quando il nostro eroe passa all’implorazione ed evoca scenari apocalittici: se l’amata non tornerà con il principe vinceranno le forze del Male, cioè quelle che hanno votato con lui il Rosatellum. Matteo si è pure portato il discorsetto scritto su “Se non torni con me vince la destra”, ma mentre lo estraeva dal portafoglio gli è caduta sul tavolo la foto di lui abbracciato a Marchionne. Che disdetta! Pensarne un’altra, subito!
Potrei non fare il premier. E’ l’ultimo stadio dell’amor cortese: l’amoroso si annulla per amore dell’amata. “Se tu torni a casa, io smetto di fare il candidato premier”, è un po’ come Lancillotto che vende il cavallo: non ci crede nessuno, ma fa molta scena e commuove il pubblico più sensibile.
 L’abilità di Giuliano Pisapia come mediatore è ormai nota nel mondo e oggetto di grande ammirazione. Al termine di una complessa operazione di intelligence, Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con il mago Otelma e Belfagor, sono in grado di anticipare le prossime mosse di Pisapia, volte a portare pace e stabilità sul pianeta.
L’abilità di Giuliano Pisapia come mediatore è ormai nota nel mondo e oggetto di grande ammirazione. Al termine di una complessa operazione di intelligence, Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con il mago Otelma e Belfagor, sono in grado di anticipare le prossime mosse di Pisapia, volte a portare pace e stabilità sul pianeta.
13 ottobre. Pisapia riunisce Spagna e Catalogna. Trasportato in una località segreta con un furgone della Guardia Civil, Giuliano Pisapia ha messo in campo le sue doti di mediatore nella grave crisi spagnola. L’incontro è iniziato alle 14. Alle 15.30 l’Andalusia ha proclamato l’indipendenza, alle 16 le Asturie hanno fondato un impero e Alicante ha chiesto l’annessione all’Honduras. L’incontro si è concluso cordialmente, e Pisapia è stato subito riaccompagnato al confine e ringraziato del suo generoso tentativo.
17 ottobre. Pisapia si offre all’Atalanta come mediatore tra reparti, nel ruolo di trequartista. Malumore tra i tifosi. Sette giocatori chiedono asilo politico al Milan, si dimette l’allenatore. Pisapia ringrazia della disponibilità al dialogo e si allontana velocemente.
26 ottobre. Pisapia risolve il caso Cesare Battisti. Grazie alla mediazione di Giuliano Pisapia l’annosa questione dell’estradizione di Cesare Battisti dal Brasile è risolta: lui verrà estradato e Pisapia andrà in Brasile. Favorevoli Pd, Mdp, Si, Calenda e suo cugino, quel che resta dei montiani, i verdiniani incensurati e tutti gli altri. Contrario Pisapia, che ci ripensa e ritira l’offerta.
30 ottobre. Chiamato dai vicini a notte fonda in un bilocale della Bovisa, a Milano, Giuliano Pisapia ha mediato fino all’alba in una lite tra coniugi, cercando di avvicinare le posizioni e di evitare che si passasse alle vie di fatto. Grazie alla sua mediazione, la lite si è sviluppata in tutto il palazzo per poi propagarsi nel quartiere, con saccheggi e incendi. Tutti hanno lodato il generoso tentativo di Pisapia, ma lo hanno pregato di allontanarsi.
3 novembre. Pisapia si offre al Pd per mediare con gli elettori del Pd. Un generoso tentativo rimasto inascoltato.
4 novembre. Pisapia interviene nella vertenza Ilva proponendo una mediazione di buon senso. Invece che quattromila esuberi e diecimila lavoratori pagati meno, suggerisce diecimila esuberi e quattromila lavoratori pagati meno. Al termine della trattativa lascia Taranto nottetempo, travestito da donna, nel bagagliaio di un’auto.
5 novembre. Congresso: pandoro o panettone in vista del Santo Natale? Giuliano Pisapia si offre come mediatore nella storica faida che divide le famiglie italiane.
10 novembre. Pisapia si offre a Mdp per mediare con gli elettori di Mdp. Un generoso tentativo ancora da valutare.
12 novembre. Pisapia e la crisi coreana. Forte della sua fama nella composizione dei conflitti, Giuliano Pisapia si è offerto di mediare tra Donald Trump e Kim Jong-un, proponendosi per colloqui di distensione. Semplice il piano di lavoro: i coreani potranno tenersi le atomiche ma dovranno diventare americani e dimostrarlo nel modo più lampante: sparandosi addosso spesso tra loro. Prime reazioni: la Corea ha lanciato seicento missili in mare e il Pentagono ha spostato tre portaerei nel golfo di Laigueglia. Pisapia è tornato in Italia, lodato per il generoso tentativo.
20 novembre. Pisapia si offre come mediatore tra tutti i giornali che insultano D’Alema e gli altri giornali, quelli che insultano D’Alema. Per una volta la mediazione riesce.
26 novembre. Il governo Messicano e i narcos firmano finalmente un comunicato congiunto: chiedono a Giuliano Pisapia di rinunciare alla sua pur generosa opera di mediazione nella guerra che insanguina il paese per non peggiorare la situazione.
30 novembre. Avviata la mediazione di Giuliano Pisapia con gli elettori di Pisapia: dalle 15 alle 15.10 ha telefonato a tutti.
 Nel paese dell’emerganza-lavoro solenne e costante, di lavoro si parla poco, e soprattutto male. Ognuno di noi è abituato al balletto delle cifre ogni volta che esce un dato Istat, una sberla Ocse, una previsione sballata. Sotto – sotto la coltre fumosa dello snocciolamento quotidiano di parole e propaganda – c’è il baratro, cioè la condizione del lavoro oggi in Italia. Marta Fana, giovane dottore di ricerca in economia a Science Po, a Parigi (la leggete ogni tanto anche su questo giornale) si mette a scavare lì dentro. L’avevamo conosciuta come puntuta scrutatrice di cifre, allorché – col Jobs act operativo da pochi mesi – il ministro del lavoro Poletti aveva sparato cifre paradossali, lei le aveva pubblicamente smentite, e dal ministero arrivarono balbettanti richieste di perdono.
Nel paese dell’emerganza-lavoro solenne e costante, di lavoro si parla poco, e soprattutto male. Ognuno di noi è abituato al balletto delle cifre ogni volta che esce un dato Istat, una sberla Ocse, una previsione sballata. Sotto – sotto la coltre fumosa dello snocciolamento quotidiano di parole e propaganda – c’è il baratro, cioè la condizione del lavoro oggi in Italia. Marta Fana, giovane dottore di ricerca in economia a Science Po, a Parigi (la leggete ogni tanto anche su questo giornale) si mette a scavare lì dentro. L’avevamo conosciuta come puntuta scrutatrice di cifre, allorché – col Jobs act operativo da pochi mesi – il ministro del lavoro Poletti aveva sparato cifre paradossali, lei le aveva pubblicamente smentite, e dal ministero arrivarono balbettanti richieste di perdono.
Ma qui Fana fa un’altra cosa, ci racconta quel che del lavoro non si dice quasi mai: non solo i suoi numeri, già deprimenti, ma la sua qualità, anzi la sua perdita di qualità. Esce in questi giorni Non è lavoro, è sfruttamento (Laterza), e il titolo dice la tesi. Ma è la sua dimostrazione che lascia basiti. Perché Fana mette in fila tutti i vagoni di un trenino che corre velocissimo – da decenni – verso l’impoverimento del lavoro: un preciso, costante e lucidissimo disegno di proletarizzazione dei lavoratori italiani. Deregolamentazioni, esternalizzazioni, privatizzazioni di servizi, perfetta aderenza del lavoro precario alle esigenze contingenti delle imprese, ricatti, rimodulazioni al ribasso dei contratti. Dai modernissimi stabilimenti di Marchionne, con Renzi in gita scolastica, alla fabbrichetta piccola o piccolissima. Fino al lavoro gratis. Fino al grottesco, gogoliano paradosso dei lavoratori della Biblioteca Nazionale di Roma, che, pagati in rimborsi spese, racimolano scontrini al bar per avere i loro quattrocento euro di non-salario. Fana ci mostra che dietro le legislazioni, i commi, le riforme cantate con enfasi epica, ci sono le storie e le vite. C’è Chiara col contratto da cassiera all’ipermercato che dopo il turno deve pulire i cessi, e lo fa per tenersi il lavoro. C’è l’inferno del settore della logistica che contrappone i diritti del consumatore (l’ho ordinato oggi e lo voglio domani!) a quelli del lavoratore sempre più strizzato da contratti prendere-o-lasciare.
Chiunque legga questo libro può scegliere in quale vagone del trenino accomodarsi: quello del lavoro a chiamata, quello degli straordinari non pagati, del demansionamento, del ricatto contrattuale, delle cooperative aperte e chiuse per dribblare le leggi. Il massimo ribasso è l’unica carta che vince e a ribassare sono salari e diritti. Se cercate paradossi e anime morte siete nel posto giusto, fino all’assurdo: il grande call center Almaviva che trasloca in Romania e licenzia in Italia, ma continua a vincere commesse pubbliche.
Detto così sembra uno stillicidio, ma visto il disegno complessivo – anche per la scorrevolezza e l’ordine con cui l’autrice mette in fila numeri ed esempi – è chiaro che si tratta di una strategia. Un assalto del capitale alla dignità del lavoro, dove i governi, tutti, e gli ultimi più di tutti, hanno tifato per una parte (le aziende); da un lato caricandole di soldi, sgravi fiscali, regali, sanatorie, dall’altro sgravandole di doveri e obblighi.
Corre più o meno il ventennale di quel governo Prodi (1995-98, ministro del lavoro Treu) che per primo parlò di flessibilità. In vent’anni quella parola si è gonfiata in modo abnorme, e la discesa agli inferi del lavoro è stata sempre più veloce.
I famosi voucher, sperimentati nel 2008 “nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata” (ahahah, ndr) sono stati progressivamente liberalizzati per ogni sorta di occupazione fino al record (regnanti Renzi e Poletti) di 69 milioni. Niente male per una vendemmia di breve durata. Poi, tranquilli, se il voucher zoppica o viene ridimensionato, ecco che aumenta il lavoro a chiamata, perché le modalità di flessibilizzazione e di scippo dei diritti sono infinite, loro sì, flessibilissime.
Non è (solo) un libro per economisti, questo combattivo pamphlet di Marta Fana, ma un libro per lavoratori. Nel paese che cita il lavoro nel primo articolo della sua Costituzione, il canto costante è che il lavoro “non c’è”. Però è lo stesso posto dove si chiede e si impone di lavorare gratis: stages, simil-volontariato, alternanza scuola-lavoro, per cui le cifre della disoccupazione fanno tremare le vene ai polsi, ma il panino all’autogrill magari te lo scalda uno studente dell’istituto tecnico, qualche stipendio risparmiato per l’azienda he lo “ospita”. Il tutto con spaventevoli ricadute culturali, ovvio, sul lavoro come merce degradata e degradabile, una svalutazione professionale e umana che riguarda tutti. Una fotografia, insomma, lo stato dell’arte qui e ora, dove la parola “sacrifici” risuona instancabile da Lama alla Fornero, da Berlusconi a Renzi nella vera continuità politica del paese: quella di umiliare il lavoro.
 Nel congratularsi con i tre vincitori del Nobel per la medicina che hanno scoperto il gene dei ritmi circadiani del nostro corpo (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael Young), corre l’obbligo di segnalare una grande dimenticanza dell’Accademia svedese. Un altro grande scienziato che ha studiato i tempi di vita degli umani, purtroppo non premiato, è Giuliano Poletti, ministro del lavoro in Italia, famoso per le sue sperimentazioni sull’armonia dei ritmi di vita. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’università di Tubinga, ha analizzato i suoi esperimenti su un grande campione di cavie umane. Insomma, i ritmi circadiani di un giovane lavoratore italiano nell’era della grande flessibilità. Ecco i risultati.
Nel congratularsi con i tre vincitori del Nobel per la medicina che hanno scoperto il gene dei ritmi circadiani del nostro corpo (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael Young), corre l’obbligo di segnalare una grande dimenticanza dell’Accademia svedese. Un altro grande scienziato che ha studiato i tempi di vita degli umani, purtroppo non premiato, è Giuliano Poletti, ministro del lavoro in Italia, famoso per le sue sperimentazioni sull’armonia dei ritmi di vita. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’università di Tubinga, ha analizzato i suoi esperimenti su un grande campione di cavie umane. Insomma, i ritmi circadiani di un giovane lavoratore italiano nell’era della grande flessibilità. Ecco i risultati.
Ore 6.45. Aumento della pressione sanguigna. Colazione. Fine della secrezione della melatonina. Primo lavoretto, pagato in voucher. Ma l’autobus non arriva. Motorino. Si alza o si abbassa la temperatura corporea (secondo stagione). Riflessi in ripresa, per fortuna.
Ore 9. Massiccia ma inutile secrezione di testosterone: il nostro soggetto è fermo a un semaforo mentre corre contando i secondi dal lavoretto numero uno (voucher) al lavoretto numero due (lavoro a chiamata), così tiene lontani i pensieri licenziosi.
Ore 11.30. Massima vigilanza di sinapsi e cellule cerebrali. Il nostro soggetto cerca di non farsi affibbiare tre ore in più di straordinari non pagati. Sono attimi di massima attenzione unita ad acuta consapevolezza: se non stai attento, qui ti salta il terzo lavoretto e i ritmi circadiani di tutto il mese, specie l’affitto, possono collassare.
Ore 14-15. E’ il momento della giornata in cui sono ai livelli massimi coordinazione e velocità di reazione, situazione perfetta per il cottimo (terzo lavoretto) misurato da una app che segnala il tuo rendimento a un algoritmo, che telefona al capo della start-up, che ti fa il culo.
Ore 17. Intervallo di massima efficienza cardiovascolare, molto utile quando il nostro soggetto apprende che la cooperativa che lo aveva assunto per il quarto lavoretto si è sciolta, ne è nata un’altra, e lui verrà pagato meno. Un simile avvenimento alle quattro del mattino (minima temperatura corporea) potrebbe arrecare danni al sistema nervoso, ma nel pomeriggio il soggetto può sopravvivere. Cioè, speriamo, perché deve correre al lavoretto successivo.
Ore 19. Perfetta efficienza del sistema e massima pressione sanguigna. E’ un peccato, perché il nostro soggetto scopre che il suo incarico (pagato in nero) è ora svolto da uno studente in alternanza scuola-lavoro costretto a farlo gratis e non, come lui, a due euro all’ora. Rischio di scompensi cardio-circolatori nei soggetti più fragili. Rischio di sbalzi d’umore (sindrome depressiva) quando il soggetto pensa alla sua laurea.
Ore 21. Lucidità moderata, inizio del rallentamento del ritmo circadiano. Il nostro soggetto può dedicarsi finalmente al suo hobby: consegnare pasti caldi a clienti che hanno ordinato con una app, pagato come un portatore aborigeno del 1700, ma in bicicletta. E’ il momento della giornata in cui l’orologio biologico suggerisce il relax e la preparazione al sonno, ma suggerisce anche di sperare in buone mance, perché senza quelle la retribuzione sarebbe ridicola.
Ore 24. Casa. Divano. Massima secrezione di melatonina e sonno, ma ancora qualche attività cerebrale. Il nostro soggetto valuta le prestazioni circadiane della giornata (26 euro e quaranta, più le mance) garantite dal perfetto funzionamento del suo orologio biologico, ma soprattutto della sveglia, che domani mattina suona alle sei e mezza. E’ il momento dell’abbassamento delle pulsazioni e del calo della consapevolezza. Peccato, perché addormentandosi come un sasso, il nostro soggetto non può leggere gli allarmati editoriali sulla tragedia degli italiani che non fanno più figli.
 Naturalmente della Germania non sappiamo niente. Anzi sì, sappiamo la vulgata tradizionale, la narrazione corrente, il luogocomunismo (unico comunismo rimasto sul pianeta) per cui quando pensano o nominano la Germania, politici e commentatori di qui impastano un semilavorato di invidia e ammirazione: eh, però la Germania! Ora che la famosa Germania si scopre un po’ fascista, con l’estrema destra al tredici per cento e alcuni simpatizzanti del Terzo Reich che entrano in parlamento, comincia ad affiorare qualche brandello di realtà.
Naturalmente della Germania non sappiamo niente. Anzi sì, sappiamo la vulgata tradizionale, la narrazione corrente, il luogocomunismo (unico comunismo rimasto sul pianeta) per cui quando pensano o nominano la Germania, politici e commentatori di qui impastano un semilavorato di invidia e ammirazione: eh, però la Germania! Ora che la famosa Germania si scopre un po’ fascista, con l’estrema destra al tredici per cento e alcuni simpatizzanti del Terzo Reich che entrano in parlamento, comincia ad affiorare qualche brandello di realtà.
Raccontata solitamente come poderosa locomotiva, dove gli operai siedono nel Cda delle grandi imprese, ed efficienza e ordine tirano tutto il carro, la Germania si scopre oggi – colpo di scena – un po’ meno gloriosa. Impazzano i mini-jobs, un trucchetto che pare italiano per contare come occupati anche quelli che portano a casa due euro, per dirne una. Risultato: regnante la signora Merkel, la disoccupazione è scesa (dall’11 al 4 per cento), ma sono aumentati i lavoratori tedeschi che vivono in povertà (dall’11 al 17), il che significa che si è svalutato il lavoro, né più e né meno che negli altri grandi paesi europei (qui facciamo malamente eccezione: la povertà aumenta, ma la disoccupazione non cala). In queste condizioni è abbastanza facile prendere il povero, scontento e incazzato tedesco, mostrargli un immigrato e dire che è colpa sua. E’ un trucchetto vecchio come il mondo, che in Germania conoscono bene. Si aggiunga che nei posti dove AfD ha vinto di più, soprattutto a est, gli immigrati non ci sono, ma abbondano altri problemi che sono quelli di un sistema economico che “ottimizza” il suo funzionamento schiacciando verso il basso milioni di cittadini: i poveri più poveri, il ceto medio spaventato e sempre sull’orlo di diventare povero pure lui.
I fascisti-rivelazione delle elezioni tedesche sbandierano lo slogan “Prima i tedeschi”, che fa scopa con il “Prima gli italiani” di Salvini e fascistume nostrano, che fa briscola con “La Francia ai francesi” della signora Le Pen. In pratica si dice al povero tedesco che se è povero è colpa di uno più povero di lui che va lì, e non di un sistema che permette al dieci per cento di tedeschi di possedere il 59 per cento della ricchezza: la Germania è leader europea anche nella diseguaglianza sociale.
A fronte del fatto che non si riesce a redistribuire decentemente la ricchezza, si indicano come nemici quelli che di ricchezza non ne hanno. E del resto negli ultimi dieci anni in Europa i lavoratori poveri (occupati ma sotto la soglia di povertà) sono aumentati ovunque. Le forze politiche tradizionali (centro, centrosinistra, larghe intese, Grosse Coalitionen) da Parigi a Berlino, da Roma a Madrid, hanno tutte più o meno agevolato questa ottimizzazione liberista a scapito dei loro cittadini. E non a vantaggio dei poveri migranti, ma della rendita, dei grandi capitali, delle grandi aziende, della finanza. Insomma, “Prima i tedeschi” andrebbe detto a quei pochi tedeschi che sono diventati molto ricchi a scapito di moltissimi tedeschi che sono diventati più poveri. E lo stesso vale per chi dice “prima gli italiani”, ovviamente.
Tutto questo sembra un poker col morto. C’è chi vince (il capitale), c’è chi perde (il lavoro) e c’è il morto, che sarebbe la sinistra, ormai inadatta al suo ruolo storico: o lo recupera mettendosi sul serio dalla parte del lavoro, o diventa, come pare oggi, solo un grande equivoco semantico. Dire “sono di sinistra” e fare politiche di destra che aumentano le diseguaglianze – qui siamo maestri – apre le porte al peggio. Poi, come in Francia, bisogna scegliere il meno peggio: le politiche sociali ed economiche delle Merkel, dei Renzi, dei Macron creano fascismo, e ci diranno che bisogna votare le Merkel, i Renzi e i Macron sennò arriva il fascismo.
 Diciamolo: siamo abbastanza uomini di mondo da non scandalizzarci per una marchetta del Tg1. Da che mondo è mondo, e da che Rai è Rai, non si lesinano certo favori ad amici, famigli e colleghi, quindi che nel primo notiziario pubblico trovi posto un servizio sul nuovo libro di Aldo Cazzullo, (5.480.576 spettatori: uno spot sarebbe costato milioni), vabbé… Ma la marchetta cazzullesca al Tg1 dell’altra sera aveva del prodigioso, e la segnaliamo perché potrebbe aprire una nuova frontiera.
Diciamolo: siamo abbastanza uomini di mondo da non scandalizzarci per una marchetta del Tg1. Da che mondo è mondo, e da che Rai è Rai, non si lesinano certo favori ad amici, famigli e colleghi, quindi che nel primo notiziario pubblico trovi posto un servizio sul nuovo libro di Aldo Cazzullo, (5.480.576 spettatori: uno spot sarebbe costato milioni), vabbé… Ma la marchetta cazzullesca al Tg1 dell’altra sera aveva del prodigioso, e la segnaliamo perché potrebbe aprire una nuova frontiera.
Ebbene sì, Cazzullo ha scritto un fondamentale saggio sui giovani che guardano il cellulare a tavola (e a scuola, e ovunque), e l’ha scritto coi suoi figli, che già sarebbe materia per Telefono Azzurro. Poi, non contento dei paginoni del Corriere scritti a sei mani coi pargoli, è andato in scena al Tg di mister Orfeo, sempre coi ragazzi. Lui a dispensare le sue massime da fila alla posta (“Non si parla più a tavola”, signora mia!), e loro, poveretti, a ribattere, felici come adolescenti rapiti da Boko Haram, con una faccia che diceva: scusatelo, è un vecchio lagnoso, ma non è cattivo. A ravvivare il teatrino, le scritte in sovrimpressione: i messaggi whatsapp dei ragazzi, in modo che anche lo spettatore del Tg1, (età media128 anni) potesse cogliere la vertiginosa profondità del discorso. Per il libro di Cazzullo, insomma, non bastava la marchetta semplice, ci voleva una sceneggiatura, una regia e la grafica. Tutto lavoro del servizio pubblico, giornalisti, montatori, effetti speciali. A loro va, naturalmente parte della nostra solidarietà. Non tutta, purtroppo, perché dobbiamo tenerne un po’ da parte per i giovani Cazzullo, costretti non solo a parlare col padre (che già… che palle!), ma a parlare col padre del perché preferiscono usare il cellulare piuttosto che parlare col padre. Coraggio, ragazzi!
 Colpo di scena, all’improvviso è tutto blu. Chi ha avuto la pazienza (e lo stomaco) di seguire la tradizionale sagra di Pontida, ha potuto constatare con un rapido colpo d’occhio la svolta cromatica della Lega. Palco blu, cartelli blu con scritto “Salvini premier”, striscioni blu sul palco. Divertente, perché quando (raramente) le telecamere facevano un controcampo sulla folla leghista, si vedeva chiaramente che quella era ancora verde, dalle camicie ai berretti, alle bandiere, ai simpatici cartelli contro neri, terroni, comunisti, giudici, eccetera. Insomma, la base di Pontida non è stata avvertita per tempo della svolta cromatica imposta al partito dal Salvini aspirante premier. Sull’invito non c’erano indicazioni per il dress code del militante del nuovo corso, che si è presentato verde mentre il capo diceva blu. Come andare in bermuda e maglietta dei Ramones a un ricevimento all’ambasciata.
Colpo di scena, all’improvviso è tutto blu. Chi ha avuto la pazienza (e lo stomaco) di seguire la tradizionale sagra di Pontida, ha potuto constatare con un rapido colpo d’occhio la svolta cromatica della Lega. Palco blu, cartelli blu con scritto “Salvini premier”, striscioni blu sul palco. Divertente, perché quando (raramente) le telecamere facevano un controcampo sulla folla leghista, si vedeva chiaramente che quella era ancora verde, dalle camicie ai berretti, alle bandiere, ai simpatici cartelli contro neri, terroni, comunisti, giudici, eccetera. Insomma, la base di Pontida non è stata avvertita per tempo della svolta cromatica imposta al partito dal Salvini aspirante premier. Sull’invito non c’erano indicazioni per il dress code del militante del nuovo corso, che si è presentato verde mentre il capo diceva blu. Come andare in bermuda e maglietta dei Ramones a un ricevimento all’ambasciata.
Comunque sia: blu.
Un blu potente e denso, piuttosto scuro, diverso (ma sono sfumature) dal classico blu berlusconiano, che è più un azzurro scuro. Lì, dalle parti di Silvio, le abbiamo viste tutte, le sfumature del blu: l’azzurrino cilestrino con le nuvolette tipo salvaschermo di Windows, poi l’azzurro al neon e lustrini stile pomeriggio Mediaset, poi un blu più presidenziale, quasi solenne, à la Macron, che però, ad essere onesti, col blu è arrivato un po’ dopo.
Del resto pare che quella per il colore blu sia un’attrazione fatale e qualcuno ha riso un bel po’ (come si fa quando c’è poco da ridere) allorché i buontemponi del Pd di Milano si presentarono alla manifestazione del 25 aprile con berretti e bandiere blu, delirando giustificazioni come “la Resistenza è europea” e cose così. Al netto degli incidenti dettati dall’ignoranza (un cartello blu inneggiava a Coco Chanel, collaborazionista dei nazi, Signore perdonali, ma anche no) fu chiaro a tutti che si trattava di uno smarcamento ideologico sottolineato da svolta cromatica. Niente rosso per carità, blu, mi raccomando, il blu sfina, signora mia. Sfina soprattutto appartenenze, identità e ideologie: non impegna, ecco.
Inutile dire: ho cominciato febbrilmente a consultare siti specializzati in cromoterapia, cose a metà tra lo pseudoscientifico e il santone indiano, per scoprire cose interessanti. Ooohmmmmm: Tipo che il blu rilassa, ed è associato alla meditazione e al pensiero. E questo escluderebbe Salvini. Però ho scoperto anche che il blu sarebbe il colore dell’anima, associato al secondo chakra, che si trova nella regione pubica, guarda un po’. E questo spiegherebbe Berlusconi.
Interessante, ma resta la sostanza politica. Il blu fa presidenziale e responsabile. Il blu è affidabile, solido, e al tempo stesso rassicurante. Soprattutto, il blu è un colore abbastanza neutro, non associato a particolari ideologie, come il rosso e (nella recente storia italiana) il verde leghista tanto usato per camicie, cravatte, fazzoletti da taschino. Insomma, chi passa al periodo blu vorrebbe farci intendere che ripudia le vecchie nuances, le sfumature, l’antico pantone delle idee e della storia, e ricomincia da capo. Di più: che si impone di presentarsi come una forza tranquilla, equilibrata e credibile. Insomma, se aspiri a governare è meglio che ti metti qualcosa di blu, almeno la cravatta. E se al vecchio Bossi è stato vietato il palco di Pontida è perché è stato valutato troppo verde-vintage, démodé, superato e impresentabile.
Quanto al gentile pubblico, sarebbe meglio avvertire: è gradito il gadget blu. Al 25 aprile di Milano il Pd cittadino lo fece: si vendevano berretti e pettorine blu, geni del marketing. A Pontida (sarà l’improvvisa crisi di liquidità) non ci hanno pensato, e il Salvini blu parlava ai leghisti ancora verdi, non aggiornati, forse colpevolmente non abbonati a Vogue Padania.
 Se sia meglio avere una vita sola, magari un po’ coerente, o averne due o tre piuttosto incasinate, non è questione che risolveremo qui, e – diciamolo subito – che non risolve nemmeno Dennis Lehane in questo suo ultimo Ogni nostra caduta. Ma siccome lo scrittore americano è uno abituato ai grandi numeri e alle grandi storie che diventano quasi sempre grandi film (registi da Clint Eastwood, Mystic River a Martin Scorsese, Shutter Island, niente male, no?), è meglio starlo ad ascoltare, perché tutto lascia intendere che la storia pazzesca della signorina Rachel la vedremo anche in sala, e quindi l’esercizio è capire quanto il nuovo romanzo sia romanzo, quanto sia cinema, e quanto sia costruito come un ottovolante per farti dire “Oh!”.
Se sia meglio avere una vita sola, magari un po’ coerente, o averne due o tre piuttosto incasinate, non è questione che risolveremo qui, e – diciamolo subito – che non risolve nemmeno Dennis Lehane in questo suo ultimo Ogni nostra caduta. Ma siccome lo scrittore americano è uno abituato ai grandi numeri e alle grandi storie che diventano quasi sempre grandi film (registi da Clint Eastwood, Mystic River a Martin Scorsese, Shutter Island, niente male, no?), è meglio starlo ad ascoltare, perché tutto lascia intendere che la storia pazzesca della signorina Rachel la vedremo anche in sala, e quindi l’esercizio è capire quanto il nuovo romanzo sia romanzo, quanto sia cinema, e quanto sia costruito come un ottovolante per farti dire “Oh!”.
Ma insomma, si parte da Rachel, e va detto che la costruzione del personaggio centrale del libro è davvero magistrale. Di lei, protagonista indiscussa che spara al marito nella prima riga, sappiamo tutto, dei rapporti tesi con una madre egoista e sfuggente (eufemismo), della sua ricerca del padre sconosciuto (e la madre non gli dice chi è), della sua scalata nell’Olimpo del giornalismo televisivo. Brava. Finché qualcosa si rompe, anzi più cose: intanto si rompe lei, promossa come inviata ad Haiti (il terremoto del 2010) non ne esce bene, viene triturata da un’esperienza estrema e sbrocca in diretta. Poi si rompe il matrimonio con il marito perfettino e carrierista. Insomma, ascesa e caduta della bella Rachel, e sono pagine ottime, che ci consegnano un personaggio cesellato fin nei dettagli, abbastanza ben scritto da non far dire al lettore: “Beh, ma il giallo quando arriva?”.
Ma tranquilli, arriva, e le rogne iniziano quando arriva anche l’amore, che non sarà una regola generale, ma… E qui parte, dopo una lunga storia tranquilla, una lunga storia agitata, frenetica, densa di sorprese che uno non si aspetta. Come sempre, il genere autorizza tutte le prudenze nel raccontare la trama, ma insomma: il nuovo marito di Rachel, Brian, che la cura, la ama e la salva dai suoi fantasmi – crisi di panico, agorafobia e tutto il catalogo – non è quello che sembra, e Rachel non ci mette molto a scoprirlo. E’ come se le prime cento pagine fossero la salita a cremagliera delle montagne russe: uno sente l’arietta fina, si gusta il panorama in soprelevata. Poi, a un certo punto, ecco la discesa che mozza il fiato, le curve secche e violente, il brivido dell’imprevedibile. La storia, insomma, si complica, l’amico diventa nemico, un imbroglione che a sua volta ha nemici feroci, la messa in scena e la finzione si confondono con la realtà, Rachel cerca di capire in che razza di incubo è finita, con la sola possibilità di fidarsi di uno di cui nessuno di noi si fiderebbe nemmeno per un nanosecondo.
Va detto che Lehane è autore di vaglia e, quindi la sua scrittura regge bene anche quando si fa più incalzante che descrittiva, e pure di più: le pagine in cui ancora l’intreccio non si scatena lasciano intendere che il genere gli va stretto. E fa un discorso, Lehane: un discorso anche complesso sull’amore che cura e che delude, che illude e che imbroglia, e della volontà di crederci comunque, perché le alternative – per Rachel e per tutti gli umani, si direbbe – non sono poi molte. Una bella storia, anche se un paio di passaggi sono un po’ estremi, e per accettarli come credibili bisogna immaginarsi seduti al cinema, più che in poltrona a leggere, compresa la metamorfosi della protagonista, che all’inizio fatica a uscire di casa, trema se deve prendere la metro, suda per il disagio, e dopo invece maneggia pistole e sotterfugi come una professionista.
Ma Lehane sa risolvere anche questo: alla fine della lettura uno si chiede se – nonostante la storia giallissima – l’autore sia da mettere nello scaffale dei thriller o in quello del romanzo (per chi ancora fa di queste differenze), un dubbio che lui si guarda bene da sciogliere. Difficile anche dire se l’happy and sia davvero happy, ognuno decida secondo i suoi standard, ma quel che è certo è che Lehane, ormai un asso pigliatutto quando si tratta di trasportare al cinema i suoi libri, ha pensato molto anche all’eventuale trasposizione cinematografica, alle svolte improvvise, ai colpi di scena un po’ esagerati (morti che poi non sono morti, per capirci), allo stupore di chi legge (o guarda). Insomma, un buon libro che si prepara a sentirsi dire: un ottimo film. E se solitamente l’accusa è di scrivere libri come sceneggiature, ecco una sceneggiatura scritta (bene) come un buon libro.
 A volte succede: devi dire una cosa a un amico, ma non sai come fare, e di solito sono cose che a un amico andrebbero dette. Tipo: “Mi spiace dirtelo, ma ho visto tua moglie caricare le valigie sulla Cadillac decapottabile del vicino di casa e partire con lui”. Insomma, non è mai bello comunicare le cattive notizie, si mischiano timore (come la prenderà?), imbarazzo e dispiacere. E così oggi abbiamo mezzo Pd imperlato di sudore che cerca di dire qualcosa all’amico Matteo: “Se a palazzo Chigi si candida qualcun altro, e magari Gentiloni, abbiamo qualche speranza, se ti candidi tu perdiamo sicuro”. E’ una cosa brutta da dire a un uomo che crede in sé così tanto, ma qualcuno deve farlo. Secondo le cronache politiche (vatti a fidare) per adempiere a questo triste compito si è già creata una discreta fila. Orlando e gli orlandiani, Emiliano e gli emilianiani (eh?), mentre Franceschini e i franceschiniani non vorrebbero proprio dirgliela in faccia, a Matteo, questa brutta notizia, e si propongono di farglielo capire piano piano, magari dopo le elezioni siciliane.
A volte succede: devi dire una cosa a un amico, ma non sai come fare, e di solito sono cose che a un amico andrebbero dette. Tipo: “Mi spiace dirtelo, ma ho visto tua moglie caricare le valigie sulla Cadillac decapottabile del vicino di casa e partire con lui”. Insomma, non è mai bello comunicare le cattive notizie, si mischiano timore (come la prenderà?), imbarazzo e dispiacere. E così oggi abbiamo mezzo Pd imperlato di sudore che cerca di dire qualcosa all’amico Matteo: “Se a palazzo Chigi si candida qualcun altro, e magari Gentiloni, abbiamo qualche speranza, se ti candidi tu perdiamo sicuro”. E’ una cosa brutta da dire a un uomo che crede in sé così tanto, ma qualcuno deve farlo. Secondo le cronache politiche (vatti a fidare) per adempiere a questo triste compito si è già creata una discreta fila. Orlando e gli orlandiani, Emiliano e gli emilianiani (eh?), mentre Franceschini e i franceschiniani non vorrebbero proprio dirgliela in faccia, a Matteo, questa brutta notizia, e si propongono di farglielo capire piano piano, magari dopo le elezioni siciliane.
Insomma, la storia è questa: qualcuno deve dire a Matteo che nel suo renzianissimo partito – nel nuovo Pd senza più gufi, rosiconi, disfattisti, problematici e rompicoglioni – è rimasto qualcuno che non lo ritiene il più adatto a fare il premier. E questo dev’essere un colpo duro. Più duro ancora perché Gentiloni non è che stia facendo i miracoli, ma sembra più affidabile, meno ciarliero, molto meno fanfarone. E non è che quando Gentiloni stringe una mano o visita un luogo ci troviamo il giorno dopo – come accadeva con Renzi – le foto ricordo, il filmino, la slide, il videogame, il romanzo a puntate, la colonna sonora e la narrazione delle gesta dell’eroe. Dunque Renzi sarà colpito – quando si decideranno a dirglielo – proprio nella più profonda renzità, quella che lo porta a pensare che “quando c’è la comunicazione c’è tutto, signora mia”.
Segnalo a questo proposito un leit-motiv non proprio azzeccato della propaganda in corso, l’intenso, reiterato, eccessivo, dunque noioso, richiamo ai Mille Giorni, come se si parlasse della prima crociata, o della guerra dei Trent’Anni, o delle Cinque Giornate. Tutto quel che di bene (pochino, si direbbe) succede nel Paese, sembra scaturire da quei magici Mille Giorni di cui si ricordano pagine memorabili (?) e si scordano le altre, quelle meno nobili e un po’ vergognose, soprattutto la cosatante mortificazione della dignità del lavoro in questo paese. Insomma, dire cose come “Considero un privilegio aver lavorato a fianco di Barack Obama…” è come dire “Sono stato fortunato a giocare con Maradona”, un bel ricordo, ma era un altro secolo. Ricordare i fasti passati fa orgoglio da “vecchia gloria”. Non so cosa ne pensano i guru della comunicazione, ma dire “Quando c’ero io…” ti colloca già nel passato, il che sembrerebbe letale per uno che ce l’ha menata con la retorica del futuro un giorno sì e l’altro pure per mille giorni (appunto). Il format con cui Renzi si presenta alle sue esibizioni – con o senza libro in promozione – conferma che non ha capito bene quel che succede, che la formula del Golden Boy un po’ indisciplinato e contaballe non paga più, non convince, proprio perché l’abbiamo vista in azione per mille lunghissimi giorni, è stata stucchevole, prevedibile (anche se non priva di spunti satirici). Forse qualcuno che gli vuole bene riuscirà a dirglielo, forse glielo diranno gli elettori siciliani sui quali ha già messo mille mani avanti dicendo che il voto in Sicilia non è un test nazionale… Non c’è fretta, ma prima o poi qualcuno dovrà farlo: avvertire Matteo che il suo format è invecchiato. Oggi va più il grigiore tranquillo, quelli che ballano il flamenco sui tavoli non piacciono più tanto e i Mille Giorni non sono il Sacro Graal da ritrovare.
 Trattasi di materia intricata e nobilissima, spesso sommersa dalla retorica, una necessità umana e civile che a volte diventa trucchetto per distrarre tutti. Insomma: la memoria.
Trattasi di materia intricata e nobilissima, spesso sommersa dalla retorica, una necessità umana e civile che a volte diventa trucchetto per distrarre tutti. Insomma: la memoria.
Ricordare quello che è stato, cosa è successo, perché. Mantenere vivo il ricordo delle ingiustizie passate in forma di monito per il presente. Il grido “Per non dimenticare” è uno dei più alti e dolorosi nel paese, riguarda stragi, delitti, presunte fatalità, fa parte del sapere popolare, sono ferite aperte che potrebbero guarire se si arrivasse alla verità, cosa che accade raramente, quasi mai.
Per questo risultano strabilianti le comunicazioni del governo, nella persona del ministro degli esteri Angelino Alfano, sul caso Regeni. Perché introducono nel discorso operativo sulla questione un bizzarro tipo di memoria: una memoria che archivia, che nasconde.
Il paradosso di una memoria costruita per dimenticare.
Perché il nostro ambasciatore torna in Egitto, il loro torna qua, l’Egitto è un posto dove abbiamo molti affari, non possiamo permetterci di rompere, eccetera eccetera. In cambio – occhio che arriva la memoria – il governo si impegna a fare un sacco di cose per non dimenticare Giulio Regeni. Gli intitoleranno un auditorium. Il governo si è “attivato con il Coni” (urca!) perché ai Giochi del Mediterraneo, in Spagna, l’anno prossimo, si osservi un minuto di silenzio. E poi, se e quando si farà, potrebbero intitolargli l’Università italo-egiziana, la cui realizzazione Angelino “auspica”. Perbacco. Ecco fatto: garantita la memoria, ufficializzato in qualche modo il senso di ingiustizia che tutti provano, e quindi normalizzata l’indignazione, la missione può dirsi conclusa, il caso Regeni quasi chiuso. Ma sì, ancora si parla (vagamente) di indagini, si allarga il campo tirando in ballo l’Università di Cambridge, addirittura (questo è Cicchitto) si insinua che l’inchiesta del New York Times – l’Italia conosce prove schiaccianti – sia stata ispirata dai servizi americani in chiave Anti-Eni.
In una parola: polverone.
E’ uno di quei casi in cui la memoria ostentata e cannibalizzata dal potere (da chi dovrebbe risolvere il caso, non semplicemente ricordarselo!) si rivela spaventevole ipocrisia. E’ una memoria come concessione, la risposta di Angelino a chi si ostina a dire che non dimentica è la seguente: ok, non dimentichiamo nemmeno noi, ma andiamo avanti, che l’Egitto è partner irrinunciabile in affari.
Non è l’unico caso in cui la memoria fa brutti scherzi. Nel paese della Resistenza e delle sue infinite (e sacrosante!) celebrazioni, per dirne una, si assiste all’avanzata burbanzosa e impunita di alcune milizie fasciste che innalzano labari, stampano fasci littori sui manifesti, scimmiottano lo Schifoso Ventennio, accolte da scuotimenti di teste, piccoli lazzi e molta tolleranza, nonostante esistano leggi in materia (le meno applicate della Galassia).
La memoria, tra l’altro, è variabile, anche in modo veloce e repentino. Sono passati solo un paio di anni da quando si celebrava Lampedusa come terra della salvezza per molti migranti, quando la si candidava al Nobel e ci si commuoveva per le sue storie di accoglienza, quando la si indicava ad esempio. Ora che si è spostato il problema qualche centinaio di chilometri più a sud, nel deserto anziché in mare, quella memoria funziona meno, si tende a scordarla, la si rimuove un po’. Quell’esempio non serve più, non si incastra più con la narrazione corrente, che ora è “aiutiamoli a casa loro”, e quindi il luminoso esempio di Lampedusa che li salva a casa nostra non piace più. Una memoria vera, consapevole, vorrei quasi dire militante, dovrà tener conto anche di questi andirivieni della memoria, valore altissimo in balìa dei venti mutevoli delle furbizie, delle tattiche, delle convenienze del momento.
Si riparte. Dal 22 settembre su Nove, Fratelli di Crozza. C’è anche il ministro Minniti, che piace a tutti tutti tutti…
Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo per ITV Movie è Patrizia Sartori.
 Bene, riassumiamo le linee etico-strategiche della nuova politica sulla migrazione dall’Africa. Noi non siamo capaci di fare gli hot spot di identificazione in modo decente. O fanno schifo con un cesso per seimila persone, o chi li gestisce ci specula sopra come una specie di schiavista, o c’è un giro di mazzette, o tutte e tre le cose. Quindi il nostro geniale piano è di spostare tutte queste belle cose verso sud, e che se la vedano un po’ loro. Naturalmente non è un servizio gratuito: bisogna dare qualcosa a chi si prende questa briga, la Libia, il Ciad, il Niger. L’abbiamo già fatto con il signor Erdogan, che incassa dei bei soldi per fare da tappo alla migrazione da sud est, dalla Siria in particolare. Certe cronache plaudenti si esaltano per numeri dell’aiuto europeo all’Africa, e alla Libia in particolare: già pronti 170 milioni! Urca! E’ un po’ come dire: mi compro una villa al mare e ho già pronti ventisette euro e mezzo.
Bene, riassumiamo le linee etico-strategiche della nuova politica sulla migrazione dall’Africa. Noi non siamo capaci di fare gli hot spot di identificazione in modo decente. O fanno schifo con un cesso per seimila persone, o chi li gestisce ci specula sopra come una specie di schiavista, o c’è un giro di mazzette, o tutte e tre le cose. Quindi il nostro geniale piano è di spostare tutte queste belle cose verso sud, e che se la vedano un po’ loro. Naturalmente non è un servizio gratuito: bisogna dare qualcosa a chi si prende questa briga, la Libia, il Ciad, il Niger. L’abbiamo già fatto con il signor Erdogan, che incassa dei bei soldi per fare da tappo alla migrazione da sud est, dalla Siria in particolare. Certe cronache plaudenti si esaltano per numeri dell’aiuto europeo all’Africa, e alla Libia in particolare: già pronti 170 milioni! Urca! E’ un po’ come dire: mi compro una villa al mare e ho già pronti ventisette euro e mezzo.
Dunque i migranti, i disperati, uomini e donne che attraversano mezzo mondo verso nord nella speranza di mangiare tutti i giorni, o di non essere arrestati dal regime, o di non dover fare il militare a vita come in Eritrea, hanno un buon valore di scambio, diciamo paragonabile a quello del petrolio e delle materie prime. E’ un affare far arrivare il gas in Italia, ed è un affare non far arrivare i migranti.
Naturalmente tutto questo prevede un aggiustamento delle rotte, delle strategie per spostare grandi carichi di persone. Insomma cambia la logistica dello schiavismo, e per ora gli accordi di Parigi sono questo, niente di più: era seccante e costoso vederli morire nel Mediterraneo, ora moriranno nel deserto, potrebbe essere costoso lo stesso, ma almeno non li vediamo e non sentiamo quel disagio di veder crepare la gente sotto casa. Se si espellono dal vocabolario parole come “etica”, “morale” e “umanità”, va tutto benissimo (si attende con ansia la pubblicazione di un vocabolario italiano-Minniti). In ogni caso, sia chiaro, alle vite di quelli che prima morivano o venivano ripescati nel Mare nostrum e che ora rischiano la pelle nel Sahara, non frega niente a nessuno, sono numeri, statistiche, flussi da bloccare. La distinzione tra migranti politici e migranti economici – che a Parigi è stata molto sottolineata – è ormai accettata dalla politica di ogni colore, come se la situazione economica di un paese che non riesce a dar da mangiare ai suoi cittadini, costringendoli a rischiare la vita per scappare da lì, non fosse una questione politica, che scemenza. Insomma, l’Europa mette un tappo – un altro – per difendere i suoi confini da quella clamorosa fake news che si chiama “invasione”, una parola prima rumorosamente inventata dalla destra xenofoba e leghista, poi sdoganata dai media, e ora praticamente diventata verità ufficiale anche se i numeri dicono il contrario. Naturalmente siamo tutti contenti se i cittadini di Sabratha, in Libia, avranno un laboratorio per analisi mediche, ovvio, e se Zwara avrà la sua rete elettrica costruita dall’Europa, benissimo, molto bene. Si segni a verbale, però, che tutto questo sarà (forse, speriamo che le pompe idriche a Kufra vengano fatte con più efficienza delle casette per i terremotati del centro Italia, ecco) costruito sulle spalle di centinaia di migliaia di migranti internati in lager libici, o morti di sete nel deserto, o arrestati prima della partenza. Il piano europeo di Parigi sottolinea anche l’esigenza di “fare opera di pedagogia” (questo l’ha detto Macron), cioè spiegare bene (suggerirei delle slide) a gente che mette in gioco la sua vita, che fa viaggi di anni, che viene picchiata, incarcerata, derubata, violentata e torturata ad ogni tappa, che qui non li vogliamo. Una pedagogia del “sono cazzi vostri”, insomma, salutata come una grande vittoria europea sul fronte dell’”emergenza immigrazione”. Amen.
Citiamo i classici: l’estate sta finendo, un anno se ne va, eccetera, eccetera. Tolto il costume da bagno e rimessi i vestiti civili, ognuno si ributta nella sua vita normale scrutando l’orizzonte dei prossimi mesi: una campagna elettorale infinita che arriva al culmine, la prevalenza del cretino che si afferma sempre più, i tweet di Nina Moric, quelli di Rita Pavone, lo ius soli che si fa, poi non si fa, poi parla il papa e forse si rifà, ma no che non si fa, perché Angelino non vuole. E però Angelino, sfanculato da Renzi due mesi fa, torna di moda per l’alleanza in Sicilia, ma forse sì, forse no, dipende da quel che serve al momento. La tattica vince quattro a zero sulla strategia, nessuno dice un’idea di Paese, di futuro, nessuno mette punti fermi, i punti sono mobili, variabili, intercambiabili a piacere.
Solo due mesi fa l’attacco alle Ong era una posizione di destra xenofoba e razzista; oggi, l’azione delle navi delle organizzazioni umanitarie è stata praticamente sconfitta e annichilita dal ministro dell’interno del governo “di sinistra” (ops!): chi sbertucciava Salvini, oggi difende di fatto le sue politiche, chi diceva “mai larghe intese” oggi dice “larghe intese perché no”.
Il povero Silvio, con capelli, senza capelli, con la Lega, senza la Lega, con la Meloni, senza Meloni, punta alla più clamorosa rivincita che si ricordi. Matteuccio nostro gira l’Italia vendendo il suo libretto e spinge sul lato umano (“Com’è umano, lei”, cfr il povero Fracchia). Molti diventano minnitiani proprio perché pare meno umano. I cinque stelle hanno buon gioco, limitano al minimo le esternazioni, consapevoli che meno parlano e meno cazzate dicono, mentre si scopre che tutto il meccanismo della loro democrazia online dal basso può essere messo in crisi da qualche hacker. Ognuno disegna le sue delusioni o le sue soddisfazioni sullo scorno dell’avversario: un topo a Roma, hurrà! Raggi dimettiti! Gli intellettuali che si schierano stanno su un’altalena che va a velocità vertiginosa: oggi viva Saviano, domani abbasso Saviano, dopodomani viva di nuovo, a seconda di quanto quello che dice si attaglia alla tattica del momento.
 In tutto questo scenario dadaista, non si può contare nemmeno sui numeri, spesso truccati, soprattutto quelli sul lavoro: se nella settimana del rilevamento Istat hai lavorato un’ora risulti occupato, per dirne una. I governativi che esultano per uno 0,4 in più di Pil sono gli stessi che prima del referendum costituzionale sventolavano le stime di Confindustria: se vince il No avremo crollo, morte e distruzione.
In tutto questo scenario dadaista, non si può contare nemmeno sui numeri, spesso truccati, soprattutto quelli sul lavoro: se nella settimana del rilevamento Istat hai lavorato un’ora risulti occupato, per dirne una. I governativi che esultano per uno 0,4 in più di Pil sono gli stessi che prima del referendum costituzionale sventolavano le stime di Confindustria: se vince il No avremo crollo, morte e distruzione.
I militanti di ogni risma e formazione, hanno ormai con i nervi come corde di violino, pronti alla giravolta. Basta con Silvio, andiamo con Silvio, basta con Angelino, andiamo con Angelino, viva Pisapia, abbasso Pisapia. Non c’è certezza, convinzione, visione strategica che non venga travolta dalla polemica passeggera e contingente, costringendo all’inversione a U: l’animale di riferimento è il camaleonte, i politici accusati di “parlare alla pancia del paese” ora non lo fanno più: è la pancia del paese che parla a loro, che gli detta la linea. I giornali seguono, i social peggio mi sento. Se uno straniero commette un reato, ecco la valanga di allarme sulla sicurezza, se un italiano commette un reato, ecco la reazione uguale e contraria, fino a esilaranti (ma tristi, c’è poco da ridere) contraddizioni, così palesi che si trasecola: a pagina due c’è la fiera reazione “il terrorismo non cambierà le nostre abitudini!”, a pagina tre si dibatte se mettere barriere in cemento o querce in vaso per fermare i furgoni sulla folla, cioè si discute animatamente di come cambiare le nostre abitudini. Questo è lo scenario emotivo della settima potenza mondiale alla fine dell’estate 2017. Buon autunno. Auguri. Ne avremo bisogno.
 Ora che la Corte dei Conti ha fatto il punto sui famosi F35 – dicendo che costeranno il doppio, che la famosa occupazione per aggiustarli e fare la manutenzione sarà poca cosa, che ci abbiamo rimesso un sacco di soldi – sarebbe interessante riavvolgere il nastro e andare a vedere (basta un piccolo lavoro d’archivio, su, coraggio) chi diceva le stesse cose cinque o sei anni fa. C’erano i soliti pacifisti (uff, che palle!), la sinistra-sinistra che dice sempre no (non erano ancora di moda i gufi, ma il concetto già esisteva), i “disfattisti”, pochissimi giornali fuori dal coro, tutti archiviati con fastidio come generici e onnipresenti rompicoglioni. Oggi la Corte dei Conti ci dice che abbiamo buttato nel progetto così tanti soldi che tirarci indietro (nonostante non ci siano penali) non conviene.
Ora che la Corte dei Conti ha fatto il punto sui famosi F35 – dicendo che costeranno il doppio, che la famosa occupazione per aggiustarli e fare la manutenzione sarà poca cosa, che ci abbiamo rimesso un sacco di soldi – sarebbe interessante riavvolgere il nastro e andare a vedere (basta un piccolo lavoro d’archivio, su, coraggio) chi diceva le stesse cose cinque o sei anni fa. C’erano i soliti pacifisti (uff, che palle!), la sinistra-sinistra che dice sempre no (non erano ancora di moda i gufi, ma il concetto già esisteva), i “disfattisti”, pochissimi giornali fuori dal coro, tutti archiviati con fastidio come generici e onnipresenti rompicoglioni. Oggi la Corte dei Conti ci dice che abbiamo buttato nel progetto così tanti soldi che tirarci indietro (nonostante non ci siano penali) non conviene.
Traduco in italiano: un impiegato a millecinquecento euro al mese si compra una Ferrari. Qualcuno gli dice, ehi, amico, stai facendo una cazzata, e lui risponde irritato che chi lo sconsiglia non capisce nulla. Ora si trova a dover pagare altre duecento rate altrimenti perde le cento già pagate, e della Ferrari possiede un cerchione.
Nella vicenda dei famosi aerei da guerra futuribili e costosissimi (e pure non del tutto affidabili, a quanto si legge) entra anche un grande classico dell’Italia contemporanea: il miraggio dell’occupazione. L’acquisto degli F35, ci diceva l’impiegato che vuole comprarsi la Ferrari, avrebbe portato tanti posti di lavoro, chi diceva seimila, chi, nel furore della discussione, addirittura diecimila. Oggi si sa che sono millecinquecento, e difficilmente aumenteranno. Sospendendo il giudizio su cosa fare di quei mirabolanti aerei, sarebbe corretto – sano, diciamo – andare a prendere per un orecchio quei propagatori di sfrenato ottimismo (potenza militare! Tanti posti di lavoro! Cuccagna!) e chiedergliene conto. Dopotutto sono passati meno di dieci anni, non due secoli, e quelli stanno ancora lì, politici, lobbysti delle armi, segretari di partito. Anche senza contare la malafede, si tratta come minimo di calcoli sbagliati, di cifre buttate lì a cazzo, mentre chi sapeva fare i calcoli li metteva in guardia, aveva ragione, ed è stato sbertucciato.
La vita pubblica italiana è piena zeppa di cose così. Se volete farvi una risata potete andare a vedere le previsioni di Confindustria prima di Expo, quando ci dicevano che la manifestazione milanese avrebbe creato un boom di occupazione e fatto impennare il Pil (si è visto…). O, andando ancora un po’ indietro nel tempo, si potrebbe parlare con quelli (no global, suore, boy scout…) bastonati a Genova nel 2001 perché, tra le altre cose, chiedevano la Tobin Tax. Passato un decennio, della Tobin Tax si parlava ai tavoli delle grandi potenze mondiali, nei vertici internazionali, nei convegni eleganti. I bastonati avevano ragione, i bastonatori avevano torto. Esattamente come i “disfattisti” degli F35, esattamente come mille altri casi, basta andare a vedere i volumi di traffico della famosa Tav: sembrava un’opera indispensabile, ma era tutto gonfiato, esagerato, sovradimensionato, e ora anche i francesi dicono che si fermano a pensarci un po’. Il motto nazionale dovrebbe essere “Ops, ci siamo sbagliati”, ma i nomi di chi ha spinto, fatto pressioni, deciso affari sbagliati non viene fuori mai. Non solo un paese senza memoria, ma senza responsabilità. Chi è stato? Boh…
I bravi italiani che non si contentano della propaganda continueranno a dire “Attenti, non fatelo, non conviene, ci sono altre priorità”, e continueranno ad essere trattati come deficienti, se serve picchiati. Quelli che decidono, invece, stanno sempre lì. Si sono sbagliati? Beh, pazienza, dai, succede, coraggio, altre duecento rate e avremo la Ferrari. Perché comprare qualche Canadair quando potremo avere i bombardieri?
 Agosto è una faccenda così, tutto pare sospeso, come in attesa, tutto si rimanda a settembre, legge elettorale, coalizioni, grandi manovre, strategie, tattiche. Restano in campo i grandi temi, come per esempio quello del carattere dei leader e, in primis, il brutto carattere di Matteo Renzi, che pare l’ultima frontiera del dibattito politico. Ebbene sì, fatto tutto il giro da Berlusconi in poi, una specie di attraversamento del deserto, per noi povericristi che seguono la politica interna muniti di popcorn, si è ritornati al punto di partenza: un leader deve essere simpatico? Umorale? Che fare se ha un caratteraccio? Semplice: dare la colpa dei suoi fallimenti al caratteraccio, una specie di considerazione umana – troppo umana – che copre tutto, che risolve il problema politico. E’ dal 2013 che si dice che Renzi è arrogante, che ha un ego ipertrofico, che offende gli avversari, che comanda come un monarca la sua truppa di fedelissimi. Tutte critiche per anni attribuite ai gufi, ai rosiconi, a quelli che dicono sempre no, eccetera eccetera. Per cui si arrivava al paradosso: davanti a una personalizzazione estrema della politica (Matteo, Matteo, Matteo), scattava l’accusa agli avversari: ecco voi personalizzate! Ecco, siete ossessionati.
Agosto è una faccenda così, tutto pare sospeso, come in attesa, tutto si rimanda a settembre, legge elettorale, coalizioni, grandi manovre, strategie, tattiche. Restano in campo i grandi temi, come per esempio quello del carattere dei leader e, in primis, il brutto carattere di Matteo Renzi, che pare l’ultima frontiera del dibattito politico. Ebbene sì, fatto tutto il giro da Berlusconi in poi, una specie di attraversamento del deserto, per noi povericristi che seguono la politica interna muniti di popcorn, si è ritornati al punto di partenza: un leader deve essere simpatico? Umorale? Che fare se ha un caratteraccio? Semplice: dare la colpa dei suoi fallimenti al caratteraccio, una specie di considerazione umana – troppo umana – che copre tutto, che risolve il problema politico. E’ dal 2013 che si dice che Renzi è arrogante, che ha un ego ipertrofico, che offende gli avversari, che comanda come un monarca la sua truppa di fedelissimi. Tutte critiche per anni attribuite ai gufi, ai rosiconi, a quelli che dicono sempre no, eccetera eccetera. Per cui si arrivava al paradosso: davanti a una personalizzazione estrema della politica (Matteo, Matteo, Matteo), scattava l’accusa agli avversari: ecco voi personalizzate! Ecco, siete ossessionati.
Ora invece siamo alla rivoluzione copernicana: siccome in qualche modo bisogna giustificare errori e disastri, sbagli e gaffes, la faccenda del “caratteraccio” la tira fuori lui, Matteo in persona. E’ una specie di estrema difesa, che prende il volo durante le presentazioni del libro Avanti, che è una specie di evento estivo buono per riempire pagine e pagine, un rosario sgranato grano per grano, giorno per giorno.
“Il mio carattere è un problema enorme”. E va bene. “Dicono che abbia un caratteraccio”, Ok, abbiamo capito. E comunque: “Non dobbiamo cambiare il mio carattere, ma l’Italia”. E dàgli. E ancora: “Pago per la mia indole? Certo che sì”. La cosa comincia a diventare stucchevole. Ciliegina sulla torta: “Ci dicono (notare il prurale maiestatis, ndr) che dobbiamo essere simpatici, imparerò a raccontare barzellette”. A posto, grazie.
Non serve nemmeno un grande analista (nl caso chiederemmo a Recalcati, ovvio) per capire che il disegno è semplice: buttare tutti i fallimenti sulla comunicazione (già fatto) e sul caratteraccio del capo, che è sì uno bravo, uno che salva il Paese, uno che ha fatto in mille giorni miracoli che gli altri (anche quelli simpatici) non sono riusciti a fare dal tempi di Traiano, ma – porca miseria – ha un caratteraccio…
E’ l’anticamera dell’assoluzione totale, un ribaltamento dell’allievo rispetto al maestro. Perché Berlusconi buonanima, ora in fase risorgente, faceva della sua simpatia da “cumenda” brianzolo un’arma d’attacco, il sole in tasca, i ristoranti pieni, le battute da sala biliardo, mentre Renzi fa della sua antipatia un’arma di difesa: se qualcosa funziona (ma cosa?) è merito delle sue qualità di statista, se invece qualcosa va male (più o meno tutto) è colpa del suo caratteraccio. Il che consente il gioco facile in un’altra delle sue uscite: “Possiamo discutere del futuro dell’Italia e non di simpatia o antipatia?”. Insomma, un trucchetto semplice semplice, il carattere personale messo a protezione di tutto il resto, che è poi una variante delle eterne giustificazioni dell’aspirante uomo forte: il capo non sapeva, il capo è stato tradito, il capo è stato ingannato (da cui il refrain ormai storico “l’ira di Renzi”). Ora la solfa è un po’ diversa, ma della stessa pasta: il capo è bravo, ma poverino, è così odioso… Mettiamoci il cuore in pace: agosto sarà così, con il principino di Rignano impegnato a dire che le cose sono andate male perché lui, dannazione, ha un caratteraccio. Di politica si parlerà un’altra volta, per ora accontentatevi della questione umorale.
 Scene di lotta di classe estiva nel ponente ligure, sequestri di borse frigorifere, pullman fermati ai caselli autostradali, inferrate e cancelli a proteggere le spiagge libere, che sono ormai francobolli di sabbia incollati tra miglia e miglia e miglia di spiagge private. L’emergenza, come al solito, sono i migranti, ma non quelli dei barconi che attraversano il mare, no, i migranti economici che da Milano, partono su torpedoni della speranza, dieci, venti euro il biglietto, con la folle ambizione di andare al mare almeno un giorno, una domenica, e spendere poco. A leggere le cronache estive della settima potenza mondiale, la battaglia è solo all’inizio e si tratta di fronteggiare con vigili, carabinieri, vigilantes privati, ordinanze e divieti, l’orda dei poveri spinti dall’invidia sociale e da un’assurda ambizione: fare il bagno.
Scene di lotta di classe estiva nel ponente ligure, sequestri di borse frigorifere, pullman fermati ai caselli autostradali, inferrate e cancelli a proteggere le spiagge libere, che sono ormai francobolli di sabbia incollati tra miglia e miglia e miglia di spiagge private. L’emergenza, come al solito, sono i migranti, ma non quelli dei barconi che attraversano il mare, no, i migranti economici che da Milano, partono su torpedoni della speranza, dieci, venti euro il biglietto, con la folle ambizione di andare al mare almeno un giorno, una domenica, e spendere poco. A leggere le cronache estive della settima potenza mondiale, la battaglia è solo all’inizio e si tratta di fronteggiare con vigili, carabinieri, vigilantes privati, ordinanze e divieti, l’orda dei poveri spinti dall’invidia sociale e da un’assurda ambizione: fare il bagno.
Ora si sa che “poveri” è parola scomoda e respingente. Va bene per le statistiche e i titoli che li danno in forte aumento, ma poi quando arriva il povero in carne, ossa e infradito, che si porta la sua birra e il suo panino per stare qualche ora spiaggiato come tutti gli altri, come i non poveri, la cosa appare intollerabile. A Laigueglia, per dirne una, chiudono la spiaggia libera alle otto di sera, in modo da impedire che i poveri in arrivo dalle città sistemino gli asciugamani prima che sorga il sole, per prendere posto. Si provvede alacremente al sequestro di ombrelloni portati da casa (“materiale ingombrante”), borse frigorifere, vettovaglie. Il tutto ai limiti dei pochi granelli di sabbia disponibili per il popolo migrante. Sudamericani, filippini, qualche italiano, molte famiglie, e quindi bambini, nonni, zie insensibili alle sublimi lezioni del giornali sulla prova costume, o sul galateo da spiaggia. E così c’è, immancabile, una discriminazione di tipo razziale e classista tra bagnanti: descritti con rispetto e ammirazione quelli che pagano mille euro al giorno al Twiga di Briatore; respinti con le forze dell’ordine quelli che si portano il panino con la frittata.
Chiusa la spiaggia libera di Laigueglia – scrive ad esempio il Secolo XIX, “Gli irriducibili non si sono arresi e sono partiti all’assalto della vicina Alassio”. All’assalto, proprio così, manovra diversiva, accerchiamento, sfondamento delle linee nemiche e poi, finalmente, il tuffo in mare, una specie di presa del Palazzo d’Inverno, anzi d’estate.
Su altri lidi parte l’eterna lotta contro il venditore abusivo, che aggiunge al difetto della povertà il colore della pelle e la latitudine di origine. In questi casi abbiamo gli arditi da salotto di Casa Pound che fanno le ronde, difendendo il sacro bagnasciuga dove il Puzzone doveva inchiodare gli alleati, oppure Salvini che si fa i selfie coi vigili, in versione mojito e manganello. Poi ci sono i poveri con pretese di consumo culturale, che vanno dove il mare non c’è, tipo Firenze, ma anche lì tignosamente decisi a infrangere il sogno della ripresa italiana portandosi il panino da casa, mascalzoni. Le autorità li hanno annaffiati con gli idranti sui grandini di chiese e palazzi, in nome del decoro. Poi, presente il sindaco Nardella, hanno fatto montagne di merce sequestrata, quella che piace ai poveri, tipo le borse di Vuitton a venti euro, che è meno di quanto lascia di mancia chi si compra una vera borsa Vuitton. L’estate è solo all’inizio, la battaglia infuria, il migrante economico che si avventura da Milano alla Liguria non cede, l’autorità costituita vigila e reprime, i sindaci sfornano ordinanze, i giornali scrivono “dove andremo a finire, signora mia”. Per coerenza, eleganti caicchi carichi di milionari dovrebbero partire dalla Versilia alla volta della Liguria, calare l’ancora, lanciare brioches all’arrogante Quarto Stato, zozzone, che pretende di fare il bagno al mare. Gratis, roba da matti.
 Sì, ma le cure? Voglio dire: ottima, davvero notevolissima per rigore scientifico e fluidità d’intuizione la diagnosi del professor Recalcati, pubblicata sulla rivista scientifica Repubblica. Meticolosa l’anamnesi, sopraffina l’analisi, univoca la diagnosi: tutti quelli a cui sta sulle balle Matteo Renzi sono matti. Chi non vuole bene a Matteo e non lo ricorda nelle sue preghiere è matto. Chi dubita di lui è matto. In poche parole: sono tutti matti.
Sì, ma le cure? Voglio dire: ottima, davvero notevolissima per rigore scientifico e fluidità d’intuizione la diagnosi del professor Recalcati, pubblicata sulla rivista scientifica Repubblica. Meticolosa l’anamnesi, sopraffina l’analisi, univoca la diagnosi: tutti quelli a cui sta sulle balle Matteo Renzi sono matti. Chi non vuole bene a Matteo e non lo ricorda nelle sue preghiere è matto. Chi dubita di lui è matto. In poche parole: sono tutti matti.
Ora, io ho da fare, ho degli impegni, una vita mia, e vorrei evitare di finire in un ospedale psichiatrico guardato a vista dalla Serracchiani, e quindi mi dichiaro subito renziano di ferro. Dottore, mi dica cosa devo applaudire e io applaudo, giusto per non essere scambiato per matto. Chiarita la posizione personale, veniamo ai problemi tecnici. Io credo che con questa faccenda dei matti si possa davvero rilanciare il Paese. Ecco come.
Censimento dei matti. Prima di affrontare il problema dei matti è meglio sapere quanti sono. Il 4 dicembre si sono autodenunciati 19.419.507 matti. Poi ci sono i matti che non hanno votato al referendum, quelli che non sanno nemmeno chi sia Matteo Renzi e persino molti che hanno votato sì e sono diventati matti dopo. Parliamo di una cinquantina di milioni di persone come minimo. Assumere medici, infermieri, capisala per curare adeguatamente questa massa poderosa di matti assicurerà il rilancio del Paese. Senza contare l’industria del mobile e falegnameria, che dovrà produrre milioni di lettini per analisi. Poi il personale amministrativo, e un fotografo nuovo per Recalcati, che nel suo sito compare ruvido e fascinoso mentre si trattiene gli occhiali, perché ha paura che un matto glieli rubi.
Profilassi e prevenzione. Contrariamente a quel che crede Matteo Renzi, non è che la gente pensi continuamente a Matteo Renzi, e quindi parla male di Renzi (mostrando sintomi di follia) solo quando si parla di politica, sinistra, diritti, economia, lavoro e quelle cose lì. Uno al bar con gli amici può chiacchierare di tutto, dal calciomercato alla pittura fiamminga, e magari solo per un momento dice “Uh, Renzi, che palle!”. Come cogliere il paziente nell’esatto momento in cui dimostra di essere matto? Secondo i miei calcoli, basterebbero tre-quattro milioni di persone dislocate in mercati, pizzerie, musei, balere, scuole, palestre, insomma ovunque. Al primo accenno di follia, il funzionario si qualifica e per il matto scatta l’identificazione, la segnalazione alla Asl di competenza, eventualmente il ricovero coatto.
Psicofarmaci. E’ ovvio che nei casi più gravi, e nelle sindromi acute (la sinistra rivoluzionaria che vuole la terra ai contadini e le armi al popolo, quella di Bersani, insomma) si dovrà ricorrere ai farmaci. Con un rapido calcolo, penso che servirebbero dalle ottocento alle mille tonnellate di Xanax da distribuire o somministrare in vario modo, a D’Alema, per esempio, sparate in siringoni con un fucile da rinoceronti. Per sedare alcuni milioni di elettori del Pd che se ne sono andati (per forza! Sono matti!) si useranno diverse formule, da “Ce lo chiede l’Europa”, (dosaggio Monti), a “Te lo giuro, è di sinistra!”, (protocollo Renzi), fino allo sbarazzino “Il primo Xanax mandorlato”, (ricetta Farinetti).
Problemi tecnici. So cosa state pensando: con cinquanta milioni di matti ci sarebbe un ingorgo burocratico. Controllare che tutti quelli che non amano Matteo Renzi vadano alle sedute, prendano le pillole, non saltino le visite periodiche del dottor Recalcati richiede una quantità immensa di dipendenti. Questo è il vero nodo della questione: per controllare i matti che non amano Renzi saremmo costretti ad assumere anche molti matti che non amano Renzi, essendo questi la stragrande maggioranza del paese. E’ un effetto collaterale non da poco. Pensiamoci, professore!
 Il 12 luglio è una data importante nella storia del mondo. Era il 12 luglio quando salì al soglio pontificio papa Felice IV (anno 526), quando debuttarono i Rolling Stones (anno 1962) e oggi (anno 2017), quando esce finalmente il libro di Matteo Renzi che tutti abbiamo già letto tre volte. E’ vero, restano dei brani inediti che ancora non hanno raggiunto il grande pubblico: si tratta di 327 preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) per cui oggi verranno transennate le librerie, distribuite bottiglie d’acqua e regolate le file con la protezione civile. Ma naturalmente siamo solo all’inizio ed è nostro dovere informare i lettori su quel che succederà da qui in avanti, e su come si evolverà la questione del libro dell’ex presidente del Consiglio.
Il 12 luglio è una data importante nella storia del mondo. Era il 12 luglio quando salì al soglio pontificio papa Felice IV (anno 526), quando debuttarono i Rolling Stones (anno 1962) e oggi (anno 2017), quando esce finalmente il libro di Matteo Renzi che tutti abbiamo già letto tre volte. E’ vero, restano dei brani inediti che ancora non hanno raggiunto il grande pubblico: si tratta di 327 preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) per cui oggi verranno transennate le librerie, distribuite bottiglie d’acqua e regolate le file con la protezione civile. Ma naturalmente siamo solo all’inizio ed è nostro dovere informare i lettori su quel che succederà da qui in avanti, e su come si evolverà la questione del libro dell’ex presidente del Consiglio.
Avanti, il film. Niente cinema italiano, i diritti sono stati acquistati dalla Paramount, che intende produrre un kolossal della durata di sei ore con protagonista Leonardo Di Caprio, molto ingrassato per l’occasione. Per dare credibilità alla figura degli oppositori di Matteo Renzi, gli attori sono stati provinati nelle peggiori carceri americane, tra i serial killer cannibali dell’Oregon. Per le scene di massa si pensa a un reclutamento di comparse senza precedenti: ognuna avrà ottanta euro ma il cestino del pranzo sarà a sue spese (costa 82 euro). Per la parte di Bersani si pensa a Charlie Manson, che avrebbe un permesso speciale.
Avanti, la serie. Prevista in 176 puntate (ma è solo la prima stagione) avrà al centro dell’intreccio lo sforzo riformista di Matteo Renzi dall’inizio della sua carriera politica (a due anni propose di trasformare il seggiolone in un trono), al referendum del 4 dicembre. Chi ha letto la sceneggiatura descrive come molto toccante la scena nel giardino dei Getsemani, quando la minoranza interna si avvicina a Renzi, lo bacia su una guancia e subito arrivano milioni di elettori che lo mandano a cagare. Farinetti fa un cameo in cui impersona Farinetti che fa un cameo e parla dell’ottimismo. Marchionne interpreta Marchionne, ma viste le numerose comparse vestite da operai ha voluto una controfigura.
Avanti, il videogioco. Si tratta di un videogame strategico a turni molto innovativo, infatti c’è solo il turno di Matteo Renzi e gli altri giocatori non giocano mai, ma applaudono forte. Molto efficace il sistema di alleanze in cui la scelta della strategia è praticamente infinita e si può fare fronte comune con Silvio, con Berlusconi, con il Cavaliere, con papi e con il padrone d Mediaset. Vince il giocatore che per primo abbatte a testate tutti gli elettori di sinistra rimasti o, in alternativa, che convince gli altri giocatori di essere Macron.
Avanti, il gioco da tavolo. Una specie di Gioco dell’Oca contaminato da Monopoli e Trivial Pursuit. Il concorrente con la pedina di Matteo Renzi può salvare banche, distribuire bonus a pioggia in cambio di diritti, insultare gli altri concorrenti, inventare giochi di parole cretini, mentire senza ritegno e altro ancora. Non mancano le insidie, per esempio la casella Franceschini (stai fermo un giro solo, tanto poi Franceschini si adegua) e la casella Referendum (stai fermo un giro, ti dimetti, fai le primarie e ti comporti come se non fosse successo niente). Vince chi arriva primo alla fine, a patto che si chiami Matteo Renzi e legge un discorso scritto da Baricco in persona.
Avanti, il giallo. La speciale declinazione “noir” del libro di Matteo Renzi è stata affidata ai migliori esperti del settore: John Grisham si è occupato degli aspetti legali, Don Winslow dei dialoghi e delle scene d’azione (bella l’irruzione nella scuola quando si menano molto forte i docenti), Denis Verdini della parte etico-morale. Un po’ prevedibile il finale, perché come nel giallo classico di ambientazione tardo-vittoriana il colpevole è il maggiordomo, povero Orfini.
Tutto Libri mi h chiesto una recensione dell’ultimo romanzo di Don Winslow. Eccola.
 Quelli che vanno a comprare un libro di Don Winslow vogliono trovarci dentro alcune cose, perché lui è il più implacabile autore di noir in circolazione e li ha abituati bene. Loro vogliono drammone shakespiriano, sturm und drang, dialoghi secchi, vite da sbirri, dexedrina, delitti efferati, western, rap a palla nelle auto di pattuglia, e il politicamente corretto picchiato a sangue in un vicolo.
Quelli che vanno a comprare un libro di Don Winslow vogliono trovarci dentro alcune cose, perché lui è il più implacabile autore di noir in circolazione e li ha abituati bene. Loro vogliono drammone shakespiriano, sturm und drang, dialoghi secchi, vite da sbirri, dexedrina, delitti efferati, western, rap a palla nelle auto di pattuglia, e il politicamente corretto picchiato a sangue in un vicolo.
E soprattutto vogliono sapere dove Winslow spingerà questa volta il confine labilissimo e sfumato tra il bene e il male, da che parte tirerà la coperta eternamente troppo corta che si chiama “giustizia”. Diciamolo subito: con Corruzione avranno tutto questo e altro ancora. Soprattutto avranno, da incorniciare e maneggiare già come un classico, il detective Denny Malone, irlandese, armato e pericoloso, la moglie e figli nei suburbi, l’amante in città, i fratelli sbirri Russo, Billy O e Big Monthy in macchina con lui a governare il suo regno di Manhattan North.
Giusto. Cattivo. Marcio.
Le strade sono “le sue strade”, lui sa tutto, vede tutto, non vuole che giri troppa eroina, non vuole che girino armi, non vuole che nella guerra tra i boss della droga le gang, i soldati di Peña e quelli di Castillo si facciano troppi buchi con l’artiglieria. O ne facciano a chi passa per caso. Non nelle sue strade. E’ lui il mito della Da Force, una squadra speciale che si basa su un assunto inattaccabile: la Narcotici pensa alla droga, la Omicidi agli ammazzamenti, ma siccome nella grande città cattiva gli omicidi dipendono quasi tutti dalla droga, Da Force agisce in proprio. Tradotto nella lingua di Winslow significa che Malone fa il cazzo che vuole.
Ora serve un’avvertenza: a parlare di Corruzione si rischia lo spoiler dalla prima pagina ed è un problema. Ma ce n’è un altro: che la storia procede dritta intricandosi con mille altre storie, casi, faccende private, buste che passano di mano, alleanze, tradimenti. Tanto che alla fine non è importante sapere che Malone finisce all’inferno, che scende tutti i gradini possibili, ma perché li scende, e come. Allo stesso modo di come fece ne Il potere del cane e Il Cartello – la memorabile saga di Art Keller – Winslow deve prima creare un mondo, e poi metterci dentro il suo eroe. Che è antieroe, sbirro, delinquente, assassino, giustiziere e aggiungete a piacere, basta mettere tutto quanto nella zozza armonia perfetta di un affresco monumentale, frenetico, esagerato, un quadro di Bosch con dentro New York City, dove dopo ogni orrore c’è un altro orrore, dove sopra un potere corrotto c’è un potere più potente e più corrotto.
E così bisogna dire della luce dell’affresco, del suo ritmo, della ruvidezza della tela e della sicurezza mirabolante del tratto. Nei dialoghi, nelle descrizioni, nelle azioni di Malone e dei tanti personaggi non c’è una parola sfuocata, non c’è un’esitazione. Ogni riga è un’esecuzione, e si finisce per perdonare a Winslow qualche svisata di maniera, qualche sbaffo di hard boiled un po’ ostentato, che del resto fa parte della poetica winslowiana, della sua tematica preferita: l’uomo solo di fronte al mondo cattivo – e diventa cattivo anche lui.
Ma insomma, ecco il punto: il detective Malone, per 500 e passa pagine tese come lo sguardo di un tossico con in mano un fucile a pompa, non fa altro che esplorare confini. I suoi confini, prima di tutto: quando si comincia? Quando si prende per la prima volta una busta di dollari? Quando si ricatta il primo trafficante per farne un informatore? Quand’è, esattamente, che i regolamenti diventano grottescamente stretti e le mani grottescamente libere? E quali confini ancora può varcare uno sbirro irlandese amico dei “negri”, ma implacabile anche con loro, che può essere un bersaglio per ogni “Jamaal” con una pistola in mano? Questa è la speciale discesa agli inferi del sergente Malone, quella privata, addirittura intima.
E poi ci sono i confini assurdi del sistema giudiziario americano: ogni reato è trattabile, ogni pena si può sistemare con un accordo, ogni accordo puòessere superato da un accordo più sporco, ogni giudice è comprabile, ogni avvocato ricattabile. Un bell’ambientino, vero Malone? Proprio il posto tuo.
Ma nell’affresco tutto si legge alla perfezione, ogni dettaglio, ogni particolare, ogni schifezza. E dopo il finale wagneriano, l’impareggiabile gloria che solo i senza gloria meritano, chi è andato a comprare l’ultimo libro di Winsolw starà ancora lì a chiedersi dove tirare la coperta della giustizia. Sempre se esiste, una cosa così.
 Siccome il catalogo delle ipocrisie planetario si arricchisce ogni giorno di più, servirebbe una bussola, un tutorial su YouTube, o almeno un rinnovo periodico del vocabolario. Il trucchetto funziona sempre: se non si riescono a cambiare le cose si cambiano le parole. Le parole nuove vengono ripetute e quindi accettate, e così, ecco che il migrante non è più migrante semplice, ma si divide in migrante perseguitato e migrante economico, con il corollario che il primo è un migrante vero, e l’altro una specie di furbacchione che non vuole lavorare al suo paese, è povero e cerca di esserlo meno andando via di lì.
Siccome il catalogo delle ipocrisie planetario si arricchisce ogni giorno di più, servirebbe una bussola, un tutorial su YouTube, o almeno un rinnovo periodico del vocabolario. Il trucchetto funziona sempre: se non si riescono a cambiare le cose si cambiano le parole. Le parole nuove vengono ripetute e quindi accettate, e così, ecco che il migrante non è più migrante semplice, ma si divide in migrante perseguitato e migrante economico, con il corollario che il primo è un migrante vero, e l’altro una specie di furbacchione che non vuole lavorare al suo paese, è povero e cerca di esserlo meno andando via di lì.
Col suo piglio neogollista da glaciale sciuparepubbliche il presidente francese Macron l’ha detto meglio di tutti: “Come spieghiamo ai nostri cittadini, alla nostra classe media, che all’improvviso non c’è più un limite?”. Perfetto e di difficile soluzione, in effetti: come spiegare a gente che borbotta se trova più di tre persone in fila alla cassa dell’Autogrill che ci sono migliaia di uomini e donne che vengono qui sperando finalmente di mangiare qualcosa? Mentre Macron diceva quelle cose (notare l’equazione “cittadini” uguale “classe media”), nei boschi tra Ventimiglia e Mentone era in corso una poderosa caccia all’uomo con i cani lupo alla ricerca di qualche decina di migranti passati clandestinamente in Francia. Scene degne dell’Alabama di fine Ottocento, a poche centinaia di chilometri dalla recente esibizione di grandeur di monsieur le Président.
Dietro le parole, le formule, le riunioni politiche ai massimi livelli, insomma, si certifica e accetta un concetto caro al pensiero liberale: i poveri sono in qualche modo colpevoli di esserlo, e quindi un po’ – lo dico in francese – cazzi loro. Le Le Pen e i Salvini e tutta la compagnia neofascista che ogni giorno starnazza dalle cronache, hanno il loro conclamato razzismo, certo. Ma esiste un razzismo molto più presentabile e pulito, accettabile e incoraggiato, da “classe media” per dirla con monsieur Macron, ed è quello contro i poveri. L’aggettivo “economico” è usato a piene mani per descrivere chi non ce la fa, chi rimane sotto le soglie, chi resta stritolato. Restando alle voluttuose giravolte del vocabolario, non è un caso che i licenziamenti economici nelle politiche del lavoro italiano si chiamino “licenziamenti per causa oggettiva”. Capito? Il mercato è oggettivo, le vite delle persone invece sono soggettive, e quindi (di nuovo) cazzi loro.
Non è niente male come paradosso per iniziare un secolo e un millennio: superate le ideologie (ahahah), archiviata ogni idea di socialismo, di pari diritti, di pari dignità eccetera eccetera, ecco che il mondo – e l’Europa in prima fila – riscopre una grandissima rottura di palle per ceti medi: i poveri. Irritano i migranti economici, in quanto poveri, irritano i turisti low cost che mangiano il panino in strada invece di andare al ristorante, con grande scorno dei Briatore e dei Nardella, irritano i laureati poveri che reclamano una vita più decente, con grande scorno dei Poletti. E’ come se si affermasse (a destra e a sinistra) un nuovo status sociale: l’equazione cittadino uguale ceto medio che Macron ha così soavemente esposto, penetra nelle coscienze. Come la bella Lisa, la prosperosa salumiera de Il ventre di Parigi di Zola, tutti paiono vagamente, persino subliminalmente convinti che il povero “si è cacciato in quella situazione”, e in un piccolo, veloce passaggio logico si trasforma la povertà in una colpa. Ecco spiegata la guerra in atto: una guerra contro i poveri, colpevoli di minare – con il loro colpevole essere poveri – la tranquilla stabilità di tutti gli altri. Non male come modernità: sono cose che si sentivano dire a tavola tanto tempo fa, quando annuendo e dicendo “signora mia”, si passava la salsa allo zar.
 Avvertenza: qui si parla di un compleanno, o se preferite di un anniversario, e la cosa è scomoda assai, perché in questi casi si finisce sempre al “come eravamo”, per concludere che – maledizione – eravamo più giovani, e di un bel po’. Ma intanto c’è la Smemoranda – la Smemo – che compie quarant’anni. Un’agenda da portare a scuola, o dove volete voi, un corpo contundente di spigoli vivi e peso notevole che nacque, appunto, quarant’anni fa a Milano e oggi abita dappertutto, e non c’è ragazzo, ex ragazzo, signorina, liceale, adolescente di ieri e di oggi che non l’abbia avuta in mano. E siccome quando si compiono quarant’anni c’è una qualche tentazione di bilancio (errore fatale!) si dirà che fin qui la Smemo ha venduto una ventina di milioni di copie, è in qualche modo l’Harry Potter delle agende, magia compresa.
Avvertenza: qui si parla di un compleanno, o se preferite di un anniversario, e la cosa è scomoda assai, perché in questi casi si finisce sempre al “come eravamo”, per concludere che – maledizione – eravamo più giovani, e di un bel po’. Ma intanto c’è la Smemoranda – la Smemo – che compie quarant’anni. Un’agenda da portare a scuola, o dove volete voi, un corpo contundente di spigoli vivi e peso notevole che nacque, appunto, quarant’anni fa a Milano e oggi abita dappertutto, e non c’è ragazzo, ex ragazzo, signorina, liceale, adolescente di ieri e di oggi che non l’abbia avuta in mano. E siccome quando si compiono quarant’anni c’è una qualche tentazione di bilancio (errore fatale!) si dirà che fin qui la Smemo ha venduto una ventina di milioni di copie, è in qualche modo l’Harry Potter delle agende, magia compresa.
Due le intuizioni geniali, una: farla durare sedici mesi, perché esiste il calendario solare, quello Maya, quello cinese, e anche quello scolastico. E poi (due): vendere un’agenda già riempita. Vignette, disegni, articoli, discorsetti, satira, umorismo, battute, scherzi, vita vissuta raccontata con leggerezza, e l’indice dei nomi degli autori ve lo risparmio, li trovate sul sito, e sono millemila, compreso chi scrive.
In più, metteteci l’antica faccenda della fisica e del peso specifico, perché oltre ad essere un discreto mattone, la Smemo è una di quelle cose che si gonfia col tempo: appunti, disegni, foglietti, pasticci di pennarelli ed evidenziatori, noterelle, battute. Sì è vero, ogni tanto, mettendo le mani su un reperto, potete trovare anche notazioni peregrine come “Interrogazione di italiano” o “Fare equazioni per martedì”, ma è raro, sappiatelo. Può capitare che per dare corso alla frase “Aspetta, prendo l’agenda”, si debba usare una gru, perché la Smemo è anche un contenitore di tutto quel che accade nella vita media di un possessore di Smemo. E dunque una cosa che stringe il cuore: arrivassero i marziani e trovassero, come reperti della nostra civiltà, solo qualche Smemoranda, penserebbero che qui c’era un mondo migliore.
Insomma, la Smemo è ed è stata per generazioni una specie di Recherche proustiana personale di ognuno, zeppa di ricordi, di suggestioni, di segnali del passaggio del presente, con le mirabolanti tappe dell’adolescenza al posto delle madeleine. E lo è tutt’ora, e si prega di non sottovalutare il dato: carta era e carta rimane, ma carta bisvalida e meritoria, in quanto sopravvissuta e coabitante all’arrembaggio dell’elettronica, di Youtube, del web, di Whatsapp e tutto il campionario. Strabiliante.
Altra faccenda portentosa: le cose “de sinistra” che durano da quarant’anni senza perdere appeal, carica vitale (e clienti) si contano sulle dita di una mano, e per quelle che lo hanno fatto con leggerezza e ironia basta un dito solo. Quanti oggetti conoscete c ancora uguali e fedeli a se stessi, pur aggiornandosi, che esistono dai tempi del Clash? Ironia della sorte (e della sinistra, che ne avrebbe gran bisogno) oggi solo la Smemo può dire senza sospirare e senza ridere: “Veniamo da lontano e andiamo lontano”.
E veniamo da Milano, anche, perché la fabbrica delle idee da cui nacque l’agenda “alternativa” (mi scuso) veniva da un terreno fertile assai, che mediava tra cose vive. Il gusto del cabaret milanese dei tempi precedenti (metteteci Jannacci, metteteci Beppe Viola, shakerate), Radio Popolare, Gino e Michele con Nico Colonna e tutti gli altri. Tempi – 1978 – stupidamente raccontati soltanto come funesti, lugubri e “di piombo”, e dove invece schioccavano istinti di genio, intuizioni funamboliche una delle quali, appunto, la Smemo. Era una specie di segno distintivo, di samizdad semiclandestino, ai tempi, ma aveva già i suoi quadrettoni e un’identità forte. Sapeva mischiare, insomma, appartenenza e leggerezza, superpop con i piedi per terra, democratica ma senza menarsela troppo. Chi l’avrebbe detto, allora che più che un’impresa editoriale sembrava una goliardata di spiriti liberi, che avrebbe segnato e contenuto l’éducation sentimentale di milioni di ragazzi? E che quei ragazzi sarebbero diventati adulti conservandole tutte?
Ecco, sì, la Smemoranda è soprattutto roba da scuola, certo, e a scuola si ripassa, no? Perfetto. E infatti niente come sfogliare le proprie antiche Smemo ci restituisce indietro, vivide, le nostre vite giovani. Perché “come eravamo” è solo la premessa di “come siamo”. Sul “come saremo” si vedrà (che paura!), ma probabile che avremmo in mano (in due mani, che pesa!) una Smemo da pasticciare.
Il Festival Letterature di Roma mi ha chiesto di scrivere e poi leggere un testo inedito. Il tema era: scrittori/lettori, i banditi delle parole. Eccolo (è lungo, non è obbligatorio, conosco gente che non l’ha letto e vive benissimo, ma insomma, a chi interessa…)

IL LETTORE RAPITO
Grazie a voi che siete venuti qui e grazie a quelli che mi hanno invitato.
A loro grazie un po’ meno, se devo dirla tutta, perché il loro è stato un orribile ricatto. Una richiesta assurda e impossibile e cioè tirare fuori da un cappello – un cappello gigantesco, un cappello immenso – una frase, una citazione, un virgolettato di quelli che mi hanno cambiato la vita, che mi hanno spiegato cos’è leggere, e perché non avrei mai smesso di farlo.
 Insomma, mi appello alla benevolenza di voi tutti, se siete lettori capirete che non è facile trovare proprio quella frase, proprio quelle parole che vi hanno aperto il mondo. Sono disposto per questo a tutta la ruffianaggine possibile, al paraculismo estremo, fino a dire: “Ehi! Sono un lettore anch’io, andremo d’accordo!
Insomma, mi appello alla benevolenza di voi tutti, se siete lettori capirete che non è facile trovare proprio quella frase, proprio quelle parole che vi hanno aperto il mondo. Sono disposto per questo a tutta la ruffianaggine possibile, al paraculismo estremo, fino a dire: “Ehi! Sono un lettore anch’io, andremo d’accordo!
Ma cosa volete? Che mi metta a cercare per casa l’Isola del tesoro per dire del mio primo salto sulla sedia? Che vada a scavare tra le belle parole degli altri, le frasi a effetto, quelle che magari ogni tanto servono per far colpo, o perché le sai agganciare a una situazione, perché le usi come didascalia, una stupida seduzione:
Venghino, venghino, signori, egli ricorda le frasi dei libri!
Ma devono essere belle frasi? O bei libri?
Ecco. Ho già fatto casino. Mi dichiaro inadeguato al compito, mi arrendo, ma al tempo stesso intendo vendere cara la pelle e mi ricordo questa frase, che è un inizio, che è una schioppettata, che è una scommessa, e una promessa, e una sfida:
IL 25 MARZO ACCADDE A PIETROBURGO UN FATTO INCREDIBILMENTE STRANO
Ecco, lo vedete. Non è una frase storica, non è nemmeno quello là che si ricordava del ghiaccio davanti al plotone d’esecuzione. Non è nemmeno Holden che dice dei libri che ti hanno fulminato e che vorresti che l’autore fosse tuo amico e poterlo chiamare al telefono ogni volta che vuoi.
No, no, per carità, lascia stare il telefono, dai, ti do la mail…
Il 25 marzo accadde a Pietroburgo un fatto incredibilmente strano.
E’ l’incipit de Il naso, di Gogol’, che di suo è già una storia assurda: come si fa a perdere un naso? E come fa quel naso a prendere una carrozza e girare per Pietroburgo, staccato dal suo generale, il titolare del naso, il legittimo proprietario? Assurdo, sì, vero. Ma più assurdo ancora è come ci finisci dentro.
Cosa? Un fatto incredibilmente strano? E quale? Dai, su, sentiamo, sbrigati.
Bastardo, Gogol… dieci parole contate, dieci di numero, e sei suo.
Scavate una buca in un bosco, in mezzo al sentiero. Ricopritela di foglie e chi ci casca dentro sarà catturato. Una trappola, una carta moschicida. Perché lui, lo scrittore, al lettore, non dice solo di quel fatto incredibilmente strano, no. Gli dice: dai, ora voglio vedere se non vai avanti. Su, prova a non leggere se sei capace.
Si dirà che è una seduzione, una piccola furbizia per attirare l’attenzione, ma non è solo questo, no. Si tratta di caricare una molla, anzi di più: di generare stupore. Anzi, di più, di generare stupore con le vite degli altri, inventate da zero o prese qui è là, sempre vite degli altri sono.
E non è nemmeno essenziale che lo stupore sia sommo e ineguagliabile, si possono raccontare vite banali, se ne esistono, anche se il dubbio è sempre lì in agguato: se vedete vite banali forse non le sapete raccontare, oppure siete di quel tipo legnoso di lettore, quello che si sforza di non cedere allo stupore, di resistere. Ecco Dostojevskij ne L’Idiota:
Dicono che non stupirsi di nulla sia un segno di grande intelligenza; ma, secondo me, potrebbe essere allo stesso modo un segno di grande stupidità…
Quelli bravi vi diranno che tra lo scrittore e il lettore c’è un patto, è vero, in qualche modo. Ma di quel patto il lettore dev’essere complice convinto, farsi portare, cascarci dentro, essere disposto a fare la faccia che fa il principe Myškin quando vede il ritratto di Natas’ja Filippovna. Insomma, cadere nella trappola, camminare sulle foglie anche sapendo, anzi di più, intuendo, anzi di più, sperando, di essere davvero catturato.
quel patto il lettore dev’essere complice convinto, farsi portare, cascarci dentro, essere disposto a fare la faccia che fa il principe Myškin quando vede il ritratto di Natas’ja Filippovna. Insomma, cadere nella trappola, camminare sulle foglie anche sapendo, anzi di più, intuendo, anzi di più, sperando, di essere davvero catturato.
Ecco i banditi delle parole, quelli che ti rapiscono. Già, perché il sottotitolo di questa serata è ancora più subdolo e carogna… “I banditi delle parole”.
Abbiamo, di questi banditi, foto segnaletiche, o ritratti, o identikit. Ne conosciamo le vite e le passioni. Sono quelli che ti portano in giro per le Halles di Parigi a metà dell’Ottocento, o che vedono Lara sul tram… Lara! E allora corrono, e corrono dietro al tram, e gli viene un infarto, povero dottor Zivago! Sono quelli che guidano la decapottabile su per Hollywood boulevard, ancora un po’ sbronzi dalla sera prima, perché hanno un caso per le mani:
“Avevo appuntamento con quattro milioni di dollari”,
dice Marlowe.
Sì, i banditi sono questi qui, quelli che ti portano via dove vogliono loro, e tu sei contento di andarci.
Sono quelli che vanno dall’Oklahoma alla California raccogliendo frutta, con la nonna morta sul tetto del furgone, ed era Furore, 1939, sentite qua:
Dove c’è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell’uno guadagna trenta cents, io mi contento di venticinque. Se quello ne prende venticinque, io lo faccio per venti. No, prendete me, io ho fame, posso farlo per quindici. Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù.
Ecco lo stupore. Ecco che il trucco funziona, ecco che restate, come dicono in Spagna, bocabienti. Ma tu guarda, mi ha rapito, mi ha portato via, in un altro mondo e in un altro tempo e mi ha spiegato il Jobs act.
Bandito anche lui, Steinbeck.
La sua tomba sta al cimitero di Salinas, California. Una tomba come le fanno gli americani, una lastra di marmo per terra e morta lì.
Morta lì è la parola giusta.
Qualcuno – qualche lettore – ci lascia sopra degli oggetti, non solo fiori, anche accendini usa e getta, pacchetti di sigarette. Non sarà come Holden che vorrebbe telefonare al suo autore preferito, però puoi portargli da fumare, anche a uno morto stecchito da cinquant’anni.
Cosa sarebbe questo se non il ringraziamento della vittima – del rapito – al bandito – al rapitore?
Gente strana, i lettori, gente che non si accontenta, e questo è giusto. Ora che i social e tutto quel digitare isterico rendono in qualche modo… telefonabili gli scrittori, come diceva Holden, se ne approfittano.
Esce il libro, lo annunci in rete, oppure pubblichi la prima recensione, oppure dici di una critica. Passano venti secondi, anche meno e sotto, il primo commento, la prima reazione che leggi è:
Bello, bene, e il prossimo? Quando esce?
Annunci che presenterai il tuo libro in un posto. Verona, Bergamo, Salerno centro, che ne parlerai con loro, con i lettori. Passano venti secondi e arriva il primo commento, la prima reazione:
E a Cuneo mai?
E a Trapani non ci vieni?
Lo stupore è reciproco, diventa una partita di ping pong. Io voglio stupirli, e loro stupiscono me. Uno mi ha fatto una specie di scenata: “Tu. Proprio tu. Che io consideravo un sincero democratico, una persona perbene, pacifista, anzi peggio, pacifico, proprio tu conosci così bene le armi da fuoco! Sei affascinato dalle pistole. Che delusione, vergogna!”
Io balbetto, in questi casi.
E’ che scrivo gialli, io. Se vuoi il morto, qualcuno deve restarci secco, è matematico. Se qualcuno resta stecchito lì sul tappeto qualcun altro lo avrà ammazzato, no?
Mi rendo conto che è una difesa debole, ma insomma, io scrivo gialli, o noir, o qualcosa del genere, la pistola è, diciamo così, un ferro del mestiere. Mi aiuta un po’ Chandler, in questo, anzi Chandler che parla di Dashell Hammett:
Hammett ha restituito il delitto alla gente che lo commette per un motivo, e non semplicemente per fornire un cadavere ai lettori; e con mezzi accessibili, non con pistole da duello intarsiate, curaro e pesci tropicali
Ma qui sta il punto, tra lo stupore di chi si fa rapire, e i banditi che ti rapiscono. Il giallo ha un vantaggio, anzi due. Il primo è che una volta che ti ho rapito, che ti ho tirato dentro, che ti ho detto, come Gogol, che è successo un fatto incredibilmente strano, tu vorrai capire, vorrai vedere come va a finire, e va bene, facile.
Il secondo vantaggio è che lì, nel giallo, nella storia nera, il delitto c’è per contratto, dichiarato, è la base da cui si parte, è il pilastro portante. Il Male, il Bene, il Buono, il Cattivo, sono lì dentro, e tu lo sai prima di cominciare.
Puoi avere buoni di tutte le specie, va molto quello sempre ubriaco con una donna che non c’è più, sporco di rimpianti ma abbastanza duro da non farli diventare rimorsi. Oppure il gentiluomo intuitivo al massimo grado, quello che vede un indizio e lo segue fino a un altro e fino a un altro e poi mette insieme i pezzi.
Oppure il buono muscolare, che fa a cazzotti e sta in piedi a caffeina e pillole.
O la caricatura scientifica del poliziesco tecnologico americano di inizio secolo – questo secolo –: si trova un pelo, lo si mette in un macchinario, anche portatile, una valigetta, e dopo tre minuti, dopo la pubblicità, saprai se il padrone del pelo beveva molto, se andava all’asilo dalle suore, se ha fatto il College a Santa Fé e guidava una Mustang. E’ l’ossessione scientifica, è il Male e il Bene ai tempi del colera tecnologico.
E anche i cattivi sono di tutti i tipi, certo. Ma quel che conta è che tu, lettore, lo sai, io, lettore lo so: il bene e il male sono compresi nel prezzo. Facile no? Ecco, ora bisogna solo mischiarli per bene.
Agitato, non shakerato.
 E per quanto mi riguarda, se volete saperlo, la mia ansia di lettore è di finire in posti nuovi già pensati; e che chi scrive, il mio rapitore, il mio bandito, me li faccia pensare meglio. Io voglio finire in un buco, in una fessura, in un’intercapedine dove raramente si va a guardare.
E per quanto mi riguarda, se volete saperlo, la mia ansia di lettore è di finire in posti nuovi già pensati; e che chi scrive, il mio rapitore, il mio bandito, me li faccia pensare meglio. Io voglio finire in un buco, in una fessura, in un’intercapedine dove raramente si va a guardare.
Ecco, un’intercapedine.
Per esempio, resto al noir, al giallo, io voglio entrare – o portarvici, quando scrivo – in quell’intercapedine che c’è tra la Legge e la Giustizia. In quella fessura lì. In quella crepa nel muro. Perché la legge e la giustizia non sono la stessa cosa, non sono in scala uno a uno, sovrapponibili. No. Quello che è legale spesso è ingiusto, quello che è giusto spesso non è legale.
Una volta entrati in questa intercapedine, come Alice che casca nel pozzo, ecco, altri buchi, altri piccoli crepacci che possono inghiottirci. Sì, perché c’è un’altra intercapedine in cui si muove il noir, il giallo, il mistero da sciogliere. Ed è quella tra due giustizie, una di nome, fatta di ricostruzioni, faldoni alti due spanne, i testimoni, le prove, l’avvocato, il Pm, e la pittoresca scritta La legge è uguale per tutti, entra la corte.
E l’altra è la giustizia come la pensiamo noi, il senso di giustizia, quello che abbiamo da qualche parte tra il cuore e il duodeno, o il pancreas, che ne so, che ti fa dire: “oh, che ingiustizia!”, “Oh, ma questo non è giusto”.
Ecco, il bravo bandito, il rapitore migliore, è quello che ti porta lì.
Va bene il “Chi”, bello scoprirlo, bello indagarlo, elementare, Watson; ma noi lettori, noi rapiti grati al rapitore, vogliamo il “Come”, il “Perché”, soprattutto il perché.
Che ci sia il Bene, che ci sia il Male, c’è scritto in copertina, nella collana di questo o quell’editore, nel nome dell’autore. E’ un giallo, gente, ovvio che qualcuno si farà male.
Ma il perché il Male fa male e il bene cerca di metterci una pezza e di punirlo, e di beccarlo, devi cercarlo dentro.
Ecco, dentro quelle intercapedini lì, in quelle fessure, in quelle spaccature del terreno, cascano, o inciampano, o scivolano senza volere, le vite degli altri che ci interessa leggere, i mondi in cui veniamo rapiti, i perché di tutto.
E’ quando si verifica questo incontro tra la trama tessuta dal bandito e la voglia di sapere, di capire del lettore, che il famoso patto viene rispettato.
E’ una specie di mesmerismo, di magia. Con i suoi trucchi o le sue sfide, con i suoi, “Dai, su, vieni a vedere cosa succede qui, vieni a scoprire questo fatto incredibilmente strano”, lo scrittore ti ha preso, e ora che sei dentro è tutto diverso.
Sì, sì, va bene, non facciamola lunga, sei sempre tu, sei sempre in treno, in poltrona, sul letto, su una panchina col tuo libro in mano, e intanto però sei anche al gran ballo dell’ambasciata, o su e giù per le Langhe con la mitraglia in spalla come Johnny o Milton. Sei sempre tu, certo, ma non sei mica tu. Sei sempre lì, ovvio, ma non sei mica lì, magari sei a Madrid e non hai voglia di tornare a casa, e bevi in un posto pulito, illuminato bene, oppure sei nella tua villa bellissima e guardi dall’altra parte del lago e vuoi vedere la luce verde, che non vedrai.
O sei un qualsiasi Buendìa a scelta… e allora, come dice Marquez, ecco che succede qualcosa:
L’aria aveva una densità ingenua, come se l’avessero appena inventata.
Meraviglia! E’ questo leggere? E’ questo scrivere? Posso cavarmela dicendo che non lo so?
Posso dire che leggendo Zola a un certo punto ho amato monsieur Saccard, e pur sapendo che il disastro sarebbe arrivato, sicuro come l’oro, anch’io non avrei venduto le azioni dell’Universale, che anch’io puntavo al rialzo, al corso di tremila franchi, alla finanza che conquista il mondo, alla speculazione? Che imbecille, vero?
E non vi dirò di quella volta che mi fermai a fare benzina e finii per ammazzare il marito di lei, per pura passione di lei, roba da matti, col postino che continuava a suonare.
O di quando ho capottato con la macchina in mezzo alla neve e mi ha salvato una lettrice – proprio una lettrice – e mi ha rapito lei, questa volta, prendendomi a martellate perché quella scema di Misery non doveva morire.
E poi quando siamo andati a fare la Resistenza sulle montagne e a catturare fascisti da scambiare col nostro amico solo perché ci dicesse, poi, alla fine di tutto, cosa c’era davvero, esattamente, tra lui e Fulvia. Tutti qui seduti abbiamo detto almeno una volta nella vita insieme al Milton di Fenoglio:
Fulvia, a momenti mi ammazzavi!
Ecco, ho finito senza dire niente, perfetto, giusto così.
Sapete cosa c’è scritto sulla tomba di Leonardo Sciascia, a Recalmuto? C’è scritto:
Ce ne ricorderemo, di questo pianeta.
Accidenti.
E’ vero. Ce ne ricorderemo, e non solo della vita nostra – che ovviamente rivedremo tutta come un film, che cazzata – o dei vicini, degli affetti, degli amori, degli amici, dei figli. Ma ci ricorderemo sempre anche di altri che stanno, che stavano, in questo pianeta. I banditi delle parole, quelli che ci hanno rapito e portato con loro chissà dove, in mezzo alla campagna inglese, nella steppa, nella giungla, in macchina a Palm Springs con un’avventuriera bella da mozzare il fiato, a sparare a qualcuno, o esserne sparati, e in tutti quei posti dove siamo stati a vedere gente che cascava nelle intercapedini, nelle fessure, nei crepacci.
Da lì, abbiamo preso anche quello che siamo, non tutto, ma un bel po’.
Ce ne ricorderemo, di questo pianeta.
Sì, sì, sicuro.
L’ho letto da qualche parte.
(Roma, Basilica di Massenzio, Festival Letterature, 26 giugno 2017)
Qui la recensione per Tutto Libri dei nove racconti di Mark Haddon, “I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura” (Einaudi)
 Se vi chiedete perché diavolo qualcuno leggendo un libro sotto l’ombrellone dovrebbe prendersi paura – ma paura vera – siete nel posto sbagliato. Mentre invece siete nel posto giusto, giustissimo, se pensate che la dissezione del Male, la sua descrizione quasi cronachistica, chirurgica, implacabile e feroce sia qualcosa di prezioso; e allora questo “I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura” di Mark Haddon vi conforterà (si fa per dire, non c’è niente di confortante o confortevole, anzi).
Se vi chiedete perché diavolo qualcuno leggendo un libro sotto l’ombrellone dovrebbe prendersi paura – ma paura vera – siete nel posto sbagliato. Mentre invece siete nel posto giusto, giustissimo, se pensate che la dissezione del Male, la sua descrizione quasi cronachistica, chirurgica, implacabile e feroce sia qualcosa di prezioso; e allora questo “I ragazzi che se ne andarono di casa in cerca della paura” di Mark Haddon vi conforterà (si fa per dire, non c’è niente di confortante o confortevole, anzi).
Mark Haddon, inglese di Northampton, che vive a Oxford, classe 1962, è quello del successo mondiale “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, insomma, uno di quegli autori attesi, di cui il lettore si chiede: “vediamo un po’ dove va a finire ‘sto tizio”. E a giudicare da questi nove tesissimi racconti, tirati come funi sul precipizio, dove andrà il narratore Haddon ancora forse non lo sappiamo (meglio, potrà sorprenderci di nuovo), ma sappiamo bene dove ha portato noi: in un territorio in cui la ferocia del vivere è descritta senza orpelli che ne smussino gli angoli, in cui la morte è una cosa implacabile e per nulla affascinante. Anzi puzza, ferisce, annienta.
Si comincia con il crollo del pontile su una spiaggia della Manica e già si capisce a cosa si va incontro. Il racconto ha la calma frenetica, o la frenesia apparentemente didascalica, dell’emergenza in corso, le descrizioni sono spaventose, il ritmo è scandito – l’orrore supplementare è che cominciamo ad esserci abituati – dal passare delle ore e dal conto delle vittime. Ogni vita è a sé, ogni morte è a sé, sembrerebbe la cosa meno letteraria del mondo, e invece.
Sospesi tra la quotidianità del disagio e dell’emarginazione (Bunny, La pistola, Respira) e l’esotismo d’avventura (il racconto che dà il titolo alla raccolta), addirittura tra la fantascienza (La lupa e il picchio) e l’impasto mitologico (L’isola), i racconti di Haddon, tutti e nove, brillano per un particolare che non è un dettaglio. C’è pochissima, quasi niente, di quella pietà preconfezionata che troviamo nei libri al cospetto della disgrazia, dell’inizio della fine, del cedimento strutturale del vivere. E se il crollo del pontile sembra scandire come un cronometro le tappe veloci del disastro, lo stesso pare accadere alle vite dei vari personaggi. Struggente ma raggelante, per esempio, la discesa agli inferi di Bunny, il grassissimo ragazzo di periferia alle prese con la sua solitudine e la sua stazza, che crede di trovare l’amore (e chissà, magari lo trova) per venirne ucciso. Oppure il gorgo – giù nel cesso – in cui finisce la vita di Gavin (in Selvatico), borghese di successo che ammazza uno sconosciuto la notte della vigilia di Natale, e da lì parte la sua fine. O ancora lo strabiliante, agghiacciante realismo con cui si descrive il ritorno a casa di Carol, il suo impatto con il disagio e il lasciarsi andare della vecchia madre, un dis egno dolorosissimo dell’oggi (o del domani: saremo vecchi, saremo poveri, saremo abbandonati) che a dispetto del finale onirico-lovecraftiano, fornisce, anche, uno spaccato sociale precisissimo, dolente, attuale.
egno dolorosissimo dell’oggi (o del domani: saremo vecchi, saremo poveri, saremo abbandonati) che a dispetto del finale onirico-lovecraftiano, fornisce, anche, uno spaccato sociale precisissimo, dolente, attuale.
Ogni storia di questa raccolta mette il lettore davanti a uno scivolo, quello dove possono finire le vite – le vite di chiunque, si direbbe – quasi senza preavviso e sempre senza remissione. E forse non è un caso che i racconti più riusciti siano quelli ambientati qui e ora, nelle periferie inglesi così simili alle periferie di tutti, nei casermoni brutti, nei prati non falciati, nei ragazzini sottoproletari che se ne vanno in giro con una pistola tra le tangenziali e i boschi dei suburbi, nell’uomo sconfitto che sente di invecchiare in solitudine, muoiono i cani, la vita scivola verso la fine dello spettacolo.
Sarà che Haddon ha l’età giusta per avere respirato quell’aria tanto tempo fa, oppure sarà che certe ambientazioni proletario-britanniche portano direttamente a quei luoghi, ma si sente nello scrivere di Haddon il respiro No-future che ebbe il punk più devastante, quell’attrazione per il Male senza redenzione e al tempo stesso quella contemplazione del degrado che fece di quella poetica un manifesto – anche estetico – della sconfitta eternamente in agguato.
 Colpo di scena, tutti stupiti che ci sia ancora la destra. Grandi oh! di sorpresa, analisi messe su in fretta e furia per spiegare il contrario di quello che si era spiegato fino al giorno prima. Questo ci ricorda due cosette da nulla: la prima, il blocco sociale della destra c’è, esiste, non se n’è mai andato. La seconda, i voti di destra che Matteo Renzi aveva programmaticamente detto di voler attrarre (testuale: “Se con i nostri voti abbiamo non vinto, per vincere davvero i voti li andiamo a cercare di là”) non sono arrivati, non arrivano mai, preferiscono l’originale, seppur sbiadito, alla copia, com’era prevedibile (e come si è ripetuto fino alla nausea, avendone sempre in cambio sberleffi e contumelie, vabbé).
Colpo di scena, tutti stupiti che ci sia ancora la destra. Grandi oh! di sorpresa, analisi messe su in fretta e furia per spiegare il contrario di quello che si era spiegato fino al giorno prima. Questo ci ricorda due cosette da nulla: la prima, il blocco sociale della destra c’è, esiste, non se n’è mai andato. La seconda, i voti di destra che Matteo Renzi aveva programmaticamente detto di voler attrarre (testuale: “Se con i nostri voti abbiamo non vinto, per vincere davvero i voti li andiamo a cercare di là”) non sono arrivati, non arrivano mai, preferiscono l’originale, seppur sbiadito, alla copia, com’era prevedibile (e come si è ripetuto fino alla nausea, avendone sempre in cambio sberleffi e contumelie, vabbé).
La mucca in corridoio di Bersani ora è una mandria, difficile non vederla. E in più, per restare alla metafora, c’è qualche maiale in cucina.
Tipo gli eletti di Casa Pound, per dire, o la lista Fasci Italiani del Lavoro che prende il 10 per cento in un paesino vicino a Mantova con tale Fiamma Nerini, 20 anni, ragioniera. Consiglio un viaggetto tra le pagine Facebook sue (ma ora le ha chiuse), del padre Claudio Negrini, fondatore del movimento, e del movimento stesso, posti dove si festeggia la presa di Addis Abeba, per dire dell’aderenza al presente e dell’odore di olio di ricino.
Come sia possibile che l’immagine di un fascio littorio compaia su un simbolo elettorale, venga stampato su una scheda e addirittura votato da 334 persone che nel caldo afoso della bassa hanno scelto una granita alla merda, è una cosa che dovrebbe spiegarci il ministero degli Interni. Si vede che la battaglia per il decoro non è ancora arrivata alle schede elettorali e si limita ai diseredati.
Naturalmente si può minimizzare, archiviare tutto come marginalità folkloristica, cavarsela con l’irrisione della macchietta, sorridere davanti alle cartoline del Ventennio, cose che in effetti qualche risata la strappano. E però i segnali si moltiplicano, le barzellette in orbace si affacciano alle cronache sempre più spesso, al punto che passa la voglia di sghignazzare. La torta con la svastica con cui Casapound di Lodi ha festeggiato il compleanno di un suo dirigente è piuttosto indicativa. Risultano le allarmate proteste delle comunità ebraiche italiane e poco altro, come se ci si trovasse al cospetto di un cretino che si veste da Uomo Ragno o una goliardia da gente che ha studiato poco. Insomma, si lascia correre (non risulta sia arrivata la polizia, ecco). A Roma, i cartelli contro i negozi stranieri affissi dai bellimbusti di Azione Frontale (urca!) sono passati via come una bravata. Anche lì non risultano retate. A Milano, città Medaglia d’oro della Resistenza, un manipolo di
Lealtà Azione ha pensato bene di andare al Cimitero Maggiore a fare il saluto romano ai camerati defunti. Gli stessi che qualche giorno dopo hanno partecipato a un’iniziativa (contro la pedofilia, andiamo, chi non è contro?) che ha ottenuto il patrocinio del municipio 7 della città. Dunque, ci è toccato pure vedere il logo dei filonazi accanto a quello del Comune, che si è poi fortunatamente – e dopo molte proteste – dissociato. E questo senza contare i periodici spettacolini con labari e gagliardetti, o i concerti dove si canta di difesa della razza.
Si sa che i paragoni storici valgono quello che valgono, l’Italia non è Weimar, una ragioniera della pianura mantovana non è un pittore austriaco coi baffetti da pirla, quelli che tagliano la torta con scritto Sieg Heil! non invaderanno la Polonia, d’accordo. Però si sappia che il virus è in circolo, che quotidianamente si infrange la legge inneggiando alle peggiori pagine della nostra storia, e che chiudere un occhio, anche due in certe occasioni, non ha frenato il fenomeno. Che il maiale in cucina, insomma, puzza un bel po’.
Qui c’è la bella intervista che mi ha fatto Rossana Maspero per Millevoci della Radio Svizzera Italiana. Grazie (mp3)
 La parrucca canuta e la barba finta sono già state consegnate a Ringnano sull’Arno, pronte per l’uso. Nel caso clamoroso che Jeremy Corbyn riesca nell’impresa di vincere le elezioni inglesi, Matteo Renzi è pronto a trasformarsi nel Corbyn italiano, dopo essere stato il Valls italiano, l’Obama italiano, il Marcon italiano e altro ancora. Già si affacciano timidamente su twitter i primi segnali della nuova trasformazione, per ora soltanto sottoforma di esternazioni “simpatiche” di portavoce ed esperti di comunicazione (!). Non che stupisca la coerenza ad assetto variabile: sono passati solo due anni (elezioni inglesi del 2015) da quando gli stessi strateghi renzisti spiegavano la sconfitta del timidissimo e conservatorissimo candidato Labour Miliband con un esilarante: “ha perso perché troppo di sinistra”. Ora che Corbyn (che è di sinistra davvero) rischia di vincere, o comunque di prendere più voti del suo predecessore, ecco in rampa di lancio il nuovo travestimento. Il vocabolario politico andrebbe aggiornato: più che trasformismo, qui si tratta di applicare la dottrina Fregoli: più cambi d’abito in pochi minuti.
La parrucca canuta e la barba finta sono già state consegnate a Ringnano sull’Arno, pronte per l’uso. Nel caso clamoroso che Jeremy Corbyn riesca nell’impresa di vincere le elezioni inglesi, Matteo Renzi è pronto a trasformarsi nel Corbyn italiano, dopo essere stato il Valls italiano, l’Obama italiano, il Marcon italiano e altro ancora. Già si affacciano timidamente su twitter i primi segnali della nuova trasformazione, per ora soltanto sottoforma di esternazioni “simpatiche” di portavoce ed esperti di comunicazione (!). Non che stupisca la coerenza ad assetto variabile: sono passati solo due anni (elezioni inglesi del 2015) da quando gli stessi strateghi renzisti spiegavano la sconfitta del timidissimo e conservatorissimo candidato Labour Miliband con un esilarante: “ha perso perché troppo di sinistra”. Ora che Corbyn (che è di sinistra davvero) rischia di vincere, o comunque di prendere più voti del suo predecessore, ecco in rampa di lancio il nuovo travestimento. Il vocabolario politico andrebbe aggiornato: più che trasformismo, qui si tratta di applicare la dottrina Fregoli: più cambi d’abito in pochi minuti.
Dai vapori delle strategie elettorali che scaldano i motori comincia a distinguersi un vecchio, caro ritornello, una cosa che si è conficcata nelle orecchie degli italiani come quelle canzoncine pop che ci allietano l’estate e che fischiettiamo anche se ci sembra di non averle mai ascoltate davvero. Insomma, ecco che s’avanza la solita tiritera del “voto utile”, dove “utile” si può tradurre che bisogna darlo al Pd.
Più la pattuglia alla sinistra di Renzi (non che sia difficile stare alla sinistra di Renzi, eh!) si avvicinerà minacciosa alla soglia del 5 per cento, più i toni si faranno suadenti, disponibili, accomodanti. In pratica, se il Pd renzizzato si renderà conto che può avere un’emorragia di voti a sinistra, più il blogger di Rignano dovrà organizzare uno dei suoi travestimenti più arditi: fingersi di sinistra pure lui, addirittura lui. Non so se TiketOne vende già i biglietti, ma ne voglio un paio di prima fila, perché lo spettacolo sarà imperdibile.
Fin’ora la strategia semantica della cordata che ha conquistato il Pd è stata abbastanza semplice: vendere come “di sinistra” provvedimenti ultraliberisti e cancellazione di diritti. Un gioco di prestigio che ha funzionato soltanto per qualche mese e poi si è sciolto come un gelato nell’altoforno: prima qualche elettore, poi molti, poi un paio di milioni, si sono accorti che scrivere la legge sul lavoro insieme a Confindustria e andare in giro a dire che si tratta di una legge di sinistra era una discreta presa per il culo. Che abbracciare il “modello Marchionne” non era proprio una cosa geniale. Che farsi periodicamente salvare da Verdini non era esattamente nel dettato teorico gramsciano. Che cancellare la tassa sulla prima casa anche ai cumenda con villa di diversi ettari non era precisamente una lotta alle diseguaglianze.
Ora si apre un periodo, assai divertente, di bastone e carota. La linea è già tracciata: da un lato screditare l’avversario (definire “sinistra radicale” una formazione che ha come riferimento Pisapia è semplicemente ridicolo), dall’altra gettare brioches al popolo, fingersi dialoganti, archiviare il vecchio arrogantissimo (e scemo) “ciaone” per sfoderare un grottesco “compagni, parliamone”. Insomma, quello che da anni si allea con Berlusconi, che concorda con lui fallimentari riforme, che inventa con lui leggi elettorali incostituzionali, verrà a spiegarci che è colpa della sinistra se alla fine farà un governo con Berlusconi. Per cui consiglio di preparare i fazzoletti: il “Renzi-torna-di-sinistra-show” sarà uno spettacolo circense di grande presa, più dell’uomo cannone, più della donna barbuta, più delle magliette gialle al terremoto. Venghino, venghino, portate i pop-corn.
Qui c’è la recensione dell’antologia Viaggiare in Giallo di Antonio D’Orrico su La Lettura del Corriere della Sera
 Ho il timore che si studieranno per anni, specie nelle facoltà di psichiatria e nei centri per il disagio comportamentale, gli effetti di una campagna elettorale estiva sul popolo italiano. Il tasso di litigiosità, già altissimo, supererà le soglie di allarme rosso, il caldo ecciterà gli animi, basterà occhieggiare in spiaggia il vicino d’ombrellone con le infradito “Vota Alfano” per fomentare terribili faide sul bagnasciuga. I primi stambecchi con scritto “Vota Silvio” avvistati dai turisti sulle Dolomiti creeranno scandalo e indignazione, ma anche molta invidia tra gli avversari, che tenteranno di scrivere “Vota Matteo” sulle vongole, un lavoraccio di cui sarà incaricato Orfini.
Ho il timore che si studieranno per anni, specie nelle facoltà di psichiatria e nei centri per il disagio comportamentale, gli effetti di una campagna elettorale estiva sul popolo italiano. Il tasso di litigiosità, già altissimo, supererà le soglie di allarme rosso, il caldo ecciterà gli animi, basterà occhieggiare in spiaggia il vicino d’ombrellone con le infradito “Vota Alfano” per fomentare terribili faide sul bagnasciuga. I primi stambecchi con scritto “Vota Silvio” avvistati dai turisti sulle Dolomiti creeranno scandalo e indignazione, ma anche molta invidia tra gli avversari, che tenteranno di scrivere “Vota Matteo” sulle vongole, un lavoraccio di cui sarà incaricato Orfini.
Nelle redazioni dei talk show è il panico. Gente che è arrivata alla fine di maggio sui gomiti, trascinandosi con la lingua fuori per le cazzate sentite e trasmesse in inverno e primavera, si vedrà annullare ferie e permessi: tutti in onda a ferragosto! Per portare il pubblico plaudente negli studi televisivi si rastrelleranno gli anziani nel centri commerciali. Prime stime delle falangi della propaganda: i Cinque Stelle quasi padroni assoluti in campeggi e spiagge libere, fastidiosi come testimoni di Geova, pronti all’evangelizzazione delle coste. I renzisti in fila nelle città d’arte, o appostati ai caselli autostradali intasati, intenti a spiegare ai viaggiatori che se avesse vinto il Sì la coda non ci sarebbe. I berlusconiani, anzianissimi, in decorose pensioncine, destinati ad incontrarsi con pensionati del Pd sulla battigia, agevolando il colpo di sole che li convincerà di essere in fondo fratelli, e benedire le larghe intesa già conclamate.
La promessa elettorale cambierà la sua natura, i programmi scoloreranno come il giornale lasciato sul parabrezza sotto il sole, a quaranta gradi. Cambiano le priorità, insomma. Va bene il welfare e le pensioni, ok, buoni argomenti. Ma a un certo punto, in macchina a sessanta gradi all’ombra, con i bambini che frignano e la spia dell’acqua accesa, sarete disposti a votare chiunque vi trovi un posto auto vicino al mare a Gallipoli.
Ci saranno innumerevoli problemi di linea politica. La svolta animalista di Berlusconi si applicherà anche al fritto di pesce o resterà circoscritta gli agnellini per farsi la foto a Pasqua? Michela Brambilla perorerà la causa dei pescespada? E Matteo da cosa si travestirà questa volta? Nel caso in Gran Bretagna dovesse vincere Corbyn (i sondaggi sono sorprendenti) si presenterà come il Corbyn italiano? O continuerà a recitare la parte del Macron italiano? O girerà per gli stabilimenti balneari presentandosi semplicemente come il Renzi italiano? (in questo caso mi porterei la scorta). Dramma per i leghisti. Sceglieranno le spartachiadi di polenta nei rifugi alpini dove credono di giocare in casa, o si spingeranno al Sud in omaggio alla linea salviniana di farsi prendere a pomodori sotto la linea gotica per poi fare le vittime?
E la sinistra, riuscirà a mettere d’accordo le sue millemila formazioni per superare l’assicella del cinque per cento adottata proprio per farla fuori, insieme ad Angelino buonanima?
Il combinato disposto campagna elettorale/sagre paesane aggiungerà delirio a delirio. Sarà un tripudio dada-ideologico tra festivalini improvvisati, feste della birra riformista, miss maglietta gialla bagnata, microconvegni in bermuda e crema solare su “i destini dell’Europa”, seminari sulla decrescita felice, arruolamenti in massa di venditori di cocco fresco, gazebo torridi, comizi negli autogrill. Sarà un inferno e al tempo stesso una spettacolare sagra della demenza, l’allegria dei naufragi, la fiera degli endorsement strappati all’intellettuale, all’attore, al cantante, allo scrittore mentre affettano il cocomero, in ciabatte e occhiali scuri, destituiti di ogni autorevolezza nell’assurda estate del nostro scontento.
Tutto Libri de La Stampa mi ha chiesto un “Diario di scrittura”. Qui si spiega com’è nato Carlo Monterossi e tutto quello che, più o meno, gli gira intorno…
 Caro direttore, amici lettori, autorità competenti.
Caro direttore, amici lettori, autorità competenti.
Vorrei attirare la vostra attenzione su una mia teoria che ogni giorno si dimostra più fondata e che dovrebbe allarmare tutti. Qualcuno ha sciolto dell’acido negli acquedotti, non c’è altra spiegazione. Il tono del dibattito pubblico, i suoi argomenti, le decisioni prese in seguito o sull’onda di quello che si dice al bar o alla fila alla posta (o che ha scritto su Facebook mio cugggino) sembrano meno lucide di un assaggiatore del Narcos o di un chitarrista rock degli anni Settanta.
L’ultimo esempio è il complicato affaire dei vaccini, un argomento importante che è stato trasformato (credo dopo massiccia assunzione di Lsd dai rubinetti) in una guerra tra untori medievali millenaristi vogliosi di strage per malattia e un esercito di crocerossini inventori della penicillina. Ogni voce sensata o ragionevole, da una parte e dall’altra, è stata zittita. Un dibattito sui vaccini da somministrare ai bambini è diventato la caricatura di uno scontro ideologico. Risultato, per non saper né leggere né scrivere: il decreto fatto in fretta e furia, pieno di buchi e di incertezze, spropositato rispetto a quello che le strutture sanitarie e scolastiche potranno fare. Se va bene sarà un casino indicibile, con in più l’introduzione di un classismo sanitario ripugnante: chi è contrario potrà continuare a essere contrario pagando, chi non potrà pagare dovrà essere d’accordo.
Come del resto è successo coi voucher: per paura di prendere un’altra sberla in un altro referendum, zac, via tutti. Non una soluzione, ma una decapitazione, tipo abbattere la casa perché hai bruciato l’arrosto. Credo che i primi sversamenti di acido lisergico negli acquedotti del Paese siano cominciati all’Expo, quando ci si divideva tra “lo straordinario successo” e il “flop clamoroso e costoso”. Oggi che si potrebbe andare a controllare gli effetti di quel “miracolo” (per esempio se ci sono i tanti punti di pil in più promessi, o le migliaia di posti di lavoro creati che no, non ci sono), addio, tutto perdonato, tutto dimenticato, ci sono altre priorità.
Alte concentrazioni di acido nella capitale ovvio. Prima il derby a testate tra olimpici e non-olimpici, poi tutti esperti di costruzione di stadi e marketing urbano, poi fotografatori di monnezza traboccante dei cassonetti (o di cassonetti lindi come a Zurigo centro, per contrastare con una cazzata altre cazzate). Politici o presunti tali vanno in tivù a dire di bambini uccisi dai topi. Saviano dice il suo pensiero sul Pd, eccolo accusato di grillismo, Saviano dice qualcosa contro Grillo, eccolo ri-arruolato, “uno di noi”. De Bortoli era un bravo e attendibile giornalista e diventa una specie di punkabbestia fissato con le scie chimiche. Gli stessi che menavano fendenti su “voi votate con Salvini” al referendum sulle riforme costituzionali, ora discutono una legge elettorale che piace solo a loro e a Salvini. Senza nemmeno sapere di che si parla si prendono le misure sull’avversario: se un Di Maio ha detto bianco io devo dire nero, se Renzi ha detto nero io devo dire bianco, la realtà dei fatti è un dettaglio trascurabile sullo sfondo. Arrivano le cifre del Jobs act – oggettivamente un disastro – ed ecco pronto il ribaltamento: senza sarebbe stato peggio. Però si può sparare al ladro. Quelli che dicevano no, no, non siamo mica in Texas ora dicono, bene, giusto, la sicurezza! Ma solo di notte. Molti ridono.
Tutto questo senza il minimo rossore né vago imbarazzo, come fosse normale vedere gli elefanti rosa, come se il Paese fosse una enorme Woodstock della scemenza collettiva, tutti a tirare mutande e reggiseni sul palco in omaggio a questa o quella star dei due schieramenti, indipendentemente da quello che sta suonando. Date retta: c’è acido negli acquedotti. Non c’è altra spiegazione.
 Ecco del buon materiale su una cosa di cui si parla sempre quando si presenta Torto marcio e si chiacchiera con i lettori: com’è raccontata Milano? Tu come la racconti? E’ una domanda che mi piace (sì, la narrazione corrente, un po’ ideologica su “Milano capitale morale” è falsa e cieca, oltre che un po’ ridicola), ma anche difficile, perché la città, la società in cui la storia si svolge, non è uno scenario in cartone, è roba viva, vera, che accade veramente, non un trucco narrativo.
Ecco del buon materiale su una cosa di cui si parla sempre quando si presenta Torto marcio e si chiacchiera con i lettori: com’è raccontata Milano? Tu come la racconti? E’ una domanda che mi piace (sì, la narrazione corrente, un po’ ideologica su “Milano capitale morale” è falsa e cieca, oltre che un po’ ridicola), ma anche difficile, perché la città, la società in cui la storia si svolge, non è uno scenario in cartone, è roba viva, vera, che accade veramente, non un trucco narrativo.
Come sa chi l’ha letto, parte di Torto marcio si svolge nelle case popolari Aler intorno a piazza Selinunte, che è un universo a sé. Si parla, nel libro, di un racket di case popolari, di occupazioni controllate da un’associazione a delinquere (nel libro sono calabresi), di disperati che vogliono un tetto sulla testa e che si rivolgono ai delinquenti perché nessun altro glielo dà. Ieri si è conclusa a Milano un’operazione di polizia, proprio in quelle case, in quelle vie, e si è scoperto un racket degli alloggi popolari (erano egiziani, non calabresi…) esattamente identico a quello descritto in Torto marcio.
Io l’avevo detto, insomma. Ma non è questa la cosa importante (lui l’aveva detto, e chissene…). Mi sembra più interessante che si sveli quello che dice, in fondo Torto marcio. Attenti, a pochi metri dalla città scintillante che state raccontando c’è questo. Si legge e si sa solo in presenza di qualche caso di cronaca nera, indagini, arresti. Ma quelli, i dannati della terra che abitano lì, i vecchi poveri, gli immigrati poveri, stanno lì tutto l’anno, tutti i giorni. Le diseguaglianze aumentano (altra coincidenza, l’ha detto ieri il rapoorto Istat, altro caso in cui posso dire io l’avevo detto, non che ci volesse molto, lo diciamo in tanti, da tempo).
Grazie a Repubblica che si è accorta di un libro uscito da poco e che racconta quello che succedeva lì prima che arrivassero legge & giustizia. Ma io lo so, e lo dico: passata la buriana, finite le indagini, tornata la calma, laggiù, alle case Aler di San Siro e ovunque le diseguaglianze mordono la gente, tutto tornerà come prima.
I riflettori torneranno sulle belle vetrine, la moda il design. Milano.
Ora che Roma è linda, pulita e scintillante grazie alle montagne di rifiuti raccolte da Matteo Orfini e dai suoi boys in maglietta gialla, si può passare ad altro: le frontiere della propaganda sono mobili e veloci. Via, si passa al terremoto, inteso come opportunità di marketing.
La chiamata alle armi viene direttamente dal Capo Renzi, su Facebook, appello accorato e ordine di mobilitazione. L’adunata è per tutti i militanti, dai deputati in giù, che andranno (cito il sacro testo) “Ognuno in un Comune diverso di quelli colpiti dal sisma”. A fare che? “Ad ascoltare, a fare il punto, a portare la testimonianza di un impegno concreto”. Insomma, niente ramazze, stavolta dovrebbero bastare le orecchie. Il Pd vuole “ascoltare” i bisogni delle popolazioni terremotate del centro Italia.
La stampa nazionale, almeno ieri, ha fatto finta di non sentire. Se si va a leggere la stampa locale, però, i commenti all’iniziativa “magliette gialle al terremoto” vanno dall’incredulità all’insulto fiero e contadino di quelle terre. Gente che si firma con nome e cognome, moltitudine di cittadini in forte disagio, non ascrivibili certo alla canea dei troll della rete.
Ma riassumiamo: Il Pd siede al governo con preminentissima posizione di comando. Il commissario straordinario al terremoto, Vasco Errani, è stato nominato da Renzi. Le quattro regioni colpite dal terremoto sono governate dal Pd. Decine e decine di comuni colpiti hanno sindaci del Pd, spessissimo brave persone che dall’agosto scorso lavorano giorno e notte per i loro cittadini messi in ginocchio dal sisma.
E con tutte quelle orecchie in loco, ora ecco che si indossa la maglietta gialla e si va “a ascoltare”.
Strabiliante. Matteo Renzi ci sta dicendo che non basta governare un territorio (regioni, comuni, frazioni) per conoscere la situazione dei cittadini che ci vivono. Bisogna andare lì in divisa (gialla) a “fare il punto”. Propaganda offensiva, per chi sta lì, uno sberleffo, uno schiaffo.
Per agevolare nella trasferta i deputati del Pd chiamati all’appello, possiamo consigliare qualche luogo d’interesse in zona. Vadano per esempio negli alberghi sulla costa, dove migliaia di persone sono state ospitate perché non gli si volevano dare container, ma le famose casette, che non arrivano, quando arrivano vengono sorteggiate. E ora che gli albergatori della costa rivogliono le stanze, che parte la stagione, i cittadini terremotati sono costretti a nuove diaspore tra campeggi e famiglie divise qua e là. Per il pranzo consiglio un ristorante di Pieve Torina, il Vecchio Mulino, che ha tenuto aperto tra mille eroici sforzi per sfamare soccorritori e operatori della protezione civile servendo migliaia e migliaia di pasti, indebitandosi perché lo Stato non paga la convenzione. Se piace la montagna, visitare Amandola, specie l’ospedale. Oppure Ussita, posto bellissimo, dove il sindaco si è dimesso perché dice che lì non si ricostruirà più. Oppure andare a comprare strepitosi formaggi da quegli allevatori che già a fine agosto di un anno fa dicevano: occhio che nevicherà, non abbiamo le stalle. Lo dissero per mesi, videro le bestie morire al gelo, gli appelli inascoltati. Ecco, chissà loro che faccia faranno vedendo delle “magliette gialle” che vanno “ad ascoltare”.
Ora è chiaro che viviamo una perenne campagna elettorale fatta di colpi di sceneggiate, trovate propagandistiche, alzate d’ingegno, e va bene. Ma scherzare con gente che dorme a 50-80 chilometri da dove lavora, che non sa dove dormirà tra una settimana o tra un mese, che un lavoro magari non ce l’ha più, che si rimette in piedi la stalla con le sue mani, che aspetta la casetta promessa per Natale, poi per primavera, poi per mai, ecco forse è un po’ troppo. Meglio fermarsi, se non per opportunità politica, almeno in nome della decenza.
 Tutto pronto per le finali di M Factor, il talent che incoronerà il Macron italiano. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Istituto Zelig, presenta le schede dei concorrenti che si esibiranno nei prossimi giorni. Sarà una gara dura ma corretta, ecco i partecipanti.
Tutto pronto per le finali di M Factor, il talent che incoronerà il Macron italiano. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Istituto Zelig, presenta le schede dei concorrenti che si esibiranno nei prossimi giorni. Sarà una gara dura ma corretta, ecco i partecipanti.
Salvatore Macron – Pizzaiolo a Posillipo, mostra sul palco la sua camminata elastica e il sorriso da sciupafemmine finto-timido. Nel discorso di candidatura ricorda la sua famosa pizza cozze- polenta, simile all’equazione Flessibilità-Europa del presidente francese. Poche chances di vittoria, ma una naturale simpatia che forse gli varrà una candidatura nel Pd, dove però dovrà fingersi toscano.
Matteo Macron – E’ il vero favorito. Ha già vinto molti talent tra cui B Factor (il Blair italiano), O Factor (l’Obama italiano, senza cravatta), V Factor (il Valls italiano, per l’occasione in camicia bianca), C Factor (il Cameron italiano, giacca blu), e altri li ha persi malamente (R Factor, il Referendum italiano). Al contrario di Macron ha alle spalle un partito, ma sta facendo di tutto per ucciderlo. Difficile la collocazione politica: come Macron è fortemente liberale, tranne al giovedì alle dalle quattro alle cinque in cui si finge laburista mentre fa pilates. Fortemente europeista quando conviene, toglie le bandiere dell’Europa quando non conviene. Qualche difetto nel suo discorso di candidatura quando ha citato i grandi pensatori che hanno influenzato il suo pensiero: La Pira, Mazinga, Baricco, Giucas Casella, Marchionne e Paperoga. Evitasse calembours e giochi di parole scemetti potrebbe avere qualche possibilità.
Federico Macron – Di lui si sa pochissimo, se non che è molto giovane, che è entrato nella direzione del Pd perché è molto giovane, e che crede che il colore del 25 aprile sia il blu, perché è molto giovane e non studia. Si definisce “quasi Millennial”, perché ha chiesto a papà 850 euro per andare a Milano a sentire il discorso di Obama. Un vero Millennial ne avrebbe chiesti mille.
Mario Macron – Già noto come Mario Monti, vanta molte analogie con il presidente francese, prima tra tutte l’essere stato acclamato come un salvatore della patria senza avere partiti alle spalle, ma solo banche. Di lui si ricorda il loden e quei pochi deputati di Scelta Civica o come diavolo si fanno chiamare adesso. Le sue chances sono ridotte dall’età avanzata e dal fatto non secondario che al solo vederlo gli elettori estraggono collane d’aglio e cornetti rossi, quindi a differenza di Emmanuel Macron e di Matteo Macron un po’ di rosso c’è.
Ursula Macron – Impiegata di banca di Vercelli, vanta molte analogie con il presidente francese: ha infatti un camera un poster della famiglia Rothschild, non è né di destra né di sinistra, non ha un partito alle spalle e sottolinea nel suo discorso una sincera passione per l’Europa di cui conosce una brasserie a Montmartre e le ramblas di Barcellona.
Enrico Macron – Secondo alcuni critici sarebbe il più vicino all’originale. Tra l’altro, insegna in Francia dopo essere stato sfrattato dal governo da un altro concorrente del talent, Matteo Macron. Purtroppo, posato e timido com’è, non partecipa alla gara, un po’ per modestia e un po’ perché, a differenza degli altri, non è mica matto.
Silvio Macron – Cabarettista nato, a suo agio sul palco, dice di aver già fatto quello che ha fatto Macron, cioè vincere con un partito creato in sette minuti. La sua conoscenza delle canzoni francesi degli anni Sessanta gli dà qualche chance, a cui si aggiunge il sincero odio per Matteo Le Pen. Nel suo discorso di candidatura però ha malamente tradotto lo slogan “En marche” con un rivelatore “Ci marcio”. E’ decisamente anziano, ma se potesse fondere tutte le fidanzate degli ultimi 20 anni in una sola donna, lei avrebbe 12.347 anni.
 Si riparte. Un nuovo inizio. In cammino. Pronti via. Il mood del nuovo Pd neo-renzianissimo che esce dalle primarie somiglia alle regole dell’hockey dove ci sono le espulsioni a tempo: fai un fallaccio, esci tre minuti e poi rientri. Perdi un referendum, stai fuori cinque mesi, poi torni in campo come un campione, tutto è perdonato, un poderoso reset cancella le gesta precedenti dell’eroe per darci un eroe nuovo di zecca. Un po’ come se Otello, strangolata Desdemona, se ne tornasse qualche mese a casa e poi dicesse: ok, rifacciamo la scena da capo! Nel Pd non si rifletterà troppo su certi trascurabili dettagli, per esempio sul fatto che il Renzi “di lotta” del 2013 prese 650.000 voti in più del Renzi “di governo” del 2017, ma insomma pare che le primarie del Pd vengano vendute come un lavacro delle passate sconfitte.
Si riparte. Un nuovo inizio. In cammino. Pronti via. Il mood del nuovo Pd neo-renzianissimo che esce dalle primarie somiglia alle regole dell’hockey dove ci sono le espulsioni a tempo: fai un fallaccio, esci tre minuti e poi rientri. Perdi un referendum, stai fuori cinque mesi, poi torni in campo come un campione, tutto è perdonato, un poderoso reset cancella le gesta precedenti dell’eroe per darci un eroe nuovo di zecca. Un po’ come se Otello, strangolata Desdemona, se ne tornasse qualche mese a casa e poi dicesse: ok, rifacciamo la scena da capo! Nel Pd non si rifletterà troppo su certi trascurabili dettagli, per esempio sul fatto che il Renzi “di lotta” del 2013 prese 650.000 voti in più del Renzi “di governo” del 2017, ma insomma pare che le primarie del Pd vengano vendute come un lavacro delle passate sconfitte.
Ora si vedrà come il partito dell’omino forte si getterà nella battaglia, anche se già un paio di solenni minace sono state pronunciate: si occuperà di scuola (una specie di recidiva) e sarà più presente in rete, il che significa una recrudescenza di quella stucchevole schermaglia fatta di sberleffi, troll, provocazioni, verità adattate alla bisogna , #ciaone, eccetera eccetera. Sarà uno spettacolo, non scordatevi i popcorn.
Qualche curiosità potrebbe ora suscitare la curvatura emotiva del nuovo storytelling renzista, cioè quell’impasto di retorica, trionfalismo quando si può, vittimismo quando serve, che abbiamo già conosciuto e che si è trasformato nel giro di tre anni da “novità comunicativa” ad auto-caricatura. L’ambiguità che abbiamo visto fin qui derivava essenzialmente dalla convivenza di due linee narrative: una rebelde e scapigliata (uh, che vecchiume!, arriva lui e vi sistema), e una celebrativo-rassicurante (va tutto benissimo, #italiariparte e consimili fregnacce). Logica vorrebbe che aver ristretto un po’ il partito e averlo modellato sulla figura del suo burbanzoso leader – l’omino forte, appunto – necessiti di una comunicazione se possibile ancor più aggressiva. Ma, alla lunga, il problema sarà un po’ più complesso. Il nuovo Renzi non potrà criticare troppo il passato, che è rappresentato dal vecchio Renzi e in gran parte dall’attuale governo, e al tempo stesso faticherà a crearsi nuovi nemici ad ogni passo: gli avversari ci sono, si conoscono, sono sempre gli stessi. Dopo Grillo, i bersaniani, D’Alema, il sindacato, l’Anpi, i costituzionalisti, l’accozzaglia, quelli “che dicono sempre no”, varie ed eventuali, il ragazzo ha, come dire, finito l’album: o si inventano nuovi marziani nemici del grande disegno renziano, oppure si è daccapo. In questo senso, la retorica già dispiegata sulla “ripartenza”, il nuovo inizio, il cammino suonano un po’ come il “riparti dal via” del gioco dell’oca. Sintesi: abbiamo perso tre anni per tornare daccapo, con un leader ambizioso e tendente a una caricatura di autocrazia e tutti gli altri cattivi fino a nuovo ordine, o finché non conviene il contrario. Ma il problema è che il grande disegno renziano non si sa cos’è. E’ il 25 aprile un po’ ridicolmente riverniciato da festa del’Europa, oppure l’orgoglioso leader nazionale che toglie le bandiere dell’Europa dall’ufficio? E’ quello che si batte come un leone contro l’aumento del’Iva, oppure quello che ne ha posto le basi con le clausole di salvaguardia che mise quand’era al governo? Quello che tratta Padoan come “un tecnico” (con annesso mascelluto disprezzo) o quello che lo fece ministro? E’ quello della #buonascuola miglior riforma possibile o quello che ora dice: affronteremo la questione della scuola? Insomma, le tattiche abbondano, la strategia non si vede, a meno che non si possa considerare strategia la solita solfa del trionfo di Matteo che prese meno di due milioni di voti nel 2013 e più di un milione oggi.
TuttoLibri mi ha chiesto di recensire il nuovo romanzo di Paula Hawkins… sì, quella de La ragazza del treno. Ecco qui
 Chi dice dodici, chi diciotto, chi arriva a venti, ma insomma, che Paula Hawkins abbia venduto milioni di libri con La ragazza del treno è noto, e che la signora stacchi ora un altro biglietto della lotteria è ampiamente annunciato. C’è attesa, dunque , e non solo per gli addicted del bestsellerismo estremo. Il fatto è che la Hawkins con quella sua storia al femminile avrebbe aperto – bene! – un filone dove donne sono quelle che raccontano e donne, quasi sempre, le vittime. Si legge dunque questo Dentro l’acqua (Piemme) un po’ per controllare l’evoluzione di un’autrice già salutata come caposcuola e un po’ per vedere se il gioco regge, e già la dedica in apertura (“A tutti i piantagrane”) promette bene.
Chi dice dodici, chi diciotto, chi arriva a venti, ma insomma, che Paula Hawkins abbia venduto milioni di libri con La ragazza del treno è noto, e che la signora stacchi ora un altro biglietto della lotteria è ampiamente annunciato. C’è attesa, dunque , e non solo per gli addicted del bestsellerismo estremo. Il fatto è che la Hawkins con quella sua storia al femminile avrebbe aperto – bene! – un filone dove donne sono quelle che raccontano e donne, quasi sempre, le vittime. Si legge dunque questo Dentro l’acqua (Piemme) un po’ per controllare l’evoluzione di un’autrice già salutata come caposcuola e un po’ per vedere se il gioco regge, e già la dedica in apertura (“A tutti i piantagrane”) promette bene.
Tutto si svolge in un paesino inglese, Beckford di cui a poco a poco conosceremo più o meno tutti gli abitanti. A Beckford c’è un fiume (non se ne fa mai il nome, è sempre “il fiume”) dove pare la gente faccia il bagno estate e inverno, giorno e notte, con tutto che l’Inghilterra non è mica ai Caraibi. A un certo punto il fiume fa un’ansa e forma uno stagno, lo Stagno delle Annegate. Tutto questo ce lo racconta la prima voce narrante, Jules (in realtà Julia) che arriva in paese perché la sorella Nel è caduta proprio nello Stagno delle Annegate da un’altissima rupe, una di quelle altezze da cui, all’impatto, anche l’acqua pare cemento. Si è buttata? L’hanno buttata? Intorno a questa domanda ruota tutta la storia, vista dai punti di vista dei diversi protagonisti.
Qui le cose si complicano, perché le ottiche si moltiplicano e il racconto – la trama vera, il “perché sta succedendo tutto questo” – si costruisce per incastri, incroci, punti di vista che si toccano, divergono, tornano a toccarsi. Oltre a Jules, a raccontare, ci sono la nipote adolescente Lena, il ragazzino Josh, il poliziotto Sean, la sua collega Erin, la matta del paese Nickie e altri ancora. Come dire che la Hawkins mette in piedi un caleidoscopio (uno split screen, se siete moderni) di racconti staccati che compongono un disegno, e in questo è davvero brava, perché ha in mano una storia che potrebbe scappare di qua e di là, e invece alla fine tutti i pezzi finiscono a posto, con tanto di sottofinale e colpo di scena conclusivo.
E poi c’è quella strana Twin Peaks inglese, di cui conosciamo gli abitanti e di cui scopriamo cose  davvero strane: più o meno tutti hanno in famiglia una donna morta, e la ricostruzione del passato, delle vite e delle storie personali, porterà sempre lì, a una donna affogata nello stagno, o caduta dentro, o spinta, o suicida, o ammazzata, senza contare i tentativi non andati a buon fine.
davvero strane: più o meno tutti hanno in famiglia una donna morta, e la ricostruzione del passato, delle vite e delle storie personali, porterà sempre lì, a una donna affogata nello stagno, o caduta dentro, o spinta, o suicida, o ammazzata, senza contare i tentativi non andati a buon fine.
Sappiamo tutto questo a pezzettini, a colpi di piccole rivelazioni, anche perché Julius scopre che la sorella morta stava studiando la faccenda, era partita dalla piccola Libby (affogata dalla brava gente del paese in quanto strega nel 1679) per arrivare ad affogate più recenti, di cui il paese, ovviamente, preferisce non parlare. Dunque si intrecciano due spiriti maligni del noir: quello un po’ gotico del paesino silente e omertoso, che custodisce i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio (cioè, nello stagno); e lo schema classico della stanza chiusa, per cui sappiamo che tra i personaggi in scena ci sarà il cattivo, o il più cattivo, e il piacere sta nello scoprire i come e i perché. Del resto che una donna che indaga su strani affogamenti muoia affogata, che l’amica del cuore di sua figlia sia morta annegata, che la madre del poliziotto che indaga sui casi delle annegate sia morta nel fiume pure lei (e molto altro che non si può dire qui), beh, convertirebbe anche il più irriducibile tifoso delle coincidenze.
La vecchia ragazza del treno, che è anche la nuova ragazza del fiume, cioè la Hawkins, cammina su un crinale molto stretto, a tratti su una lama: di qui l’abilità nel costruire storie personali, con tutte le loro acrobazie emotive, gli struggimenti, i rimorsi, i silenzi, le seduzioni e gli amori proibiti; di là una storia un po’ estrema, con una mezza dozzina di donne morte in acqua (e una cittadina di provincia che continua imperterrita a andare al fiume a nuotare, divertirsi, tuffarsi), ognuna per oscuri motivi che verranno piano piano a galla, almeno loro.
“Donne che portano guai”, le chiama la Hawkins facendolo dire a una delle sue protagoniste (che finisce affogata, ovvio). Ed in effetti sì, è un campionario di quei guai che avrebbero in qualche modo a che vedere con la libertà: di amare chi ti pare, di avere una vita decente, di cercare la verità, di mantenere certe promesse. L’abilità specifica della Hawkins è quella di scavare sotto le vite, di svelarne segreti e elementi nascosti, in questo aiutata da una costruzione polifonica, e forse si merita tutti i milioni di lettori che avrà. Tutta gente, che magari, letto Dentro l’acqua, avrà il buon senso di non fare il bagno nel fiume che passa da Beckford.
 Torto marcio va molto bene, è ancora on the road e siccome ho promesso di aggiornare le date ecco qui il programmino (denso) del mese di maggio
Torto marcio va molto bene, è ancora on the road e siccome ho promesso di aggiornare le date ecco qui il programmino (denso) del mese di maggio
6 maggio, Garbagnate, Libri in corte, ore 18.
L’incontro è alle 18 alle Biblioteca comunale (via Monza 12)
13 maggio, Palermo, Tutti i colori del giallo, ore 18.30.
Si parla del Monterossi (e di tutto il resto) al Teatro Rouge et Noir (Piazza Verdi 8) con Costa e Piazzese.
20 maggio, Torino, Salone del libro, ore 16.30.
L’incontro su Torto marcio si intitola: “Romanzo civile. Con sottofondo musicale”. Dialogo con Giorgio Fontana, Sala rossa
21 maggio Torino, Salone del libro, ore 14.
Antonio D’Orrico presenta Viaggiare in giallo, la nuova antologia Sellerio che contiene un racconto del Monterossi. Ci siamo tutti: Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Francesco Recami, Alessandro Robecchi e Gaetano Savatteri. Sala gialla
24 maggio Milano, Feltrinelli Duomo, ore 19
Una presentazione che non c’entra con Torto marcio. Il professor Alessandro Carrera presenta il terzo volume delle Lyrics di Bob Dylan (ne ho scritto su TuttoLibri de La Stampa, qui). Ho l’onore di presentarlo proprio nel giorno del compleanno di Dylan (auguri). Qui l’invito.
28 maggio, Carpi, Festa del racconto, ore 10.30 .
Incontro su Torto marcio. Presenta Daniele Bresciani. Locandina
28 maggio, Ravenna, ScrittuRA Festival, ore 18.30.
Si parla di Torto marcio in piazza Unità d’Italia con Federica Angelini. Il programma lo trovate qui. Qui la Locandina
Due o tre cose sul nuovo racconto, la nuova storia di Carlo Monterossi. E’ uscito settimana scorsa nella nuova antologia Sellerio Viaggiare in giallo, in cui mi ritrovo in eccellente compagnia (Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Francesco Recami, Gaetano Savatteri). Torto marcio sta andando molto bene, le presentazioni sono interessanti e i lettori fanno domande (a volte domande che non mi aspetto. Bene, è un po’ come se il dibattito sulla giustizia delle schermaglie sulla giustizia tra Carlo e donna Isabella De Nardi Contini continuasse in pubblico, come se Katrina cucinasse per tutti). Questa volta Carlo Monterossi e Oscar Falcone sono in missione per conto loro, e mi è piaciuto fargli attraversare la Brianza, luogo per certi versi misterioso e esotico. Non aspettatevi morti ammazzati, anche se il racconto si intitola Killer (la gita in Brianza). Non posso dire niente sulla trama, ovvio, ma è una storia un po’ americana e on the road, se si riesce a non investire i ciclisti e si apprezza il cielo lombardo “che è bello quando è bello”. E la Brianza, vista dalla macchina è ancora un po’ gaddiana, a saperla vedere… E poi la misura del racconto è… stimolante per chi scrive, ecco.
Al Monterossi non gli passa il blues, ma insomma, è una buona convalescenza, e se c’è Oscar qualcosa succede sempre. La scheda del libro la trovate qui. Buona lettura.
 Con tutto quello che succede sul pianeta, dal derby nucleare tra le due persone peggio pettinate del mondo alla manovrina di Padoan, dagli ordini di Trump a Gentiloni alle primarie del Pd, saranno sfuggite ai lettori alcune notizie di cronaca. Cerchiamo di rimediare con un piccolo riassunto.
Con tutto quello che succede sul pianeta, dal derby nucleare tra le due persone peggio pettinate del mondo alla manovrina di Padoan, dagli ordini di Trump a Gentiloni alle primarie del Pd, saranno sfuggite ai lettori alcune notizie di cronaca. Cerchiamo di rimediare con un piccolo riassunto.
Firenze. Gli addetti della Polfer di Firenze hanno sorpreso un uomo intento a cambiarsi in una toelette della stazione. Si tratta di M. R., già noto alle cronache e con numerosi precedenti per trasformismo, che tentava di travestirsi da Emmanuel Macron, incorrendo così in diversi reati, tra cui atti osceni in luogo pubblico e scambio di persona. “Lo abbiamo visto cianotico e siamo intervenuti”, hanno detto gli agenti, accertato che M. R. cercava di sembrare quaranta chili più magro. La vicenda si è chiusa con un verbale e un ammonimento a non riprovarci, a cui M. R. ha risposto con “Bien sûr, au revoir! Vive l’Europe!”. Non è la prima volta che M. R. cerca di travestirsi da vincitore, era già successo in occasione di un défilé con la camicia bianca, insieme a leader in camicia bianca tutti finiti malissimo.
Roma. Una pattuglia di Carabinieri ha sedato una rissa tra gang rivali nei pressi del ministero del Tesoro. Le due bande che si sono fronteggiate erano capitanate da M. R., contrarissimo all’aumento dell’Iva prima delle primarie del Pd e poi prima delle elezioni, e M. R., ex Presidente del Consiglio, inventore delle clausole di salvaguardia nella passata legge di stabilità, che contenevano l’aumento dell’Iva. Come sempre, lo scontro è iniziato con male parole e provocazioni, per poi degenerare. I due M. R. interrogati separatamente, si sono rivelati la stessa persona e si aspetta ora un confronto al’americana. Il bilancio dei tafferugli è di un contuso: si tratta di un passante ignaro convolto nello scontro, un tecnico, tale Pier Carlo Padoan, che ha riportato ferite all’autostima curabili in dieci giorni.
Pontassieve. Un noto blogger della provincia di Firenze ha intrattenuto online gli iscritti al suo blog, Facebook, Twitter, Instagram, PacMan e PokemonGo, oltre ai clienti della sua app, sui suoi pensieri alla vigilia dell’incoronazione del nuovo/vecchio segretario del Pd che avverrà domenica prossima. Ordinaria amministrazione, vanterie e chiacchiere, fino all’atroce minaccia: subito dopo le primarie M. R. si occuperà di scuola, di una nuova riforma della scuola, di nuove riflessioni sulla scuola, di inedite soluzioni politiche per la scuola. La popolazione civile è stata avvertita, professori, studenti e famiglie si apprestano a scendere nei rifugi. Timidi e per ora prudenti i commenti delle associazioni del docenti: “Assistiamo con rispettosa curiosità le prossime riflessioni del comandante Schettino sulla riforma della navigazione”.
Fiumicino. Finalmente restaurato, tornerà nei cinema un capolavoro del giugno 2015, sempre apprezzatissimo dalla critica e poco conosciuto al grande pubblico. Si tratta di un raro documentario in cui un certo M. R., in evidente trance agonistica, ammoniva di allacciarsi le cinture, perché “si decolla”, perché “Se decolla Alitalia decolla l’Italia”. Secondo i recensori più acuti, si tratta di un capolavoro di recitazione, perfetta sintesi del metodo Stanislavskij, in cui l’attore esaspera il meccanismo dell’identificazione, diventa pietra, poi albero, poi – esercizio di difficilissimo – salvatore di Alitalia. Per chi studia recitazione si tratta di un documento prezioso, specie nei passaggi in cui M. R. confessa di aver sempre sognato di fare lo steward e attacca frontalmente i gufi che non credono al prodigioso rilancio della compagnia di bandiera. Meno di due anni dopo, il film sarà proiettato a bordo degli aerei Easy Jet e di tutte le compagnie di bandiera non affidate alle sapienti cure di Montezemolo.
E’ uscito il terzo volume delle Lyrics di Bob Dylan. Ne ho scritto su TuttoLibri de La Stampa.
 Ecco, ora le opere complete sono davvero complete. Che lo vogliate ancora menestrello (uff!), o Zelig elettrico, o profeta di chissaché, o bislacco cantante, ora i testi di mister Bob Dylan li abbiamo tutti. Con l’uscita del terzo volume delle sue Lyrics (Feltrinelli, qui tutti i testi dal 1983 al 2012, i primi due tomi coprivano gli anni 1962-68 e 1969-83), si compone la monumentale cosmogonia dylaniana.
Ecco, ora le opere complete sono davvero complete. Che lo vogliate ancora menestrello (uff!), o Zelig elettrico, o profeta di chissaché, o bislacco cantante, ora i testi di mister Bob Dylan li abbiamo tutti. Con l’uscita del terzo volume delle sue Lyrics (Feltrinelli, qui tutti i testi dal 1983 al 2012, i primi due tomi coprivano gli anni 1962-68 e 1969-83), si compone la monumentale cosmogonia dylaniana.
Queste, insomma, sono le parole, tutte le parole. Ottimamente tradotte e magistralmente commentate da uno dei più grandi dylanologi viventi, Alessandro Carrera, professore illustre di Letterature e Culture del Mondo all’Università di Houston, Texas, saggista, scrittore e altro ancora. Un’opera preziosa che oggi suona come un involontario risarcimento: mesi e mesi a disquisire se Dylan meritasse il Nobel – e caliamo un velo pietoso sulle strambe accuse di “cafonismo” per il ritardato ritiro del premio – e ora ecco nero su bianco la materia del contendere. Leggere i testi – si dice in giro – conta più del chiacchiericcio salottiero-letterario del “Oh, signora mia, che maleducato quel Dylan!”. Il primo grazie al professor Carrera per il suo lavoro di cesello sul prezioso intarsio dylaniano è dovuto per questo: fornisce argomenti, letture critiche, interpretazioni sapienti capaci di uccidere l’ottuso luogocomunismo dei senzapoesia.
E dunque via, che il viaggio cominci, ricco di deviazioni, di salti, di passaggi di tono. Una poetica ingombrante e ramificata, a volte contraddittoria, eppure, vista nel suo corpus complessivo, di straordinaria, cristallina coerenza. Il terzo volume delle Lyrics copre trent’anni di Dylan, ed è il Dylan adulto,  quello che si affranca faticosamente dall’ombra del suo mito (avvertenza: se leggo ancora una volta “portavoce della sua generazione” metto mano alla pistola), che lo stropiccia implacabilmente, rinnegandolo e rafforzandolo al tempo stesso. Un Dylan che si lascia alle spalle la formula della “canzone di protesta” (ri-uff!) e persino le svolte religiose fatte di gospel, inni e salmi.
quello che si affranca faticosamente dall’ombra del suo mito (avvertenza: se leggo ancora una volta “portavoce della sua generazione” metto mano alla pistola), che lo stropiccia implacabilmente, rinnegandolo e rafforzandolo al tempo stesso. Un Dylan che si lascia alle spalle la formula della “canzone di protesta” (ri-uff!) e persino le svolte religiose fatte di gospel, inni e salmi.
Si parte, ordine cronologico, da Infidels (1983), salutato all’epoca come uno dei periodici “grandi ritorni” di Dylan, e si arriva a Tempest (2012), capolavoro di misticismo laico, dove lo scoramento e il disincanto scivolano in un groviglio di rimpianti: lido mattino /abbiamo pianto per le nostre anime lacerate / a cosa sono valse le nostre lacrime? / a cosa sono valsi quei lunghi anni sprecati?” (Long and wasted years). “Abbiamo pianto in un freddo, ge
Tra questi due estremi, tra queste stazioni di testa e di coda lontane tre decenni, si dispiega il grande affresco di Dylan. Che è un racconto sull’America e sull’Anima, sul Bene e sul Male, la Vita, l’Amore, l’Abbandono, e su come – maldestramente, umani come siamo – maneggiamo tutto questo. Il testo originale a fronte ci dà conto delle assonanze e dei ghirigori semantici, roba per gli anglofoni esperti, e qui un altro grazie al traduttore va per la scelta, ogni volta, del giusto registro: letterale quando serve, capace di illuminare sullo slang dylaniano fatto di allusioni e citazioni, persino in rima quando il testo lo richiede. E preziosissime sono le note di Carrera, rabdomante colto e spericolato che cerca e scava tra significati profondi e rimandi di senso, ammiccamenti, assorbimenti di parole sempre sospese tra la Bibbia e i Poeti (quelli che se avessero vinto il Nobel nessuno avrebbe storto il naso).
Ma Dylan sa attingere anche dalle filastrocche per bambini, dall’enorme serbatoio della Grande Canzone Americana, dai proverbi, dal folk pre-operaio fino alla ricerca del Blues, o meglio, se si consente l’uso di una categoria kantiana, della “bluesità”. Per cui leggere questi testi (non poesie, canzoni!) è intraprendere un viaggio non, banalmente, in “quello che voleva dirci l’artista”, ma in quello che ci ha detto veramente, cantandolo, appoggiando il senso delle parole su metriche che è bello strascicare e tradire mille e mille volte. E sarà un caso, o gusto personale, ma i testi di album come Love and Theft (2001) o Tempest (2012), dove la descrizione e lo sgomento per ciò che si descrive si uniscono in gloria, sono capolavori sinuosi e fluidi. Dal poeta impariamo che le storie del mondo, dalla grande alluvione del Delta del Mississippi del 1927 all’affondamento del Titanic, da Romeo e Giulietta alle vite di piccoli banditi già sconfitti alla prima strofa, sono le storie nostre, che ci riguardano e che in qualche modo ci spettano.
è intraprendere un viaggio non, banalmente, in “quello che voleva dirci l’artista”, ma in quello che ci ha detto veramente, cantandolo, appoggiando il senso delle parole su metriche che è bello strascicare e tradire mille e mille volte. E sarà un caso, o gusto personale, ma i testi di album come Love and Theft (2001) o Tempest (2012), dove la descrizione e lo sgomento per ciò che si descrive si uniscono in gloria, sono capolavori sinuosi e fluidi. Dal poeta impariamo che le storie del mondo, dalla grande alluvione del Delta del Mississippi del 1927 all’affondamento del Titanic, da Romeo e Giulietta alle vite di piccoli banditi già sconfitti alla prima strofa, sono le storie nostre, che ci riguardano e che in qualche modo ci spettano.
Perché alla fine di tutto – alla fine del libro, della musica e di una carriera durata oltre mezzo secolo e che ancora dura – siamo ancora qui a dirci, stupefatti e storditi di malinconia: “Hai gambe che fanno impazzire gli uomini / Quante cose non abbiamo fatto e invece dovevamo fare” (Scarlet Town).
Qui c’è l’intervista di Paolo Maggioni per TuttiFrutti di RaiNews.
 Dilemma etico non da poco: i fasci da compatimento che qualche notte fa a Tor Bella Monaca hanno attaccato cartelli contro negozi stranieri, fanno più paura o fanno più ridere? E’ una questione antichissima: era sublime il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, ma certo non ha impedito a Hitler di fare quello che ha fatto. E dall’altro lato la bramosia dei piccoli arditi di borgata di farsi prendere sul serio suggerirebbe proprio il contrario: coglierne il lato macchiettistico e involontariamente auto-satirico. Che fare, dunque? Intervistati dai giornali, i titolari dei negozi presi di mira dicono che non denunceranno, il che significa che ci credono poco alla “giustizia che fa il suo corso”, mentre i balilla sulla pagina Facebook del gruppetto fascista che ha rivendicato l’azione (qualche cartello appeso, forse qualche scritta sul muro) festeggiano la Santa Pasqua (Auguri camerati!”). Tutto un po’ surreale, insomma. Lasciamo perdere la faccenda dei negozi italiani e dei negozi stranieri: si può spaziare dagli orrori della Notte dei Cristalli al ridicolo sogno dell’autarchia in un mondo globalizzato, in entrambi i casi si prova una certa vertigine. I gerarchetti di Tor Bella Monaca rilasciano comunicati manco fossero l’Onu, e sono righe esilaranti da cui traspare la prima preoccupazione: farsi conoscere, dire chi sono, collocarsi. “Identitari, nazionalisti, di ispirazione cattolico-fascista”. Ecco fatto, semplice, no? Siamo a un passo (dell’oca) dalla barzelletta sul matto che si crede Napoleone.
Dilemma etico non da poco: i fasci da compatimento che qualche notte fa a Tor Bella Monaca hanno attaccato cartelli contro negozi stranieri, fanno più paura o fanno più ridere? E’ una questione antichissima: era sublime il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, ma certo non ha impedito a Hitler di fare quello che ha fatto. E dall’altro lato la bramosia dei piccoli arditi di borgata di farsi prendere sul serio suggerirebbe proprio il contrario: coglierne il lato macchiettistico e involontariamente auto-satirico. Che fare, dunque? Intervistati dai giornali, i titolari dei negozi presi di mira dicono che non denunceranno, il che significa che ci credono poco alla “giustizia che fa il suo corso”, mentre i balilla sulla pagina Facebook del gruppetto fascista che ha rivendicato l’azione (qualche cartello appeso, forse qualche scritta sul muro) festeggiano la Santa Pasqua (Auguri camerati!”). Tutto un po’ surreale, insomma. Lasciamo perdere la faccenda dei negozi italiani e dei negozi stranieri: si può spaziare dagli orrori della Notte dei Cristalli al ridicolo sogno dell’autarchia in un mondo globalizzato, in entrambi i casi si prova una certa vertigine. I gerarchetti di Tor Bella Monaca rilasciano comunicati manco fossero l’Onu, e sono righe esilaranti da cui traspare la prima preoccupazione: farsi conoscere, dire chi sono, collocarsi. “Identitari, nazionalisti, di ispirazione cattolico-fascista”. Ecco fatto, semplice, no? Siamo a un passo (dell’oca) dalla barzelletta sul matto che si crede Napoleone.
Poi c’è, nelle prime righe, il severo monito: “non siamo la costola di nessuno”, che messo così in evidenza significa proprio il contrario: saranno camerati che hanno litigato con altri camerati su chissà quale centrale questione strategica (il fez va portato storto? DVX si potrà scrivere anche con la U normale?). Non si sa quanti ardimentosi adepti abbia questa nuova setta grottesco-fascista, ma se si va a vedere il manifesto d’intenti, che è un po’ anche un programma, una dichiarazione e un “che fare?”, si può leggere questo: che lottano contro i poteri forti e “nello specifico satanismo e massoneria , signoraggio bancario e lotta al sionismo”. Non si capisce come siano esclusi dagli ambiziosi obiettivi anche l’alopecia, l’imperialismo e il surf, ma non si può avere tutto. Quel che è certo è che per fare tutto questo (cioè per lottare come belve contro il satanismo, per dirne una) serva “un’immensa rettificazione morale”, che fa paura, ma anche ridere, solo a dirlo. Risparmio al lettore innocente il resto della prosa, ma resta il dilemma di prima: quando vedi uno che delira ridi, come verrebbe spontaneo fare, o ti preoccupi che il delirio non si espanda?
Una cosa però appare abbastanza evidente: pur propugnando arditamente “la controinformazione a dispetto dei metodi tradizionali di comunicazione” (sic), gli arditi che difendono la civiltà occidentale e l’identità italiana contro un macellaio rumeno o una parrucchiera nigeriana ai “metodi tradizionali di comunicazione” (ri-sic) ci tengono in bel po’, e difatti sventolano come un gagliardetto consunto dalla battaglia un articolo di giornale che parla di loro (“sulla prima pagina”, si lasciano scappare con orgoglio). Alla fine pure questo fa un po’ ridere: mentre teorizzano “Il
servizio di una causa che va al di là dell’uomo” (eh?), mentre ci assicurano che “Contano soltanto le qualità dell’anima, le sue vibrazioni, il dono totale” (prego?), contano le righe e raccolgono la rassegna stampa, come se entrare in qualche modo nella cronaca fosse un atto di esistenza in vita. Naturalmente non farò qui il nome di questi arditi alfieri della “rettificazione morale” (scusi?), proprio per non finire nella loro collezione di “dicono di noi”. Il dilemma se siano più preoccupanti o più ridicoli resta aperto.
 Un fantasma si aggira per l’Italia. È il fantasma della “disintermediazione”. Parolina di moda per addetti ai lavori, un tempo, più che altro riguardante l’informazione: perché affidarsi alla mediazione di un organo di stampa quando invece ci si può informare sulla pagina Facebook di Gino, o Pino, o Sempronia? Perché leggere analisi e cronache quando il Capo ti sistema con un tweet tutto quello che c’è da sapere? Affascinante concetto. Matteo Renzi ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia, naturalmente. Disintermediare, per lui, significava fare a meno dei corpi intermedi, sindacati in primis, che generano confusione, rallentano il paese, mettono in campo spossanti trattative, mentre il modello vincente sarebbe quello dei lavoratori che fanno accordi aziendali, magari singolarmente, qui la pecunia qui il cammello.
Un fantasma si aggira per l’Italia. È il fantasma della “disintermediazione”. Parolina di moda per addetti ai lavori, un tempo, più che altro riguardante l’informazione: perché affidarsi alla mediazione di un organo di stampa quando invece ci si può informare sulla pagina Facebook di Gino, o Pino, o Sempronia? Perché leggere analisi e cronache quando il Capo ti sistema con un tweet tutto quello che c’è da sapere? Affascinante concetto. Matteo Renzi ne aveva fatto un suo cavallo di battaglia, naturalmente. Disintermediare, per lui, significava fare a meno dei corpi intermedi, sindacati in primis, che generano confusione, rallentano il paese, mettono in campo spossanti trattative, mentre il modello vincente sarebbe quello dei lavoratori che fanno accordi aziendali, magari singolarmente, qui la pecunia qui il cammello.
Ora ecco che con la disintermediazione sul posto di lavoro arriva il carico da undici del grillismo. Dal blog (quello di Genova, non quello di Rignano) arriva il disegno per le future relazioni industriali: basta con il sindacato, vecchio, incrostato, eccetera eccetera, e avanti con la disintermediazione, un luogo di sogno in cui in fabbrica, in ufficio, nel magazzino della logistica, a scuola e, insomma, in ogni posto in cui si scambi tempo-lavoro per salario, “uno vale uno”.
Immaginarsi la scena non costa niente: l’operaio del terzo turno che entra nell’ufficio di Marchionne disintermediando la segretaria e dice: “Oh, capo, oggi non mi va di montare i parabrezza alla Panda, venga giù lei a farlo”. Interessante, ma poco realistico, diciamo, non si sa se più vicino agli antichi sogni di un’ipotetica “autonomia operaia” o a quelli Dickensiani dei vecchi padroni del vapore, scegliete voi.
Naturalmente il concetto di disintermediazione, una volta portato alle estreme conseguenze, genererà un po’ di confusione. Perché affidarsi alla mediazione del chirurgo per quella dolorosa appendicite? Su, coraggio, disintermediate! Uno specchio, un coltello da cucina e fate da soli. Perché affidarsi alla mediazione del tranviere per andare da un posto all’altro della città? Basta disintermediare e guidare l’autobus un po’ per uno. Si potrebbe continuare all’infinito, ma insomma, il concetto è chiaro. Stupisce però che questa febbre da “disintermediazione” si alzi sempre quando si parla di lavoro e di sindacato. Che certo è un corpo intermedio con le sue lentezze e le sue “incrostazioni”, con tutte le sue magagne e difficoltà. E però stupisce questa voglia di “fare da sé”, di autoorganizzarsi, di “uno vale uno” proprio in un momento storico in cui chi lavora – chi abita le infinite varianti di un mondo del lavoro trasformato in giungla selvaggia – pare più indifeso che in passato, come ci insegna il Jobs act ( basta dare un’occhiata alle cifre dei licenziamenti “disciplinari”, così massicciamente sdoganati e prontamente attuati dalle aziende appena gliene è stata data l’occasione). Certo, il mondo del lavoro subisce (e ancor più subirà) notevoli scossoni, dalla tecnologia, dall’automazione e da altro ancora. Logica suggerirebbe quindi di rafforzare (e certo, migliorare, disincrostare, mi scuso per questo gergo da tecnico della lavatrice) i corpi intermedi che lo difendono, e non di mettere in campo un altro ostacolo al loro lavoro, che in questa fase storica è di difesa dei diritti, furbescamente confusi con privilegi, come se avere un posto di lavoro più o meno fisso fosse essere “casta”. Ora sarebbe lungo e noioso ripercorrere la storia del movimento dei lavoratori, ma è indubbio che i corpi intermedi (in italiano: i sindacati) abbiano detto la loro. Il sospetto, legittimo è che se i ragazzini di otto anni che a fine Ottocento lavoravano per dieci ore nelle filande (ancora Dickens e dintorni) avessero “disintermediato”, sarebbero ancora lì.
Sabato alle 11.30 (pazzesco, eh!) a Verona, alla Biblioteca civica, si parla di Torto marcio. Qui la recensione di Flavia Marani su L’Arena di Verona
 Dopo tante morose (di Silvio), è il momento dei morosi (di Forza Italia). Ne parlerò con un certo pudore, perché le aziende che vanno male intristiscono sempre, si pensa ai dipendenti, ai loro figliuoli, alle ristrettezze di tante famiglie, insomma è brutto quando un’impresa economica cola a picco. Una parte del grosso debito dell’azienda è rappresentato dai morosi. Quelli che devono ancora i soldi per la candidatura del 2013 (un posto in lista costava 25.000 euro), quelli che non pagano il contributo, deputati, senatori, consiglieri comunali che devono sganciare chi cinquecento euro, chi ottocento, mille per l’adesione, più molti arretrati, fino a certi casi di insolvenza gravissima che arrivano a 60.000 euro. I fulmini del tesoriere Alfredo Messina sono arrivati, la minaccia è che chi non paga non potrà più avere cariche elettive nel partito e non verrà ricandidato.
Dopo tante morose (di Silvio), è il momento dei morosi (di Forza Italia). Ne parlerò con un certo pudore, perché le aziende che vanno male intristiscono sempre, si pensa ai dipendenti, ai loro figliuoli, alle ristrettezze di tante famiglie, insomma è brutto quando un’impresa economica cola a picco. Una parte del grosso debito dell’azienda è rappresentato dai morosi. Quelli che devono ancora i soldi per la candidatura del 2013 (un posto in lista costava 25.000 euro), quelli che non pagano il contributo, deputati, senatori, consiglieri comunali che devono sganciare chi cinquecento euro, chi ottocento, mille per l’adesione, più molti arretrati, fino a certi casi di insolvenza gravissima che arrivano a 60.000 euro. I fulmini del tesoriere Alfredo Messina sono arrivati, la minaccia è che chi non paga non potrà più avere cariche elettive nel partito e non verrà ricandidato.
Si immaginano dunque scene degne di Miseria e nobiltà: Silvio in redingote che va a riscuotere la pigione nei miseri appartamenti di deputati e senatori di Forza Italia e quelli che si fingono malati, indigenti, mostrano le scarpe sfondate, i volti emaciati dei bambini. Insomma Dickens con dentro Totò. Viene da pensare che non vogliano pagare, ‘sti morosi, perché il privilegio di far parte di quel grande partito che sognava la “rivoluzione liberale” (che imbarazzo…) non sembra più ’sto grande privilegio. Se i soffitti si crepano e la muffa avanza, perché continuare a pagare l’affitto? Ha una sua logica.
Del resto, la storia dell’azienda Forza Italia pare un caso di scuola. Il brand era molto forte sul mercato, ai tempi del suo boom si canticchiavano le sue canzoncine pubblicitarie, i testimonial erano di primo livello nazionalpopolare e l’amministratore delegato sembrava un sovrano (retro)illuminato capace di trasformare il ferro in oro. Ora, il marchio sembra polveroso, vintage, si parla di Forza Italia come del mangianastri o del Moplen, cose passate che sì, fecero sognare, ma poi…
Si comincia a non essere più all’avanguardia, a sbagliare la comunicazione, a vendere sempre lo stesso prodotto; si finisce a stare in piedi perché si spera nell’aumento di capitale o per non licenziare i dirigenti. Il tutto mentre milioni di clienti scoprono che anche ai tempi d’oro il prodotto venduto e comprato in gran quantità non era ‘sta gran cosa, anzi, la solita fuffa liberista in versione “il sole in tasca”, “basta crederci” e “bisogna essere ottimisti”. Tutte cose che se la giocano alla pari, con la fuffa di oggi, solo che ora si chiamano hashtag. Forza Italia è dunque alle prese col un bel problemino: cerca di restare azienda anche senza un capo che decide tutto e pensa a tutto, e che non ha più intenzione di affrontare da solo nuovi aumenti di capitale, mentre i morosi fanno gli gnorri e gli arretrati aumentano.
Altri marchi famosi, come il Pd, attuano veloci ristrutturazioni: credono sia meglio un’azienda più piccola ma comandata a bacchetta dal suo amministratore delegato, che una grande azienda molto ramificata e complessa. La trasformazione del Pd nel Partito di Renzi è dunque un’altra fase nel mercato politico attuale: un caso di ristrutturazione dell’azienda in termini efficientisti, che assicuri al capo una guida decisa e personalistica. Si tenta di somigliare al più acerrimo concorrente, tipo quando Apple e Samsung si accusano a vicenda di rubarsi i brevetti, e mentre si tuona contro la struttura monarchica di Grillo, si lavora per imitarla, blog del Capo compreso. Nel mercato della politica italiana, quindi, c’è grande attenzione alle strutture, alle guerre di consigli di amministrazione e alla definizione delle linee di comando, e intanto il prodotto che si vende è un po’ sempre lo stesso, scadente, più mercato, meno diritti, mentre ci sarebbe un gran bisogno di un modello nuovo.
Ho scritto questa recensione per Tutto Libri de La Stampa
 Regola numero uno: se “è troppo bello per essere vero” meglio non fidarsi. Quando le capita l’occasione della vita, Alice Humphrey se lo ripete più e più volte, ma niente da fare, non funziona. Lei, esperta d’arte, disoccupata e testarda nel non voler godere dei privilegi famigliari e dell’aiuto del padre regista ricco e famoso, si vede offrire da uno sconosciuto la direzione di una galleria d’arte. Roba off-off, New York, caffè nei bicchieri di carta, metropolitana sferragliante, artisti maledetti, foto d’autore ma zozze forte, e tutto il campionario. Più i poliziotti e più – fin qui tutto bene – il morto stecchito. Che sarebbe poi il tizio mistero & fascino che le ha offerto l’affare della galleria.
Regola numero uno: se “è troppo bello per essere vero” meglio non fidarsi. Quando le capita l’occasione della vita, Alice Humphrey se lo ripete più e più volte, ma niente da fare, non funziona. Lei, esperta d’arte, disoccupata e testarda nel non voler godere dei privilegi famigliari e dell’aiuto del padre regista ricco e famoso, si vede offrire da uno sconosciuto la direzione di una galleria d’arte. Roba off-off, New York, caffè nei bicchieri di carta, metropolitana sferragliante, artisti maledetti, foto d’autore ma zozze forte, e tutto il campionario. Più i poliziotti e più – fin qui tutto bene – il morto stecchito. Che sarebbe poi il tizio mistero & fascino che le ha offerto l’affare della galleria.
Il fascino finisce lì, morto ammazzato, ma il mistero continua, perché due sbirri della omicidi le mostrano una foto: lei che bacia il morto quand’era ancora vivo. Tutto chiaro e limpido, solo che lei il tizio non l’ha mai baciato, e che da lì comincia una sarabanda di prove a suo carico, indizi, piste, incastri, coincidenze e tracce, per cui Alice sembra la donna più colpevole del mondo, e l’ingiustizia faccia il suo corso.
Comincia così – e continua pure peggio per la povera Alice – Una perfetta sconosciuta (Piemme) il nuovo thriller di Alafair Burke, stella americana del genere, una per cui si spella le mani, tra gli altri, Michael Connelly, come se non bastasse il suo lavoro di docente di diritto penale, la carriera di pubblico ministero e l’essere figlia di un altro giallista di rango, James Lee Burke. Carte in regola, insomma. L’autrice. Perché la sua protagonista, invece, pare un discreto disastro: un fratello mezzo tossico, un fidanzato sì-ma-anche-no, una famiglia con tanti segreti, e ora pure un’accusa di omicidio. Bingo. Se non vi basta, fa da contrappunto alla vicenda centrale il dramma di una ragazzina scomparsa.
L’ultimo lavoro della Burke (che era andata benone con il precedente La ragazza del parco) è  dunque un paziente e sapiente ricomporre tasselli, cercare tessere del puzzle, accatastare stati d’animo e docce fredde, perché ogni volta che Alice vede uno spiraglio di speranza, ecco un altro indizio che la inchioda. Ci vorrà una specie di angelo custode, agente dell’Fbi ma in rotta con il Bureau, per guidarla fuori dal labirinto, e per una che di mestiere ha fatto il pubblico ministero è un bel contrappasso scrivere una storia dove il buono gioca fuori dagli schemi mentre la polizia indaga con il paraocchi.
dunque un paziente e sapiente ricomporre tasselli, cercare tessere del puzzle, accatastare stati d’animo e docce fredde, perché ogni volta che Alice vede uno spiraglio di speranza, ecco un altro indizio che la inchioda. Ci vorrà una specie di angelo custode, agente dell’Fbi ma in rotta con il Bureau, per guidarla fuori dal labirinto, e per una che di mestiere ha fatto il pubblico ministero è un bel contrappasso scrivere una storia dove il buono gioca fuori dagli schemi mentre la polizia indaga con il paraocchi.
La scrittura è scorrevole e piana, buona per il noir mainstream americano, e non manca qualche guizzo, anche se, ovvio, è la trama che comanda. Come in cerchi concentrici sempre più stretti, Alice si trova a indagare su vecchi segreti, più vicini a lei di quanto vorrebbe.
Catalogato come “giallo psicologico” (categoria invero un po’ bislacca), Una perfetta sconosciuta propone alcune riflessioni sulle pieghe nascoste nel privato di ogni famiglia (meglio se ricca e famosa), ma soprattutto conferma una vecchia massima di Henry Kissinger: “Essere paranoici non esclude che qualcuno ce l’abbia con te”. Perché siamo abituati a delinquenti e farabutti che cambiano la loro identità, ma non a quelli che cambiano la tua (un altro nome, un’altra vita, persino una pagina Facebook con tutte le tue foto…), e ti costruiscono intorno una ragnatela perfetta. La Burke compie dunque con maestria un doppio lavoro: costruisce la gabbia che imprigiona la sua eroina e al tempo stesso si ingegna per smontarla, operazione certosina che non manca di virtuosismi. Compresa la figura (pare obbligatoria, oggi in America) del predicatore invasato timorato di Dio con la chiesetta fai-da-te che si scaglia contro il degrado dei costumi. Alla fine, Alice, scoprirà il valore della regola numero uno, “troppo bello per essere vero”, ma anche della numero due: “Non cercare lontano”, perché il bene pare sempre irraggiungibile, ma il male ti sta spesso vicino, a volte vicinissimo.
 Oggi parliamo del nulla. Dov’eravamo? Ah, già, il ministro Poletti. Dunque, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ne ha fatta un’altra delle sue. Era un po’ che non finiva sui giornali e ha provveduto come sa lui. La poetica polettiana è un sapiente mix stilistico che comprende un po’ di luogocomunismo, una parte di nostalgia canaglia riassumibile nel solito “si stava meglio quando si stava peggio”, e una sostanziosa dose di analfabetismo funzionale (in particolare quella che porta a citare casi isolati e personali per dimostrare una tesi universale. Esempio: non è vero che c’è la disoccupazione perché mio cugino ha trovato lavoro a Cesenatico).
Oggi parliamo del nulla. Dov’eravamo? Ah, già, il ministro Poletti. Dunque, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ne ha fatta un’altra delle sue. Era un po’ che non finiva sui giornali e ha provveduto come sa lui. La poetica polettiana è un sapiente mix stilistico che comprende un po’ di luogocomunismo, una parte di nostalgia canaglia riassumibile nel solito “si stava meglio quando si stava peggio”, e una sostanziosa dose di analfabetismo funzionale (in particolare quella che porta a citare casi isolati e personali per dimostrare una tesi universale. Esempio: non è vero che c’è la disoccupazione perché mio cugino ha trovato lavoro a Cesenatico).
Non è il caso qui di analizzare l’ultima pièce polettista, recitata davanti a incolpevoli studenti bolognesi, laddove ha tenuto a precisare che giocare a calcetto serve a trovare un lavoro più che mandare curricula a destra e a manca. Gli fai un bel passaggio, gli fai fare gol, e se il centravanti è un imprenditore, oplà, assunto. Dopo il capitalismo di relazione, ecco il lavoro di relazione: proletari di tutto il mondo, cambiatevi, che si va a giocare a calcetto. Ma siccome il ministro del (poco) lavoro ci ha abituato a simili uscite (disse che il voto di laurea non è importante, ma è meglio uscire in fretta dall’Università, disse che quelli che se ne vanno dall’Italia non sono tutti cervelli in fuga, e che se se ne vanno è meglio, più altre amenità) è inutile fare il solito balletto di ironie e commenti. Meglio prevenire. Il Fatto Quotidiano, è in grado di fornire in anteprima le prossime affermazioni di Poletti, prendete nota.
Maggio 2017 – Sposate una donna ricca. Davanti ai dottorandi di fisica, nel corso di un toccante discorso in cui ricorda che a sei anni già mungeva le vacche, Poletti afferma che, potendo scegliere, è meglio sposare una milionaria che una ricercatrice precaria. “In questo modo – ha detto – avrete molto tempo libero e potrete dedicarvi a lavori manuali che oggi gli italiani sposati con donne povere non vogliono più fare”. Solite polemiche, seguite dalla scuse: “Sono stato frainteso”
Giugno 2017 – Leggete solo le pagine dispari. Al termine in un intervento alla Camera sull’ingresso nel mondo del lavoro, il ministro Poletti ha stigmatizzato l’antica usanza di leggere libri, che crea confusione nei giovani e tiene lontani dalle fatiche del lavoro. “Non dico di non leggere, dio bòno, ma limitatevi! Per esempio leggete solo le pagine dispari, in modo da dimezzare la perdita di tempo e dedicarvi a cose più utili”. Tipo mungere le mucche a sei anni o giocare a calcetto. Solite polemiche e scuse del ministro: “Ho sbagliato, è vero, d’accordo. Leggete solo le pagine pari”.
Luglio 2017 – Il 2×3 sul mercato del lavoro. Parlando a un convegno dell’ufficio legislativo del ministero del Lavoro (Confindustria) , Poletti ha lanciato l’innovativa idea del 2×3, formula che ha un certo successo nella grande distribuzione. “Di facile applicazione, basta che un imprenditore assuma tre lavoratori e ne paghi due. Oppure che due lavoratori facciano il lavoro di tre persone”. Applausi scroscianti dalla platea, ma solite polemiche sui giornali, alle quali il ministro ha risposto che lui, a sei anni, mungeva tre mucche anche se ne aveva solo due, portando così una ventata di ottimismo e positività nella stalla.
Agosto 2017 – Chiuso per ferie.
Settembre 2017 – Alternanza lavoro-lavoro. Visto il successo dell’alternanza scuola lavoro, che prepara i nostri giovani al futuro facendoli lavorare gratis, il ministro Poletti lancia un’idea rivoluzionaria: l’alternanza lavoro-lavoro. Finito il proprio turno, il lavoratore si recherà presso un’altra azienda per svolgere gratuitamente alcune mansioni. La norma non riguarderebbe i giovani in cerca di occupazione, per non distrarli dal calcetto.
Sabato Libri, la trasmissione di libri di Radio Popolare, mi ha intervistato su Torto marcio. L’intervista è di Bruna Miorelli. Per ascoltare, cliccate sul simbolo della radio. Buon ascolto
Qui una bella bella recensione di Torto marcio. La firma Roberto Ellero su Ytali.com. Come al solito cliccare sull’immagine. Oppure qui c’è il link
Ce l’avete la  macchina del tempo? Ma sì, quel marchingegno che vi fa andare su e giù sulla scala degli anni per vedere se si stava meglio prima, o meglio ora, per controllare cos’è cambiato, per osservare, fatti alla mano, come il lungo viaggio della fu sinistra italiana verso destra sia ormai completo e conclamato. Non ce l’avete? Peccato, dovrete accontentarvi della memoria e dei vecchi giornali. Per esempio quelli della torrida estate 2008, nove anni fa, quando le cronache riferivano ossessivamente degli esilaranti successi del decreto Maroni in materia di sicurezza urbana, decoro, poteri ai sindaci eccetera eccetera. Roberto Maroni era allora ministro dell’Interno e esortava i sindaci italiani ad esprimersi con “ordinanze creative”, insomma di inventarsi qualcosa per mettere ordine nelle loro città. La Grande Crisi non c’era ancora, ma la povertà, a saperla vedere, ci circondava già. La ricetta, perfettamente di destra, era dunque: nasconderla.
macchina del tempo? Ma sì, quel marchingegno che vi fa andare su e giù sulla scala degli anni per vedere se si stava meglio prima, o meglio ora, per controllare cos’è cambiato, per osservare, fatti alla mano, come il lungo viaggio della fu sinistra italiana verso destra sia ormai completo e conclamato. Non ce l’avete? Peccato, dovrete accontentarvi della memoria e dei vecchi giornali. Per esempio quelli della torrida estate 2008, nove anni fa, quando le cronache riferivano ossessivamente degli esilaranti successi del decreto Maroni in materia di sicurezza urbana, decoro, poteri ai sindaci eccetera eccetera. Roberto Maroni era allora ministro dell’Interno e esortava i sindaci italiani ad esprimersi con “ordinanze creative”, insomma di inventarsi qualcosa per mettere ordine nelle loro città. La Grande Crisi non c’era ancora, ma la povertà, a saperla vedere, ci circondava già. La ricetta, perfettamente di destra, era dunque: nasconderla.
Per mesi fu un florilegio di notizie e notiziette che andavano dal vulnus costituzionale al colore locale. A Sanremo fu vietato di chiedere l’elemosina “stando seduti”, a Voghera si proibì di accomodarsi sulle panchine pubbliche oltre le ore 23 a più di tre persone (adunanza sediziosa? Sesso di gruppo? Boh…). Ad Alassio, Venezia, Pisa si vietava di passeggiare con borsoni “presumibilmente carichi di merci”. Ad Assisi si vietò l’accattonaggio, con buona pace di San Francesco, a Vicenza si vietò di sedersi sulle panchine “in modo scomposto”. Potrei continuare per pagine e pagine. L’estate del 2008 fu la festa della “tolleranza zero” contro i poveracci. La famosa e democratica città di Firenze (sindaco Leonardo Domenici) ingaggiò una inesausta lotta contro i lavavetri ai semafori che occupò le prime pagine dei giornali come se fosse la terza guerra mondiale, come se venti sfigati con una spazzola in mano turbassero l’Occidente (non c’era ancora l’Isis, c’erano i lavavetri). Nacque in quell’epoca la moda delle “panchine anti-bivacco” (con braccioli in ghisa a dividerne la seduta) per cui molti comuni dei nord spesero fior di soldi, investiti perché nessuno potesse sdraiarsi e magari (orrore!) dormire al freddo per qualche ora.
Gran parte di quella paccottiglia securitaria fu fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale, le notizie sulle assurdità delle ordinanze creative rallentarono e poi sparirono del tutto. Tre furono i pilastri teorici di quella stagione densa di imbecillità: l’affermazione che la sicurezza non è “né di destra né di sinistra”, il vecchio trucco della percezione (non importa se siamo più o meno sicuri secondo le statistiche sui crimini, conta “l’insicurezza percepita”) e l’attentato al “decoro”.
Che sono, oggi, con minime varianti, i tre pilastri del decreto Minniti sulla sicurezza, quello che dà enormi poteri discrezionali ai sindaci, che permette il “daspo urbano”, che risolve il problema del disagio, dell’emarginazione e della povertà con la ricetta più semplice: nasconderli alla vista. Perfettamente di destra, si diceva. Ecco.
Piccole varianti. Una pratica e una teorica. Quella pratica: i sindaci potranno “allontanare” (Daspo) chi turba il decoro. Particolarmente difesi saranno le stazioni e i luoghi di interesse turistico, per cui si presume che gli “allontanati” andranno a turbare il decoro altrove, nei quartieri più poveri e nelle periferie, ad esempio. Quella teorica è stata invece presentata con toni mascelluti dal ministro in persona: “La sicurezza è di sinistra”. Un bel salto da quel “Non è né di destra né di sinistra” di nove anni fa. Ecco compiuto il cammino, ecco la sinistra finalmente, conclamatamente e con tanto di rivendicazione, arrivata alla chiusura del cerchio. Il decreto Maroni, il decreto Minniti, l’arte della fotocopia. Nove anni, una lunga marcia. Indecorosa.
 Metto qui il calendario delle presentazioni fino a metà aprile… ognuno scelga la data che vuole…
Metto qui il calendario delle presentazioni fino a metà aprile… ognuno scelga la data che vuole…
MARZO
Sab 25 – MILANO. Alle 16.00, a BOOKPRIDE (Base, via Bergognone 34) presentazione e chiacchierata con Massimo Carlotto. Il giallo, i cattivi nei gialli e tutto il resto
Lun 27 PAVIA. Alle 21 al Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso 404, l’incontro è aperto a tutti, ovvio) si parla di Torto marcio, ma anche di gialli, serialità, scrittura, informazione e chissà cos’altro. L’incontro si chiama “Scrivere di mestiere” e sarà una chiacchierata con il professor Paolo Costa, docente di Comunicazione Digitale Multimediale all’Università di Pavia
Mer 29 MILANO. Alle 19 all’Arci Bellezza (via Bellezza 16) presentazione di Torto marcio. Inutile dire che l’Arci Bellezza è un posto speciale. Il mio amico Maso Notarianni che presenta e discute è speciale pure lui.
APRILE
Sab 1 CARUGATE. Alle 17 al Centro socioculturale Atrion (via San Francesco) si parla di Torto marcio. Presenta Silvia Carli
SAB 8 VERONA. Alle 11.30 (dai, l’ora dello spritz) alla Feltrinelli (via quattro spade 2) si parla sempre di Torto marcio. Presenta Guariente Guarienti
Il Venerdì di Repubblica mi ha chiesto un raccontino. Che succederebbe se Pepe Carvalho, il grande detective di Manuel Vasquez Montalbàn dovesse indagare nel Pd come fece nel Partito Comunista Spagnolo nel suo “Assassinmio al Comitato Centrale (1981)? Beh, ci ho provato… indagine difficile. Ecco qui
 “Ce lo chiede l’Europa” è stato per anni una specie di ritornello da canzonetta pop, un mantra buono per giustificare ogni cosa, un acceleratore di particelle, leggi, leggine, regolamenti, commi, riforme. Come in quegli stati americani dove la gente mette sul paraurti l’adesivo con scritto “Ha detto Gesù che devi tenere la distanza di sicurezza”, così in Italia la decalcomania “Ce lo chiede l’Europa” è stata appiccicata ovunque, da ogni governo. A volte anche allargando le braccia, facendo la faccia contrita, dicendo tra le righe: “Che volete, io non lo farei, ma ce lo chiede l’Europa…”. Anche la famosa riforma delle unioni civili, sbandierata dal renzismo come una specie di rivoluzione civile (in ritardo di anni, come se avessimo scoperto nel 2016 che la terra è rotonda o che il vapore può muovere le macchine) è arrivata da lì: la famosa Europa, dopo anni di sollecitazioni e bacchettate e strilli e urli, cominciava a incazzarsi davvero.
“Ce lo chiede l’Europa” è stato per anni una specie di ritornello da canzonetta pop, un mantra buono per giustificare ogni cosa, un acceleratore di particelle, leggi, leggine, regolamenti, commi, riforme. Come in quegli stati americani dove la gente mette sul paraurti l’adesivo con scritto “Ha detto Gesù che devi tenere la distanza di sicurezza”, così in Italia la decalcomania “Ce lo chiede l’Europa” è stata appiccicata ovunque, da ogni governo. A volte anche allargando le braccia, facendo la faccia contrita, dicendo tra le righe: “Che volete, io non lo farei, ma ce lo chiede l’Europa…”. Anche la famosa riforma delle unioni civili, sbandierata dal renzismo come una specie di rivoluzione civile (in ritardo di anni, come se avessimo scoperto nel 2016 che la terra è rotonda o che il vapore può muovere le macchine) è arrivata da lì: la famosa Europa, dopo anni di sollecitazioni e bacchettate e strilli e urli, cominciava a incazzarsi davvero.
Ora – la notizia è dell’altro ieri – succede che per l’ennesima volta l’Europa ci chiede, anzi, ci sollecita vivamente, siamo all’anticamera dello schiaffone, di fare una legge. Questa volta non c’entrano soldi, spread, pensioni, bilanci: quel che si chiede, banalmente, a cinquecento anni da Torquemada e a settanta da via Tasso (e a sedici da Bolzaneto), è di fare una legge sulla tortura. Matteo Renzi l’aveva pure detto con il ditino alzato in uno dei suoi tweet ieratico-programmatici: “Quello che dovremo dire lo diremo in Parlamento con il reato di tortura. Questa è la risposta di chi rappresenta un paese!” (8 aprile 2015). Urca che paura. Intanto nessuna legge sulla tortura è arrivata in Parlamento. Chiacchiere e distintivo.
Soprattutto distintivo, viene da dire, perché a fermare un Ddl sulla tortura (una cosetta che ci metterebbe in regola con l’articolo 3 della convenzione europea dei diritti umani) è sostanzialmente una scuola di pensiero di grandi pensatori (tra gli altri, Giovanardi, Gasparri, Salvini), cui si aggiunse a un certo punto l’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano: “Evitiamo messaggi fuorvianti nei confronti delle forze dell’ordine”. Insomma: c’è il terrorismo, non è il caso di turbare gli animi delle forze dell’ordine. Come dire che se arresti un serial killer che fa il postino getti nello sconcerto tutti i postelegrafonici.
Non è ovviamente la prima volta che l’Europa ci sollecita. Il G8 di Genova si porta appresso decine di processi e ricorsi alle corti europee ed ogni volta che si accertano i fatti parte lo schiaffone per chiederci di fare una legge sulla tortura. Un famoso Ddl gira da anni tra commissioni e tavoli dei vari leader, compare e scompare, va e viene, poi sparisce di nuovo appena si parla di calendarizzarlo in Parlamento. Il dinamico tipino che doveva fare una riforma al mese, poi tre in un anno, poi due in due anni, poi i cento giorni, ah, no, i mille che è più comodo, ecco, quella riforma lì non l’ha saputa o voluta fare. Intanto abbiamo visto le piaghe più evidenti di un dolore di altri, i Cucchi, gli Uva, gli Aldrovandi, facendole un po’ nostre, partecipando di una sacrosanta richiesta civile: non si picchia la gente, tantomeno i prigionieri, e non li si ammazza di botte. Un principio etico basilare. Niente. Per una volta, anche se ce lo chiede l’Europa, tutti fermi. Quelli che ogni giorno ci mettono in guardia dal disamore per la politica, dal disincanto colpevole, dal babau del “se no vince il populismo”, dovrebbero un po’ riflettere su questo fatterello: noi, #Italiariparte, #Italiacolsegnopiù, #ItaliaGrandePotenzaCulturale, non abbiamo una legge che impedisca e punisca “la tortura, e i maltrattamenti inumani e degradanti”, eppure casi di tortura e maltrattamenti inumani e degradanti – nelle cronache – ne abbiamo un bel po’, il campionario allargato, la collezione completa.
Quelli di Ibs.it mi hanno fatto un’intervista, con la scusa che avevano una telecamera. La metto qui. Grazie per avermi fatto vedere i magazzini. Lì c’è da leggere un bel po’, eh!
 La questione, più che politica, si fa psichiatrica e dunque è bene avvicinarsi guardinghi, usando le dovute cautele. Si parla qui dell’antica questione di come scendere dal carro del vincitore, se sia meglio farlo sgomitando, oppure se sia preferibile darsi alla fuga senza clamori, con modi liftati, ostentando la pacata ragionevolezza dei delusi. La faccenda è complicata dal fatto che il vincitore alla guida del suddetto carro non è vincitore per niente e, a parte una tornata elettorale pagata in contanti, ha perso sempre, e quasi ovunque. Ma insomma, le hostess che indicano nervosamente le uscite di sicurezza per chi vuole abbandonare il renzismo si sbracciano da tempo, basti ricordare i candidati sindaci Pd che pregavano Renzi di non andare a fare campagna elettorale per loro (Fassino a Torino), o che proclamavano gonfiando il petto “non sono renziano” (Sala a Milano).
La questione, più che politica, si fa psichiatrica e dunque è bene avvicinarsi guardinghi, usando le dovute cautele. Si parla qui dell’antica questione di come scendere dal carro del vincitore, se sia meglio farlo sgomitando, oppure se sia preferibile darsi alla fuga senza clamori, con modi liftati, ostentando la pacata ragionevolezza dei delusi. La faccenda è complicata dal fatto che il vincitore alla guida del suddetto carro non è vincitore per niente e, a parte una tornata elettorale pagata in contanti, ha perso sempre, e quasi ovunque. Ma insomma, le hostess che indicano nervosamente le uscite di sicurezza per chi vuole abbandonare il renzismo si sbracciano da tempo, basti ricordare i candidati sindaci Pd che pregavano Renzi di non andare a fare campagna elettorale per loro (Fassino a Torino), o che proclamavano gonfiando il petto “non sono renziano” (Sala a Milano).
Va bene, la faccenda del potente che perde aderenza e slitta di brutto quando non è più tanto potente è vecchia di secoli e millenni. Allo stesso tempo, è dovuta qualche prudenza. E se poi l’ex presunto vincitore perdente dovesse rivincere? Staccarsi dalla truppa senza farsi notare non basta, bisogna uscire dai ranghi pronti a ritornarci come se niente fosse se mai dovesse passare la tempesta e questo un po’ ridicolo tramonto renzista dovesse trasformarsi in una nuova alba radiosa. Sognare non costa niente.
Anche qui, diverse scuole di pensiero. La prima è giocare la carta del complottone, che è sempre buona e può attecchire presso le anime semplici. In questo caso la storiella è: ecco, Matteo voleva scardinare i vecchi poteri incrostati e ne ha pagato il fio, schiacciato dalla resistenza del vecchio (che sarebbe per esempio la Costituzione) contro il nuovo (che sarebbe nel caso una Boschi, non ridete). E’ una tesi suggestiva, che rispolvera nuove parole nella prosa social dei troll irriducibili: parole come “restaurazione”, “tornare indietro”, “vince la conservazione”. Cioè – traduco in italiano – era arrivato il rivoluzionario con il suo direttorio made in Tuscany, ma poi ecco Bersani e i poteri forti che fanno il Congresso di Vienna e ripristinano l’ancien régime dei baffi di D’Alema. Una tesi che fa acqua da tutte le parti e infatti viene spesso messa lì nelle discussioni come senza parere, in inciso, tra parentesi, appoggiata con nonchalance. E’ una modalità di discesa dal carro che somiglia al vecchio “ti lascio perché ti amo troppo” a cui è vietato credere, almeno dopo la quinta elementare.
Ancor più divertente l’altra teoria, quella della separazione per motivi caratteriali. Tutto era bene, tutto era bello, ma lui, il blogger di Rignano, è stato arrogante, antipatico, un po’ supponente. Insomma se ne parla come di quei grandissimi calciatori un po’ matti e accecati dall’ego che mandano affanculo il mister, litigano coi compagni di squadra e finiscono in panchina. E’ una tesi molto comoda, che permette di non dissociarsi politicamente, ma di dare tutta la colpa al cattivo carattere, e lascia intendere la pronta disponibilità a risalire sul carro, se soltanto il ragazzo si darà una regolata.
Terza scuola di pensiero, quella del renzismo critico, cioè dei passeggeri del carro che dicono di non essere mai stati del tutto d’accordo. Il vecchio caro “io l’avevo detto” pronunciato da chi non aveva detto proprio niente è sempre disarmante, lascia senza parole. Per cui si consiglia, a questi ultimi che scendono dal carro fingendosi passeggeri casuali, di munirsi di pezze d’appoggio. Un tweet del 2014, un post del 2015, una dichiarazione critica di quando il re sedeva a Versailles osannato, temuto e riverito sarebbe utile. Insomma, chi dice “io l’avevo detto” esibisca qualche prova che l’aveva detto davvero, per un minimo sindacale di decenza.
Qui sotto l’intervista di Claudia Cangemi per Quotidiano Nazionale (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino)
L’intervista pubblicata da Libreriamo (cliccare sull’immagine per leggere, altrimenti il link è qui)
 Comunicazione di servizio per chi passa di qui.
Comunicazione di servizio per chi passa di qui.
Ecco le prossime presentazioni di Torto marcio. Grazie come sempre a chi viene, ascolta, chiede e chiacchiera. Ci vediamo qui e là…
MONZA – Sabato 4 marzo – Alle 18 al Libraccio di via Vittorio Emanuele 15
NOVI LIGURE – Sabato 11 marzo– Alle 17.30, Palazzo Pallavicini, via Giacometti 22
VIMERCATE – Domenica 12 marzo – Alle 17, libreria Il Gabbiano, via Pinamonte 2/A
LECCO – Sabato 18 marzo – Alle 18, libreria Volante, via Bovara 30
MILANO – Sabato 25 marzo – Alle 16, a BookPride, a Base, via Tortona, chiacchierata sul giallo e tutto il resto con Massimo Carlotto (conduce Luca Crovi)
MILANO – Mercoledì 29 marzo – Alle 19, all’Arci Bellezza, via Giovanni Bellezza 16
 Ma sì, ma sì. Anch’io ho camminato per qualche città americana con un bicchierone di caffè in mano, mi piace, non nutro alcuna preclusione né ideologica né culturale nei confronti dell’ingurgitare caffeina a litri con il naso all’insù verso la cima dell’Empire State Building. E però confesso di provare un certo fastidio nella prosopopea e nella retorica rinascimental-aziendale che accompagna in questi giorni l’apertura (prossima) di Starbucks a Milano. Un grande bar, alla fine, cantato e celebrato (ieri due pagine sui principali quotidiani nazionali) con toni di strabiliato trionfo, come un tempo si salutava la costruzione delle cattedrali gotiche, come si festeggiasse, che so, il ritorno della Gioconda o l’annessione di Istria e Dalmazia. Non ne faremo una colpa al signor Howard Shultz, l’intervistatissimo capo di quasi 25.000 bar nel mondo (utile netto 2,8 miliardi di dollari): lui fa il suo mestiere ed è persino commovente quando dice cose come “siamo innamorati della vostra cultura” e “abbiamo una grande affinità”. Tutto bello, anche se suona un po’ come il calciatore che bacia la maglia dopo averne baciate altre cinque o sei, vai a sapere, magari ‘sta faccenda delle grandi affinità l’ha detta anche nelle Filippine, in Bolivia o a Hong Kong.
Ma sì, ma sì. Anch’io ho camminato per qualche città americana con un bicchierone di caffè in mano, mi piace, non nutro alcuna preclusione né ideologica né culturale nei confronti dell’ingurgitare caffeina a litri con il naso all’insù verso la cima dell’Empire State Building. E però confesso di provare un certo fastidio nella prosopopea e nella retorica rinascimental-aziendale che accompagna in questi giorni l’apertura (prossima) di Starbucks a Milano. Un grande bar, alla fine, cantato e celebrato (ieri due pagine sui principali quotidiani nazionali) con toni di strabiliato trionfo, come un tempo si salutava la costruzione delle cattedrali gotiche, come si festeggiasse, che so, il ritorno della Gioconda o l’annessione di Istria e Dalmazia. Non ne faremo una colpa al signor Howard Shultz, l’intervistatissimo capo di quasi 25.000 bar nel mondo (utile netto 2,8 miliardi di dollari): lui fa il suo mestiere ed è persino commovente quando dice cose come “siamo innamorati della vostra cultura” e “abbiamo una grande affinità”. Tutto bello, anche se suona un po’ come il calciatore che bacia la maglia dopo averne baciate altre cinque o sei, vai a sapere, magari ‘sta faccenda delle grandi affinità l’ha detta anche nelle Filippine, in Bolivia o a Hong Kong.
Ma insomma, pare che le aziende abbiano anche loro bisogno di storytelling, e fino a ieri non era andata benissimo: il primo segno di Starbucks a Milano (in veste di sponsor) era stato quel giardinetto di palme e banani diventato famoso per le scemenze razziste di Salvini e per qualche cretino che aveva bruciato una pianta. Ora si passa invece all’offensiva emozional-economica: i posti di lavoro (350, mica apre la General Motors, eh!), i piani futuri, l’obiettivo, si legge, di 200-300 punti vendita in 4-5 anni. Tutto bene, elegante, ben raccontato e denso di omaggi alla nostra cultura (uh, il caffè e l’italiano! E sapessi il mandolino!), di genuflessioni allo “stile Milano”, eccetera, eccetera. Di fatto: lo sbarco di un grande gruppo in un settore dove ancora è stradominante la piccola proprietà, niente che non si sia già visto con la grande distribuzione, l’autogrill diffuso, la catena gloabal.
Ma poi la retorica aziendale, che è già fastidiosa di suo, diventa insopportabile quando si sposa con altre retoriche. Quella della città modello per il paese perché ha fatto l’Expo (ahahah), per dirne una; oppure quella del paese che riparte (perché apre un bar). A leggere le celebrazioni stampate ieri si direbbe che Starbucks venga qui a fare beneficenza, curare i lebbrosi e riportare il sole. Una narrazione che si conosce bene, del resto: l’istituzione di qualche corso Apple a Napoli (borse di studio pagate quasi tutte dalla Regione) venne salutata come se Cupertino si fosse trasferita qui. Oppure si parlò di Foodora – quella dei fattorini a cottimo modernamente chiamati riders – come di “un’agile, coraggiosa e giovane start-up”, salvo poi scoprire che è una multinazionale tedesca con filiali ovunque.
Nulla è quello che sembra: tutto è inondato dalla narrazione, meglio se diventa favola, meglio ancora se sfocia in leggenda. Il provincialismo italiano aiuta: si pensa che bere un caffè alla moda di New York o Boston sia a una specie di promozione culturale di massa, o forse le grandi conquiste sociali ancora alla portata sono quelle lì: urca, guarda come siamo internazionali, che goduria, quanto zucchero? Sarà un bel bar, alla fine, ma perché diavolo me lo si vuole vendere come una specie di Rinascimento in bicchiere di carta, un’epifania della cultura di cui finora ero inspiegabilmente orbato? La narrazione del “niente sarà più come prima” – anche perché inflazionata e resa ridicola dal suo recente abuso renzista – fa sempre più ridere. E se ridi, finisce che ti va di traverso il caffè.
Qui sotto (audio) la bella intervista di Graziano Graziani per Fahrenheit, su Radio Tre. Grazie grazie (il podcast è qui)
Trovate l’intera puntata che Quante Storie (Rai Tre, dal lunedì al venerdì alle 12.45) ha dedicato a Torto marcio a questo link, su Rai Replay. Qui un piccolo estratto… come si dice, grazie per le bele parole….
Una bella intervista uscita su Il Giornale di Vicenza, l’Arena di Verona e Brescia Oggi. Grazie a Chiara Roverotto
 Sperando di fare cosa grata ai lettori e di aiutarli a districarsi nell’appassionante discussione interna al Pd, elenchiamo qui di seguito le principali correnti del partito di maggioranza relativa. Due avvertenze. La prima: tutto può cambiare da un momento all’altro, un Franceschiniano Rinato del Settimo Giorno può diventare Orfiniano Crudista in poche ore; e allo stesso modo un Cuperliano Ortodosso è un attimo che ce lo ritroviamo Giovane Turco ascendente Orlando. La seconda: nessun militante del Pd è stato maltrattato per realizzare questa ricerca, anche se molti si sono gravemente feriti da soli in questi anni.
Sperando di fare cosa grata ai lettori e di aiutarli a districarsi nell’appassionante discussione interna al Pd, elenchiamo qui di seguito le principali correnti del partito di maggioranza relativa. Due avvertenze. La prima: tutto può cambiare da un momento all’altro, un Franceschiniano Rinato del Settimo Giorno può diventare Orfiniano Crudista in poche ore; e allo stesso modo un Cuperliano Ortodosso è un attimo che ce lo ritroviamo Giovane Turco ascendente Orlando. La seconda: nessun militante del Pd è stato maltrattato per realizzare questa ricerca, anche se molti si sono gravemente feriti da soli in questi anni.
Renziani di rito ortodosso. Cominciano la giornata con il saluto al sole, di cui hanno proposto una riforma in senso liberale scritta da Maria Elena Boschi. Non mancano piccoli distinguo e sotto-correnti, divise soprattutto sul modo di essere renziani. Chi preferisce il metodo dolce come l’Area Delrio (tisane, pranoterapia, massaggi plantari) e chi invece teorizza l’approccio muscolare come i Lottiani Metodisti (nomine, deleghe all’editoria, fustigazione con le ortiche).
Renziani che leggono gli annunci di lavoro. E’ una corrente in costante crescita. La filosofia che la ispira è semplice: non bisogna aspettare di rimanere disoccupati per cercare lavoro, ma è bene guardarsi in giro per tempo. Così scorrono le inserzioni e valutano offerte. La voce che gli Orlandiani facessero sconti fino al 30 per cento sugli pneumatici invernali si è rivelata infondata, ma ha causato qualche sbandamento.
Gentiloniani. Corrente attendista che osserva e aspetta gli sviluppi della situazione, composta per il momento dal 76 per cento di Paolo Gentiloni.
Franceschiniani di pianura. Forza schiacciante nei gruppi parlamentari, decisivi nella composizione della maggioranza del partito, hanno sviluppato straordinarie capacità di adattamento e mangiano di tutto. Particolarmente temuti dai Renziani ortodossi per la capacità di muoversi in branco verso chi vincerà, chiunque sia.
Franceschiniani di montagna. Identici in tutto per tutto ai Franceschiniani di pianura a parte le scarpe e il cervello più ossigenato dall’altitudine. Si sono formati politicamente sui romanzi del capocorrente Dario Franceschini prima di scoprirne il prezioso uso come sottopentola.
Giovani Turchi. Corrente di difficile decrittazione, perché divisa in sottocorrenti contrapposte. I Giovani Turchi di Orfini sembrerebbero una costola dei Renziani Ortodossi ma meno forti alla Playstation, mentre i Giovani Turchi Orlandiani teorizzano una specie di “renzismo senza Renzi” che aprirebbe le porte a un “orlandismo con Orlando” per cui sarebbe indispensabile l’appoggio dei Franceschiniani di pianura e di montagna.
Martinitt. Seguaci del ministro Martina, alleati dei Renzisti Ortodossi, ma fortemente critici su aspetti fondamentali della linea del segretario, come la ricetta della ribollita e la campagna acquisti della Fiorentina. Facevano inizialmente capo alla corrente “Sinistra è cambiamento”, poi diventata “Sinistra, eh, cambiamento”, poi diventata “Sinistra, e il cambiamento?”
Martinitt Problematici. Amici su Facebook di Cesare Damiano, facevano parte anche loro della corrente “Sinistra è cambiamento” di Martina, ma poi gli si è rotto il navigatore e ora vagano un po’ confusi alle isole Svalbard. E’ stata allestita una squadra di ricerca e recupero.
Cuperliani animisti. Niente da dire, è proprio un bell’uomo.
Bersaniani brut metodo champenoise. Il colore giallo paglierino è dato dai numerosi insulti ricevuti dai Renziani Ortodossi in tre anni di invecchiamento. Sono gli unici che si ostinano a dire che là fuori c’è un Paese pronto a gettarsi nella braccia delle destre. La risposta dei Renziani Ortodossi è: “Più di così? Impossibile”.
Domani (sabato) c’è una presentazione a Biella. Grazie a Mauro Zola per questa bella intervista su Biella Cronaca (cliccare sull’immagine per leggere, il link è qui)
 Qui trovate le date di presentazioni, incontri, chiacchiere su Torto marcio nel mese di febbraio. Altre ce ne saranno in marzo e anche più avanti, ma insomma, questa è l’agenda del mese…
Qui trovate le date di presentazioni, incontri, chiacchiere su Torto marcio nel mese di febbraio. Altre ce ne saranno in marzo e anche più avanti, ma insomma, questa è l’agenda del mese…
SABATO 11, BIELLA – Alle 18,00, Libreria Vittorio Giovannacci (via Italia 14), presenta Patrizia Bellardone
LUNEDI’ 13, TORINO – Al Circolo dei Lettori (via Bogino 9) chiacchierata e presentazione. Ci saranno Bruno Gambarotta e Enrico Emmert (onoratissimo)
MERCOLEDI’ 15, MILANO – Cena organizzata da Cucina Calibro Noir Presenta Luca Crovi, Gigio Alberti leggerà qualcosa, insomma, ottima serata. Mi dicono che i posti sono esauriti, ma potete chiedere a cucinacalibronoir@gmail.com
GIOVEDI’ 16, MILANO – lle 18.30 alla Feltrinelli di piazza Duomo, presentazione di Torto marcio. Sarà una chiacchierata con Gad Lerner (grazie Gad!) sul libro e su quello che c’è dentro, forse andremo un po’ oltre il giallo…
VENERDI’ 17, MILANO – Alle 20.00 alla libreria Isola Libri (via Antonio Pollaiuolo 5) si parla di Torto marcio e di “Guida al giro del mondo”, di Nanni Delbecchi, due libri diversissimi, ma proprio per questo sarà divertente. Modera (ma che c’è da moderare?, io e Nanni siamo amici da anni) Silvia Truzzi, esimia collega de Il Fatto.
SABATO 18, VOGHERA – Alle 17.30 alla libreria Ubik (via Emilia 102) si presenta Torto marcio. Chiacchierata con Matteo Colombo
MARTEDI’ 21, VICENZA – Alle 18.30 alla libreria Galla (corso palladio 11) si presenta Torto marcio
SABATO 25 febbraio, MANTOVA – Dettagli presto…
Insomma, diciamo che comincia la rumba. E’ sempre un piacere parlare con i lettori, quindi… per prossime date state collegati…
 Si sa che la retorica è una brutta bestia. Serve, sì, certo, ma ha effetti collaterali difficili da prevedere e capita (spesso) che renda alcune parole logore e inservibili, che le consumi e le renda fruste, trasformando concetti pesanti e nobili in astruse formulette – addirittura strampalati nonsense – buone per ogni occasione. Un caso di scuola molto attuale nel prêt-à-porter semantico della politica: la parola “futuro”. Così abusata dalla retorica renzista che ce la ritroviamo pure nella pubblicità di un ideologo (ideuzzologo, va’) del post-ideologico come Farinetti Oscar, patron di Eataly, il quale declama in uno spot la seguente frase: “Ecco perché mi piace dimenticare il passato e ricordarmi solo del futuro”. Prego? Scusi? Traduzione?
Si sa che la retorica è una brutta bestia. Serve, sì, certo, ma ha effetti collaterali difficili da prevedere e capita (spesso) che renda alcune parole logore e inservibili, che le consumi e le renda fruste, trasformando concetti pesanti e nobili in astruse formulette – addirittura strampalati nonsense – buone per ogni occasione. Un caso di scuola molto attuale nel prêt-à-porter semantico della politica: la parola “futuro”. Così abusata dalla retorica renzista che ce la ritroviamo pure nella pubblicità di un ideologo (ideuzzologo, va’) del post-ideologico come Farinetti Oscar, patron di Eataly, il quale declama in uno spot la seguente frase: “Ecco perché mi piace dimenticare il passato e ricordarmi solo del futuro”. Prego? Scusi? Traduzione?
Non è colpa del copy o di Farinetti se il claim sul futuro che a lui “piace ricordare” (si pubblicizza una grande compagnia telefonica) ha un suono leopoldo che nella politica italiana sa già di passato, è già antico. E questo è perché il futuro, maledetto, va dove vuole lui, e non dove vuole Farinetti.
Del resto, poche parole come “futuro” si prestano a giochetti semantici spazio-temporali, e questo accade da sempre, e volendo fornire una datazione nel campo pop dell’andirivieni tra presente, passato e futuro si pasa sempre da lì, da Ritorno al futuro, il film di Zemeckis (1985, passato remoto).
Fantascienza a parte (il viaggio nel tempo è un format), il passato recente ci ha subissato di formulette facili sul futuro, figlie del nuovismo imperante. In soldoni, per essere attrattivi, moderni, dinamici, si parla del futuro fino a convincere che si è il futuro, mentre gli altri sono il passato, vade retro, pussa via. “E adesso il futuro”, era il titolo della Leopolda 2016 (con tutta ‘sta visione del futuro non videro l’iceberg, una prece), e quando, dopo la scoppola epocale, Renzi decide di rifarsi vivo aprendo un blog, ecco la frasetta “Il futuro prima o poi ritorna”, dove si legge in filigrana una specie di “il futuro sono me”, che fa ridere un bel po’. Dev’essere una discreta ossessione del Pd nuovista e smart, questa cosa del tunnel spazio-temporale, perché quando l’Unità tornò in edicola (giugno 2015) decise di farlo con un bizzarro slogan: “Il passato sta cambiando”, altro testacoda semantico di sapore involontariamente orwelliano.
Il malinteso sull’abuso infantil-enigmistico della parola “futuro” è spazio-temporale pure lui. Il Sol dell’Avvenire, grandiosa, intramontabile speranza novecentesca, per non dire delle “Magnifiche sorti e progressive” di Leopardi, e siamo già due secoli indietro. Insomma va detto anche se non è rassicurante: il futuro visto dal passato sembrava chissà quale prodigio, mentre visto dal presente induce più timori e tremori che speranze, e fa paura. Per dirla con Chuck Palahniuk (1999, una vita fa): “Quand’è che il futuro è passato da essere una promessa a essere una minaccia?”. Ecco, appunto. Dunque sì, la retorica serve, ma diventa una specie di boomerang se la si usa fuori tempo e fuori luogo, masticandola stancamente come un chewingum che perde sapore subito.
La convenienza di sventolare la parola “futuro” come una bandiera di vittoria è che il futuro, per sua natura, si sposta sempre un po’ più in là, e questo ti illude che non verrai mandato a cagare nel presente. Ma ormai è una bandiera strappata: sanno tutti che il futuro non sarà necessariamente migliore, e una parola che sembrava luminosa diventa un po’ opaca, addirittura un’ombra, controproducente anche per la propaganda. Se si parla del futuro, insomma, e la politica dovrebbe farlo, lo si faccia seriamente, non a metà tra il gioco di parole e le frasette dei Baci Perugina. “Lascia dormire il futuro come si merita – diceva Kafka nei Diari -. Se lo si sveglia prima del tempo, si ottiene un presente assonnato”.
Corrado Augias, nella sua rubrica di lettere su Repubblica del 4 febbraio, cita Torto marcio… Inutile dire che mi fa molto piacere, che il giallo sia giallo, sì, va bene, ma che dica anche delle cose… grazie per la citazione (soprattutto per aver letto, sì)
Ho scritto questa recensione per TuttoLibri de La Stampa
 Tim Sunblade si è spezzato la schiena per quattro mesi su una trivellatrice, in Louisiana, caldo e zanzare, quindi quando arriva a Kotz Springs prende una stanza, fa un bagno e chiede una ragazza in camera. Ecco fatto, così sappiamo subito dove siamo: non solo nel Sud americano degli anni Cinquanta, ma anche dalle parti degli outsider, degli avventurieri che guidano una Packard decapottabile, che dalla femme fatale con gli occhi color lavanda avranno più della prestazione standard, ma una vorticosa discesa nel gorgo del male. Lei, Virginia, dietro. Una che dice: “Mi spoglierò completamente nuda e farò il bagno fra verdi banconote da cento dollari nuove di zecca”. Lui guida e la guarda: “Si leggono e si sentono dire un sacco di cose sulle gambe. Ma quando ne vedi un paio davvero da favola, allora capisci che tutto ciò che hai letto e sentito è solo spazzatura”. Tim ha un piano: la rapina perfetta secondo le regole imparate in una prigione da cui è evaso. Virginia ha un piano: stare lì finché ci sono soldi, e se c’è da farne tanti dare una mano, perché no?
Tim Sunblade si è spezzato la schiena per quattro mesi su una trivellatrice, in Louisiana, caldo e zanzare, quindi quando arriva a Kotz Springs prende una stanza, fa un bagno e chiede una ragazza in camera. Ecco fatto, così sappiamo subito dove siamo: non solo nel Sud americano degli anni Cinquanta, ma anche dalle parti degli outsider, degli avventurieri che guidano una Packard decapottabile, che dalla femme fatale con gli occhi color lavanda avranno più della prestazione standard, ma una vorticosa discesa nel gorgo del male. Lei, Virginia, dietro. Una che dice: “Mi spoglierò completamente nuda e farò il bagno fra verdi banconote da cento dollari nuove di zecca”. Lui guida e la guarda: “Si leggono e si sentono dire un sacco di cose sulle gambe. Ma quando ne vedi un paio davvero da favola, allora capisci che tutto ciò che hai letto e sentito è solo spazzatura”. Tim ha un piano: la rapina perfetta secondo le regole imparate in una prigione da cui è evaso. Virginia ha un piano: stare lì finché ci sono soldi, e se c’è da farne tanti dare una mano, perché no?
Sarebbe bello dire che Il mio angelo ha le ali nere, di Eliott Chaze (provvidamente ripescato da Mattioli 1985, traduzione e ottima postfazione di Nicola Manuppelli) è tutto qui, l’irregolare e la puttana, una macchina dal Mississippi, al Texas, al Colorado, la rapina, il delitto e il castigo. Sarebbe bello ma non si può, perché agganciato a questo inizio da manuale del noir americano c’è un capolavoro, una meraviglia di tensioni ed equilibri e paure sottili, di inquietudini che restano anche dopo, a libro finito e chiuso.
Pubblicato in economica nel ‘53 (35 cents, compratelo in stazione e lasciatelo in treno!) in una  collana di giallacci dozzinali, Black Wings non ha mai raccolto quanto meritava. L’autore Lewis Eliott Chaze (1915-1990), giornalista di qualche successo, ne soffrì parecchio e nonostante una decina di romanzi e vari racconti (pubblicati qui e là, dal Reader’s Digest a Life, al New Yorker) si arrese all’oblìo: quando morì era un uomo stanco e fuori catalogo. Ci resta per le mani questo testo strabiliante, che mette in fila indiana tutti i topos del noir di strada americano: i due outisider che si riconoscono, la rapina, gli inseguimenti, la sparatoria, la prigione e l’evasione, i soldi (il bagno nei dollari lo avrà, Virginia, lo pagherà carissimo), il buco nero dei rimpianti e forse – ehi, non è da loro! O forse sì… – dei rimorsi.
collana di giallacci dozzinali, Black Wings non ha mai raccolto quanto meritava. L’autore Lewis Eliott Chaze (1915-1990), giornalista di qualche successo, ne soffrì parecchio e nonostante una decina di romanzi e vari racconti (pubblicati qui e là, dal Reader’s Digest a Life, al New Yorker) si arrese all’oblìo: quando morì era un uomo stanco e fuori catalogo. Ci resta per le mani questo testo strabiliante, che mette in fila indiana tutti i topos del noir di strada americano: i due outisider che si riconoscono, la rapina, gli inseguimenti, la sparatoria, la prigione e l’evasione, i soldi (il bagno nei dollari lo avrà, Virginia, lo pagherà carissimo), il buco nero dei rimpianti e forse – ehi, non è da loro! O forse sì… – dei rimorsi.
Chaze scrive piano e lucido, apparentemente leggero, spesso ironico. Ma pause e tensione non escludono mai lo sguardo implacabile del suo Tim Sunblade: sia sul mondo fuori (non gli piace), sia sul suo orizzonte esistenziale (non gli piace nemmeno quello, ma gli va incontro con l’eroismo dei disperati). L’amore? Ma sì, può darsi. Il sesso, certo. Ma è un amore tra serpenti, lei che fugge appena può, lui che non può lasciarla andare e pensa che dovrà ucciderla, lei che lo salva rocambolescamente. Due crotali che possono mordersi baciandosi, ma anche due falene strane, attratte dal buio, da (letteralmente, chi leggerà capirà) un buco nero che inghiotte vite e storie. Intorno, l’America, quell’America là, che pare uscire da un vecchio Technicolor troppo carico. Un posto di lavori sporchi e pericolosi, di piccola  borghesia assennata che bagna il prato, di coabitazione tra i prodromi di un benessere middle class e un presente da redneck. Si vedranno anche i ricchi, poi, in una New Orleans stupida e alcolica, e a Tim non piaceranno nemmeno quelli. Pagine sprezzantemente ironiche, la strada, i piccoli alberghi da pochi dollari, i bar dove si beve forte, i suburbi residenziali, persino le miniere e i cercatori d’oro della domenica, deserti e neve. Il lettore segue, assiste allo spettacolo di quella vivida autocombustione di vite, perdute fin dalla prima riga del libro ma che paiono non perdersi mai, fino alle ultime pagine. Se per fare del noir grande scrittura si tende di solito a scantonare, a sacrificare la trama, Chaze fa esattamente l’opposto. E’ mettendo in fila tutti gli stilemi del genere, tracciandone addirittura una specie di catalogo, che risolve l’enigma mai risolto tra genere e grande letteratura (quella linearità nel narrare, quella tensione… chi ha letto James Cain sa di quale potenza si parla), e ne tira fuori un gioiello vero, lasciando al lettore, alla fine, qualche ombra di ineluttabile disperazione e tutti i dubbi possibili sul bene e sul male, ma non su come raccontarli.
borghesia assennata che bagna il prato, di coabitazione tra i prodromi di un benessere middle class e un presente da redneck. Si vedranno anche i ricchi, poi, in una New Orleans stupida e alcolica, e a Tim non piaceranno nemmeno quelli. Pagine sprezzantemente ironiche, la strada, i piccoli alberghi da pochi dollari, i bar dove si beve forte, i suburbi residenziali, persino le miniere e i cercatori d’oro della domenica, deserti e neve. Il lettore segue, assiste allo spettacolo di quella vivida autocombustione di vite, perdute fin dalla prima riga del libro ma che paiono non perdersi mai, fino alle ultime pagine. Se per fare del noir grande scrittura si tende di solito a scantonare, a sacrificare la trama, Chaze fa esattamente l’opposto. E’ mettendo in fila tutti gli stilemi del genere, tracciandone addirittura una specie di catalogo, che risolve l’enigma mai risolto tra genere e grande letteratura (quella linearità nel narrare, quella tensione… chi ha letto James Cain sa di quale potenza si parla), e ne tira fuori un gioiello vero, lasciando al lettore, alla fine, qualche ombra di ineluttabile disperazione e tutti i dubbi possibili sul bene e sul male, ma non su come raccontarli.
Eliott Chaze,
Il mio angelo ha le ali nere
Mattioli 1985
pag. 203, euro 14,90
 Un blogger di Rignano sull’Arno ha recentemente lanciato un Concorso Nazionale di Idee per un grande progetto a medio termine (giugno). Titolo del concorso: “Pensieri, visioni e idee per cacciare Gentiloni e tornare a Palazzo Chigi”. Aperto a tutti, il concorso ha stimolato la fantasia degli italiani e sono giunte migliaia di relazioni, alcune dettagliate, altre anonime, una testa di cavallo, un gatto morto e numerosi studi statistici. Il lavoro di selezione è stato lungo e faticoso: si sono scartate prima di tutto le prove fotografiche poco credibili. Gentiloni in lamé azzurro che entra in un locale di lap dance di Alba Adriatica era chiaramente un maldestro fotomontaggio, mentre sulla foto taroccata di Gentiloni che spara a un cucciolo di foca il segretario ha esitato un attimo, scartandola a malincuore.
Un blogger di Rignano sull’Arno ha recentemente lanciato un Concorso Nazionale di Idee per un grande progetto a medio termine (giugno). Titolo del concorso: “Pensieri, visioni e idee per cacciare Gentiloni e tornare a Palazzo Chigi”. Aperto a tutti, il concorso ha stimolato la fantasia degli italiani e sono giunte migliaia di relazioni, alcune dettagliate, altre anonime, una testa di cavallo, un gatto morto e numerosi studi statistici. Il lavoro di selezione è stato lungo e faticoso: si sono scartate prima di tutto le prove fotografiche poco credibili. Gentiloni in lamé azzurro che entra in un locale di lap dance di Alba Adriatica era chiaramente un maldestro fotomontaggio, mentre sulla foto taroccata di Gentiloni che spara a un cucciolo di foca il segretario ha esitato un attimo, scartandola a malincuore.
Ma ecco le proposte vincenti per le tre sezioni del concorso “Cacciare Gentiloni”.
Le termiti – Animale voracissimo e maledetto, la termite può mangiarsi un palazzo in pochi giorni, specie se c’è molto legno dentro. Per esempio Palazzo Chigi. Basterebbe introdurre poche centinaia di animaletti (Maria Elena può portarne dentro una decina al giorno nella borsetta). Seguirebbe l’evacuazione di Gentiloni e l’arrivo (da Rignano) di una squadra specializzata in disinfestazione e ripristino. Grande allarme popolare e richiesta elezioni subito. Il progetto sarebbe economico e veloce. Vantaggi: Gentiloni uscirebbe di corsa. Difficoltà: cambiare la serratura in pochi minuti. Imprevisti: l’opinione pubblica, vedendo le termiti che si mangiano Palazzo Chigi potrebbe simpatizzare con gli odiosi animaletti. La proposta è stata presentata da Alberto U., di Portogruaro, che vince 80 euro.
Il testamento – L’idea è vecchia e venne per primo a Ottaviano nel 32 avanti Cristo. Fece leggere in Senato il testamento di Marco Antonio mentre quello era vivo e vegeto, documento che fece incazzare un po’ tutti e portò alla guerra con Cleopatra e Marco Antonio. Un gioco da ragazzi. Un testamento di Gentiloni abilmente realizzato in una tipografia di Rignano, potrebbe smuovere le acque e portare al voto entro giovedì pomeriggio. Qualcosa tipo “Lascio l’Eni alla mia vecchia maestra”, oppure “per quanto riguarda il gettito Irpef del 2017, lo lascio tutto a mio cugino Pino”. Vantaggi: con 25 euro di tipografia e due timbri falsi è tutto sistemato. Difficoltà: scrivere un buon falso senza espressioni toscane o frasette cretine sul futuro. Imprevisti: l’opinione pubblica potrebbe valutare che l’Eni in mano alla vecchia maestra…, perché no? La proposta è stata presentata dal professore di storia Federico S., di Caserta, che vince un bonus di 500 euro spendibile al Trony di Rignano.
Manovra correttiva – Il primo premio va alla proposta più praticabile e di fatto già in corso, si tratta solo di indirizzare gli eventi. Gentiloni deve trovare da qualche parte 3,4 miliardi per sistemare i casini di Renzi. Così Renzi può ritirarsi in campagna a fare il blogger indignato, mentre Gentiloni fa la figura di quello che aumenta le tasse. Allora Renzi dice che quando c’era lui i treni arrivavano in orario e chiede di votare subito, al massimo sabato mattina, perché non si può continuare in questa situazione, bisogna dare una scossa all’economia e parlare un po’ del futuro, che sarebbe lui. Vantaggi: apre Eataly a Belluno. Difficoltà: a parte Orfini, Maria Teresa Meli e l’Unità, non ci cascherebbe nessuno. Imprevisti: il piano necessita una massiccia azione di ipnosi su quaranta milioni di elettori, che sarebbe costosa. In più, già ipnotizzati una volta per la durata di tre anni, i pazienti potrebbero risultare refrattari. Il piano è stato comunque premiato come l’unico attuabile e ha la percentuale di riuscita dello 0, 00000045 per cento. Secondo gli esperti è più facile vincere all’Enalotto in una ricevitoria di Rignano.
Ecco qui un po’ di appuntamenti, le prime date per la presentazione di Torto marcio, ma prima…
 Il romanzo, mi dicono, va molto bene, le recensioni (quelle uscite finora lo trovate qui) sono ottime, e molti hanno capito che dietro la storia noir del Monterossi, del Ghezzi, di Carella e di tutta la banda c’è anche dell’altro… ma cosa sia non è facile dire, magari ci proveremo parlandone insieme. Ma soprattutto grazie a chi ha letto e ha capito, ha detto la sua, o la dirà, o leggerà. Questo passaparola e questo dialogo con chi legge e tra chi legge è assai prezioso (alla fine, si scrive per chi legge, no?).
Il romanzo, mi dicono, va molto bene, le recensioni (quelle uscite finora lo trovate qui) sono ottime, e molti hanno capito che dietro la storia noir del Monterossi, del Ghezzi, di Carella e di tutta la banda c’è anche dell’altro… ma cosa sia non è facile dire, magari ci proveremo parlandone insieme. Ma soprattutto grazie a chi ha letto e ha capito, ha detto la sua, o la dirà, o leggerà. Questo passaparola e questo dialogo con chi legge e tra chi legge è assai prezioso (alla fine, si scrive per chi legge, no?).
Molti chiedono date e presentazioni, quindi ecco qui sotto un primo elenco. Ogni appuntamento sarà ricordato per tempo, qui sulla pagina Fb e su twitter, ma ecco un primo elenco… A Milano sono dedicate tre serate consecutive
Sabato 11 febbraio, BIELLA. Alle 18,00 presentazione alla Libreria Vittorio Giovannacci di Biella, via Italia 14
Lunedì 13 febbraio, TORINO. Alle 18,00 presentazione al Circolo dei Lettori di Torino, via Bogino 9. Una chiacchierata su Torto marcio (e suppongo molto altro) con Bruno Gambarotta
Mercoledì 15 febbraio, MILANO. Alle 20,00 per il ciclo di incontri Cucina Calibro Noir c’è una cena con presentazione. Presenta Luca Crovi, Gigio Alberti leggerà dei brani del libro, si parlerà di tutto quanto. La cena di svolgerà presso l’Osteria del Biliardo di Milano, via Cialdini 107. Per prenotare scrivere a cucinacalibronoir@gmail.com. Tutte le informazioni su posti disponibili, prezzo, menu, le trovate qui
Giovedì 16 febbraio, MILANO. Alle 18.30 la presentazione alla Feltrinelli Duomo. In qualche modo è la presentazione “ufficiale” a Milano, quella dove si incontrano i lettori in libreria per la prima volta con il romanzo nuovo. Insomma, voi venite, se siete in zona, eh!
Venerdì 17 febbraio, MILANO. Alle 20,00 alla libreria Isola Libri di Milano, via Antonio Pollaiuolo 5, si parla (insieme) di due libri, Torto marcio e Guida al giro del mondo di Nanni Delbecchi (Bompiani). Nanni è un vecchio amico e avere in libreria contemporaneamente i nostri due libri, anche così diversi, è una circostanza che non potevamo farci scappare per fare una chiacchierata, specie di venerdì 17. Con noi ci sarà Silvia Truzzi, che nostra amica e collega di giornale… (qui la locandina)
Ci saranno altri appuntamenti, ovviamente, e saranno comunicati per tempo. Per ora segnatevi questi qui. Grazie, a presto… Se riuscite o avete voglia ci vediamo lì…
 I sondaggi parlano chiaro: otto italiani su dieci vogliono l’uomo forte, il leader carismatico, il Capo. Uno che decide, uno così forte che se non sei d’accordo solleva una lavatrice e te la tira in testa, un mix tra Obelix, Zorro e Kim Jong-un, ma pettinato meglio. E’ un mito divertente, questo dell’uomo forte che comanda da solo, ogni tanto torna su come la peperonata, ma i risultati degli uomini forti sono lì da vedere: non proprio da vantarsi, ecco. L’ultimo uomo forte che ci è toccato andava in giro con quelle facezie degli otto milioni di baionette e dell’Italia inarrestabile potenza, e poi – dopo qualche milioncino di morti – s’è visto, l’hanno beccato che scappava in Svizzera, tragico fantozzismo prima di Fantozzi.
I sondaggi parlano chiaro: otto italiani su dieci vogliono l’uomo forte, il leader carismatico, il Capo. Uno che decide, uno così forte che se non sei d’accordo solleva una lavatrice e te la tira in testa, un mix tra Obelix, Zorro e Kim Jong-un, ma pettinato meglio. E’ un mito divertente, questo dell’uomo forte che comanda da solo, ogni tanto torna su come la peperonata, ma i risultati degli uomini forti sono lì da vedere: non proprio da vantarsi, ecco. L’ultimo uomo forte che ci è toccato andava in giro con quelle facezie degli otto milioni di baionette e dell’Italia inarrestabile potenza, e poi – dopo qualche milioncino di morti – s’è visto, l’hanno beccato che scappava in Svizzera, tragico fantozzismo prima di Fantozzi.
Dopo, solo caricature e smisurate ambizioni. Ma soprattutto prodigiosi abbagli di chi scambiava per “uomo forte” il primo che passava, osservandone il triste tragitto da dono della provvidenza a figurante generico, a volte nel giro di qualche mese, tra lo sconcerto generale e le risate in sottofondo. Abbagli così grossi che vien da pensare che otto italiani su dieci non abbiano solo bisogno dell’uomo forte, ma anche di un dottore bravo, e in fretta. Per esempio in certe valli del Nord ci fu chi scambiò per uomo forte Umberto Bossi, partito minacciando fucilate e arrivato con la ristrutturazione del terrazzo, i dané alla scuola della moglie, per tacere dei geniali rampolli. Tratto distintivo: parlare di rivoluzione e incendiare gli animi, e poi quietarsi nelle faccenduole dei piccoli cumenda prealpini, piazzare figli e famigli, piccolo cabotaggio.
E poi, uomo fortissimo, Silvio buonanima, che sembrava l’ammazzasette, quello col sole in tasca, quello del “ghe pensi mi”. Chissà quanti degli otto-su-dieci che oggi vogliono l’uomo forte pensarono, ai tempi, che fosse lui. E chissà quanti, sempre del campione rappresentativo, cambiarono un po’ idea vedendolo forte, fortissimo, nel farsi gli affari suoi, in una ragnatela di conflitti d’interesse, furbizie, leggi su misura, per tacere delle señoritas che un pochino ne minarono il carisma andando in giro a dire che l’uomo forte, quello della Provvidenza, l’unto dal Signore, aveva – questo ammazzerebbe anche Maciste – “il culo flaccido”. Tristezza.
Minimo comun denominatore dell’uomo forte made in Italy, il disprezzo per gli intellettuali. Poggiando la sua visione del mondo sul pensiero elementare che le cose sono semplici a meno che qualcuno non le complichi riflettendoci sopra, l’uomo forte detesta chiunque abbia un pensiero complesso. Famosa la frase dell’uomo forte Bettino Craxi sugli “Intellettuali dei miei stivali”, che come si sa non è solo un modo per attaccare gli uomini di cultura, ma soprattutto un lisciare il pelo ai mediocri e aizzarli contro quelli che usano la testa. Una cosa che fa scopa coi “Professoroni” della coppia Renzi-Boschi: insofferenza suprema per i caca-dubbi che dissentono, mentre lui, l’uomo forte, non vuole ostacoli sul suo cammino, e ogni intoppo è un attentato alle sorti progressive e luminose eccetera eccetera. Ave, Matteo, rottamati te salutant, e alla fine te salutant anche tutti gli altri, il giorno del referendum. Si suppone, nei giorni leopoldi de #lavoltabuona, uno sfrenato entusiasmo di quegli otto-su-dieci che presero un’altra cantonata. Poi, quando si vede che l’uomo forte ha lasciato solo macerie (nel Paese, nella società, nel suo partito, colpevole di non essere abbastanza suo), quelli mica cambiano idea e dicono “Mah, questa dell’uomo forte forse è una cazzata”. No, maledetti, insistono e ne vogliono un altro. Chissà, forse sarebbe il caso di valutare l’ipotesi che gli uomini forti, come i telefonini e le riforme del lavoro, noi non li sappiamo fare. Ci vengono male. Storti. Difettosi. Sarebbe meglio non insistere con gli esperimenti.
La recensione di Gloria M. Ghioni su Critica Letteraria (cliccare per leggere, chi vuole il link è qui)
Qui la recensione di Paolo Manacorda su Milano Nera (cliccare, il link invece è qui)
 Come presentarsi a un convegno di alcolisti anonimi con un fiasco di vino, questa è stata l’intervista di Matteo Renzi, molto simile a quelle che danno i calciatori infortunati quando tornano in campo. Sia gli orfani di Matteo che i detrattori di Renzi hanno tirato un sospiro di sollievo: rieccolo in tutto il suo splendore, con le retoriche appena un po’ appannate dalla botta. Tra le tante, quella più mascelluta: il “metterci la faccia” e il dire sempre “io”. Ma insomma, si difende lui: l’Italia andava male, ci voleva una scossa, ho dovuto farlo. Forzando il suo carattere schivo, verrebbe da pensare, insomma si è sacrificato e ha “dato la scossa”.
Come presentarsi a un convegno di alcolisti anonimi con un fiasco di vino, questa è stata l’intervista di Matteo Renzi, molto simile a quelle che danno i calciatori infortunati quando tornano in campo. Sia gli orfani di Matteo che i detrattori di Renzi hanno tirato un sospiro di sollievo: rieccolo in tutto il suo splendore, con le retoriche appena un po’ appannate dalla botta. Tra le tante, quella più mascelluta: il “metterci la faccia” e il dire sempre “io”. Ma insomma, si difende lui: l’Italia andava male, ci voleva una scossa, ho dovuto farlo. Forzando il suo carattere schivo, verrebbe da pensare, insomma si è sacrificato e ha “dato la scossa”.
Ora, un po’ per noia, un po’ per archeologia, a uno verrebbe voglia di andare a vedere le volte che “ci ha messo la faccia”, per tornare dall’esplorazione un po’ stordito, frastornato, stupefatto. Lasciamo stare le famose profezie su Monte del Paschi, rivelate al Sole 24 Ore e poi recitate in giaculatoria nel pied-à terre di Bruno Vespa: “Mps oggi è un bell’affare”. Caso di scuola, buono per le schermaglie e le polemiche da bar tra renzisti e antirenzisti, figuraccia ormai triturata dalla propaganda e dalla contro-propaganda. Però insomma, se un anno fa esatto il vostro promotore finanziario vi avesse consigliato così caldamente di investire in Mps, ora sareste sotto il suo ufficio ad aspettarlo con un bastone, sempre che possiate ancora permettervi un bastone. Ci ha messo la faccia, ecco, diciamo così.
Ma poi il problema è che la faccia ce la metti prima, e dopo a volte sei costretto a sperare che nessuno si ricordi che ce l’hai messa. Figurarsi se non ci metti solo la faccia, ma anche la mimica, lo spettacolino e tutto il repertorio. Tipo “Il mio sogno è sempre stato quello di fare lo steward”, alla toccante cerimonia che rilanciava (non ridete) Alitalia. Uno stand-up da comedian di Broadway (Off-off), con tanto di “Allacciate le cinture di sicurezza perché stiamo decollando davvero”, e poi il florilegio di calembours tristanzuoli che si sa: “Il decollo di Alitalia è il decollo dell’Italia”, e “Se vola Alitalia, viva l’Italia”. Consiglio il video, perché è anche questo un caso di scuola: presentare i desideri come già realizzati, un futuro ipoteticissimo come già avvenuto. Erano gli inizi di giugno del 2015, un anno e mezzo dopo quel decollo collettivo, così aggressivo e burbanzoso, Alitalia sta di nuovo col cappello in mano, i suoi dipendenti tremano, i conti ballano, siamo già all’atterraggio di emergenza.
Metterci la faccia ha questo, di bello, che nel momento in cui ce la metti fai un figurone con tutti, ma dopo, all’apparir del vero o quando il futuro non va come lo speravi, se ne ricordano solo quelli toccati dallo specifico problema. Come i dipendenti Alitalia, nel caso specifico. O come le popolazioni terremotate in un altro caso anche più mesto e doloroso, quando al consiglio dei ministri e poi in dozzine di dichiarazioni, si giocava la carta dell’efficienza “I container entro Natale e le casette in primavera”. Preciso. Definitivo. Poi, appena due mesi dopo, ecco che i conteiner non arrivano, le casette chissà, le poche che ci sono vengono assegnate a sorteggio. Moltissimo (bene) viene dalle donazioni private, dalle associazioni, dal volontariato, dalle raccolte fondi, “L’Italia decolla” si stempera in un più realistico e triste “L’Italia si arrangia”. Si scopre che non ci sono le stalle e il bestiame muore di freddo (gli allevatori lo dicono da settembre) e che intere zone rischiano lo spopolamento, insieme al loro piccolo ma vivo e ramificato tessuto produttivo. L’altro giorno, prime proteste pubbliche, ad Accumoli, altre ne verranno. La retorica volitiva del “metterci la faccia” perde un altro pezzettino, si consigliano i narratori del Grande Rientro di Matteo di pensarne un’altra.
 Agghiacciante prospettiva, terribile destino: per risanare i debiti Alitalia pensa a una mossa geniale, abolire gli snack gratuiti a bordo. Una mossa di grandissimo spessore economico-strategico, se si pensa che il “risanamento” della compagnia di bandiera è costato finora 7,4 miliardi, che serve un altro miliardo per non precipitare, e che quindi tagliando i tarallucci, le patatine e i due millilitri di acqua minerale calda fin qui generosamente distribuiti ai passeggeri, si raggiungerà il pareggio di bilancio intorno al 3027. “A quel punto avranno inventato il teletrasporto e noi saremo salvi”, ha detto Luca Cordero di Montezemolo nel corso di una conferenza stampa a pagamento (1.000 euro per assistere, 2.000 per fare domande).
Agghiacciante prospettiva, terribile destino: per risanare i debiti Alitalia pensa a una mossa geniale, abolire gli snack gratuiti a bordo. Una mossa di grandissimo spessore economico-strategico, se si pensa che il “risanamento” della compagnia di bandiera è costato finora 7,4 miliardi, che serve un altro miliardo per non precipitare, e che quindi tagliando i tarallucci, le patatine e i due millilitri di acqua minerale calda fin qui generosamente distribuiti ai passeggeri, si raggiungerà il pareggio di bilancio intorno al 3027. “A quel punto avranno inventato il teletrasporto e noi saremo salvi”, ha detto Luca Cordero di Montezemolo nel corso di una conferenza stampa a pagamento (1.000 euro per assistere, 2.000 per fare domande).
Si tratta di una vera sorpresa, ardita e imprevedibile, una “mossa del cavallo”, come dice qualche osservatore: infatti tra poco sarà più agevole raggiungere le destinazioni a cavallo piuttosto che con i voli Alitalia.
Naturalmente si tratta solo del primo passo, cui seguiranno altre sorprendenti soluzioni. Se l’abolizione dello snack gratuito, sostituito dallo stesso snack a pagamento, darà i suoi frutti, si passerà alla fase successiva del piano di risparmi: i passeggeri dovranno portarsi i sedili da casa e, nel caso della classe business, l’intero salotto. Le cinture di sicurezza saranno realizzate all’uncinetto dai lavoratori Alitalia in esubero. Per quanto riguarda il combustibile, ogni passeggero dovrà contribuire succhiando dalla macchina, nel parcheggio dell’aeroporto, una tanica di gasolio da consegnare al check-in. Si studiano convenzioni con i taxisti: una trattativa non facile. Restano, per raggiungere il pareggio di bilancio almeno nel millennio, due dettagli non trascurabili: le ali degli aerei sono molto costose, rigide, difficili da spostare da un aereo all’altro, quindi si sta studiando di realizzarle in plastica. E poi si può risparmiare sul costo dei piloti, sorteggiando un passeggero a turno ed affidandogli i comandi.
Non essendoci più da distribuire gli snack il personale di volo sarà ridotto, con un ulteriore risparmio, il che potrebbe far accelerare il pareggio di bilancio, si calcola intorno al 2745. Inevitabile un ridisegno delle rotte: volare consuma molto carburante, per cui si varano nuove tratte come la Fiumicino Terminal A – Fiumicino Terminal B, percorribile a terra tenendo motori al minimo. L’ultima mossa, ma solo se tutto questo non basterà, sarà la riduzione dello stipendio dell’amministratore delegato, che verrà retribuito con gli snack avanzati per ora stoccati nei magazzini dell’azienda.
Qui due recensioni uscite in questi giorni. Quella de Il Libraio (qui c’è il link, e anche un piccolo estratto del libro), e quella di Maria Sole Bramanti per Thriller Nord (link qui)
Massimo Ferrario ha seguito se avventure del Monterossi e lo conosce bene. Qui la sua recensione per Mixtura (immagine i link, qui)
Qui c’è il pezzo di Roberta Scorranese per Sette de Il Corriere della Sera. Tu pensa dove va a infilarsi il Monterossi! Cliccare sull’immagine per leggere
La recensione di Torto Marcio di Pietro Cheli, su Amica. Cliccare sul’immagine per leggere. Chi preferisce il link è qui
 “Mal comune mezzo gaudio” è una frase orribile, senza senso, cinica e destituita di ogni fondamento. Che il mio disagio di italiano senza rappresentanza politica, ficcato come una barchetta al centro del Triangolo delle Bermude, equilontano dai tre poli del tripolarismo nazionale, sia condiviso da molti, non mi dà nessun gaudio, anzi, fa incazzare un bel po’. Sulla figuraccia europea dei Cinque Stelle, e segnatamente del loro leader, viene in mente una battuta di Luttazzi (Berlusconi gliela fregò ai tempi antichi quando cacciava Fini dal partito). “Sapete che uno zio di Fini è morto ad Auschwitz? Sì, è caduto dalla torretta di guardia”. Pessimo gusto, ma fa ridere. Così del Grillo che si fa chiudere la porta in faccia dal gruppo europeo più amico di lobby e poteri forti si può dire: “Ma è ferito! Gli ha fatto male l’Establishment? Ma no! E’ scivolato mentre correva a iscriversi”.
“Mal comune mezzo gaudio” è una frase orribile, senza senso, cinica e destituita di ogni fondamento. Che il mio disagio di italiano senza rappresentanza politica, ficcato come una barchetta al centro del Triangolo delle Bermude, equilontano dai tre poli del tripolarismo nazionale, sia condiviso da molti, non mi dà nessun gaudio, anzi, fa incazzare un bel po’. Sulla figuraccia europea dei Cinque Stelle, e segnatamente del loro leader, viene in mente una battuta di Luttazzi (Berlusconi gliela fregò ai tempi antichi quando cacciava Fini dal partito). “Sapete che uno zio di Fini è morto ad Auschwitz? Sì, è caduto dalla torretta di guardia”. Pessimo gusto, ma fa ridere. Così del Grillo che si fa chiudere la porta in faccia dal gruppo europeo più amico di lobby e poteri forti si può dire: “Ma è ferito! Gli ha fatto male l’Establishment? Ma no! E’ scivolato mentre correva a iscriversi”.
Ora per riassumere: abbiamo tre grandi forze politiche in campo: una che conosciamo bene e che lavora per tenere insieme le spoglie del berlusconismo, una destra Frankenstein Junior; una che ha governato sbagliandole tutte e coniugando in modo superbo arroganza e incompetenza, affarucci privati e la solita minestra liberal liberista fingendosi però di sinistra; e poi un corpo estraneo che entra a gamba tesa (il famoso apriscatole) nel sistema, e in effetti un po’ lo scardina e lo stupisce (oh! Non c’è più il bipolarismo!), ma pratica anche i peggiori vizi e le giravolte ciniche che la politica ci ha insegnato. Iscriversi a un gruppo che dice il contrario di quello che dici tu per avere “visibilità e contare di più” è un carpiato turbo-ideologico di difficile comprensione.
Aggiungerei un altro problema, tanto per gradire. Ed è che ormai scelte, decisioni, errori madornali, gaffes e capitomboli di ognuna delle parti in commedia, non hanno quasi una lettura politica, ma soltanto il peso, per così dire ludico, del rimprovero reciproco. Siamo allo sberleffo costante, come se la vita politica italiana fosse più legata al gusto sadico di veder scivolare l’avversario che alle sorti del povero paese. Con punte di vero surrealismo, come quando Grillo ha parlato di espatri e le tricoteuses del Pd sono saltate su come tappi ad accusarlo di leghismo. Il giorno dopo di espatri ha parlato il governo e tutto a posto, anzi grandi applausi.
Il disagio dell’italiano equilontano è dunque doppio: non solo nessuno lo rappresenta, ma non circola un’idea forte, all’orizzonte si vede solo tattica e nessuna strategia. Mentre si esce e si entra nei gruppi europei, abili come l’ispettore Clouseau, o si gioca il risiko della legge elettorale, o si pensa a trucchi e trucchetti per gabbare il referendum sul Jobs act, non si vede da nessuna parte un’idea di società più giusta. Tutti, distratti dalla guerricciola quotidiana, dalle scaramucce di confine, si scordano di occuparsi del fatto che le diseguaglianze aumentano, e che stanno diventando intollerabili, una cosa allarmante, che può scappare di mano.
Nessuno dei tre poli dice chiaramente il punto primo di un qualunque programma di salvataggio del Paese: cioè che la distanza siderale tra il fattorino che vi consegna le pizze e il banchiere va ridotta, e non aumentata come si fa da decenni. Un’idea, insomma, un disegno, un obiettivo, anche lontano, anche difficile, ma chiaro e preciso. Ridurre le diseguaglianze sarebbe una buona corrente per spingere l’equilontano con la sua barchetta verso un polo o verso l’altro, ma non succederà, perché il piccolo cabotaggio trionfa. La prima esigenza della politica italiana è quella di poter cambiare idea al volo per motivi tattici, il che impedisce di avere grandi idee. Visto da qui, dal centro esatto del triangolo delle Bermude, lo spettacolo è piuttosto deprimente.
 Dunque, il 12 gennaio esce Torto marcio, il nuovo romanzo. Su carta, in E-book, in libreria, prenotabile su Amazon e su Ibs, insomma, chi lo vuole non farà fatica a procurarselo. E’ il quarto romanzo con Carlo Monterossi, c’è tutta la sua banda e soprattutto c’è una storia cattiva, che viene da lontano ma si incastra qui nel presente, tempi duri quelli e tempi duri questi.
Dunque, il 12 gennaio esce Torto marcio, il nuovo romanzo. Su carta, in E-book, in libreria, prenotabile su Amazon e su Ibs, insomma, chi lo vuole non farà fatica a procurarselo. E’ il quarto romanzo con Carlo Monterossi, c’è tutta la sua banda e soprattutto c’è una storia cattiva, che viene da lontano ma si incastra qui nel presente, tempi duri quelli e tempi duri questi.
Della trama, si sa, non si può dire molto, perché è pur sempre un giallo, un noir, un… beh, insomma, vi metto qui la scheda dell’editore con la quarta di copertina e tutto il resto, così vi fate un’idea.
Posso dire che ci tengo molto, per molti motivi, ma anche perché credo che si precisi qui un discorso già iniziato con Di rabbia e di vento, un discorso sulla giustizia com’è e come la vorremmo, che sono due cose che non si somigliano molto.
Poi è una storia, questo mi sembra importante, se si scrive una storia.
Tante volte nelle presentazioni, nelle interviste, viene fuori questa cosa che si dice sempre: il giallo è un pretesto per raccontare la società… Ma sì, sarà anche vero, anzi è vero di sicuro, ma certe volte non si capisce quanto la storia descriva i tempi e quanto i tempi facciano la storia, la disegnino, in qualche modo la contengano, generandola. Qui c’è Milano, come al solito quando c’è il Monterossi di mezzo, ma c’è anche di più, ci sono delle vite, diversissime, di questi tempi nostri.
Come al solito troverete qui sul sito le recensioni, la rassegna stampa ecc ecc. I vostri commenti sono ovviamente graditissimi.
Che giovedì o venerdì dovete andare il libreria ve l’ho già detto, vero?
 Se davvero vi interessa il dibattito sulla post-verità – la costruzione di bufale intesa a cambiare la storia e a piegare gli avvenimenti della politica – vi consiglio di cercare un piccolo filmato su Youtube, datato febbraio 2003. Molto istruttivo. Si vede Colin Powell, allora Segretario di Stato americano, che parla alle Nazioni Unite e agita una fialetta di polvere bianca. Dice che è antrace, che Saddam Hussein ne produce tonnellate. Poi fa vedere delle vaghe fotografie satellitari e dice che lì Saddam sta costruendo armi di distruzione di massa, e insomma pone le basi, con quel discorso, dell’aggressione americana all’Iraq. Tony Blair faceva un discorsetto analogo ai suoi compatrioti. Entrambi qualche anno dopo – Colin Powell e Tony Blair – ammetteranno di aver diffuso notizie false sapendo che erano false. Colin Powell – qualche anno dopo convinto sostenitore di Obama – definisce ancora oggi quel discorso “una macchia sulla sua carriera”. Ma sì, una macchiolina da un milione di morti, che volete che sia. Macchia e non macchia, entrambi i diffusori di quelle micidiali menzogne sono oggi a piede libero, ammirati e riveriti e, nel caso di Blair, addirittura portati ad esempio della “sinistra che vince” (ommioddio, ancora!).
Se davvero vi interessa il dibattito sulla post-verità – la costruzione di bufale intesa a cambiare la storia e a piegare gli avvenimenti della politica – vi consiglio di cercare un piccolo filmato su Youtube, datato febbraio 2003. Molto istruttivo. Si vede Colin Powell, allora Segretario di Stato americano, che parla alle Nazioni Unite e agita una fialetta di polvere bianca. Dice che è antrace, che Saddam Hussein ne produce tonnellate. Poi fa vedere delle vaghe fotografie satellitari e dice che lì Saddam sta costruendo armi di distruzione di massa, e insomma pone le basi, con quel discorso, dell’aggressione americana all’Iraq. Tony Blair faceva un discorsetto analogo ai suoi compatrioti. Entrambi qualche anno dopo – Colin Powell e Tony Blair – ammetteranno di aver diffuso notizie false sapendo che erano false. Colin Powell – qualche anno dopo convinto sostenitore di Obama – definisce ancora oggi quel discorso “una macchia sulla sua carriera”. Ma sì, una macchiolina da un milione di morti, che volete che sia. Macchia e non macchia, entrambi i diffusori di quelle micidiali menzogne sono oggi a piede libero, ammirati e riveriti e, nel caso di Blair, addirittura portati ad esempio della “sinistra che vince” (ommioddio, ancora!).
Questo per dire che la post verità non è cosa proprio nuovissima, e che quella con cui ce la prendiamo oggi è faccenda minuscola rispetto a certe post-verità che hanno ammazzato centinaia di migliaia di innocenti.
E poi, a dirla tutta, la storia è piena di post-verità inventate per giustificare le più solenni e dolorose porcate. Il diciassettenne ebreo Hershel Grynszpan che nel novembre del 1938 sparò a Parigi al diplomatico nazista Ernst von Rath, fu sbandierato come l’esempio migliore della cattiveria ebraica, e consentì di mettere in atto quella “Notte dei cristalli” (9 e 10 novembre 1938, decine di sinagoghe date alle fiamme, migliaia di negozi proprietà di ebrei bruciati e saccheggiati, SS in gran spolvero) che avviò la persecuzione degli ebrei. Recenti ricerche storiche hanno svelato che il ragazzo aveva una storia con il diplomatico, che gli aveva sparato per questioni, diciamo così, personali, e che dunque su di lui fu costruita una micidiale post-verità che alla fine, presentando il conto, arrivò a un totale di milioni e milioni di morti.
Naturalmente – che seccatura – in questi come in altre centinaia di casi, la costruzione di post-verità non era affidata ad anonimi leoni da tastiera, piccoli o grandi truffatori anonimi che cavalcano l’indignazione per costruite bufale, ma dal potere stesso, nel caso dell’Iraq addirittura da due governi democratici liberamente eletti.
Ecco dunque un paio di casi in cui un’Authority governativa preposta al controllo della verità non avrebbe frenato la bufala, anzi l’avrebbe agevolata come da direttive politiche, come da “superiore interesse della nazione”, che era, in quel momento, far fuori Saddam accusandolo con prove false.
Se il dibattito sulla post-verità a cui assistiamo oggi ci sembra un po’ surreale, insomma, è anche perché punta a vedere la costruzione di false notizie come incontrollabile: si pensa che oscure e anonime minoranze nascoste dietro una tastiera possano cambiare il destino di popoli e nazioni, mentre i governanti, poveretti, si dannano l’anima per difendere la verità dei fatti. Insomma: l’allarme sulla post verità diventa allarme perché le bugie vengono dal basso e non dall’alto. Basta un po’ di conformismo, qualche piagnisteo degli sconfitti e qualche vergognoso esempio di bufala in rete (gli immigrati portano la menengite in Toscana! Ridicolo) per far gridare al pericolo e all’attentato alle istituzioni. E’ la post-verità cattiva del popolino gretto e ignorante. Vuoi mettere con quella smerigliata e cristallina del potere?
 Moltitudini e marmaglie si affollano per partecipare: la Top 10 della mediocrità politica corrente dovrebbe essere una Top 100, una Top 1000. Ma restiamo nelle regole. Ecco i dieci peggiori dell’anno.
Moltitudini e marmaglie si affollano per partecipare: la Top 10 della mediocrità politica corrente dovrebbe essere una Top 100, una Top 1000. Ma restiamo nelle regole. Ecco i dieci peggiori dell’anno.
Renzi Matteo. Come quei motivatori aziendali che ti spingono a camminare sulla pizza margherita, istigatori di un futuro tutto pro domo loro, ha occupato la scena come e più di Silvio Berlusconi. Disastro. Eppure ancora oggi, con la nuova narrazione fatta di sguardi sperduti al supermercato, ci si ostina a criticarne il metodo e non il merito. Ma la bullesca personalità e l’ego ipertrofico, servono a sviare dalle vere colpe. Che sono di pura inefficienza. Doveva fare, con il suo governo, la legge elettorale, e ha partorito quell’Italicum che oggi schifano tutti, pure lui. Della riforma costituzionale si sa la portata della sconfitta, il resto (jobs act, buonascuola) non viene più nemmeno nominato tra le medaglie di cui fregiarsi. Dunque non si tiene conto qui, di simpatia, antipatia, né della provincialissima categoria della renzità, né dell’infantile storytelling, ma solo dei risultati. Che sono zero, con aggravanti. Lo rivedremo, sì, ma di nuovo non avrà nulla, niente male per un “nuovista”.
Voto: 0 Tanto rumore per nulla
Napolitano Giorgio. Il ribaltamento del soprannome togliattiano ne “il Peggiore” parrebbe un record notevole, eppure. Grande spingitore di governi tecnici o para-tecnici, o di scopo, o di ego, è stato il primo a personalizzare il referendum – si potrebbe dire: con il culo degli altri – fin dalla storica intervista al Corriere (“O il sì o il nulla”). Poi, a frana avvenuta, silenzi e piccole grida, non ultima l’accusa – da mandante – all’esecutore materiale, quel giovinotto di cui sopra, che “ha personalizzato”.
Voto 1 Con viva e vibrante soddisfazione
Poletti Giuliano. La pessima legge che “uberizza” il lavoro, scritta tra palazzo Chigi e Confindustria, lo ha costretto a mentire sui numeri, più volte sbugiardato. Chi s’indigna per sue gaffes (l’ultima: che certi italiani emigrati è meglio non averli tra i piedi) manca di fare il salto decisivo: non si tratta di inciampi, ma di perfetti precipitati della sua cultura post-contadina, trasportare cassette come éducation sentimentale del giovane italiano, darsi da fare, non farla lunga coi diritti… E’ tutta un’ideologia primitiva, una Weltanschauung da cacciatore-raccoglitore, una retorica di “ai miei tempi…”, presentata però come faro di innovazione e dinamismo. Dimostrare così plasticamente come siano antiche le strategie della modernità confindustriale (trattali male, pagali peggio) è buona mossa, ma totalmente inconsapevole.
Voto 2 Primitivo
Salvini Matteo. Nella top ten dei peggiori ha un suo posto d’onore, ma non per meriti acquisiti, che non ha, e non per particolari demeriti pratici, che non ha, essendo ininfluente. Il suo tentativo di coinvolgere il ceto medio sofferente nelle battaglie che furono delle tribù pedemontane quando “le pallottole costavano 300 lire” (cfr. Bossi buonanima) è solo ronzare di tweet, insulti razzisti, ricette facili-facili a problemi complessi. E’ la vera semplificazione: perché inventare i satelliti quando si può mollare un colpo di clava?
Voto 3 Fasci da compatimento
Raggi Virginia. Si guadagna un angolino nella top ten in qualità di unica Cinque Stelle in ottima posizione di potere. Ha molti nemici, quelli che non le perdonano le tute di pile e la casa in periferia, peccati capitali agli occhi dell’establishment più dell’ignavia nell’arte di governo. Ma insomma, che non dovesse circondarsi di certa gente glielo dissero tutti, in tutte le lingue e più volte. Di gran lunga la politica più attaccata e con meno responsabilità sul passato, ma questo non toglie il disagio di vedere una vittoria storica macerare nell’inanità. Con tutto che a Roma non si trova un cittadino – dicasi uno – che sostenga: “erano meglio quelli di prima”.
Voto 5 Paralizzata
Boschi Maria Elena. Partita con enormi applausi sulla fiducia, è arrivata con la messa ai margini in quanto controproducente nel furore della battaglia. Inadatta a quasi tutto, ha alla fine salvato le due categorie che la descrivono: testarda e secchiona, ma secchiona per fare cosa e testarda per dire che non si è capito. Promossa sul campo per manifesti demeriti – demeritocrazia! – si trova a gestire in franchising un potere meno celebrato dai media, meno coccolato, con gran scorno dei numerosi cicisbei che “Uh, che brava Maria Elena!”. Ma brava de che?
Voto 2 Chiacchiere e distintivo
Lotti Luca. Pettinato come un Rod Stewart che ha preso la scossa, doveva essere l’astuto Mazarino di Renzi, all’occorrenza il mistr Wolf che risolve i problemi Poi, all’apparir del vero, eccolo mediocre brigatore di nomine e pressioni (sulla stampa, di cui custodisce le deleghe), un aiuto regista del sottogoverno. Divertente l’idea di bramare la delega ai servizi segreti, che, per uno indagato per diffusione di segreto, non è ambizione da poco.
Voto 3 Ribollito
D’Anna Vincenzo e Barani Lucio. Si scuserà l’accoppiata, ma non bastava uno a fare un vero personaggio. Così eccoli affiancati, gli alfieri verdiniani di Ala. Uno pronto ai gestacci sessisti, l’altro provvidenziale accorruomo per dittatori con cui facciamo affari (su Giulio Regeni disse il suo schifoso se l’è cercata). Più di Verdini, sono l’anima del verdinismo, di un estremismo centrista foriero di risse verbali e giochi di corrente. Insieme, hanno cambiato più partiti che mutande, che non è vietato, ma ridicolo sì.
Voto 2 + 2 = 4 Vecchietti del Muppet’s Show
Vincenzo De Luca. Profeta del “clientelismo come Cristo comanda”, piazza i figli, insulta, dileggia e spinge all’estremo l’antica arte del sarcasmo dei potenti, come un Pulcinella inopinatamente arrivato a Palazzo. Poi, quando serve (alle comunali, al referendum) non arriva mai, manco fosse Godot. Decisionismo senza decisioni, superiorità esercitata dal piano terra.
Voto 4 Personaggetto
Lorenzin Beatrice. Si direbbe contemplata tra il peggio dell’anno per le scemenze sul Fertility day, ma la statura quella è, non è che si può chiedere troppo. Invece finisce in classifica per quel tagli alla sanità (oltre 400 esami che ora pagate, e prima di lei no) accompagnati dal refrain “Non abbiamo tagliato la sanità”. Poi uno va, gli prendono il sangue e lo fanno pagare. Si dirà: esecutrice, non mandante. Embé? Si è peggiori anche così, da “volenterosi carnefici”.
Voto 4 Caratterista
 Ma chi l’avrebbe detto che Babbo Natale, sceso dalla slitta ed entrato di soppiatto nelle nostre case, ci avrebbe portato, poggiandola con nochalance sotto l’albero, una bella confezione-famiglia di marce indietro sul prodigioso Jobs act. Quella legge che rilanciava il lavoro, quella per cui Giuliano Poletti dava i numeri al Lotto, corretto e bacchettato ad ogni esternazione, la legge che teorizzava che licenziare era un toccasana, perché si sarebbe fatto spazio ad altri. Una specie di grandiosa ammuina: quelli che stanno a prua vadano a poppa… quelli a poppa vadano a prua… quelli che lavorano li cacciamo, così possono lavorare un po’ gli altri. La legge che portava la modernità contro quei maledetti corpi intermedi vecchi come il gettone del telefono. La legge dei voucher, soprattutto. Se ne vendevano mezzo milione all’anno, prima del Jobs act, e poi, dopo la rivoluzione di Renzi e Poletti, nel 2016, si è arrivati a 160 milioni. Niente male per chi diceva di aver “abolito il precariato”, e nemmeno gli veniva da ridere mentre registrava un videomessaggio in cui diceva che non pensava alla Thatcher, ma a Marta, a Giuseppe e alle loro vite da Co.co.co… Era una retorica buona fino al 4 dicembre, quando alcune centinaia di migliaia di Marte e Giuseppi, passati da Co.co.co a vaucheristi, gli hanno fatto – non precariamente – il gesto dell’ombrello.
Ma chi l’avrebbe detto che Babbo Natale, sceso dalla slitta ed entrato di soppiatto nelle nostre case, ci avrebbe portato, poggiandola con nochalance sotto l’albero, una bella confezione-famiglia di marce indietro sul prodigioso Jobs act. Quella legge che rilanciava il lavoro, quella per cui Giuliano Poletti dava i numeri al Lotto, corretto e bacchettato ad ogni esternazione, la legge che teorizzava che licenziare era un toccasana, perché si sarebbe fatto spazio ad altri. Una specie di grandiosa ammuina: quelli che stanno a prua vadano a poppa… quelli a poppa vadano a prua… quelli che lavorano li cacciamo, così possono lavorare un po’ gli altri. La legge che portava la modernità contro quei maledetti corpi intermedi vecchi come il gettone del telefono. La legge dei voucher, soprattutto. Se ne vendevano mezzo milione all’anno, prima del Jobs act, e poi, dopo la rivoluzione di Renzi e Poletti, nel 2016, si è arrivati a 160 milioni. Niente male per chi diceva di aver “abolito il precariato”, e nemmeno gli veniva da ridere mentre registrava un videomessaggio in cui diceva che non pensava alla Thatcher, ma a Marta, a Giuseppe e alle loro vite da Co.co.co… Era una retorica buona fino al 4 dicembre, quando alcune centinaia di migliaia di Marte e Giuseppi, passati da Co.co.co a vaucheristi, gli hanno fatto – non precariamente – il gesto dell’ombrello.
Ma torniamo a Babbo Natale. Accortosi da qualche trafiletto sui grandi giornali che il referendum promosso da quelli là – quelli del gettone del telefono, antichi, anziani, ideologici, pussa via – potrebbe essere accolto, ecco la scatola di montaggio con dentro tutte le nuove visioni del mondo e le autocritiche: bisogna regolare, prevedere multe per chi abusa, controlli più efficaci, eccetera, eccetera. E anche ora non gli viene da ridere, mentre alle Marte e ai Giuseppi sì, anche se amaro.
Dunque ora sono tutti d’accordo, si direbbe, il Poletti furioso, il presidente dell’Agenzia nazionale per il lavoro Del Conte – messo lì da Renzi – che dice addirittura (al Corriere) che “Gli effetti sono stati opposti a quelli previsti”, poi le pagine dell’economia, i commentatori, gli ex-entusiasti di colpo diventati critici e pensosi. Sono i miracoli dei referendum: non fossero arrivati sul tavolo della Consulta i quesiti della Cgil, Babbo Natale ci avrebbe portato le solite sciapine e i soliti golfini, e non le accorate e tardive preoccupazioni sul lavoro vaucherizzato. Tanto è vero che qualche voce dal sen fuggita lo dice: mica è per raddrizzare le orribili storture del mercato del lavoro che si metterà mano (forse) alla discipina nefasta dei voucher, ma perché non ci si può permettere – coté renzista – un’altra sberla referendaria. Insomma, care Marte e Giuseppi, mica lo fanno per voi: lo fanno per loro, qualcosa si inventeranno, tranquilli, non lo vedere il padulo che già si libra nell’aere?
Senza contare che sì, va bene, uff, che palle, sui voucher si farà qualcosa, ma sull’articolo 18 (altro pezzo del Jobs act sotto scacco referendario) no, quello è la linea del Piave, altrimenti (ancora Del Conte) “Amazon e Google sarebbero tentati di andar via”. Porca miseria, che rischio. Comunque, tranquilli, come ha già detto il ministro Poletti in una delle sue dadaiste esternazioni, se proprio si dovrà votare al referendum sul lavoro, basterà piazzargli di traverso le elezioni politiche, in modo da farlo saltare. Genio. Si registra comunque, ora che Babbo Natale se n’è tornato là da dove è venuto, che tra Natale e Capodanno dell’anno 2016 si è consumato il grande testacoda: il toccasana è diventato una polpetta avvelenata, il “superamento” (ahah!) del precariato si è rivelato un moltiplicatore di sfruttamento e tutti sono più buoni. Finché non trovano il trucco giusto. Buon anno.
 La terrificante profezia di Oscar Farinetti (“Dobbiamo tornare simpatici”) sta per compiersi. Matteo Renzi l’ha pure detto durante l’assemblea nazionale del Pd: “Siamo stati efficienti, ma non siamo stati empatici”. Dunque ora, davanti a una campagna elettorale che durerà mesi, si abbatterà su di noi un uragano di simpatia, una punizione così dura che non si ebbe nemmeno il coraggio di metterla tra le dieci piaghe d’Egitto. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Ipnosi, è in grado di rivelare le nuove linee guida della narrazione renziana a cui narratori, comunicatori e guru dovranno attenersi fino alla vittoria finale.
La terrificante profezia di Oscar Farinetti (“Dobbiamo tornare simpatici”) sta per compiersi. Matteo Renzi l’ha pure detto durante l’assemblea nazionale del Pd: “Siamo stati efficienti, ma non siamo stati empatici”. Dunque ora, davanti a una campagna elettorale che durerà mesi, si abbatterà su di noi un uragano di simpatia, una punizione così dura che non si ebbe nemmeno il coraggio di metterla tra le dieci piaghe d’Egitto. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Ipnosi, è in grado di rivelare le nuove linee guida della narrazione renziana a cui narratori, comunicatori e guru dovranno attenersi fino alla vittoria finale.
Volto umano – Come ha detto Delrio in televisione, Matteo è molto cambiato, è umile e va a fare la spesa, e siccome da solo si annoia ci va coi fotografi di Chi, l’organo ideologico di casa Berlusconi. Dunque, ripartire dal quotidiano. Matteo che rimbocca le coperte ai figli, Matteo che sbaglia l’ammorbidente, Matteo che fa la maionese: diffondere e sostenere il nuovo volto di Matteo dovrà essere il nuovo corso della narrazione renziana. Però la faccia sperduta davanti agli scaffali dice tutto il suo sconcerto: da “un uomo solo al comando” a “un uomo solo al carrello”. Proprio lui, che aveva negato l’appoggio ad Anna Finocchiaro per la presidenza della Repubblica perché l’avevano beccata a far la spesa all’Ikea con la scorta che spingeva il carrello, beccandosi in risposta un “miserabile”, eccolo ora a concordare il servizio fotografico in versione massaio. Nemesi storica: ora lei fa la ministra al posto della Boschi buonanima, e lui fa la spesa con la faccia sperduta del “che ci faccio io qui”. Ma come che ci fa? Un servizio per Chi! La nuova narrazione dal volto umano. Seguirà lo speciale “Matteo appende una mensola” e il tutorial “Taglia il salame con Matteo Renzi”.
Gattini – Per gli addetti al web. Postare in rete molti gattini, che sono teneri e divertenti. Per il pubblico giovane: postare gattini che giocano alla playstation con Orfini, e vincono. Il gattino comunica dinamismo, simpatica follia, casa, focolare. Per convegni e dibattiti, cercare citazioni sul gattini: cosa diceva Max Weber? E Caetano Veloso? E Churchill? Sempre sui gattini, ovvio. Aggiungere a piacere frasi celebri che nessuno può controllare. Slide con tanti gattini che salvano le banche. Per la scuola: gattini tristi perché hanno i supplenti, gattini felici perché hanno il professore di ruolo.
Outfit operaio – Le fotografie del premier (ex) in visita alle fabbriche di amici e finanziatori con gli operai sorridenti accanto al padrone, vestiti alla perfezione in divisa, elmetto di sicurezza, tute intonse appena stirate, hanno fatto il loro tempo. Il nuovo corso della narrazione dovrà mostrare operai più credibili, magari mentre scartavetrano il gratta e vinci, bestemmiano contro il governo, parlano di calcio, bevono il prosecco,. Si consiglia di portare via il Segretario dopo il terzo prosecco, prima che gli scappi la frase: “Lo champagne di Marchionne era più buono”.
Giovani – I grandi traditori del nuovo corso renziano, i famosi giovani, non sono stati convinti, peccato. Mostrarsi con davanti un computer un iPhone e in mano può impressionare gli ottuagenari (uh, che diavoleria!), ma non uno che davanti a un computer sta seduto tutto il giorno per due lire. Dunque, il nuovo storytelling punterà molto sull’empatia: diffondere e ritwittare le immagini del Segretario che si fa un piercing. Nei tatuaggi, evitare frasi troppo roboanti (tipo “Mille asili in mille giorni” o “L’Expo è stato un grande successo”). Meglio i tatuaggi tribali, non necessariamente di antiche tribù aborigene toscane. Si consiglia ampia diffusione sui social network delle immagini del Segretario che arriva al Nazareno in skateboard.
Bufale – “Abbiamo perso sul web” (Renzi all’assemblea del Pd) è una mesta constatazione, ma anche un atto d’accusa verso chi mente, inventa post-verità e diffonde falsità in rete. Dunque evitare d’ora in poi la diffusione di bufale online, frasi come “Il sistema bancario italiano è solido” o “Abbiamo abolito il precariato”, battute che hanno fatto ridere quasi tutti. Sostituire gli slogan con fatti concreti, tipo i gattini, ecco.
 Osservare il governo Gentiloni sarà come guardare la televisione con Renzi che tiene il telecomando. Però – anche se può spegnersi da un momento all’altro – non sottovalutiamo lo spettacolo dell’unico governo nella Galassia in cui il ministro dello Sport nominerà i vertici di Eni, per dirne una. Bizantinismi del potere renziano. Ma quello che è giusto è giusto e bisogna ringraziare il governo Gentiloni di una cosa: nel giro di poche ore ha fatto piazza pulita di tutte le retoriche puttanate che sentiamo da anni a proposito di “premiare il merito”.
Osservare il governo Gentiloni sarà come guardare la televisione con Renzi che tiene il telecomando. Però – anche se può spegnersi da un momento all’altro – non sottovalutiamo lo spettacolo dell’unico governo nella Galassia in cui il ministro dello Sport nominerà i vertici di Eni, per dirne una. Bizantinismi del potere renziano. Ma quello che è giusto è giusto e bisogna ringraziare il governo Gentiloni di una cosa: nel giro di poche ore ha fatto piazza pulita di tutte le retoriche puttanate che sentiamo da anni a proposito di “premiare il merito”.
Questa annosa questione di “premiare il merito” ci viene recitata in accorate novene, allarmati appelli e invocazioni ad ogni discorso pubblico. Il pippone didattico-darwinista che chi è bravo deve andare avanti, che il talento va premiato, che bisogna battersi con la vita come leoni nella savana, è un classico imperituro di un paese che è molto nepotista e molto ereditario. E’ una specie di regola, per cui più si parla di una cosa e meno la si pratica, vale per lo sport, per il sesso, e pure per il merito. Ora il nuovo governo mette un punto decisivo sulla questione: tutte fregnacce, si può essere molto mediocri ed essere premiati lo stesso. Si può cannare completamente il compito assegnato ed essere promossi con lode. Immaginate lo sconcerto di uno che va a scuola e si ritrova in classe, al primo banco, cocca della prof, quella biondina bocciata l’anno scorso con tutti quattro in pagella.
Grazie, grazie, grazie, finalmente cade il velo su quella assurda questione che per fare qualcosa bisogna saperla fare. E invece la nuova compagine ministeriale libera lo spirito ardimentoso che è in noi, e ognuno penserà: beh, se dopo il disastro causato a colpi di voucher e licenziamenti Poletti può fare ancora il ministro del lavoro, perché io non posso costruire un missile, aggiustare una caldaia, fondare una corrente pittorica?
Insomma, l’ascensore sociale è bloccato, le scale sono insaponate, ti fanno il bel discorsetto sul merito e sul meritarsi le cose. Dopo una giornata in cui ti sei fatto un merito così, vai a casa, accendi la tivù e vedi Marianna Madia, che ha appena preso quattro nella sua materia, che viene promossa e ri-giura da ministro. Di Maria Elena Boschi non serve quasi dire: la sua è una promozione clamorosa, un’incoronazione, una specie di giubileo in ode alla sconfitta. Come stappare lo spumante dopo Caporetto, come promuovere il comandante Schettino a capo della Marina, davvero incomprensibile. Con il che si capisce che non solo il merito (e vabbé), ma pure la sconfitta, personale, tecnica e politica, non c’entrano più nulla con l’essere promossi o bocciati. Se la signora Finocchiaro, che è stata relatrice al Senato di una riforma presa a ceffoni dagli italiani, giura come nuovo ministro delle riforme, allora vale tutto. E si spiega in un solo modo: le ruote hanno perso aderenza, si sbanda di brutto, la distanza tra quel che sente il paese e chi lo governa è così siderale, vertiginosa, incolmabile, che non basterà qualche trucchetto della narrazione. Chi si fosse addormentato sabato 3 dicembre e svegliato ieri, avrebbe detto: “Oh, cazzo, ha vinto il Sì, ma dov’è Matteo, manca solo lui”. Il giuramento del governo Premiare-il-merito, in quel meraviglioso salone quirinalizio, aveva questa volta un sapore di decadenza vera. Una solenne cerimonia, a Versailles, nell’estate del 1789, mentre fuori impazza lo scontento, la rabbia, il disamore. I vecchi notabili, i piccoli impiccioni di corte, le mezze figure che hanno potere vero, le contessine delle riforme bocciate che ancora guidano il minuetto. Matteo sta sul divano con il telecomando in mano. Guarda questo film in costume pronto a spegnere quando conviene a lui e di quelli fuori da Versailles chi se ne frega. Se ne faranno una ragione (cit).
Caro Michele,
ho letto con attenzione il tuo aperto – direi conquistato, posso? – sostegno alla “proposta Pisapia” (oggi su Repubblica, lo trovate qui) con conseguente pippone (mi consenta) sulla sinistra che dice sempre no, no, no. Non un argomento nuovo, diciamo, visto che ci viene ripetuto da tre anni almeno: vuoi mangiare la merda? No. Uff, dici sempre no.
Ma prima due premesse. Giuliano Pisapia è stato il mio sindaco, uno dei migliori degli ultimi decenni (oddio, dopo Albertini e Moratti…), credo anche di essere stato tra i primi a firmare un appello per la sua candidatura a sindaco di Milano, altri tempi. Ricordo che il giorno del ballottaggio (suo contro la mamma di Batman) avevo una prima a teatro, e sarà stato il clima in città, la tensione della prima, l’aria di attesa di un’elezione che squillava come un 25 aprile, ma ricordo quei giorni come giorni di grande gioia. Di come poi quell’entusiasmo si sia un po’ smorzato nella pratica quotidiana e nella maldestra uscita di scena di Pisapia non è qui il caso di dire.
Seconda premessa: non ho tessere in tasca, a parte quella dell’Anpi (una volta avevo quella dell’Inter, altri tempi pure quelli), e faccio parte di quella sinistra-sinistra “mai con Renzi”, come la chiami, senza essere né un “blogger trentenne a corto di letteratura” né “solido quadro di partito”. Vivo (bene) del mio lavoro, ho una casa, una macchina, due figli che vanno alla buonascuola e tutti i comfort, anche quelli inutili, del presente. Insomma, non vivo su Saturno, né abito in una comune, né coltivo il culto del Grandi Padri del Socialsmo buoni per le magliette. Mi trovo, nel grottesco tripolarismo italiano, nella felice posizione di equilontano.
Ma veniamo ai tuoi argomenti (in sostegno fiero e pugnace alla proposta Pisapia). Attribuisci alla “sinistra del no” una specie di pregiudizio insormontabile: non vuole Renzi segretario del Pd, lo considera un corpo estraneo alla storia di quel partito e della sinistra in generale (anche quella che ha detto troppi sì, a Napolitano, a Monti, alla Fornero…), lo schifa e lo irride come fosse un leader della destra.
Insomma, quei cattivoni della “sinistra del no” non praticano il principio di realtà, che il Pd oggi è Renzi, e quindi rifuggono alle sirene di un lavoro comune. Di più e peggio. Dici che il renzismo non è la causa di questa diffidenza, ma ne è invece l’effetto. In soldoni: Renzi sarebbe Renzi (arrogante, decisionista, sprezzante nei confronti del dibattito, insofferente ai distinguo e alle opinioni diverse), proprio per colpa loro.
Mah, io preferirei parlare di politica, la psicoanalisi dei leader mi interessa pochino.
E sia, allora: immaginiamo lo scenario. Una sinistra-sinistra guidata da Guliano Pisapia va a sostenere Renzi e quel che resta del renzismo, in modo da cacciare il sor Verdini e la sua cricca, Alfano, parlandone da vivo, e compagnia cantante. Intanto, un problemino. Naturalmente non si può parlare di una vittoria al referendum della sinistra-sinistra (a meno che non si voglia intestarle il 60 per cento, sarebbe ridicolo tanto quanto Renzi che si intesta il 40), ma dire che aveva visto giusto (con l’Anpi, l’Arci, Zagrebelsky, la Cgil… mica pochi, eh!) sì, quello si può dire. E allo stesso modo si può dire che Pisapia, con il suo Sì al referendum si sia schierato, in una scelta di-qua-o-di-là, contro la parte che aveva ragione, e lui torto. E’ già un’incrinatura: uno sconfitto federa e unisce i vincitori per andare a sostenere un ipotetico governo del capo degli sconfitti. Non suona male? E anche i tempi suonano male: se Pisapia avesse lanciato il suo sasso prima del referendum, il suo “Che fare?” sarebbe stato più denso e credibile. Proposto così, il giorno dopo la sconfitta, sembra solo un piano b, una via d’uscita dal cul de sac. E’ come se i napoleonici chiedessero a inglesi e prussiani di fare pace con Napoleone non il giorno prima, ma il giorno dopo Waterloo, un po’ surreale. E ho il sospetto (sono rognoso e diffidente) che questa uscita dal cul de sac, sia anche un perfetto piano b per riportare in gioco i pentiti del Sì: commentatori, intellettuali, corsivisti, guru, bon vivants, vip, filosofi, psicologi leopoldi che si sono schierati con Renzi e ora non vogliono tramontare con lui. Scusa, retropensiero maligno, succede. perdonami.
Ma poi: ammettiamo che una “sinistra-sinistra” che dice sempre no dicesse sì, e andasse a vedere le carte di questo mirabolante governo senza Verdini ma con Landini (semplifico), cosa porterebbe? Cosa chiederebbe?
Ok, programma di massima. Via la legge sul lavoro scritta da Confindustria. Via il pareggio di bilancio in Costituzione (strano: Renzi ha tuonato e tuonato contro quel vincolo, ma poi, volendo cambiare 47 articoli della Costituzione, non l’ha messo nella sua riforma). Via la buonascuola e le sue stupide visioni aziendalistiche. Via riforme e riformette fatte per compiacere questo o quel potere o poterino (le concessioni per le trivelle, le banche degli amici, i bonus, le regalie, le nomine, l’occupazione della Rai, i bonifici una tantum al posto dei diritti…).
cambiare 47 articoli della Costituzione, non l’ha messo nella sua riforma). Via la buonascuola e le sue stupide visioni aziendalistiche. Via riforme e riformette fatte per compiacere questo o quel potere o poterino (le concessioni per le trivelle, le banche degli amici, i bonus, le regalie, le nomine, l’occupazione della Rai, i bonifici una tantum al posto dei diritti…).
In pratica si andrebbe a governare con Renzi con il presupposto di cancellare ciò che ha fatto Renzi. Non credo sia un caso, Michele, che quando passi dalla teoria (il pippone contro i cattivoni del no no no) agli esempi (quel che di buono ha fatto Renzi) citi solo e soltanto la legge sui diritti civili. Bene, evviva, hurrà. Ma su tutto il resto glissi, silenzio. Davvero pensi che una sinistra-sinistra possa governare insieme a chi ha “vaucherizzato” (pardon) il mondo del lavoro? Davanti a chi non solo ha colpito (articolo 18) ma anche irriso i lavoratori dipendenti? Con chi ha usato il sarcasmo per descriverne la patetica antichità? Con chi ha detto “ciaone” e si è inventato la frase idiomatica “ce ne faremo una ragione” che – ammetterai – suona come un moderno “me ne frego?”. Con chi, per “disintermediare” e cioè per evitare mediazioni e politica, ha sputato in faccia ai corpi intermedi che rappresentano il lavoro flirtando invece con quelli che rappresentano il capitale, la finanza? (il tuo omonimo finanziere a Londra passato per ideologo di quella roba lì, il renzismo, è un caso di scuola).
Riassumo: si chiederebbe alla sinistra-sinistra di andare a sostenere una destra sbrigativa, decisionista e a-ideologica, che penalizza i bassi redditi, non difende i giovani né i ceti medi, che toglie l’Imu anche alle ville dei cumenda, che regala 500 euro ai figli diciottenni sia del notaio che del bracciante. Insomma, lo dico male, che in tre anni ha fatto di tutto – ma di tutto – per aumentare le diseguaglianze, e non per ridurle o attenuarle. In sostanza: è bella la cornice (le varie anime della sinistra che dimenticano il referendum e si ritrovano in pizzeria) ma fa schifo il quadro (una delle due sinistre non è di sinistra per niente e ha fatto molte delle cose che la destra ha sempre sognato di fare, più il tentativo di stravolgimento della Costituzione, che non è un dettaglio). In sostanza si sollecita (nobile intento) l’unità della sinistra con una forza molto forte (il Pd renzista) che di sinistra non è nemmeno lontanamente, ma nemmeno col binocolo.
 E poi c’è un’altra cosa: insieme, Michele, abbiamo visto dalla scialuppa pirata di Cuore (e riso parecchio) il craxismo tronfio e grottesco, il berlusconismo delle furbate e delle scappatoie. Possibile che tu non veda nel renzismo (nel ciaone, nel “gettone del telefono” degli operai, nella celebrazione seppiata delle foto da agenzia Stefani di Nomfup, nelle strette di mano a Marchionne, nella retorica leopolda, potrei continuare per ore) una differenza che non è più nemmeno politica, ma antropologica? E non ti fa ridere? Quante volte in questi anni ho pensato: che titolo avremmo fatto a Cuore su un leader della sinistra che dicesse e facesse le cose che ha fatto Renzi? Avremmo riso molto, Michele, so che lo sai. Il titolo del primo numero di Cuore parlava del Pci-Pds e diceva : “Siamo d’accordo su tutto purché non si parli di politica”. Mi sembra attualissimo, eravamo bravini.
E poi c’è un’altra cosa: insieme, Michele, abbiamo visto dalla scialuppa pirata di Cuore (e riso parecchio) il craxismo tronfio e grottesco, il berlusconismo delle furbate e delle scappatoie. Possibile che tu non veda nel renzismo (nel ciaone, nel “gettone del telefono” degli operai, nella celebrazione seppiata delle foto da agenzia Stefani di Nomfup, nelle strette di mano a Marchionne, nella retorica leopolda, potrei continuare per ore) una differenza che non è più nemmeno politica, ma antropologica? E non ti fa ridere? Quante volte in questi anni ho pensato: che titolo avremmo fatto a Cuore su un leader della sinistra che dicesse e facesse le cose che ha fatto Renzi? Avremmo riso molto, Michele, so che lo sai. Il titolo del primo numero di Cuore parlava del Pci-Pds e diceva : “Siamo d’accordo su tutto purché non si parli di politica”. Mi sembra attualissimo, eravamo bravini.
Ma visto che parti dal principio di realtà (Renzi è segretario del Pd con ampia maggioranza), ti oppongo un altro principio di realtà: la fauna renzista dei fighetti milanesi, della schiatta toscana, dei Rondolini, della nostra gloriosa Unità trasformata in fanzine della rockstar di Rignano, dei portavoce che giocano a Leni Riefenstahl, mi è lontana come Dell’Utri, come la Meloni, come un finanziere-squalo che fa il grano a Londra e viene a darci lezioni di come tagliare le pensioni in Italia. E’ a questa roba qua che dico sempre no, no, no? Esatto, è a questa roba qua. E se Giuliano Pisapia, che stimo e ringrazio per quello che ha fatto nella mia città, mi chiede di costruire qualcosa con quelli lì io dico no. Telefonatemi quando il Pd sarà un’altra cosa, quando davanti a un paese in ginocchio, stanco, ferito, spaventato, non verrà a dirmi gufo, rosicone, disfattista, non mi presenterà una storiella di Italia potenza culturale con le scuole che cascano in testa agli studenti, non mi dirà #Italiariparte o stronzate consimili.
Aspetto. Per ora no, grazie.
 Il risultato ha scosso il paese. Niente sarà più come prima. Ecco i primi segni del cambiamento.
Il risultato ha scosso il paese. Niente sarà più come prima. Ecco i primi segni del cambiamento.
Indelebile – Il più contento è Pino, tatuatore di Roma sud, che ha la fila davanti al negozio. “Va molto la scritta #maistatorenziano – dice – ma il problema è che deve essere visibile se vai a un dibattito, a una serata televisiva, o a mangiare la frittura ad Agropoli, e quindi mi chiedono di farla sulla fronte”. Buon successo anche per altri tatuaggi, come la finta scheda del Senato sventolata da Renzi. “Qualcuno la chiede sulla schiena, ma già votata, se no poi è scomodo”.
Pallottoliere – Grande attenzione dei sismologi per la reazione di Giuliano Ferrara, mentre gli esegeti più esperti aggiornano il pallottoliere. Con Bettino, Silvio, Joseph e lo 0,00002 per cento di quando si candidò contro l’aborto, ora aggiunge Matteo al suo Palmares: ne ha ammazzati più lui, sostenendoli a spada tratta, della peste del ‘600. Passano le ore, poi arriva il suo tweet, dedicato ai giovani: “Cari elettori dai 18 ai 34 anni, avevo la tentazione di una vecchiaia gay. Ora non più. Menatevela da soli. Stronzi”. Testuale. Al Foglio pensano di farci tre pagine, poi due, poi un taglio basso poi un piccolo corsivo, poi decidono di telefonargli: “Giuliano, hai di nuovo dimenticato le goccine”.
Reliquie – Grande successo di vendite a Roma, nelle botteghe adiacenti piazza San Pietro, di un telo in lino finissimo riproducente le fattezze di Maria Elena Boschi. Si dice sia la Sindone di quando ha visto il primo exit poll. Si mormora che abbia poteri miracolosi, tipo trasformare gente di “cultura contadina” in capataz del sistema bancario. Meglio del gratta e vinci.
Nuove app – Tra i commentatori dei grandi quotidiani va molto un programmino (App-erò!®) che scava nel loro archivio e trova una frase negativa su Renzi da esibire in forma di “io l’avevo detto”. Si tratta di un algoritmo capace di tirar fuori da milioni e milioni di parole adoranti e adulatorie, una critica del 2013, tipo “Matteo è spettinato” o “Matteo è apparentemente distratto”. A quel punto, invitati ai talk show, potranno dire: “Io? Ma io l’avevo detto! Guardi qui, già nel 2013!”. Leggere attentamente le istruzioni: su certi telefoni non funziona, quello di Maria Teresa Meli è esploso, causando l’irreparabile perdita di 36.784 messaggini “Renzi ai suoi”.
Concorso – Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha lanciato un concorso di idee internazionale per scegliere chi torturerà meglio, e in modo dolorosissimo e prolungato, il sindaco di Agropoli Franco Alfieri, quello del “clientelismo come Cristo comanda”. Alfieri doveva portare i voti servendosi delle sue raffinatissime analisi politiche (fritture di pesce), ma si è dimenticato. Da qui l’iniziativa culturale del governatore che “Apre alle culture altre”. Molto apprezzata la proposta di un giovane startupper Cherokee: seppellirlo nel deserto e lasciar fare alle formiche, mentre un maestro di cucina giapponese ha calcolato che tagliando molto fine, dal sindaco di Agropoli si potrebbero ricavare 31.000 porzioni di sushi.
Crisi – Avevano ragione i più tormentati sostenitori del Sì: è una tragedia economica. No, non per i famosi mercati, lo spread, le azioni, le Borse, i flussi internazionali e gli investimenti stranieri, che se ne sono largamente fottuti, ma per una dolorosa questione occupazionale. Con la caduta del governo Renzi perdono il posto circa 700 creatori di hashtag, lavoratori altamente specializzati, perché non si limitavano a scrivere puttanate, ma ci mettevano pure davanti un cancelletto. Ci vuole talento. E ora più nulla. #tristezza
Filosofie – Gli avvenimenti del paese sono così gravi che si afferma il pensiero Cacciariano: “Mi fa schifo ma lo compro lo stesso”. Molto apprezzato da osti e camerieri. Com’è la zuppa? “Fa vomitare, è salata e c’è dentro un topo, ma tranquillo, io sono un cacciariano, la mangio lo stesso”.
 Non è la prima volta che lo dico: farsi convincere dalla propria stessa propaganda è un errore idiota, da comunisti. E si direbbe l’ultima cosa comunista rimasta da queste parti.
Non è la prima volta che lo dico: farsi convincere dalla propria stessa propaganda è un errore idiota, da comunisti. E si direbbe l’ultima cosa comunista rimasta da queste parti.
Il primo pensiero sulla Waterloo renzista è questo: la narrazione ha fallito. Era sbagliata. Era stupida. Offensiva. Disegnava scenari inesistenti di sorti luminose e progressive per coprire una realtà di crisi e sofferenza. Un leader sconfitto che dice “Non credevo che mi odiassero così tanto” (il Corriere, oggi) è un leader che parla solo coi i suoi servi, che visita solo le fabbriche degli amici finanziatori e non quelle in crisi, che delegittima sempre l’avversario, perdendolo per sempre, trasformandolo in un nemico.
Chi semina vento raccoglie tempesta.
Questo fatto di vedere in primo piano la débacle della narrazione – me ne scuso – è una specie di deformazione professionale. Ma di questo, sul mio giornale (e qui), mi sono occupato soprattutto in questo anno: segnalare la distanza tra lo storytelling renziano e l’Italia. Non si può dire che non li avevamo avvertiti, ecco.
In cambio, in cambio di quel “ehi, vi state sbagliando!”, sono arrivati insulti e contumelie, prima eravamo gufi, poi rosiconi perché Lui vinceva, poi (fascisticamente, le parole sono importanti) “disfattisti”. Irridere i lavoratori e i sindacati (il gettone del telefono…), sposare una modernità da startup un po’ pirata con il mito della velocità che trasforma i diritti in zavorre e le regole in fastidiosi condizionamenti. Questo è stato il renzismo, se gli levate le storielle dei narratori. E precariato alle stelle, lavoro mortificato, tasse mascherate, bugie vergognose, tagli alla sanità. Tutto il contrario di quello che narravano le loro favolette di “futuro” e “italiariparte” e “grande potenza culturale”. Il No al 51 sarebbe stato un “no grazie”, al 55 un “No, e piantala”, al 60 è un “No e vaffanculo”. Spiace che questa nobile espressione popolare sia diventata lo slogan di un partito che non mi è simpatico, ma sia: si certifica almeno che non c’è copyright sul vaffanculo.
Ci mancheranno le bischerate toscane, le foto in bianco e nero dell’agiografia ufficiale, gli slogan infantili dei cantori a tassametro, la malafede di quelli che “il segretario ha sempre ragione”. Tra questi – una prece – i giovinetti burbanzosi della “nuova politica”, ordinati e devoti come balilla al servizio del capo, storditi, oggi, nell’apprendere finalmente quanto (tanto) il capo fosse detestato. Ora assisteremo ai riposizionamenti, ai distinguo, ai “Io? Mai stato renziano”. E’ il momento di avere buona memoria.
Ma al di là di questo – che non è contorno ma nemmeno sostanza – c’è il più disastroso fallimento politico del dopoguerra italiano. L’idea di poter perdere i propri voti di sinistra (spacciando quella perdita per modernizzazione) perché tanto arrivano quelli di destra era un calcolo sbagliato. Berciare per anni sui giovani a cui le generazioni precedenti “rubano il futuro” e poi essere votati solo dalle generazioni precedenti e non dai giovani. Mettere in circolo il veleno della guerra tra generazioni e perdere pure quella. Sostituire diritti con regali pensando che la gente non se ne accorga. Andare a elemosinare voti e consensi con il peggior clientelismo possibile (i De Luca, il pellegrinaggio di Lotti dai capataz cosentiniani, i favori a banchieri e mercati, l’occupazione del potere in ogni angolo…).

Mi diceva un amico rumeno che ad ogni comparsa di Ceausescu, molta gente si avvicinava al leader con bigliettini che dicevano : grande leader, succede questo, sucede quello… Pensavano che lui non sapesse, lo credevano in buona fede, lo avvertivano. Con Renzi si è fatto lo stesso: lo si avvertiva che il paese di cui parlava non era quello reale. E lui – e i suoi – rispondevano a insulti.
Il fallimento politico del renzismo è il fallimento clamoroso, il crollo indegno, di un disegno che il paese non vuole. Il partito della nazione, una macchina statale più veloce e controllabile per favorire “la velocità dell’economia”, che significa piegarsi a regole decise nei consigli di amministrazione e non dalla politica e dalla democrazia. Tutto questo non va bene. A tutto questo è stato detto No. E proprio ora che c’è incertezza nel futuro si capisce bene che tenersi una Costituzione così, che ci ha salvato in larga parte persino da Berlusconi, è una cosa preziosa, da non stravolgere per il plebiscito di un singolo.
Il plebiscito c’è stato, comunque: 60 a 40 non è una sconfitta, è un disastro.
Ci sarà tempo di pensare a quello che è diventata l’informazione, grandi giornali, tutte le tivù, tutti schierati dalla parte della sconfitta bruciante, è un vaffanculo un po’ anche per loro. Ma non tanto sull’inchinarsi al potente di turno, quando sull’incapacità, anche loro, persino loro, di vedere il paese reale e di preferire le favolette belle della propaganda. Approfitto per dire che sono molto contento del mio giornale, Il Fatto Quotidiano, di chi ci scrive, di come ha condotto questa battaglia di autodifesa degli italiani.
Ora è il tempo di ricominciare a parlare di politica, non delle visioni lisergiche di un ragazzotto con problemi di ipertrofia dell’ego e dei suoi camerieri.
Via, e subito, e presto, anche dal Pd, se si vuole un partito vagamente di sinistra in Italia. E via subito anche i suoi uomini nei posti chiave, per evitare che un potere perdente si aggrovigli alle strutture e faccia ulteriori danni. Il paese che si voleva “velocizzare” ha perso un anno intero dietro alle paturnie di una sedicente classe dirigente, la più mediocre che si sia mai vista.
Della signorina Boschi non è il caso di parlare, questa singola riga è già troppo per il suo spessore.
E’ l’ora del “Che fare?”, ma siamo qui per questo, no?
E’ sempre l’ora del “Che fare?” se non ti va di essere suddito, ardito o balilla.
 Negli angoli più sperduti della galassia, nelle visioni paradisiache che ci porterebbe una vittoria del Sì e nelle speculari tradegie che, inevitabili, accompagnerebbero la vittoria del No (pensate al disastro, fallirebbe Banca Etruria! Mon Dieu!), i narratori renzisti stanno facendo un po’ di casino con il Pantheon.
Negli angoli più sperduti della galassia, nelle visioni paradisiache che ci porterebbe una vittoria del Sì e nelle speculari tradegie che, inevitabili, accompagnerebbero la vittoria del No (pensate al disastro, fallirebbe Banca Etruria! Mon Dieu!), i narratori renzisti stanno facendo un po’ di casino con il Pantheon.
Ci siamo fatti due risate con Renzi che si appropriava di Sant’Agata (vergine, martire, e sostenitrice del Sì già dal Terzo secolo), ma quello dei testimonial involontari, arruolati en passant, con una citazione, un filmato, una suggestione di impianto sentimental-romantico, comincia ad essere un pozzo profondo. Non si trasecola tanto per la costruzione di un sistema valoriale basato sugli esempi (lo fanno tutti), ma per la distanza siderale tra quegli esempi (che parlano al cuore, all’appartenenza, alle radici) e la realtà. Per capirc: citare Don Milani e fare una riforma della scuola come quella renziana è come predicare una vita sana e morigerata facendo il capo del cartello di Medellin. Un equilibrismo pericoloso e, a lungo andare, ridicolo.
Ultimo esempio, la citazione-videoclip di Eric Cantona, mito del calcio maledetto, attore, provocatore di genio, in qualche suo bislacco modo leader progressista. Renzi, in tour a Bologna, mostra un video tratto dal film di Ken Loach sul calciatore francese. E sottolinea quello che Cantona dice, nel film, al suo ammiratore: “Devi fidarti dei tuoi compagni”. Video riciclato, già usato in luglio a una direzione del Pd, quella volta per rubare un’altra frase di Cantona: “L’importante non è il gol, è il passaggio”, e quello del referendum è un passaggio, eccetera eccetera (aggiungere a piacere).
E’ evidente il problema di assestamento tra l’immaginario evocato e il reale. Se celebri Cantona come un pezzetto della tua formazione, un angolino di genio sregolato ribellista e di sinistra come tuo riferimento (tweet commosso di Filippo Sensi), non puoi invitare a cena a Palazzo Chigi Tony Blair. Scegliere: se ricordi commosso Berlinguer, non puoi correre ad abbracciare Marchionne. Celebrare Ken Loach in un discorso pubblico dopo aver detto cose assai offensive sul sindacato i corpi intermedi (vecchi, barbogi, il gettone del telefono, eccetera eccetera) crea una specie di stordimento, come minimo un disorientamento: insomma, porca miseria, dobbiamo stare con i minatori o con la Thatcher? Con i risparmiatori o con JP Morgan? Con i ragazzi che pedalano nella notte per portarci il sushi o con i dinamici startupper che li pagano due euro a consegna? Il dilemma si risolve così: l’adesione sentimentale, il tributo emozionale, la lacrima vanno ai primi, la politica , le decisoni e l’impianto ideologico guardano ai secondi. Una politica di destra, non a caso sostenuta e benedetta dai padroni del vapore (da Confindustria alla grande finanza), confezionata con ammiccamenti al vecchio, ormai quasi gozzaniano, cuore di sinistra.
Il partito della Nazione che si affermerà in caso di vittoria del Sì ha già fatto le sue prove generali sull’impianto emotivo del paese, usando come cavia l’elettorato del Pd. E’ una specie di “liberi tutti ideologico”, che permette ogni cosa, che allenta ogni freno. A distanza di poche ore si può andare in pellegrinaggio dal capataz cosentiniani in Campania e celebrare Ken Loach e Cantona, tagliare cinquanta milioni per le cure a chi vive vicino all’Ilva di Taranto, dire arditamente che si rimedierà in Senato, e un minuto dopo ribadire l’inutilità del Senato. Vale tutto, insomma, commuoversi per la sorte degli schiavi e andare al ricevimento con lo schiavista, tifare per il fagiano mentre si carica la doppietta. Chi ancora casca in questo giochetto, chi si piega a questa schizofrenia cinica e calcolata, ha già in tasca – peggio, in testa – il suo partito della Nazione.
 A Milano! A Milano! Mi sembra giusto chiudere con le presentazioni di Di rabbia e di vento a Milano.
A Milano! A Milano! Mi sembra giusto chiudere con le presentazioni di Di rabbia e di vento a Milano.
Quindi grazie alla Cooperativa La Liberazione (via Lomellina, 14) che mi invita (lunedì 28, alle 21) a fare una chiacchierata. Si parlerà di tutto, come al solito: il giallo, Milano, la scrittura e tutto il resto.
Intanto, il libro è andato molto bene (qui trovate un po’ di recensioni, se vi va) e approfitto per ringraziare tutti quelli che in questi mesi sono venuti a sentire, a parlare, a fare domande.
Per quanto riguarda Carlo Monterossi, la sua banda, i suoi blues e tutto quello che gli gira intorno, a gennaio arriverà la nuova avventura, della quale – ovvio – non dirò niente, se non che Carlo è un po’ confuso, che la storia è piuttosto scura e che la legge e la giustizia, beh, insomma, lo sapete che non sono la stessa cosa, vero?
Quindi se venite lunedì sera mi fa molto piacere (è pure un posto dove si mangia e si beve bene). Ci vediamo lì
 Il dibattito sulla post-verità (l’Oxford English Dictionary ha eletto Post-Truth come parola dell’anno) sembra leggermente post-datato. Le sorti del mondo sarebbero messe in forse dal fatto che milioni, forse miliardi, di persone credono alla prima fregnaccia che dice la rete, invece di leggere il New York Times sulle poltrone in pelle del circolo del bridge. C’è del vero, probabilmente. E del resto se i media ufficiali cavalcano questa cosa della post-verità è anche per non ammettere il fallimento: non sappiamo più leggere la società (Trump, Brexit, eccetera). Ma questi sono discorsi complessi, per esperti. Ci limitiamo a scorgere piccoli segnali di post-verità che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
Il dibattito sulla post-verità (l’Oxford English Dictionary ha eletto Post-Truth come parola dell’anno) sembra leggermente post-datato. Le sorti del mondo sarebbero messe in forse dal fatto che milioni, forse miliardi, di persone credono alla prima fregnaccia che dice la rete, invece di leggere il New York Times sulle poltrone in pelle del circolo del bridge. C’è del vero, probabilmente. E del resto se i media ufficiali cavalcano questa cosa della post-verità è anche per non ammettere il fallimento: non sappiamo più leggere la società (Trump, Brexit, eccetera). Ma questi sono discorsi complessi, per esperti. Ci limitiamo a scorgere piccoli segnali di post-verità che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
Il post-soffritto. In una bella intervista al Corriere della Sera, il famoso cuoco Massimo Bottura, il più bravo del mondo, dicono, ci spiega cos’è la narrazione ai fornelli. “Dovevo fare una carbonara per duemila persone, ma avevo bacon per due porzioni. L’ho tagliato a fettine sottilissime e le ho stese sulla teglia. Poi ho preso delle bucce di banana. Le ho sbollentate, grigliate, tostate in forno. Alla fine erano affumicate, croccanti. Le ho fatte a cubetti, ricoperte di un altro strato di bacon e rimesse in forno: il bacon si è sciolto; le bucce di banana parevano guanciale”. Perfetto, pare la ricetta delle riforme renziane, tipo il Jobs act al sapore di tempo indeterminato (tagliato finissimo) e tanti cubetti di voucher, ma tanti, eh! Per carità, saremo lontani dalle solenni riflessioni sulla post-verità, ma la post-carbonara esiste e lotta insieme a noi
Il post-emigrante. Piccolo esempio di post-valigia-di-cartone. Intervistato a Piazzapulita, il grande manager Andrea Guerra (ha lavorato in molte aziende, non tutte in attivo: Luxottica, Governo Italiano, Eataly) ha detto la sua sugli italiani all’estero. Ha detto che lui se n’è andato, che è giusto andarsene, e che l’importante è che dopo, fatte queste “esperienze meravigliose all’estero”, si torni qui a dare una mano. In pratica, fateci caso, quando si parla di italiani all’estero si citano sempre i supermanager, gli scienziati, le eccellenze, oppure una specie di éducation sentimentale per giovani europei, una gaia aria di Erasmus per milioni di persone. Inutile dire che la realtà si avvicina di più al pizzaiolo che sta a Stoccarda, o al lavapiatti a Londra, non proprio “esperienze meravigliose all’estero”, ma vera emigrazione per bisogno (in aumento, tra l’altro). Il post-emigrante, nella post-verità, è o un numero uno, oppure una specie di flâneur bohémien che gira il mondo facendo meravigliose esperienze.
La post-condicio. Nulla è più post della post-iccia faccenda della par condicio, eppure se ne discute animatamente come se esistesse. Lo sbilanciamento clamoroso nelle posizioni del Sì e del No sui “media ufficiali” è sotto gli occhi di tutti, ma questo non impedisce le dissertazioni teoriche, le analisi e le riflessioni, i moniti, gli appelli su una cosa che evidentemente non c’è. Parlare come se esistesse di una cosa che non esiste è tipico della post-verità, un po’ come dare una cosa per fatta quando non lo è (innumerevoli casi, valgano per tutti i “mille asili in mille giorni”, o il roboante “abbiamo abolito il precariato”, o l’Expo “straordinario successo”, o l’Italia “superpotenza culturale”). E’ vero, la post-verità è un pericolo reale. Se si diffonde nel paese la prassi che dirlo è come farlo sarà un disastro a partire dalla prima media. Hai fatto i compiti? Ho fatto i compiti, sì, ecco fatto, bastava dirlo.
Quella sulla post-verità sarà dunque un dibattito infinito, ma si consiglia vivamente di saperla vedere ovunque, nelle follie del web come nella narrazione quotidiana, normale, persino inconsapevole.
E’ lì che ci prendono veramente per post-cretini.
 Molliamo il colpo, ragazzi, usciamo con le mani alzate, arrendiamoci. Va bene i bonus, va bene i regali elettorali, va bene le promesse roboanti e vanno bene persino i morti (tipo Nilde Iotti, arruolata da salma)… ma Sant’Agata che vota Sì è l’arma fine-di-mondo! Noi siamo attrezzati per la Boschi (e già fatichiamo), al massimo per la Madia (che fatica!), ma Sant’Agata è l’asso pigliatutto. Eppure è stato il vescovo di Catania in persona a dirlo a Renzi (“Sant’Agata vota sì”), e lui, sempre così distante dalle esagerazioni, lo ha preso in parola.
Molliamo il colpo, ragazzi, usciamo con le mani alzate, arrendiamoci. Va bene i bonus, va bene i regali elettorali, va bene le promesse roboanti e vanno bene persino i morti (tipo Nilde Iotti, arruolata da salma)… ma Sant’Agata che vota Sì è l’arma fine-di-mondo! Noi siamo attrezzati per la Boschi (e già fatichiamo), al massimo per la Madia (che fatica!), ma Sant’Agata è l’asso pigliatutto. Eppure è stato il vescovo di Catania in persona a dirlo a Renzi (“Sant’Agata vota sì”), e lui, sempre così distante dalle esagerazioni, lo ha preso in parola.
Certo, la storia di Sant’Agata è interessante: vergine consacrata, fece involontariamente girare la testa al proconsole Quinzano, che la voleva a tutti costi. Lei si negò, e quello la fece torturare in tutti i modi (compresi i seni strappati con le tenaglie arroventate, porca miseria!). Dunque, se stiamo alle vite dei Santi, diciamolo, Sant’Agata fece una bruttissima fine perché disse No. Se avesse detto Sì sarebbe andato tutto bene. Senza più il bicameralismo, ma con ancora le tette. E’ quello che si dice un perfetto parallelismo storico. Essendo poi Sant’Agata anche la patrona dei pompieri, la cosa si incastra bene col terremoto, e la propaganda diventa, diciamo così, bisvalida come le vecchie figurine Panini.
Per un tipetto dinamico come Renzi, che dice di guardare al futuro, rifarsi a un’elettrice del III secolo potrebbe sembrare contradditorio, ma non è così. Forse Jim Messina gli ha detto che può recuperare voti presso il pubblico femminile molto pudico e testardo, e la figura di Sant’Agata casca a fagiuolo. Un po’ come se volendo recuperare voti tra i correntisti di Banca Etruria li si convincesse che San Matteo Evangelista (patrono dei banchieri) avrebbe votato Sì, e questo proprio mentre Matteo il Ballista (patrono dei banchieri pure lui, ma in un altro modo) ai risparmiatori truffati dice No.
Insomma un bel casino. Non se ne esce. Resta da vedere cosa dirà Santa Barbara, che cade il quattro dicembre. Sant’Agata ha già detto, cioè, lei votò No, ma dopo, si vede, ha cambiato idea.
 Eh, dici bene, stargli dietro, ma come si fa! Passato in un nanosecondo dallo sventolìo europeista di Ventotene a togliere le bandiere dell’Europa dalla scenografia, asceso da rottamatore a establishment, poi da responsabile statista ad alfiere antisistema, Matteo Renzi pone un nuovo problema politico all’Italia. Non il trasformismo – roba vecchia – ma il trasformismo col teletrasporto: fulmineo, istantaneo. Stupisce che i giornali non pubblichino le previsioni del Renzi, cose tipo: domani un po’ populista con venature anti-casta, schiarite nel pomeriggio, statista europeo dopo cena, a nord-ovest, con cirri costituzionalisti sopra i mille metri.
Eh, dici bene, stargli dietro, ma come si fa! Passato in un nanosecondo dallo sventolìo europeista di Ventotene a togliere le bandiere dell’Europa dalla scenografia, asceso da rottamatore a establishment, poi da responsabile statista ad alfiere antisistema, Matteo Renzi pone un nuovo problema politico all’Italia. Non il trasformismo – roba vecchia – ma il trasformismo col teletrasporto: fulmineo, istantaneo. Stupisce che i giornali non pubblichino le previsioni del Renzi, cose tipo: domani un po’ populista con venature anti-casta, schiarite nel pomeriggio, statista europeo dopo cena, a nord-ovest, con cirri costituzionalisti sopra i mille metri.
Dopo accurati studi statistici, il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’istituto Zelig, è in grado di anticipare le prossime strabilianti trasformazioni del nostro primo ministro anti-casta.
Matteo esistenzialista – Secondo Jim Messina il sì può recuperare lo 0,4 nel quartiere della Sorbona e tra gli avventori del Café de Flore, a Parigi. Matteo si presenta con un girocollo nero, una giacca stazzonata e sigarette francesi. Bevendo un pastis, assicura che Simone de Beauvoir avrebbe votato sì di sicuro, peccato che non sia qui a dircelo di persona. Ospite di Fabio Fazio, canta un pezzo di Juliette Gréco.
Matteo trumpista – Recuperare il voto degli italiani del Maryland, del Montana e del Wyoming è possibile, dice Jim. Matteo si presenta da Maria De Filippi a bordo di una Cadillac di sedici metri e dice che se vince il sì caccerà dall’Italia tutti i messicani (che sono dodici, tra cui due gemelli e una centenaria). Mostra la sua colt placcata oro e annuncia che sarà presente alla finale di Miss Bastaunsì, a Recoaro Terme.
Matteo rasta – Uno 0,3 recuperabile tra gli italiani che vivono in Jamaica, più un possibile 0,2 di amanti del reggae, dice Jim. Matteo coi i dreadlocks tiene un commosso discorso contro il caro-cartine e promette, ospite di Vespa, che se vince il sì tutti avranno ottanta euro di filtrini in omaggio. Ira di Giovanardi.
Matteo nazionalista – Generali in pensione, colonnelli a riposo, attempate crocerossine dismesse. Secondo Jim c’è uno 0,8 per cento che si può recuperare facilmente cavalcando battaglie popolari, come la presa di Fiume o Nizza italiana. Da Lilly Gruber si presenta a cavallo. Promette che se vince il sì gli schioppi ad avancarica saranno sostituiti con modernissimi fucili della prima guerra mondiale (questo, secondo Jim, vale un recupero del 2,4 tra gli elettori che abitano sul Carso)
Matteo castrista – Ingannato dal ministro Martina sulla redditività della monocoltura della canna da zucchero, si presenta in uniforme e basco rosso a una toccante cerimonia, che ha conclude con un “Sì o muerte”, puntando al voto della comunità italiana all’Avana. Poi, in diretta da Barbara D’Urso, annuncia la nazionalizzazione delle banche. Tutte tranne una, ché ci sono problemi di successione.
Matteo futurista – Zang! Zang! Bzzzzz! Tra i giovani poeti italiani il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 99 per cento (uno fa il panettiere). Ospite del segnale orario, Matteo Renzi si rivolge a loro e declama alcuni versi di sua produzione “La Ue non si deve solo commuovere / Si deve muovere”. La serata è un successo anche se viene “locomotivamente fischiato” (cfr. Marinetti). Jim dice che si può recuperare il tre per cento tra quelli che odiano i poeti.
Matteo populista – Secondo Jim Messina si può recuperare un poderoso 8,8 per cento tra tutti gli elettori che si sono addormentati nel 1998 e svegliati ieri. Matteo tuona contro le banche, le multinazionali, il dollaro, l’euro, le scie chimiche e i semi transgenici. Poi fa un milione di promesse spericolate. Entusiasmo nell’entourage: “Pazzesco, Matteo, sembravi te stesso”
 E poi viene il giorno in cui muore anche la malinconia. Era una cosa sottile, calma e avvolgente, incartata in una voce così bassa, così raschiata, che sembrava uno strumento da bordone, con le parole precise e nette, le melodie disegnate – no, incise – e condotte per mano dolcemente, una presa tenera ma sicura, come si fa con le ragazze quando si finge timidezza. Ora, come sempre davanti alle morti illustri, Cohen diventerà materia di critica e di ricostruzione: se fosse prima poeta o cantante, mistico (persino asceta, persino eremita) o fisico come le storie di amore e di sesso e di stanze d’albergo che cantava. O ancora si dirà di quell’amore lungo e della sua perdita, Marianne Ihlen, morta qualche mese fa, a cui lui aveva promesso di raggiungerla presto: “Sappi che sono così vicino dietro di te che se tendi una mano puoi trovare la mia”. E questo a proposito dell’amore, che non solo sopravvive agli abbandoni, ma ne trae, se possibile, più amore. “Nella sua ultima ora le ho tenuto la mano e ho sussurrato Bird on a Wire”. Basterebbe questo, per un poeta, lo sapete, vero?
E poi viene il giorno in cui muore anche la malinconia. Era una cosa sottile, calma e avvolgente, incartata in una voce così bassa, così raschiata, che sembrava uno strumento da bordone, con le parole precise e nette, le melodie disegnate – no, incise – e condotte per mano dolcemente, una presa tenera ma sicura, come si fa con le ragazze quando si finge timidezza. Ora, come sempre davanti alle morti illustri, Cohen diventerà materia di critica e di ricostruzione: se fosse prima poeta o cantante, mistico (persino asceta, persino eremita) o fisico come le storie di amore e di sesso e di stanze d’albergo che cantava. O ancora si dirà di quell’amore lungo e della sua perdita, Marianne Ihlen, morta qualche mese fa, a cui lui aveva promesso di raggiungerla presto: “Sappi che sono così vicino dietro di te che se tendi una mano puoi trovare la mia”. E questo a proposito dell’amore, che non solo sopravvive agli abbandoni, ma ne trae, se possibile, più amore. “Nella sua ultima ora le ho tenuto la mano e ho sussurrato Bird on a Wire”. Basterebbe questo, per un poeta, lo sapete, vero?
Eppure Cohen era stato anche spigoloso, persino scomodo. Una voce così roca e dunque così esplicitamente sessuale, senza veli né troppi giri di parole, nella quale si sporgevano non i mali del mondo, che pure ci sono, ma i mali suoi, la depressione, la nostalgia, il suicidio, tema ricorrente. E la malinconia, sostanza collosa, intima, irraccontabile e dunque perfetta da raccontare, se sei capace. La mischiava, quella voce, con la chitarra acustica, all’inizio. E nella stagione dei figli dei fiori e dell’amore libero sembrava un monito: che libero non vuol dire leggero, ma denso, e questo lo faceva passare per il deprimente Leonard Cohen, il noioso Leonard Cohen. Poi la mischiò con il pianoforte, poi con arrangiamenti più orchestrali, pieni, e poi addirittura con un’elettronica gentile, e i cori, le voci multiple a contrappunto della sua, sempre scura, autosegregata nel mistero dell’intimità. Marianne, Suzanne, persino Jeanne D’Arc. Le donne – quindi la Donna – erano un’ossessione di equilibri, tra passione e abbandono, tra il rimpianto della perdita e la gioia tranquilla di avere, almeno, nella tristezza della fine, qualcosa da rimpiangere. Per questo – anche per questo – la cifra di Cohen è stata, sempre, la malinconia.
E dunque se ne va non solo un cantante e non solo un poeta, ma un intero impasto, non sempre lineare e mai semplice, di prescrizioni emotive, di appunti per leggere la vita e il mondo: “Dammi un’assoluta maestà su tutto / E stenditi vicino a me / E’ un ordine perfetto” (The future, 1992). Chissà, forse perché sapeva, ebreo errante affascinato dal buddismo al punto di ritirarsi per anni in eremitaggio, che la vita privata – noi – e il mondo pubblico, sono la stessa cosa, e nemmeno troppo rassicurante, cose che non ci faranno carezze.
Si sa che non bisogna fidarsi dei cantanti, che sono in qualche modo autorizzati alla ciarlataneria dei sentimenti, e pochi fanno eccezione. Ma in Leonard Cohen questa eccezione era monumentale, poderosa. Niente, mai, che suonasse falso. Ed è per questo che le sue canzoni erano confessioni e salmi, spesso più nascosti nelle b-sides, nelle canzoni che non si affacciavano alle classifiche, che in quell’Halleluiah che oggi molti riconoscono come la pietra migliore del suo scrigno, e mi permetto di dissentire. Non è lì che bisogna cercare Cohen, ma nei capricci del corpo e del cuore, nel sesso e nella bottiglia, nelle camere d’albergo del suo scontento, nell’amore che è sì uno scherzo, ma non per questo è divertente.
Una cosa, come gli diceva Suzanne nella canzone, da cercare “tra la spazzatura e i fiori”. Chi ha sentito Leonard Cohen come si deve, chi l’ha incontrato davvero, queste cose le sa. Perché sono vere. E perché gliele ha spiegate lui.
 Forse è il momento di spiegarsi un po’. Perché va bene la battaglia, il tweet, la polemica spicciola e le considerazioni sulla tattica, ma prima o poi bisogna dirlo. Quindi, piccolo ragionato endorsement, come dicono quelli bravi: il 4 dicembre voterò NO, convinto e motivato. Non so come andrà a finire, dicono che l’esito è incerto, e dei sondaggi non è sano fidarsi.
Forse è il momento di spiegarsi un po’. Perché va bene la battaglia, il tweet, la polemica spicciola e le considerazioni sulla tattica, ma prima o poi bisogna dirlo. Quindi, piccolo ragionato endorsement, come dicono quelli bravi: il 4 dicembre voterò NO, convinto e motivato. Non so come andrà a finire, dicono che l’esito è incerto, e dei sondaggi non è sano fidarsi.
Voterò NO perché non mi piace la logica della “semplificazione”. C’è stato un tempo, in questo paese, in cui si facevano straordinarie riforme con il bicameralismo perfetto, il proporzionale, dieci-quindici partiti, le correnti e un’opposizione forte e decisa (il vecchio Pci in testa). Il Servizio Sanitario Nazionale, lo Statuto dei Lavoratori… insomma, non la faccio lunga. La classe politica era migliore, sapeva mediare, sapeva – lo dico male – fare politica. La classe dirigente di oggi no, non è capace, è mediocrissima, raccogliticcia e composta da yesmen e yeswomen (che fino a ieri dicevano yes ad altri, tra l’altro). Insomma nasconde le sue incapacità dietro la lentezza delle regole.
Un’operazione di auto-mantenimento in vita: chi non sa fare un puzzle da 1.000 pezzi se ne compra uno da 500, poi da 250, adatta la realtà alla propria inadeguatezza invece di adeguarsi alla complessità.
(Qui c’è una piccola divagazione. Non è vero che la riforma semplifica, anzi, incasinerà molto. L’articolo 70 è una specie di patchwork dadaista, quindi anche la questione della semplificazione, diciamo, traballa).
Voterò NO perché vedo una tendenza – nemmeno troppo nascosta, anzi, a volte rivendicata – a limitare la rappresentanza e la sovranità popolare, cioè il voto. Le province, per dire, fanno tutto quello che facevano prima, solo che invece di votarli noi, i rappresentanti sono nominati altrove, a volte da luridi accordi di partiti e di correnti. Sarà così, più o meno, per il nuovo Senato, non lo voteremo più, se non in modo largamente indiretto.
limitare la rappresentanza e la sovranità popolare, cioè il voto. Le province, per dire, fanno tutto quello che facevano prima, solo che invece di votarli noi, i rappresentanti sono nominati altrove, a volte da luridi accordi di partiti e di correnti. Sarà così, più o meno, per il nuovo Senato, non lo voteremo più, se non in modo largamente indiretto.
Del doppio lavoro di sindaci e consiglieri comunali, un po’ a Roma, un po’ a fare quello per cui sono stati eletti nei loro territori, si è già detto, un altro pasticcio. E l’immunità da senatori (quindi anche da consiglieri regionali? Mah), altro pasticcio. E l’età, per cui potremo avere senatori diciottenni ma deputati non sotto i 25 anni. Pasticcio. Senza contare gli statuti delle regioni autonome che andranno riscritti (suppongo con qualche fatica) perché prevedono incompatibilità tra l’attività di consiglieri regionali e quella di senatori. Pasticci su pasticci su pasticci.
Per semplificare, tra l’altro! Ridicolo.
La questione poi dei “costi della politica” è risibile pure quella: si risparmiano una cinquantina di milioni in cambio di un cedimento di rappresentanza, una goccia nel mare delle spese della politica, anche se hanno provato a raccontarci che si risparmiavano 500 milioni (Renzi), o un miliardo (sempre Renzi), o che la riforma vale sei punti di Pil (Boschi… Farebbe un centinaio di miliardi. Pura follia). Stupidaggini sesquipedali.
E’ come dire: cara risparmiamo! Non compriamo più gli stecchini per le tartine al caviale, mangiamole con le mani, finger food, che fa anche smart e moderno.
 Voterò NO perché questa riforma, fatta male e scritta peggio, sposta qualche potere dal Parlamento all’Esecutivo. I sostenitori del Sì dicono, con aria di sfida, di mostrargli l’articolo che aumenta i poteri del Presidente del Consiglio. Ovviamente non c’è. O no? Tranquilli, c’è. L’articolo 72, detto anche del “voto a data certa”, prevede una corsia preferenziale per i disegni di legge del governo, che quindi avranno sempre la precedenza. In pratica, in una situazione di emergenza permanente, si potranno discutere solo leggi di iniziativa del governo (un governo, tra l’altro, saldamente in mano al premier che è pure segretario del primo o secondo partito). In quella corsia preferenziale potranno correre sia le leggi di bilancio, sia quelle elettorali. Insomma, un governo, con questa nuova Costituzione, potrà approvare in 70 giorni una nuova legge elettorale se quella esistente non gli conviene.
Voterò NO perché questa riforma, fatta male e scritta peggio, sposta qualche potere dal Parlamento all’Esecutivo. I sostenitori del Sì dicono, con aria di sfida, di mostrargli l’articolo che aumenta i poteri del Presidente del Consiglio. Ovviamente non c’è. O no? Tranquilli, c’è. L’articolo 72, detto anche del “voto a data certa”, prevede una corsia preferenziale per i disegni di legge del governo, che quindi avranno sempre la precedenza. In pratica, in una situazione di emergenza permanente, si potranno discutere solo leggi di iniziativa del governo (un governo, tra l’altro, saldamente in mano al premier che è pure segretario del primo o secondo partito). In quella corsia preferenziale potranno correre sia le leggi di bilancio, sia quelle elettorali. Insomma, un governo, con questa nuova Costituzione, potrà approvare in 70 giorni una nuova legge elettorale se quella esistente non gli conviene.
Dunque è vero, la riforma non tocca teoricamente i poteri del Presidente del Consiglio, ma in pratica lo aiuta un bel po’.
Voterò NO perché questa riforma Costituzionale è stata costruita, scritta e pensata in parallelo con l’Italicum, una legge elettorale che ancora più pesantemente lede il diritto di rappresentanza. Le minoranze Pd (mi sembra giusto parlare al plurale) che l’hanno votata l’hanno fatto esplicitamente dopo la promessa, la vaga assicurazione, il miraggio, che si sarebbe modificato pesantemente l’Italicum. Questo non solo non succederà in tempo (prima del 4 dicembre), ma consentirà a Renzi, se vince il Sì, di considerare il referendum un avallo all’Italicum (lo sapevate e l’avete votata… eccetera, eccetera).
Inutile dire che la riforma, che è solo brutta e complessa e foriera di nuove confusioni, con l’Italicum allegato diventa anche pericolosa. Il mio NO diventa quindi autodifesa democratica e non più soltanto posizione tecnico-politica.
Ora veniamo ai motivi politici.
Le riforme renziane le abbiamo viste. Sono in larga misura pasticciate, dettate dalla fretta di mostrarsi veloci e decisionisti, ma all’apparir del vero abbastanza disastrose. Come minimo i loro effetti sono stellarmente lontani da quanto si era promesso e prefigurato con gran dispiego di storytelling. Il Jobs act (la legge sul lavoro, in italiano) ha prodotto qualche migliaio di nuovi posti di lavoro, parecchie stabilizzazioni e un profluvio di lavoro precario (voucher e compagnia brutta), ed è costata venti miliardi che, investiti in altro modo, avrebbero creato più lavoro. Tipica riforma renziana: risultati immediati molto sbandierati per la propaganda (anche truccando i numeri), e poi la realtà che arriva a darti una sberla, e intanto si sono levati diritti a chi di sicurezze ne aveva già poche. La “buonascuola” ancora peggio.
Dunque ci troviamo davanti a varie contraddizioni politiche.
La prima: riformisti che non sano fare riforme decenti.
La seconda: riformisti che fanno le riforme, e se ne vantano ogni due per tre, ma che vogliono cambiare la Costituzione con l’argomento che con questa che c’è non si possono fare le riforme.
Quanto alla velocità delle leggi, l’argomento è specioso e rasenta la malafede: la legge Fornero venne approvata in 18 giorni, il bail-in in 13, le banche pericolanti (anche quella del papà della ministra delle riforme) sono state salvate in due settimane. In sostanza, semplifico, le leggi che aiutano il sistema e penalizzano il cittadino corrono assai (quella sul reato di tortura no, non corre).
Ma poi, perché si vuole essere così veloci? Perché il mercato è veloce, il mondo è cambiato, eccetera, eccetera. Dunque si dice: costruiamo una Costituzione più a misura di mercato, ed è esattamente quello che non mi piace per niente. La Costituzione deve essere a misura di cittadino e permettere a chi governa di regolare il mercato (aziende, banche e finanza), non di agevolarlo sempre e comunque sacrificando interessi comuni. Il mercato è, ahimé, parte di questo mondo, ma non è questo mondo.
Mi sembrano tutti motivi validi per il mio No, e probabilmente altri ce ne sono. Non ultimo, il ridicolo assalto della propaganda per cui se vince il No sarà il disastro, l’apocalisse, moriremo tuti e i mercati ci uccideranno. Non è vero, è terrorismo, a volte ben confezionato dialetticamente, a volte (spesso) arrogante e sbruffone come nello stile di chi ha inventato la riforma. Lo storytelling trinariciuto e banale, il ricatto dell’”allora non vuoi cambiare”, la retorica infantile del premier dinamico e giovane. Tutte cose irricevibili da gente che si proclama di sinistra (per chi ancora ci casca, pochi) e fa cose che la destra italiana sogna da anni.
No, non è un voto sul Presidente del Consiglio, ma in fondo lo è. Se vince il No a una brutta riforma, chi ha proposto e sostenuto una brutta riforma perdente verrà un po’ ridimensionato, e penso che Renzi e il renzismo abbiano bisogno proprio di quello: una regolata. Se hanno i voti governino pure, ma con le regole fissate, non con regole nuove fatte su misura. Fa parte della propaganda il grottesco leit-motiv delle cattive compagnie, per cui la ministra che vota con Verdini in Parlamento accusa me di votare come Casa Pound. Stupidaggine: io voto quello che voglio, indipendentemente da chi lo fa anche lui. E visti i banchieri, i milionari, Confindustria, i finanzieri, Moody’s e tutto l’establishment schierato per il Sì non so quanto convenga ai “riformisti” fare questo discorso.
Nel referendum costituzionale del 2006 Renzi votò No, come Rauti, discorso chiuso.
C’è un altro motivo per il mio No, e riguarda il paese spaccato. Se una riforma così importante divide i cittadini a metà già vuol dire che non va bene, che non è ampiamente condivisa, che rompe in due la società, mentre dovrebbe compattarla (questo fecero, tra mille ottimi compromessi, i padri costituenti, quelli veri).
In sostanza, voterò NO per il merito (anche il ritornello “non parlate del merito” è una scemenza, parlare del merito della riforma è il modo migliore per mostrarla per quello che è, un pasticcio), per il metodo e per il disegno di lungo periodo che vi si scorge dietro. Perché mi sembra sempre più, ogni giorno che passa, un referendum delle élites contro i cittadini. Non mi sento per questo un conservatore né un immobilista. Ci sono cambiamenti che vorrei, fuori e dentro la Costituzione, ma non sono questi.
Quindi, No grazie.
Se volete abolire il Cnel, chiamatemi, a quello ci sto. Basta una riga, non serve stravolgere la Costituzione.
 Oggi, nel corso di una toccante cerimonia, Barack Obama ha ricevuto Trump alla Casa Bianca. In esclusiva mondiale, il Fatto Quotidiano può raccontare ai suoi lettori i dettagli rimasti segreti
Oggi, nel corso di una toccante cerimonia, Barack Obama ha ricevuto Trump alla Casa Bianca. In esclusiva mondiale, il Fatto Quotidiano può raccontare ai suoi lettori i dettagli rimasti segreti
– Questa è la camera da letto…
– Uff! Niente specchio sul soffitto? Niente letto rotondo?
– Ehm… no. E questo è il mio studio, la sala ovale…
– Bello! E questo bottone rosso? Per la servitù? Posso provare?
– No! Non toccare!
– Ok, ok, calmino Barack… E questo è il bagno?
– Sì, Donald, questo è il bagno
– E quello?
– E’ il bidé, Donald
– Ah, capisco… l’orto di Michelle dov’è?
– Là dietro… sono contento che ti interessi, gli ho dedicato molti tweet
– Devo capire le misure… per il parcheggio, io devo metterci molte jeep
– Beh, Donald, la casa l’hai vista, ma non voglio forzarti, se non ti piace puoi rifiutare…
– No, no, è carina… Anzi, Barack, volevo dirle… E’ un onore ricevere la chiavi da lei, io l’ho sempre considerata il miglior presidente americano. Il migliore a… scendere le scalette dell’aereo… a giocare a basket… a chiacchierare coi cantanti… davvero bravo… Ora può andare, ecco dieci dollari
– Ma… Donald… mi dai del lei?
– Ah, già che sei negro! Eccoti cinque dollari, sparisci!
– Scusa Donald… però… avrei una domanda
– Dimmi, su, veloce, che ho da fare
– Ma come hai fatto? Avevi contro tutti, i giornali, le televisioni, la sinistra…
– La sinistra? What is sinistra?
– Ma sì, Hillary, De Niro, Springsteen, Madonna…
– Ah, dici quelli che vivono negli attici di Manhattan?
– Beh, sì, anche loro…
– Ma io quelli li conosco bene! Glieli ho venduti io, gli attici a Manhattan! E alcuni sono ancora in affitto…
 Passata un po’ in cavalleria perché il Paese sta pensando ad altro, non ha avuto il giusto risalto la notizia che i nostri figli – quelli che secondo il famoso psichiatra leopoldo Recalcati sono bloccati nella vita dall’ottusità dei padri – potrebbero formarsi oltre che sui banchi, anche alla scuola di McDonald’s. La famosa innovazione dell’alternanza scuola-lavoro è uno dei passi più deprimenti e al tempo stesso esilaranti della famosa buonascuola. L’iter lo conoscete tutti, è quello delle più recenti riforme renziane: 1. Annuncio roboante e applausi. 2. attuazione riforma: accuse di immobilismo a chi contesta e fiducia in Parlamento. 3. la riforma è avviata e non funziona un cazzo.
Passata un po’ in cavalleria perché il Paese sta pensando ad altro, non ha avuto il giusto risalto la notizia che i nostri figli – quelli che secondo il famoso psichiatra leopoldo Recalcati sono bloccati nella vita dall’ottusità dei padri – potrebbero formarsi oltre che sui banchi, anche alla scuola di McDonald’s. La famosa innovazione dell’alternanza scuola-lavoro è uno dei passi più deprimenti e al tempo stesso esilaranti della famosa buonascuola. L’iter lo conoscete tutti, è quello delle più recenti riforme renziane: 1. Annuncio roboante e applausi. 2. attuazione riforma: accuse di immobilismo a chi contesta e fiducia in Parlamento. 3. la riforma è avviata e non funziona un cazzo.
L’alternanza scuola-lavoro è una specie di ciliegina sulla torta: insomma, bisogna far vedere ai ragazzi cos’è il mondo del lavoro, no? E’ il motivo per cui presidi e dirigenti scolastici hanno passato ore al telefono pregando enti, istituzioni, parrocchie, musei, studi professionali, associazioni caritatevoli, volontariato, marziani e altri, di prendersi in carico per qualche ora qualche studente. Ora, visto che ci sono da piazzare alcune centinaia di migliaia di ragazzi per alcuni milioni di ore di lavoro (pardon, di alternanza scuola-lavoro), il ministero ha siglato alcuni accordi con aziende grandi e piccole, enti, multinazionali. Tra queste (in buona compagnia, tra Eni e Zara, tra Accenture e Fca), McDonald’s, che si impegna a creare diecimila “percorsi formativi” (traduzione, piazzare diecimila ragazzi) nei suoi ristoranti. Ogni percorso formativo comprende (tra le altre cose) 35 ore in un locale della catena. Lasciamo ad altri calcoli più precisi, ma diecimila per trentacinque fa 350.000 ore non retribuite. Ora i casi sono due: se è un lavoro, come dovrebbe, sono 350.000 ore che non lavoreranno quelli che di solito sono pagati per farlo. Se invece non è un lavoro, non si capisce cosa significhi alternanza scuola-lavoro. Puro surrealismo.
A questa caritatevole cessione di ore-lavoro gratuite a varie multinazionali, si aggiunge la componente didattica. Dicono a McDonald’s che ci sarà anche “una parte formativa in aula per spiegare come funziona il nostro modello di business”. Traduco: migliaia di studenti italiani avranno come unico insegnamento di economia (non prevista dai programmi delle superiori), le lezioni di business di un’azienda multinazionale, cui doneranno, per ringraziamento, alcune ore della loro vita.
L’alternanza scuola-lavoro, come si configura fin qui, oscilla dunque tra un frenetico arrovellarsi su come accumulare ore di “formazione” (la prego, la imploro, faccia fare un po’ di fotocopie ai ragazzi…) e il disegno ideologico: la grande azienda planetaria che ti spiega in classe il suo “modello di business”, e poi te lo fa anche vedere da vicino, tra il ketchup e il doppio bacon. Una perfetta sintesi delle riforme renziane, in perenne oscillazione tra “arrangiatevi, cazzi vostri” e il regalo ai potenti di turno. Si ufficializza così l’ingresso (surrettizio, strisciante, travestito da “formazione”) delle aziende nel mondo scuola. Viene in mente un piccolo eroe di cui nessuno si ricorda, il diciannovenne (allora, 1998) Mike Cameron che al Coke Day, giornata ufficiale della Coca Cola, sponsor della sua scuola, la Greenbriar High School di Evans, in Georgia, si presentò con una maglietta della Pepsi. Sacrilegio e provocazione. E infatti fu espulso e sospeso dalle lezioni. Non siamo ancora lì, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. E se le 350.000 ore di scuola-lavoro tra i tavoli di McDonald’s sostituiranno 350.000 ore di lavoro retribuito, il messaggio ai ragazzi sarà chiaro e forte: nel Walhalla delle riforme renziane il mondo del lavoro è una guerra tra poveri, chi lo fa per poco scalzato da chi lo fa gratis. Una vera lezione.
Quando noi di Cuore dicevamo “Tina Anselmi Presidente” e la volevamo al Quirinale. Oggi se n’è andata la vecchia staffetta partigiana, prima donna ministro, grande riformista. Qui c’è la figurina, buona visione.
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 Ma chi se lo ricorda più Michelino, alias Michele Gramazio, il cantante che nel 1960 conquistava il mondo con il Cha cha cha della segretaria, hit planetario cantato in spagnolo e in italiano? Testo: “Cha cha cha della segretaria, / cha cha cha, che non pensa a dattilografar…”. Oplà! Ed eccoci in pieno – tra mitologia del boom economico e sorrisini maschili – nell’immaginario dell’Homo Capufficius, un filino sotto il Sapiens, ma sempre, immancabilmente, abbellito da una figura mitica, metà badante, metà pensiero stupendo da barzelletta cochonne: la segretaria. Un mito che va dagli albori dell’umanità aziendale a oggi, punto di svolta ed epifania gloriosa, grazie alla notizia che Bernardo Caprotti, mister Esselunga, ha lasciato alla segretaria – Germana Chiodi, per i giornali, “la segretaria” – 75 milioni di euro cash, cinque volte tanto quello che ha lasciato ai nipoti. Tié.
Ma chi se lo ricorda più Michelino, alias Michele Gramazio, il cantante che nel 1960 conquistava il mondo con il Cha cha cha della segretaria, hit planetario cantato in spagnolo e in italiano? Testo: “Cha cha cha della segretaria, / cha cha cha, che non pensa a dattilografar…”. Oplà! Ed eccoci in pieno – tra mitologia del boom economico e sorrisini maschili – nell’immaginario dell’Homo Capufficius, un filino sotto il Sapiens, ma sempre, immancabilmente, abbellito da una figura mitica, metà badante, metà pensiero stupendo da barzelletta cochonne: la segretaria. Un mito che va dagli albori dell’umanità aziendale a oggi, punto di svolta ed epifania gloriosa, grazie alla notizia che Bernardo Caprotti, mister Esselunga, ha lasciato alla segretaria – Germana Chiodi, per i giornali, “la segretaria” – 75 milioni di euro cash, cinque volte tanto quello che ha lasciato ai nipoti. Tié.
Colpo da maestro e riscatto definitivo di una categoria, quella della segretaria, appunto, tra le più bistrattate dalla storia. Lei, che in azienda accanto al patron è entrata nel 68, nemmeno ventenne, ne esce oggi con più soldi di quelli che si risparmierebbero facendo a pezzi la Costituzione. Una bella liquidazione per essere stata negli anni segretaria, assistente, complice, confidente, manager, stratega e braccio destro, esperta in questioni aziendali e in gineprai famigliari.
Onore a Germana, dunque, perché le segretarie che entrano nelle cronache non sono molte, e a quelle famose non si risparmia mai un fastidioso aggettivo di tipo canino: “fedele”, o “fedelissima”, quando non si arriva al semi-mistico “devota”. Lo era la mitica Enza, (Vincenza Tomaselli), segretaria di Bettino Craxi, più di trent’anni accanto al boss, per cui finì anche in galera, e poi via, dimenticata in una casa di periferia fino al funerale senza clamori (dove si suonò, però, l’Internazionale: chapeau). Poi venne Marinella, la Brambilla, segretaria di Silvio. Una che sapeva tutto e non diceva niente, una capace di tenere in anticamera i potenti del Paese, con i suoi “il dottore arriva subito”. Organizzatrice perfetta, temuta da tutti, così dignitosa da andarsene all’inglese – grazie di tutto – quando si cominciò a vociferare di cene eleganti e signorine Olgettine, che a prendere il conquibus andavano dal ragioniere, non certo da lei. Mujer vertical, potremmo dire, estromessa dal cerchio magico delle badanti di Arcore. Anche lei, c’è da scommettere, non se la passa male, ma i 75 milioni della signora Germana no, quello è record.
Chi poi volesse entrare nel gorgo delle interpretazioni, faccia pure. Ci metta l’estremismo calvinista di patron Caprotti, che amava il supermarket più dei figli (e te credo!), e l’efficienza aziendale più della famiglia. Ma resta il fatto: la signora Chiodi vendica in un solo colpo – il tempo di aprire una busta e fare due conti – decenni di subalternità e sottomissione di una figura quasi neorealista considerata buona per battere a macchina e poco altro. Errore fatale: le segretarie sanno tutto, vedono tutto, tengono l’agenda, sanno a chi mandare fiori e quando, conoscono peccati e peccatori. E insieme del peccato incarnano segretamente (segretamente per l’Homo Capufficius, spesso non più furbo del ficus aziendale dietro la scrivania) l’essenza, al punto di litigarsi con le infermiere la palma delle più visitate categorie di Youporn. Da oggi, grazie alla signora Chiodi e alla sua fresca e meritata ricchezza, la parola “segretaria” andrà letta con altri occhi: più alter ego, consigliera, socia, che arredo d’ufficio. Era ora, certo, e non è mai troppo tardi per diventare una bandiera. Altro che Cha cha cha della segretaria: la signora avrà ballato il mambo, sapendo di contare più di tanti manager, dirigenti e direttori galattici. Ecco, giustizia è fatta. Cha cha cha.
La recensione di Anna Girardi per 84Charingcross.com. Cliccare sull’immagine per leggere, oppure il link è qui
 Alla fine c’è riuscito. Matteo Renzi, a tarda sera, provato dalla giornata ma indomito e sovreccitato per tutta la cena è riuscito a far dire sì a Obama. A tradimento, fingendosi sovrappensiero gli ha chiesto, “Scusa Barack, mi passi il sale?”. E quello: “Sì”. Missione compiuta.
Alla fine c’è riuscito. Matteo Renzi, a tarda sera, provato dalla giornata ma indomito e sovreccitato per tutta la cena è riuscito a far dire sì a Obama. A tradimento, fingendosi sovrappensiero gli ha chiesto, “Scusa Barack, mi passi il sale?”. E quello: “Sì”. Missione compiuta.
Lo sbarco a Washington della pattuglia italiana – meno numerosa di quella dei nostri soldati in Lettonia, o in Libia, o di quelli che combattono a Mosul – è stato assai seguito e celebrato. Una specie di apoteosi, con Matteo che sostiene Hillary, Barack che sostiene Matteo, e Matteo che sostiene Benigni, appesantito dal piatto di lenticchie. Le eccellenze italiane sono state esibite, due registi premi Oscar, il grande stilista e la giovane campionessa disabile, la scienziata, la sindaca eroe (non è un modo di dire) di Lampedusa, la direttrice del dipartimento del design (vanto italiano ma museo americano, il Moma, roba buonissima), più il capo dell’anticorruzione Cantone. Insomma una specie di Bignami dell’Italia come la vede Matteo: fantasiosa e divertente, ma anche con capacità scientifiche, tenace e fresca come la giovane schermitrice Bebe Vio, ma anche manageriale e colta, creativa e, ovvio, elegante. Insomma, l’orgoglio. Ma anche il grande problema geopolitico delle migrazioni umane (Giusi Nicolini e la sua frontiera di mare) e sì, sì, va bene, lo sappiamo che c’è un po’ di corruzione, ma ci stiamo lavorando (ed ecco Cantone, oplà! Magari è uscito dalla torta).
Il manuale Cencelli delle eccellenze serve essenzialmente ad accreditarsi come buon alleato e, qui da noi, a mostrarci il magico mondo dell’Italia che dice Sì, un Mulino Bianco delle farine migliori, un po’ di retorica del Belpaese, il “ce la faremo” e tutta la prosopopea del nuovo contro il vecchio, del futuro contro il passato, del veloce contro il lento, del bonus contro i diritti. Tutto lustro, pulito e levigato come in un’inquadratura di Sorrentino.
Naturalmente non si pretende che un Presidente del Consiglio in visita ufficiale faccia della sociologia e si porti appresso una reale rappresentanza del suo paese. Pensa che imbarazzo le presentazioni con Michelle: “Questo è Fabrizio Corona, italian bad boy, occhio all’argenteria, eh!”. Oppure: “Questo è il fratello del ministro dell’Interno… tranquilla, non chiederà dov’è il bagno, si porta il suo”. O ancora: “E questo è il bambino più fortunato del mondo: ha schivato il controsoffitto della scuola per ben tre volte!”. E non staremo qui a dire delle altre rappresentazioni dell’Italia reale, magari pescando dalle cifre della Caritas diffuse proprio mentre l’Air Matteo One prendeva il volo: i poveri triplicati in sette anni (ora sono 4,6 milioni), o il fatto che moltissimi siano giovani. O ancora che si impennano voucher e neo-finte partite Iva.
Insomma, va bene l’orgoglio e va bene pure la propaganda. Lo spot americano avrà forse i suoi effetti, Renzi andrà a parlare di soldi in Europa con ancora calda la pacca sulla spalla di Obama, e tutti i media italiani faranno oh! di ammirazione. Il paese reale si ostinerà a restare reale, e anzi, trovandosi in gran parte a fare i conti del pranzo con la cena, guarderà al galà americano come a una cosa assai distante, una fiction a sorpresa, che può virare verso Hollywood come verso la commedia, una recita quasi ostile nella sua siderale lontananza. A raccogliere onori esibire la sua idea di Italia – una specie di Fantabosco delle eccellenze – lo stesso premier che qualche giorno prima, alla Camera (a Roma, non a Washington) difendeva i bassi salari italiani come elemento di competitività, come attrattiva per capitali esteri: venite qui che costiamo poco. Insomma, scintillante Italia là, alla casa Bianca; Italia in saldo per chi cerca mano d’opera a basso costo qui. Il sogno e la realtà.
 Se il dylanismo fosse una scienza esatta sarebbe tutto un po’ meno divertente. Invece nulla è imprevedibile come mister Zimmerman, cosa che ha scatenato negli anni moltitudini di dylanologi dediti all’ipotesi ardita, alla lettura dei segni, all’interpretazione cervellotica di occhiate e mezze frasi: cosa dice, fa, pensa Dylan? Il modo migliore di saperlo, naturalmente è comprare il biglietto: Dylan suona sempre, il suo tour si chiama “Neverending” e chissà, magari se oggi andate a Phoenix, o martedì a Albuquerque, o mercoledì a El Paso, potete chiederlo a lui. Non ha cambiato programmi, sarà sul palco.
Se il dylanismo fosse una scienza esatta sarebbe tutto un po’ meno divertente. Invece nulla è imprevedibile come mister Zimmerman, cosa che ha scatenato negli anni moltitudini di dylanologi dediti all’ipotesi ardita, alla lettura dei segni, all’interpretazione cervellotica di occhiate e mezze frasi: cosa dice, fa, pensa Dylan? Il modo migliore di saperlo, naturalmente è comprare il biglietto: Dylan suona sempre, il suo tour si chiama “Neverending” e chissà, magari se oggi andate a Phoenix, o martedì a Albuquerque, o mercoledì a El Paso, potete chiederlo a lui. Non ha cambiato programmi, sarà sul palco.
Per ora si sa che quelli dell’Accademia svedese continuano a cercarlo per telefono e a non trovarlo, il che eccita parecchio i media: che farà Bob? Un no grazie come Sartre nel ’64? Manderà qualcuno a ritirarlo, come fece per protesta Marlon Brando con l’Oscar? Fanno notare i dylanisti più attenti (è una forma di follia, sapete?), che a Las Vegas – già sapeva del Nobel – ha chiuso il concerto con un pezzo dell’amato Sinatra, Why try to change me now, che sembra un commento beffardo dei suoi, ma sarà invece un caso, uno di quelli che alimentano le leggende.
Ora si può immaginare la telefonata: mister Dylan? Qui è l’Accademia di Svezia… Eh? Chi? Ah, sì, ho letto qualcosa… Cortese e fuggevole: Dylan è sempre stato questo in fondo, la proiezione di quello che gli altri avrebbero voluto che fosse. La sua rivincita, dunque, è di essere quello che è, ed è una cosa che sa probabilmente solo lui.
Ma che Dylan non vada a prendersi il suo Nobel è piuttosto improbabile: non è un tipo che disdegna i premi, e se volesse inscenare una protesta probabilmente protesterebbe perché non gliel’hanno dato prima. Alla consegna della Legion d’Onore, a Parigi, tre anni fa, si presentò in cravatta con un’improbabile giacchetta simil-marinara, impettito come un generale durante l’inno, mentre per prendersi la medaglia della Libertà alla Casa Bianca (2012) si mise pure il farfallino, la faccia di una vecchia prozia, le labbra piegate impercettibilmente come se dicesse: che ci faccio io qui? Una siderale, ma anche ironica, inscalfibile distanza dal mondo.
Non si preoccupino troppo gli accademici di lassù: Dylan non è un ospite ingombrante, non è uno che fa lunghi discorsi e di solito se ne va all’inglese. Intervistato da Rolling Stone sul suo incontro con Dylan per un concerto all-stars alla Casa Bianca, Barack Obama ha confessato di non essere riuscito a farsi far una foto con lui: “Finisce la canzone, scende dal palco – io sono seduto proprio davanti a lui – si fa avanti, mi stringe la mano, fa un cenno con la testa, un mezzo sorriso e se ne va”. Ecco, diciamo che Dylan non è uno che si ferma al rinfresco, di solito. E si noti en passant che di solito si chiede ai cantanti come hanno trovato il Presidente, e non viceversa. Per dire del fenomeno.
Mai come in questi giorni, parafrasando quello che McLuhan diceva del rock, Dylan è “un evento elettromagnetico che avvolge il pianeta”. E magari chissà, un giorno verremo a sapere (manoscritti ritrovati? appunti sparsi?) cos’ha pensato mentre il mondo si divideva tra apocalittici (Sacrilegio! Così si uccide la letteratura! Un cantante!) e integrati (Giusto così, perché Dylan è anche grande letteratura). Il ragazzo (75 anni) sa essere autocritico, ma non si può dire sia un falso modesto: “Nessuno ha fatto quello che ho fatto io”, e “Non pretendo di essere capito, forse succederà tra un secolo”, frasi storiche. Al momento, mentre scrivo, non ha ancora risposto il telefono, né commentato sul suo sito, dove campeggia invece la maestosità dell’ultima follia di noi collezionisti: 36 cd (trentasei!) con tutto ciò che ha suonato nell’anno di grazia 1966, quando il ragazzino del folk diventava elettrico. Ora pare interessante guardare al mistero e scuotere il capo per Bob che non risponde al telefono, ma chissà, magari trovano occupato, magari sta solo cercando un volo per Stoccolma.
Altro giro, altra corsa. E ancora Dylan, e ancora perché sì. Audio da Radio Company
 Va bene, il Nobel a Dylan è arrivato. Ero uno di quelli che lo aspettava. Assisto un po’ sconcertato al dibattito se considerare Dylan letteratura. Siccome io dentro Dylan ci trovo più letteratura che in qualunque altro autore che abbia scollinato il Novecento, beh, capirete. In più c’è la faccenda Carlo Monterossi: lui se ne frega dei dibattiti culturali e si sarà fatto un Oban come si deve, magari cercando questo e quello nella sua mirabolante collezione dylaniana. Anche la mia non è male, eh!
Va bene, il Nobel a Dylan è arrivato. Ero uno di quelli che lo aspettava. Assisto un po’ sconcertato al dibattito se considerare Dylan letteratura. Siccome io dentro Dylan ci trovo più letteratura che in qualunque altro autore che abbia scollinato il Novecento, beh, capirete. In più c’è la faccenda Carlo Monterossi: lui se ne frega dei dibattiti culturali e si sarà fatto un Oban come si deve, magari cercando questo e quello nella sua mirabolante collezione dylaniana. Anche la mia non è male, eh!
Sull’argomento mi ha intervistato Radio Popolare – il bravo Davide Facchini – e la chiacchierata è qui sotto.
 “Per i miei figli, per i nostri figli, non ci fermeremo”. Così Matteo Renzi ha chiuso la direzione Pd, al netto del mascellone volitivo e degli occhi penetranti, ma insomma, il tono era quello. Ed eccone un altro che tira fuori i figli, un classicone, come quegli standard dello swing che ti bastano due note per riconoscerli. I figli! Quell’altro, il poro Silvio, giurava spesso sulla testa dei figli, e non essendo uno di indole sincerissima tutti ci preoccupavamo molto.
“Per i miei figli, per i nostri figli, non ci fermeremo”. Così Matteo Renzi ha chiuso la direzione Pd, al netto del mascellone volitivo e degli occhi penetranti, ma insomma, il tono era quello. Ed eccone un altro che tira fuori i figli, un classicone, come quegli standard dello swing che ti bastano due note per riconoscerli. I figli! Quell’altro, il poro Silvio, giurava spesso sulla testa dei figli, e non essendo uno di indole sincerissima tutti ci preoccupavamo molto.
Ma comunque: i figli. Argomento di natura emotiva (so’ piezz’e core) ed evocazione del tempo a venire, insomma, il futuro, le nostre scelte che riguardano loro, perché a loro consegneremo… (eccetera eccetera, aggiunere a piacere). A pensarci, questo essere strenuamente dalla parte dei figli è un leit-motiv del primo renzismo. Qualche Leopolda fa, il finanziere Serra tuonò contro le generazioni precedenti (intendeva i pensionati) che “rubano il futuro” ai figli. In soldoni: siccome prendi la pensione, aumenti il debito pubblico che pagherà tuo figlio. Seguì il plauso dei figli leopoldi, roba da tragedia greca, alti lai contro il papà pensionato che ruba il futuro al figlio precario (magari dopo avergli pagato gli studi, ovvio). Siccome i figli erano (e sono) abbastanza sfigati, alle prese con un mondo del lavoro polverizzato che li paga in voucher, si tentò di affascinarli con la carta della modernità. E allora si presero allegramente per il culo i padri, scemi, che mettono il gettone nell’iPhone e vanno in giro col mangianastri. Padri consumati e pure privilegiati: urgeva abolire l’articolo 18 per ristabilire un po’ di parità nella sfiga (senza pensare che l’articolo 18 di papà poteva servire da mini-garanzia anche ai figli, mah). Sempre in nome dei figli, si disse che autorizzando a licenziare liberamente si sarebbe aumentata l’occupazione. Bella pensata. Per poi scoprire che il jobs act assume soprattutto over cinquanta (così le garanzie crescenti non crescono troppo), e i figli vanno avanti a voucher, stage, contrattini, buoni pasto, pacche sulle spalle e le faremo sapere.
Naturalmente di questa retorica sui figli, le nuove generazioni, la caricatura di modernità, fa parte il mito renzista della dinamicità. Uff, due camere, che seccatura. Uff, discutere, che perdita di tempo, su, su, usiamo la app, facciamo in fretta. E così si alimentano miti modernissimi, la startup creata in cantina, dove il ragazzino può passare da studente a imprenditore in un nanosecondo. E giù hurrà per questi giovani dinamici, anche se poi scopri (a Torino e Milano in questi giorni) che senza altri giovani che pedalano per due euro a consegna tutto sto dinamismo non starebbe in piedi. Ecco, tra padri e figli e chi li usa strumentalmente si crea questo cortocircuito: da una parte si disegnano scenari futuribili di ripresa economica creativa e moderna, dall’altra siamo al neorealismo di Ladri di biciclette, stipendi da fame, cottimo, e la bicicletta propria come mezzo di produzione. Solo che nel film (De Sica, 1948) lo sfigato era il padre, con grande tristezza del bambino, mentre qui a pedalare per due euro a consegna (Poletti, 2016) sono i figli. Ecco fatto.
Ora arriverà il regalo di 500 euro per i figli (quelli grandi, che compiono diciott’anni), e aspettiamo il battimani d’ordinanza. Naturalmente, accecati dalla manciata di euro, pochi noteranno che dare la stessa cifra al figlio del notaio e a quello del bracciante produce una di quelle cose che ai nostri figli vorremmo evitare: l’aumento delle diseguaglianza. E invece. Insomma, quel che fanno Renzi, il renzismo, e la renzità per i figli – “Per i miei figli, per i nostri figli, non ci fermeremo” – è l’esatto contrario di quel che bisognerebbe fare per i figli, se si augura loro un futuro migliore.
 Lungo e disteso al tappeto come un pugile che le ha prese di santa ragione, il deputato europeo di Ukip Steven Woolfe ha pagato (con il ricovero all’ospedale) un franco scambio di vedute con un collega. Rissa, schiaffoni, colpo alla testa e una serena discussione tra compagni di partito – quello di Farage – basata sul vecchio e granitico argomento del chi-mena-per primo-mena-più-forte. Risultato: ko tecnico e un po’ di paura per Woolfe, che sarebbe il più accreditato successore di Farage in Europa (tranquilli, ora sta bene, era pure il suo compleanno, povero! Auguri!), e una foto che fa il giro del mondo.
Lungo e disteso al tappeto come un pugile che le ha prese di santa ragione, il deputato europeo di Ukip Steven Woolfe ha pagato (con il ricovero all’ospedale) un franco scambio di vedute con un collega. Rissa, schiaffoni, colpo alla testa e una serena discussione tra compagni di partito – quello di Farage – basata sul vecchio e granitico argomento del chi-mena-per primo-mena-più-forte. Risultato: ko tecnico e un po’ di paura per Woolfe, che sarebbe il più accreditato successore di Farage in Europa (tranquilli, ora sta bene, era pure il suo compleanno, povero! Auguri!), e una foto che fa il giro del mondo.
Nemmeno il tempo di leggere le agenzie, di scuotere la testa per cotanta armonia, di commentare, ed ecco la notizia di un altro incontro. Ring prestigioso (il cortile della Camera dei deputati) ed altro scontro tra fratelli. Faccia a faccia del genere sto-stronzo-mi-ha-fregato-il-parcheggio, parole grosse, atteggiamenti minacciosi tra Giorgio Sorial e Francesco Chiariello, cinque stelle contro cinque stelle, che fa dieci stelle, quindici stelle se contiamo anche Vincenzo Caso, il collega che si è messo in mezzo per dividerli (bravo). Nessuno si è fatto male come Woolfe, e a uscirne contusa è stata solo la favoletta del movimento unito, armonico e animato da fraterna amicizia, che ne esce un po’ malconcia. Indiscrezioni a bordo ring parlano di dissidi sull’agenda e riunioni saltate all’ultimo minuto. Saltate insieme ai nervi, si direbbe.
Andiamo, non è il caso di fare del facile moralismo: tutti sanno che spesso la testata sul setto nasale è un ottimo argomento dialettico, specie per chi non ne ha altri, e quel che stupisce è semmai che le due risse siano avvenute tra colleghi dello stesso schieramento: grillini versus grillini qui, e “faragiani” contro “faragiani” là, alleati in Europa per motivi tattici. I primi reduci dal grande successo della presa di Roma, i secondi entusiasti della vittoria al referendum sulla Brexit. Insomma, nel caso specifico, più che guai ai vinti, guai ai vincitori. Sarà che le vittorie non sono mai ciambelle perfette, con il loro buco d’ordinanza. La vittoria di Roma è complicata dalle vicende che sappiamo, quella dell’Ukip da altre faccende, tra cui la successione in Europa al dimissionario Farage. Contraddizioni in seno al popolo, finite a cazzotti. Si potrebbe dire che il successo gli ha dato alla testa, ma anche che l’insuccesso ci ha messo del suo. Per le rivincite vi terremo aggiornati.
 Le dentiere gratis per gli anziani. L’abolizione del bollo auto, cartuccia che Silvio si sparò all’ultimo secondo contro Prodi. La cura per il cancro se si vincono le regionali in Piemonte (sempre Silvio buonanima). E poi basta andare a sfogliare nell’album dell’ultimo ventennio per trovare prebende e mance, roboanti promesse, qui la pecunia qui il cammello, una specie di voto di scambio di massa. Per dire che Matteo è solo all’inizio, gli basta schioccare le dita ed ecco altri mirabolanti doni. Il Ponte sullo Stretto, che era un simbolo del berlusconismo come il pupazzo Five, il biscione e le leggi su misura – una cosa diventata addirittura proverbiale per descrivere la polvere negli occhi che l’uomo di Arcore sapeva gettare – è diventata una nuova bandiera di Matteo. Con sponde politico-economiche notevoli: il signor Salini, che il ponte dovrebbe costruirlo, nel caso, dice che se vince il No potrebbe lasciare il Paese, nientemeno. Un portafoglio in fuga, insomma. E’ un’offerta specialissima: se comprate il Sì vi danno in omaggio l’Italicum e un ponte. Pacchetto completo.
Le dentiere gratis per gli anziani. L’abolizione del bollo auto, cartuccia che Silvio si sparò all’ultimo secondo contro Prodi. La cura per il cancro se si vincono le regionali in Piemonte (sempre Silvio buonanima). E poi basta andare a sfogliare nell’album dell’ultimo ventennio per trovare prebende e mance, roboanti promesse, qui la pecunia qui il cammello, una specie di voto di scambio di massa. Per dire che Matteo è solo all’inizio, gli basta schioccare le dita ed ecco altri mirabolanti doni. Il Ponte sullo Stretto, che era un simbolo del berlusconismo come il pupazzo Five, il biscione e le leggi su misura – una cosa diventata addirittura proverbiale per descrivere la polvere negli occhi che l’uomo di Arcore sapeva gettare – è diventata una nuova bandiera di Matteo. Con sponde politico-economiche notevoli: il signor Salini, che il ponte dovrebbe costruirlo, nel caso, dice che se vince il No potrebbe lasciare il Paese, nientemeno. Un portafoglio in fuga, insomma. E’ un’offerta specialissima: se comprate il Sì vi danno in omaggio l’Italicum e un ponte. Pacchetto completo.
Tra le notevoli trovate del partito-Renzi c’è anche questa: l’Armageddon economico, la narrazione tossica che se vincesse il No, i capitali scapperebbero via, nessuno investirebbe più, i grandi gruppi se la darebbero a gambe. Altro che mobili all’Ikea e consegne di Amazon: vi monterete i comò da soli e dovrete camminare per comprare qualcosa, sempre se rimarrà della merce nei negozi. Terrorismo insomma. Ma come molte cose del renzismo, basta scostare la tenda e dietro c’è la panzana. La sostituzione del Senato con una specie di dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali è venduta come il toccasana per l’insostenibile lentezza del nostro iter legislativo. Panzana grossa, perché invece qui le leggi si fanno eccome, e anche velocemente. La Germania ne approva 144 all’anno (in media, dal ’97 al 2013), l’Italia 120, la Francia 91, la Spagna 45, la Gran Bretagna appena 42. Cade con questi numeri la tiritera del “non si decide”, recitata da uno che decide molto, e spesso da solo, e quasi sempre in fretta e male. Quanto alla diaspora dei capitali, che fuggirebbero via nel caso il premier perdesse il referendum sul premier, è bene ricordare come tentiamo di attirarli. Un’elegante brochure del ministero dello Sviluppo da poco pubblicata, svela il mistero: rivolgendosi agli investitori stranieri, vanta con orgoglio il fatto che In Italia “il costo del lavoro è al di sotto della media Eurozona”. E dunque altro che riforme, Sì, No, Senato in miniatura e velocizzare il Paese: chi viene qui a investire lo fa perché costiamo meno e ultimamente pratichiamo anche notevoli sconti sui diritti dei lavoratori.
Dunque siamo a questo: gran parte delle affermazioni che ogni giorno il presidente del consiglio pronuncia nel suo Grand Tour per sostenere il referendum su se medesimo, sono presentate come dogma di fede. Siamo lenti nel fare le leggi! Tutti annuiscono. Oppure si tratta di mesmerismi: il Pil previsto col burbanzoso ottimismo del bulletto (poi preso a ceffoni da Corte dei Conti e Bankitalia), oppure le fantasiose architetture numeriche per dire che il Job Act ha funzionato e gli ottanta euro pure: trenta miliardi distribuiti a imprese e cittadini che sul Pil hanno pesato zero (e basta andare a vedere i dati sulla stagnazione degli investimenti privati per capire che quei 20 miliardi ricevuti in dono con il Jobs Act le aziende non li hanno investiti per niente). Basterebbero i fatti invece delle parole, insomma. Invece avremo un profluvio di parole, promesse, minacce, ricatti, il babau, l’uomo nero e il costruttore di ponti che se vince il No se ne va. E noi rimaniamo senza ponte. Gné gné.
Stiamo tornando… Crozza nel Paese delle Meraviglie, da venerdì 7 ottobre, su La 7, ore 21.10
Crozza nel paese delle meraviglie è un programma di Maurizio Crozza scritto con Vittorio Grattarola, Andrea Zalone, Alessandro Robecchi, , Francesco Freyrie, Claudio Fois, Alessandro Giugliano e Luca Restivo. Orchestra del Maestro Silvano Belfiore. La regia è di Massimo Fusi.
25 anni fa moriva Miles Davis. Qui c’è la sua figu. Buona visione
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 Siccome non ha niente da fare – economia tutto bene, paese in perfetto ordine, nessuna emergenza – il presidente del Consiglio annuncia il suo tour propagandistico per il Sì. Duecento incontri in sessanta giorni: significa che perdiamo uno che governa il paese (poco male, nel caso specifico) e guadagniamo un piazzista in trance agonistica. Un po’ come se uno, impiegato all’anagrafe, andasse dal capufficio a dirgli: ehi, capo, per due mesi vado a lavorare in banca.
Siccome non ha niente da fare – economia tutto bene, paese in perfetto ordine, nessuna emergenza – il presidente del Consiglio annuncia il suo tour propagandistico per il Sì. Duecento incontri in sessanta giorni: significa che perdiamo uno che governa il paese (poco male, nel caso specifico) e guadagniamo un piazzista in trance agonistica. Un po’ come se uno, impiegato all’anagrafe, andasse dal capufficio a dirgli: ehi, capo, per due mesi vado a lavorare in banca.
La ricaduta di questo sforzo bellico sarà mostruosa. Ogni sera e ogni giorno i telegiornali ci diranno di Renzi di qui e di Renzi di là, sarà un bombardamento senza precedenti, una specie di pandemia del consenso obbligatorio. Il Fatto Quotidiano, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, fornisce alcuni consigli, profilassi e modi per aumentare le difese immunitarie.
Tappi. Antichissimo metodo analogico, consiste nel ficcarsi qualcosa nelle orecchie per non sentire altre baggianate. Purtroppo le tappe del tour di Renzi, i processi alla tappa, il tappone di montagna, la cronometro (oggi sei incontri! Record!) saranno on-air giorno e notte, quindi l’unica profilassi sensata è tenere i tappi sempre.
Farmaci retrovirali. Contrastare l’azione della propaganda con regolare assunzione di fatti. Quando sentirete per la trentaduesima volta che serve un parlamento smart per fare le riforme perché altrimenti moriremo tutti, correte a leggere il foglietto che trovate nella scatola dei tappi. Elenca le riforme fatte in Italia quando c’era il bicameralismo perfetto e addirittura il proporzionale. Divorzio, Statuto dei Lavoratori, Sistema Sanitario Nazionale, fine del delitto d’onore, legge Basaglia… Potrete leggere per mezz’ora (sono tante, e anche buone), decidete voi la posologia. Alla fine del trattamento proverete un senso di piacevole spossatezza, e avrete la certezza fattuale che le grandi riforme che hanno cambiato il Paese sono state fatte con la Costituzione che oggi si vuole cambiare.
Yoga e zen. Le discipline orientali possono aiutare. Mettersi nella posizione del loto e fare “Ohmmmmmm” mentre Matteo Renzi annuncia le mirabilie del Sì è certamente un buon metodo. Il problema è se il comizietto di giornata vi arriva dalla radio mentre state guidando, e incrociare le gambe non è prudente. Per fortuna avete i tappi (mica vi sarete scordati i tappi, vero?)
Calamite da cruscotto. Sempre pensando all’eventualità di essere colti di sorpresa dalla propaganda generata dal Renzi tour, utili anche vecchi talismani anni Cinquanta, come le calamite da cruscotto. Invece dei figli (“Papà, vai piano pensa a noi”) o di Padre Pio, potrete mettere la foto di Verdini che scrive la nuova legge elettorale.
Conto Corrente. Tenete sotto controllo l’estratto conto. Per convincere la gente a votare un pasticcio simile bisognerà dare qualche incentivo. Come sempre prima di importanti votazioni c’è qualche donazione, mancia, bonus, prebenda, arrotondamento o paghetta. Attivate l’apposito servizio via sms: vi avvertirà delle novità e dai prelievi sul vostro conto. Qualcosa come: Plin! Da domani pagherete ticket sanitari su esami o interventi che prima erano gratis. Plin! Ecco cinquecento euro a chi vota per la prima volta, indipendentemente dal reddito di famiglia. Plin! Ri-perdonati quelli che hanno portato soldi all’estero. Se siete tipi nervosi silenziate il telefono, o rimettete i tappi.
Coltivare il dubbio. Non respingete il dubbio, non trinceratevi dietro granitiche certezze. Ora, per due mesi avrete questo dubbio: ma Renzi fa tutto questo per noi, suo amato popolo e Paese, o per Matteo Renzi, suo amatissimo se stesso? Fare duecento comizi in due mesi non è esattamente “spersonalizzare il referendum”, dunque il dubbio vi verrà, ecco, pensateci, non scacciatelo, imparate a conviverci. Fino al 4 dicembre.
 Dovrei rivedere la registrazione, leggere il sottopancia, sapere il nome del signore, operaio all’Ilva di Taranto intervistato in tivù, che commentando la morte di un giovane collega (Giacomo Campo, 25 anni) ha detto con le lacrime agli occhi: “Noi non ne possiamo più”.
Dovrei rivedere la registrazione, leggere il sottopancia, sapere il nome del signore, operaio all’Ilva di Taranto intervistato in tivù, che commentando la morte di un giovane collega (Giacomo Campo, 25 anni) ha detto con le lacrime agli occhi: “Noi non ne possiamo più”.
Una frase vera, non televisiva. Quelle parole che ti escono da sole quando davvero ti cascano le braccia, quando “non ce la fai più”. Una sincerità così dolente e disarmante che nel tempo di dirla vaporizzava tutte le belle e edificanti narrazioni sul lavoro che ci beviamo ogni giorno. Poi ho deciso di non cercarlo, il nome. Non mi dispiace ricordare quel “Noi non ne possiamo più” come un sospiro sconfitto dell’Operaio Ignoto, che riguarda un po’ tutti.
Nella stessa settimana, abbiamo visto un altro operaio (Abdesselem El Danaf, 53 anni) morto sotto un Tir a Piacenza. Lui faceva il picchetto, il camion l’ha tirato sotto, la procura ha chiuso velocemente l’inchiesta, la rabbia resta: altri che “non ne possono più”. Per un paio di giorni abbiamo letto le condizioni dei lavoratori della logistica, con le loro coop fantasma che appaiono e scompaiono fregandosi ad ogni curva qualche mese di stipendio di gente che già fatica parecchio a mettere insieme il pranzo con la cena. Poi basta, uh, che noia, che cosa poco glamour, vero?
Questo accade in un Paese che è la seconda manifattura d’Europa (dopo la Germania) e dove, nonostante questo, si ripete da anni che “gli operai non ci sono più”. Roba vecchia (il gettone del telefono, il rullino… Renzi il Moderno ci scherzò sopra, ovviamente). Dove si rappresenta sempre il lavoro dipendente come una specie di palla al piede, una seccatura antica, dove si limano costantemente garanzie, diritti, tutele, dove l’emergenza di trovare un lavoro ha cancellato ogni discorso sulla sua qualità. La narrazione ventennale sulla “rigidità” del lavoro che andava reso più flessibile ha portato fin qui, e ora si può dire che da flessibili non si sta meglio di prima, anzi. E pure l’economia, a guiardare il Pil, non se n’è giovata granché. Le teorie confindustrial-leopolde che facevano passare un operaio con l’articolo 18 come una specie di privilegiato, manco fosse un banchiere, hanno fatto il loro corso, ma è solo l’ultima goccia nel vaso.
E quindi grazie ancora all’Operaio Ignoto che dice “Noi non ne possiamo più”, perché non parla “solo” dell’Ilva, ma di tutto il lavoro, e non solo di leggi e contratti, ma anche di quel clima che c’è intorno al lavoro, un po’ di emergenza (tienitelo stretto a qualunque condizione!), un po’ di ricatto, sempre di pressione e di compressione colpevole (devi lavorare domenica?, fare la notte?, dodici ore? Ringrazia Dio che hai un lavoro!). Un clima che si sente, palpabile, difficile da nascondere, perché più o meno tocca tutti: il mondo del lavoro è oggi il luogo della paura sociale, dello stringere i denti.
Eppure di lavoro si parla tanto. In genere per litigare sui numeri: come per tutte le riforme renziane si chiede l’atto di fede e bisogna dire “Il Jobs act ha funzionato”, anche se i numeri dicono il contrario. Oppure vengono mostrate le immagini delle eccellenze: la Ferrari, il cioccolato, il tapis roulant, e via così: gallery un po’ surreali e un po’ nord-coreane in cui il Grande Leader si complimenta per la bella fabbrica. L’operaio-slide al posto dell’operaio diffuso, reale, stanco. La mortificazione del lavoro è roba vecchia, non l’hanno certo inventata Renzi e Poletti, ma il distacco della narrazione ufficiale dalla vita reale non è mai stato così ampio e clamoroso, addirittura offensivo per chi abita la vita reale e non i fotogrammi della propaganda. Chissà se l’Operaio Ignoto gradisce questa girandola propagandistica che continua a ripetere che tutto è bello e luccicante e #italiariparte, mentre lui “non ne può più”.
 Come farà Matteo ora che ha litigato con Angela? Ma soprattutto come farà a tornare da lei con il cappello in mano ora che l’ha fatta incazzare? In esclusiva la trascrizione la telefonata con cui Matteo ha chiesto aiuto a un vecchio maestro, uno che Angela la conosce bene…
Come farà Matteo ora che ha litigato con Angela? Ma soprattutto come farà a tornare da lei con il cappello in mano ora che l’ha fatta incazzare? In esclusiva la trascrizione la telefonata con cui Matteo ha chiesto aiuto a un vecchio maestro, uno che Angela la conosce bene…
– Pronto, Silvio… Ehm… sono Matteo
– Eh? Ma che ore sono?
– Le due passate. Scusa, io…
– Cose gravi, eh?
– Sì, Silvio… Torno da Bratislava… Ho litigato con Angela e… magari tu…
– Ah, hai litigato con Angela e svegli me? Perché non chiami Verdini?
– Ma no, non fare così… Mi fai il geloso! …Poi Verdini l’ho nascosto, che se quello dice che vota Sì mi rovina… Senti, io so che tu con Angela…
– Eh, una volta l’ho fatta persino aspettare perché ero al telefono…
– Sì, lo so, con Erdogan…
– Sì… sì, diciamo che era Erdogan… buona idea… le Erdoghine!
– E poi le hai anche detto quelle brutte cose… culona (incomprensibile)
– Ma poi mi ha perdonato…
– Ma io come faccio, Silvio?
– Ma dai! Le tieni un po’ il muso, poi le prometti qualcosa, tipo che riduci il debito pubblico… sono anni che ci casca… Le piace crederci!
– Ma io devo chiederle più flessibilità e ora abbiamo litigato!
– Tranquillo, c’è un piano B: fai il duro…
– Ma come?
– Batti i pugni sul tavolo, fai il matto… E poi, quando è tutta intenerita le dici… senti, per quella flessibilità che mi servirebbe… coprila di regali…
– Ma che regali, Silvio? Ma che dici! Cosa regalo a una che ha già tutto?
– Non so, un’agenda del Monte dei Paschi… Stai solo attento allo spread… a me mi hanno riso in faccia per quello…
– Ma no! Noi abbiamo l’Italia che riparte…
– Eh?
– No, dicevo, l’Italia che riparte…
– Come? Non si sente!
– Oh, io sto urlando, eh… dico l’Italia che riparte!
– Non si sente, Matteo…
– (tu-tu-tu…)
– Silvio! Silvio!…
(tu-tu-tu)
 Con tutto il rispetto per i film del filone catastrofico – astronavi aliene, meteoriti giganti, onde anomale, glaciazioni – bisognerebbe avere più rispetto per le profezie di sventura. Un po’ perché i disastri sono una cosa seria, e un po’ per scaramanzia, perché disseminare paranoia a volte equivale a chiamarsela. In più, c’è un altro elemento notevole: se invochi il disastro, l’Apocalisse, “il nulla”, come disse Napolitano in una famosa intervista, poi è difficile tornare indietro e rassicurare la gente, è come dire “abbiamo scherzato”, non rassicura nessuno e ti fa sembrare fesso.
Con tutto il rispetto per i film del filone catastrofico – astronavi aliene, meteoriti giganti, onde anomale, glaciazioni – bisognerebbe avere più rispetto per le profezie di sventura. Un po’ perché i disastri sono una cosa seria, e un po’ per scaramanzia, perché disseminare paranoia a volte equivale a chiamarsela. In più, c’è un altro elemento notevole: se invochi il disastro, l’Apocalisse, “il nulla”, come disse Napolitano in una famosa intervista, poi è difficile tornare indietro e rassicurare la gente, è come dire “abbiamo scherzato”, non rassicura nessuno e ti fa sembrare fesso.
Urge correre ai ripari, correggere la rotta. Il bastone non ha funzionato, amici! Avanti con la carota! Naturalmente non è mai agevole passare dall’annuncio della fine del mondo al “tranquilli, non cambia niente”, e così si pensa che basti sostituire il terrore con la lusinga, la minaccia con la promessa.
Pronti? Via! Ecco il ministro Padoan, maestro di bipolarismo (“Rivediamo al ribasso le stime del Pil, ma l’economia cresce”, bizzarro, eh!), che dice che il Sì ci farà risparmiare qualcosa: bello, si passa dalle piaghe d’Egitto al porcellino salvadanaio. Ed ecco il soccorso dell’amico americano: l’ambasciatore John Phillips convinto che con il Sì gli investitori internazionali arriverebbero a frotte, come dire che la Costituzione non si fa per i cittadini, ma per le aziende, una specie di trailer dello spottone di Renzi alla Casa Bianca, in ottobre, prima del voto.
Risultato: il “disastrismo”, il “o questo o la morte”, il “o me o il nulla cosmico” è archiviato, e ora va di moda la roboante promessa. Insomma, basta, piantiamola col filone catastrofista. Al posto di minacciare sventure si passa a promettere meraviglie.
Non è una cosa nuova, anzi. Ci dissero che permettere agli imprenditori di licenziare i lavoratori senza smenarci troppo sarebbe stato il miracoloso toccasana dell’economia. Risultato: il Jobs act ci ha fatto spendere molti miliardi, i risultati – per quanto decantati – sono assai mediocri, e in compenso si scopre che rendere più facile licenziare aumenta i licenziamenti (chi l’avrebbe detto, eh!). Oppure, così per farsi due risate, si possono rileggere gli studi rilasciati da Confindustria, Bocconi e altri buontemponi su quello che l’Expo ci avrebbe portato in dote. Pil alle stelle, gettito fiscale moltiplicato dal rilancio dell’economia, posti di lavoro a centinaia di migliaia grazie al fantastico volano… Bene, i dati del Pil fermo al palo dicono che lo straordinario indotto di Expo non si è proprio visto: la carota era finta.
Il fatto è che questo oscillare tra la minaccia della disgrazia definitiva (“il nulla”, che meraviglia!) e la promessa dell’Eldorado, rende il tutto ancora più ridicolo, pasticciato e poco credibile.
Ora la palla passa al famigerato Italicum. La legge elettorale perfetta, grandiosa, intoccabile, che tutto il mondo ci invidiava e ci avrebbe prontamente copiato (una carota gigantesca), all’improvviso non piace più nemmeno a quelli che ci hanno messo sopra (e votato) la fiducia. Fino al micidiale paradosso che ora quelli che l’hanno scritto e imposto (o lo votate o cade il governo, con conseguente Apocalisse, ovvio) sperano che la Consulta glielo azzoppi. Dunque si procede così, per contrari estremi: o il paradiso e la Morte Nera, o il trionfo o il disastro, o la medaglia d’oro o l’eliminazione vergognosa.
E’ che fare il profeta è un lavoro difficile, e se in più correggi le profezie ogni dieci minuti, le adatti agli umori, le modifichi a seconda delle esigenze contingenti, delle tattiche, delle paturnie, chi ti crede più? Attenti! Arriveranno dieci terribili piaghe. Ah, no, scusate, otto. No, sei. No, niente piaghe. Però vinceremo all’Enalotto. Fu così che il popolo si volse a guardare il profeta. E si fece la sua risata.
In occasione della presentazione di Di rabbia e di vento al FestivaLetteratura di Mantova, ecco l’intervista di Claudia Cangemi de Il Giorno
 E’ una questione di vie di mezzo, anche quando si inventano delle scuse. Tra “La drammatica situazione internazionale mi ha impedito di occuparmi della questione” e “Maestra, il gatto mi ha mangiato i compiti” ci sono infinite sfumature, anche di stile. Quindi non si può che ammirare il “Non ho capito la mail” di Luigi Di Maio, che alza un po’ l’asticella nella nobile arte delle scappatoie in forma di pietosa bugia. Non l’ho ricevuta. E vabbé, son buoni tutti. Non l’ho letta, ci sta pure questo. E’ finita nello spam, ottima attenuante. Ma “non l’ho capita” è davvero osare molto, trattandosi di un presunto, possibile futuro premier. Ah, c’era un cessate il fuoco? Scusate, non ho capito la mail. Non proprio rassicurante.
E’ una questione di vie di mezzo, anche quando si inventano delle scuse. Tra “La drammatica situazione internazionale mi ha impedito di occuparmi della questione” e “Maestra, il gatto mi ha mangiato i compiti” ci sono infinite sfumature, anche di stile. Quindi non si può che ammirare il “Non ho capito la mail” di Luigi Di Maio, che alza un po’ l’asticella nella nobile arte delle scappatoie in forma di pietosa bugia. Non l’ho ricevuta. E vabbé, son buoni tutti. Non l’ho letta, ci sta pure questo. E’ finita nello spam, ottima attenuante. Ma “non l’ho capita” è davvero osare molto, trattandosi di un presunto, possibile futuro premier. Ah, c’era un cessate il fuoco? Scusate, non ho capito la mail. Non proprio rassicurante.
Ma se usciamo dai trucchetti della poltica e torniamo umani (peggio: uomini) non possiamo che apprezzare il gesto atletico della balla più scema del mondo. Cara, posso spiegarti tutto, non ho capito la mail. Buono per fidanzate nervose, padroni di casa che sollecitano il saldo, creditori in genere, suocere invadenti, seccatori. Dopotutto cosa vogliamo da una scusa? Che giustifichi una mancanza, va bene, ma anche che induca alla pietà coloro a cui la raccontiamo. Ecco, “non ho capito la mail” è perfetto: ci si assume la colpa come se si dicesse, “Scusa, hai ragone, sono un cretino, spiegamelo meglio”, il che ammanta tutto di una sincerità ai limiti dell’autolesionismo. Il destinatario della scusa (nel caso specifico: tutti) dovrebbe esser mosso a pietà e compassione. Grazie a Luigi Di Maio, schiere di mariti, amanti, debitori, gente indietro con le rate, potrà appellarsi a questa specie di Primo Emendamento. Sì, sì, ok, lo sapevo ma non l’ho capito. Ed è anche un monito per il futuro, una specie di avviso: se scrivete una mail a Di Maio, scrivetela semplice e chiedete una risposta di due parole: “Ok, capito”. Non si sa mai.
Ecco, qui sotto trovate il video integrale del dibattito con gli ottimi Margherita Oggero e Maurizio de Giovanni. Ottimo anche Fabrizio d’Esposito, il bravo presentatore e collega del Fatto (dopotutto, era la festa del Fatto Quotidiano). Non è obbligatorio, e non è nemmeno un vero dibattito, più buone chiacchiere tra amici (meglio). Approfitto per dire che invece venerdì 9 settembre sarò al Festival di Mantova, a parlare dei libro e dei libri. Alle 11 alla casa del Mantegna (via Acerbi), insieme a Gianni Farinetti e Luigi Caracciolo… Per altre date, passate di qui ogni tanto, o dalla pagina fb, insomma, non vi nasconderò nulla, ahimè.
Chi chiede del nuovo Monterossi stia un po’ calmino, eh, arriva, arriva…
 Grande è la confusione sotto il sole, e quindi la situazione è indecente. Per capirci qualcosa abbiamo provato con i sondaggi, vediamo.
Grande è la confusione sotto il sole, e quindi la situazione è indecente. Per capirci qualcosa abbiamo provato con i sondaggi, vediamo.
Sono indagata. Sì 46 per cento. No: 32 per cento. Non so, non rispondo: 20 per cento. Lo dico al direttorio: 2 per cento.
Se lo dico al direttorio. A tutto il direttorio: 43 per cento. Solo a quelli che mi stanno simpatici: 25 per cento. Cazzo! Non ricordo più a chi l’ho detto!: 19 per cento. Ma quando arriva questa ambulanza?: 13 per cento.
E’ vero, è indagata! Mannaggia! Me lo ha detto in luglio: 57 per cento. O era giugno?: 26 per cento. Però pioveva: 13 per cento. Sicuri che me l’ha detto?: 4 per cento.
Il sondaggio è stato effettuato su un campione rappresentativo di gente che non sa niente di niente. Non sa niente perché la trasparenza è una bella regola ma di difficile applicazione: 47 per cento. Non sa niente perché era meglio non dirlo ai militanti: 32 per cento. Militanti chi?: 11 per cento. Non sa, non risponde, si è già dimesso: 10 per cento.
Come vedete, coi sondaggi non si risce a chiarire la difficile situazione del Movimento 5 stelle a Roma. Proviamo con il numero verde.
Per sapere se la Raggi sapeva: digitare uno.
Per essere proprio sicuri che sapeva e non ha detto di sapere: digitare due.
Per sapere se Raggi ha parlato con Grillo: digitare tre.
Per sapere cosa le ha detto Grillo: digitare quattro (attenzione: linguaggio adatto a un pubblico adulto).
Per il menu della cena del direttorio in cui Raggi ha detto che Muraro è indagata: digitare cinque (buone le puntarelle, un po’ duro l’abbacchio, il vino così così).
Per sapere chi ha indicato il nuovo assessore digitare sei (se cade la linea chiamare lo studio Previti).
Per parlare con un operatore: digitare nove. Se l’operatore è Paola Taverna (“Aò, e te chi sei? Che cazzo voi?”) riattaccare subito e ricomporre il numero.
Ora è tutto più chiaro, non trovate? Bene. Passiamo alla modulistica. Per chiedere alla sindaca come mai sapeva e non ha parlato, compilate in ogni sua parte il modulo 357/B che potete ritirare allo sportello C. Se l’addetto allo sportello C si è dimesso, chiedetelo allo sportello D. Se l’addetto allo sportello D è inviso a una corrente interna che fa la guerra a alla corrente di Di Maio o va a mangiare il gelato con il fidanzato della Taverna chiedete allo sportello E (consiglio da amico: non fate tutto ‘sto casino: ogni sportello è uguale agli altri, perché ogni sportello vale uno, ma non ve lo dicono per non creare aspettative).
Una volta compilato il modulo in ogni sua parte, presentatelo allo sportello F. Allo sportello F vi diranno che non possono rispondere perché avete barrato la casella sulla privacy. Cretini, cos’avete capito?, mica era la privacy vostra, era quella dell’assessore Muraro, che ha diritto alla sua privacy e a non dire se è indagata.
Siete indignati? Volete protestare? Speravate che il Movimento fose un po’ più sveglio e reattivo? Nessun problema, è un vostro diritto: compilate il modello 743-2/G che potrete ritirare presso lo sportello H dalle 10 alle 10.03 tutti i giovedì. Se invece volete dare consigli sulla difficile situazione, convocate una riunione, riprendetela con una telecamera e trasmettetela in streaming in rete. Per fare questo bisogna compliare il modulo 549/F/RH che ancora non è stato stampato e sarà disponibile al pubblico quando lo deciderà il direttorio.
Mentre aspettate il modulo potrete leggere un giornale. Magari questo, Il Fatto Quotidiano. Anche lì troverete un interessante sondaggio. Bastardi, siete il giornale dei grillini : 45 per cento. Bastardi, attaccate i grillini: 45 per cento. Bastardi, date le notizie senza guardare in faccia nessuno, non si fa, non siamo più abituati: 9 per cento. Non sa / non risponde / legge l’Unità: 1 per cento (approssimato per eccesso).
 2016, Alto Medioevo. L’Impero Centrale chiede al re della Mela tredici miliardi di tributi non pagati. Facendo questo accusa un suo alleato, il re d’Irlanda, di tradimento. Il re d’Irlanda implora il re della Mela di non pagargli le tasse. Se un italiano, un francese, un tedesco, come nelle barzellette, comprano una canzone a 99 cents, praticamente la comprano in Irlanda, e il re della Mela paga meno tasse. Come nelle barzellette.
2016, Alto Medioevo. L’Impero Centrale chiede al re della Mela tredici miliardi di tributi non pagati. Facendo questo accusa un suo alleato, il re d’Irlanda, di tradimento. Il re d’Irlanda implora il re della Mela di non pagargli le tasse. Se un italiano, un francese, un tedesco, come nelle barzellette, comprano una canzone a 99 cents, praticamente la comprano in Irlanda, e il re della Mela paga meno tasse. Come nelle barzellette.
Insomma, la guerra tra stati nazionali (macroeconomie pubbliche) e stati aziendali (macroeconomie private), è in pieno svolgimento. Lo scenario Medievale non è poi così peregrino. Giochi di potere, intere casate torinesi che cambiano casa e paese e si trasferiscono dove più conviene, re e principi ricevuti a corte che trattano con i governi, vengono accolti come gran dottori che concionano di futuro davanti ai giovani, per non dire della munificienza e del mecenatismo.
Insomma, come nelle antiche cronache medievali, è un via vai di sovrani portatori della loro visione del mondo: giungono in città, lasciano doni, visitano i governanti, si concedono al pubblico. Ecco che arriva Zuckerberg e sembra che stia arrivando Federico II, si pende dalle sue labbra, si sviscerano le sue parole come se fosse l’oracolo di Delfi. Anche se poi quello dice cose come “Ehi, ragazzi! Credeteci sempre!”, cose che dicevano le nonne nei momenti di euforia, senza essere miliardarie.
Questa dei bei discorsi è una costante delle nuove monarchie: avere un leader è importante anche per loro. E anche quei discorsi passano alla storia come quelli di Kennedy o di Cicerone: “Siate affamati, siate folli!”, il famoso speach di Steve Jobs, il primo re della Mela. Lui era così affamato che per mangiare ha scelto l’Irlanda.
Oltre ai favori fiscali, quando arriva un sovrano c’è un gran dispiego di tappeti rossi e trombette: ecco Sergio Marchionne in cattedra (letteralmente), ascoltato come nel Seicento avrebbero dovuto ascoltare Galileo. E cosa ci dice – tra le altre amenità – il re delle macchine? Che il suo regno gradirebbe un’Italia stabile, un sistema affidabile. In breve: un capo di stato estero che viene a dirci come vorrebbe il nostro paese e la nostra Costituzione. Esattamente come il re della Mela vuole dire la sua sulla politica fiscale europea, esattamente come le multinazionali della salute intervengono sui sistemi sanitari dei paesi, e così via. Alcune aziende hanno capito che conviene trattare direttamente come stati sovrani. Hanno i loro ambasciatori, fanno gentili concessioni, e rivendicano una funzione sociale: noi creiamo lavoro.
Ora, la guerra, come vedete, è complicata. Le grandi multinazionali hanno ormai un potere che non si riesce a regolare con le semplici leggi pensate per aziende normali. In più, la loro funzione è solo quella di creare lavoro (sempre pronte a licenziare se non ce n’è, ovvio, dunque con l’arma del ricatto occupazionale su vasta scala), mentre uno Stato ha quel problema lì, creare lavoro, ma anche altre cosucce da fare: gli ospedali, le scuole, badare che mangino tutti, eccetera. Oneri fastidiosi, che i nuovi re non vogliono. Chissà, forse in un prossimo futuro le mega-aziende penseranno anche a questo, ma vi avverto: non fatevi ricoverare in un ospedale Apple se avete un by-pass Samsung, lo dico per il vostro bene. Altre cose saprebbero farle, tipo riscuotere le imposte: tra Id, password, numeri di telefono, impronte digitali, localizzazione in ogni minuto della giornata, il re della Mela sa di noi più di quanto ne sappia l’Agenzia delle Entrate e forse pure i nostri parenti. E’ solo l’inizio, lo scenario è mutevole, la guerra sarà lunga. Quella sull’Impero Centrale e il re della Mela, magari, sarà una domanda alla maturità per i nostri nipoti.
 Come sempre, è una questione di aspettative. Se uno ti dice che ti regala un’industria dolciaria e poi si limita a offrirti un gelato, e spesso nemmeno quello, un pochino ti scappa la poesia. Così si diventa allergici alle narrazioni trionfanti e diventa difficile vedere tre leader sotto elezioni – ognuno coi suoi problemi, divergenti da quelli degli altri due – come i presidenti che “rilanciano” o addirittura “rifondano” l’Europa. Nientemeno. Ma sia, la scenografia è ben studiata, il mare, il vento, l’omaggio all’idea primigenia, i simboli, e una certa solennità da grande evento, molto telegenica. A leggere le cronache sembrerebbe che da lì, da Ventotene, sia ripartita l’Europa, un nuovo inizio, nuove prospettive, una nuova vita per tutti, hurrà.
Come sempre, è una questione di aspettative. Se uno ti dice che ti regala un’industria dolciaria e poi si limita a offrirti un gelato, e spesso nemmeno quello, un pochino ti scappa la poesia. Così si diventa allergici alle narrazioni trionfanti e diventa difficile vedere tre leader sotto elezioni – ognuno coi suoi problemi, divergenti da quelli degli altri due – come i presidenti che “rilanciano” o addirittura “rifondano” l’Europa. Nientemeno. Ma sia, la scenografia è ben studiata, il mare, il vento, l’omaggio all’idea primigenia, i simboli, e una certa solennità da grande evento, molto telegenica. A leggere le cronache sembrerebbe che da lì, da Ventotene, sia ripartita l’Europa, un nuovo inizio, nuove prospettive, una nuova vita per tutti, hurrà.
Pur con qualche scetticismo che traspare dai commenti, sembra prevalere nei grandi media una gran voglia di crederci, più che alto per disperazione. E’ la solita ideoligizzazione del sogno. Cioè: non solo si costrusce una visione idilliaca, efficiente, potente, densa di belle promesse – un sogno, appunto – ma la si trasforma in una visione del mondo, e chi la contesta, o osa dubitarne, è iscritto all’ideologia contraria, negativa e “sconfittista”.
Ma insomma, là dove la grande idea di Spinelli, Colorni e Rossi era timidamente germogliata, si è vista un ostentazione di potenza, la portaerei, la stampa schierata, i marinai che fanno il saluto. Mancava solo lo striscione Mission accomplished, come quello Bush fece appendere sulla portaerei per dire che aveva vinto una guerra persa, e il quadretto era completo.
La distanza tra la narrazione di questa nuova Europa “che rinasce” e l’Europa reale, poi, è facilmente colmabile. Da Ventotene, una volta raggiunta Napoli e fatte due orette di macchina fino ai dintorni di Foggia, si possono visitare i campi degli schiavi, una cosa non proprio modernissima e progressiva, diciamo. Una mattinata di viaggio (dieci minuti in elicottero) dalla Nuova Europa all’Alabama degli anni Venti, per gradire, braccia da 4 euro e 50 a cassa (tre quintali di pomodori) e la percentuale da lasciare al caporale. E tutto quasi identico a quel che abbiamo letto nei romanzi sul blues, sul cotone, sui neri delle piantagioni. Roba americana, roba buonissima, compreso quel Furore di John Steinbeck (1939) che descriveva perfettamente, come fosse oggi, come lo sfruttamento approfitti della disperazione degli sfruttati e dei migranti per diventare schiavitù. Ecco: averceli qui “i neri delle piantagioni”, mentre quotidianamente si chiacchiera di “superpotenza culturale” e di “ruolo storico nel rilancio dell’Europa”, fa un po’ vergogna.
Si sa che la propaganda non è un’invenzione nuova, e va bene. Ma qualche legame con la realtà deve pur averlo, anche lontano, anche labile. Se invece si tratta di una rappresentazione totalmente parallela alla realtà, alternativa ad essa, addirittura contraria, si ottiene l’effetto opposto: una crisi di rigetto. E poi non c’è peggio dei deboli che gonfiano il petto e si atteggiano a campioni: la cosa appare abbastanza ridicola, se si pensa che i tre impettiti conducator schierati sulla nave da guerra hanno appena consegnato nelle mani di un tizio come Erdogan il rubinetto dell’immigrazione.
Insomma, bella Ventotene, la tomba di Spinelli, il sogno che va recuperato, eccetera eccetera, ma le immagini, volendo dire quello in modo un po’ eccessivo, finivano per dire il contrario: una prova di enorme debolezza, tutta scenografia e niente sceneggiatura, un filmone con gli effetti speciali ma senza trama, cioè sempre la stessa: noi chiederemo soldi e quelli ci diranno che ce li hanno già dati. Un po’ poco per la rifondazione dell’Europa, la fanfara, le bandiere al vento, la retorica e la voglia di grandeur. A un tiro di schioppo dalle bidonvilles degli schiavi.
 A 75 anni suonati, c’è questo signor Bob Dylan che si diverte a scarnificare Frank Sinatra (gli ultimi due dischi, Shadows in the night e Fallen angels), e canta ancora dal vivo con maramalda disinvoltura. E va bene. Ma soprattutto alimenta senza sosta l’ossessione dei dylaniani. Temibile setta dal dogma inconfutabile: Dylan è Dylan, e chi non capisce questa semplice regola peggio per lui.
A 75 anni suonati, c’è questo signor Bob Dylan che si diverte a scarnificare Frank Sinatra (gli ultimi due dischi, Shadows in the night e Fallen angels), e canta ancora dal vivo con maramalda disinvoltura. E va bene. Ma soprattutto alimenta senza sosta l’ossessione dei dylaniani. Temibile setta dal dogma inconfutabile: Dylan è Dylan, e chi non capisce questa semplice regola peggio per lui.
Ed eccoci alla dylanite, patologia (letteraria? musicale? Boh…) che indaga su Dylan, studia, cerca, interpreta, collega, mette insieme i pezzi di un puzzle che pare (per fortuna) incomponibile.
Ultimo contributo alla scienza, tutt’altro che esatta, della dylanologia è un saggio di Marco Zoppas, Ballando con Mr. D – nessuno suona il blues come Bob Dylan (BookTime, 2016), pamphlet colto, ricco di citazioni, denso di studi e anche – soprattutto – amabilmente dietrologico. Ne esce un Dylan tutt’altro che pacifista, una specie di profeta dell’ipercapitalismo americano e soprattutto “il più grande cantore della Guerra Fredda” (testuale).
Lo dico a scanso di equivoci: il saggio di Zoppas è uno spasso. Ricco di spunti, angolazioni inedite, interpretazioni audaci, aneddoti che si vorrebbero illuminanti. E dà conto di alcuni paradossi: possibile che Maggie’s Farm (canzone del ’65) si preconizzasse addirittura la reazione di Israele al piano nucleare iraniano? Non si starà esagerando con l’esegesi?
Nel saggio di Zoppas c’è anche di più, ovvio, e gli studiosi di dylanologia non se lo faranno scappare, ma il suo primo merito è di dimostrare ancora una volta che di Dylan non si butta niente, e ognuno può dire e pensare quello che vuole (persino che una canzone di amore e abbandono come It ain’t me baby sia un’invettiva anticomunista contro i radical-chic… mah!), sapendo che l’oggetto di tanti studi non confermerà, non smentirà, farà quello che ha sempre fatto, convinto come ha detto più volte che (forse) sarà capito tra un secolo.
Chi cerca meno interpretazioni socio-politiche (quelle che hanno fatto esultare Il Foglio: hurrà! Dylan non è di sinistra! Oddio, siamo ancora lì…) e un approccio più cultural-antropologico-letterario al signor Dylan può puntare su un altro saggio critico, di un luminare della materia, Alessandro Carrera, traduttore “ufficiale” dei testi di Dylan, del suo simil-romanzo (Tarantula, 1966), della biografia (Chronicles, Feltrinelli 2005) e di altre notevoli opere. Insomma, Carrera, che insegna cultura e letteratura italiana e del mondo a Houston, Texas, pubblica un pamphlet di rara bellezza (Bob Dylan, Doppiozero) che è una specie di ricerca intima tra sé (il prof è assai simpatico) e Bob Dylan. Chi è? Che fa? Che dice? E soprattutto cosa dicono e pensano i suoi maniaci esegeti?
Dylan non è di sinistra! Oddio, siamo ancora lì…) e un approccio più cultural-antropologico-letterario al signor Dylan può puntare su un altro saggio critico, di un luminare della materia, Alessandro Carrera, traduttore “ufficiale” dei testi di Dylan, del suo simil-romanzo (Tarantula, 1966), della biografia (Chronicles, Feltrinelli 2005) e di altre notevoli opere. Insomma, Carrera, che insegna cultura e letteratura italiana e del mondo a Houston, Texas, pubblica un pamphlet di rara bellezza (Bob Dylan, Doppiozero) che è una specie di ricerca intima tra sé (il prof è assai simpatico) e Bob Dylan. Chi è? Che fa? Che dice? E soprattutto cosa dicono e pensano i suoi maniaci esegeti?
Una cavalcata mirabolante di riflessioni, citazioni, interpretazioni che vanno dalla Bibbia all’amor cortese, dall’eguaglianza alla giustizia, all’America e a tutto il resto. Un ottovolante di curve improvvise e geniali (che c’entra un cantante americano del XX secolo con il trattato De Amore di Andrea Cappellano, secolo XII, quasi mille anni prima? Eh, appunto!). Ironico e divertente, autoironico nel confrontarsi con la dylanite, intesa questa volta come malattia, ossessione e gaudio dei dylanisti.
Che poi, come ovvio, si dividono sulle svolte dell’opera omnia. E qui, per aiutarli a non perdersi, ecco il compendio ragionato e discusso, libro prezioso e anche lui fonte di infiniti dettagli e aneddoti e rivelazioni: Bob Dylan disco per disco, di Bream Jon (edizioni Il Castello). Così, chi vuole, può sapere dove si trovava Dylan ad ogni album. E non si intende il luogo fisico, ma emotivo ed esistenziale, insomma in quale pezzo del suo tragitto. Era felice? Incazzato? Era nella fase cristiano-messianica? Innamorato? Fresco sposo? Era incattivito o morbido? Eccetera, eccetera. Il tutto attraverso dialoghi tra esperti, musicisti, critici, amici, complici, tecnici, eccetera, che discettano su ogni disco del Nostro, anno dopo anno, svolta dopo svolta, e ne esce la storia della Great American Song, niente di meno.
Alla fine, l’ossessione continua, la saggistica su Dylan è più ampia della discografia di Dylan, e pochi come il vecchio ragazzo del Minnesota la sanno stimolare. Il fatto, come sanno i dylaniani e gli altri ignorano, è che Dylan contiene parecchia roba, la Poesia e il Poeta, la Storia, l’Odio, l’Amore, e altro ancora. Per cui un dylanologo esperto può entrare nel labirinto dalle parti della Bibbia e uscirne con un blues del Delta, oppure entrare con una ballata acustica e uscirne con una visione del mondo, o ancora farsi aiutare da Dylan a fare a pezzi il mito-Dylan e partire ogni volta da capo. Si entra, sì, nel labirinto, e si rischia di non uscirne mai. Mica male per un cantante, eh!
 Nei romanzi gialli c’è sempre un momento in cui si parla dell’arma del delitto. Dove l’hai presa? Chi te l’ha venduta? Così, lette e ascoltate ai Tg alcune notizie sullo Yemen – spesso notiziette corte corte, o qualche secondo nei Tg – e sapendo che la coalizione capeggiata dai sauditi si diverte a bombardare scuole (sabato scorso, 10 ragazzini uccisi) e ospedali (l’altro ieri, bilancio ancora provvisorio, ma molti morti e feriti), veniva da chiedersi chi ha procurato l’arma del delitto. E siamo stati noi, noi intesi come Italia, la grande potenza culturale eccetera eccetera.
Nei romanzi gialli c’è sempre un momento in cui si parla dell’arma del delitto. Dove l’hai presa? Chi te l’ha venduta? Così, lette e ascoltate ai Tg alcune notizie sullo Yemen – spesso notiziette corte corte, o qualche secondo nei Tg – e sapendo che la coalizione capeggiata dai sauditi si diverte a bombardare scuole (sabato scorso, 10 ragazzini uccisi) e ospedali (l’altro ieri, bilancio ancora provvisorio, ma molti morti e feriti), veniva da chiedersi chi ha procurato l’arma del delitto. E siamo stati noi, noi intesi come Italia, la grande potenza culturale eccetera eccetera.
Le bombe spedite in Arabia Saudita, si parla di almeno cinque consegne negli ultimi mesi, per nave e per cargo aereo dall’aeroporto di Cagliari, sono costruite dalla RWM Italia, controllata dal grande gruppo tedesco degli armamenti Rheinmetall. Autorizzazioni alle esportazioni di materiale bellico verso i paesi della coalizione che bombarda lo Yemen erano già state rilasciate dai governi Letta e Monti, e non si sa se ci siano state nuove autorizzazioni da parte del governo Renzi, anche se spedizioni così urgenti (persino in aereo da un aeroporto civile) lo farebbero supporre. Sia come sia, la ministra Pinotti ha assicurato che è tutto regolare, che si tratta di componenti per un’azienda tedesca, che quindi noi, ahimé, dannazione, siamo tranquilli. Aggiunge seraficamente la ministra (intervista a Repubblica dicembre 2015): “Non do un giudizio etico, non dico se è giusto o sbagliato, dico che è stato fatto secondo le regole”. Ah, beh, allora.
Le regole, tra l’altro, sono un po’ controverse, perché l’Onu ha già più volte fatto notare che gli attacchi aerei della coalizione a guida saudita su obiettivi civili non vanno per niente bene, e sul bombardamento della scuola di sabato scorso l’Arabia Saudita ha dovuto, obtorto collo, aprire un’inchiesta (che immaginiamo severissima, visto che i sauditi dovranno indagare su un presunto crimine di guerra compiuto dai sauditi, mah…). Resta il fatto, un po’ si minimizza e un po’ si depista: non è roba nostra, chiedere alla Germania, perché la RWM Italia (sede a Ghedi, stabilimento a Domusnovas, Sulcis, in Sardegna) è roba loro. Peccato che in Germania neghino. L’otto marzo scorso un’interrogazione parlamentare di Die Linke ha permesso al governo tedesco di chiarire la sua posizione, e la risposta è stata: “Nessuna autorizzazione per l’export di componenti destinati agli stabilimenti Rwm Italia di Domusnovas”. Come dire che la faccenda delle bombe che vanno dalla Sardegna verso l’Arabia Saudita e poi da lì cascano sugli ospedali dello Yemen sono faccenda nostra. Tutto molto complicato, come al solito, anche se Famiglia Cristiana, in una sua inchiesta, mostra tra l’altro foto di ordigni inesplosi a Sana’a, capitale dello Yemem, e sono proprio giocattolini nostri.
Ora, si sa che il mondo è quello che è e la situazione non è buonissima. Con tutto questo, la guerra in Yemen rischia di essere un puntino di vernice su un quadro di Pollok, quasi invisibile. Ma c’è il dettaglio che ogni tanto (spesso, anzi), si colpisce un ospedale, o una scuola, o un deposito di viveri, e persino un campo di rifugiati, e questo, dannazione, diventa una notizia. Diverse fonti – organizzazioni non governative come Amnesty International, ma anche la Croce Rossa, e pure l’Onu – parlano di catastrofe umanitaria, più di seimila morti, più della metà civili, molte donne e bambini, oltre tre milioni di profughi eccetera eccetera, le solite vergogne. Lo Yemen è un po’ lontano perché i profughi di quella guerra arrivino qui e chiedano di essere accolti. Ma, dovesse succedere, sarà un po’ difficile dirgli “Vi aiutiamo a casa vostra”, perché probabilmente ci direbbero, no, no, basta così, a posto, grazie.
 Per quanto interessante, il dibattito sulla satira è piuttosto ripetitivo, probabilmente è dai tempi dei sumeri che, se non si può vietarla, la si accusa di volgarità, di cattivo gusto, di zozzeria eccetera eccetera, insomma le si rimprovera di essere satira. Per dire della raffinatezza storica della materia, capitava non di rado che durante la commedia dell’arte gli attori mimassero sul palco l’atto del defecare (a volte nemmeno fingevano), e nel Medioevo (ma pure dopo), quando un nobile veniva assolto ingiustamente, si inscenavano in piazza delle “executio in effige” in cui il potere veniva sbertucciato in ogni modo (seguiva repressione). Ma insomma, l’arietta non è nuova: la satira prevede una libertà assoluta e ribelle, e se si vuole partire con la faccenda del pensiero unico, beh, storicamente è la prima che prende qualche sberla.
Per quanto interessante, il dibattito sulla satira è piuttosto ripetitivo, probabilmente è dai tempi dei sumeri che, se non si può vietarla, la si accusa di volgarità, di cattivo gusto, di zozzeria eccetera eccetera, insomma le si rimprovera di essere satira. Per dire della raffinatezza storica della materia, capitava non di rado che durante la commedia dell’arte gli attori mimassero sul palco l’atto del defecare (a volte nemmeno fingevano), e nel Medioevo (ma pure dopo), quando un nobile veniva assolto ingiustamente, si inscenavano in piazza delle “executio in effige” in cui il potere veniva sbertucciato in ogni modo (seguiva repressione). Ma insomma, l’arietta non è nuova: la satira prevede una libertà assoluta e ribelle, e se si vuole partire con la faccenda del pensiero unico, beh, storicamente è la prima che prende qualche sberla.
Solo che vietare la satira (o chiederle di piegarsi al conformismo grottesco del politicamente corretto, che è lo stesso) non ferma la satira, perché chiedere ai sudditi di non ridere di chi li comanda è al di là delle umane cose.
Ah, sì, Mannelli, ovvio. Il sessismo è trovata relativamente nuova, ma la faccenda del cattivo gusto e dell’oscenità, invece è roba antica. George Grosz, a cui dobbiamo la più feroce descrizione della Germania anni ’20, coi suoi pescecani di guerra, fu condannato (e rovinato: morì in un manicomio) proprio per oscenità, per il disegno di un Cristo con la maschera antigas, vignetta di protesta contro la Grande Guerra. Ma il vero osceno della sua opera sono quei volti sfatti dal benessere diseguale, dalla ricchezza arraffona. E le donne, puttane povere o razza padrona, con quei corpi tumefatti dal presente, lividi dall’avere troppo, o troppo poco, dicono alla perfezione lo spirito dei tempi. Insomma, satira. Sgradevole, anche, e quindi buona.
Non che andasse meglio in altri posti e in altre epoche. Vero che il fascismo tollerò qualche risata, ben attento che l’umorismo non tracimasse nella critica. E vero anche che molti dei migliori talenti del dopoguerra maturarono in giornali satirici blandamente tollerati (Zavattini, Scola, Fellini, Marcello Marchesi al Marc’Aurelio, per dire). E l’immenso Petrolini, insignito di qualche medaglia dal regime riuscì addirittura a prenderli per il culo durante la cerimonia, urlando: “Me ne fregio!”. Grandioso.
risata, ben attento che l’umorismo non tracimasse nella critica. E vero anche che molti dei migliori talenti del dopoguerra maturarono in giornali satirici blandamente tollerati (Zavattini, Scola, Fellini, Marcello Marchesi al Marc’Aurelio, per dire). E l’immenso Petrolini, insignito di qualche medaglia dal regime riuscì addirittura a prenderli per il culo durante la cerimonia, urlando: “Me ne fregio!”. Grandioso.
Però quando il gioco si faceva duro, niente da fare, censura e confino. Così per Giuseppe Scalarini, che di fatto inventò la vignetta politica italiana, fu un continuo di condanne e soggiorni punitivi. E Il Becco Giallo, che faceva ridere un bel po’, fu fatto chiudere senza tante cerimonie. Osava, tra l’altro, irridere il fervente fascismo di Luigi Pirandello chiamandolo P.Randello. Chapeau.
Non per questo gli italiani smisero di ridere dei loro (in effetti ridicoli) capataz: le barzellette sul Duce sono state una specie di genere letterario per anni. Punite e represse dall’occhiuto regime, che quindi faceva più ridere ancora e generava più barzellette, come quella storica dell’autista di Mussolini che investe con la macchina un maiale.
“Vai a avvertire alla fattoria – dice il Duce, sempre attento al popolo – dì che sei il mio autista”.
Quando quello torna carico di doni, il Duce fa la faccia stupita e il milite spiega:
“Ho detto: sono l’autista del duce e ho ammazzato il porco. E quelli mi hanno fatto festa e coperto di doni”.
Divertente. Oggi si direbbe che alimenta la violenza? Mah.
 A vietare la satira, poi ci hanno provato tutti. Nel grigiore sovietico del dopoguerra, anche dopo Stalin, la risata sul regime era un classico, e si rischiava pure parecchio, come dice appunto la barzelletta dei due giudici che parlano tra loro:
A vietare la satira, poi ci hanno provato tutti. Nel grigiore sovietico del dopoguerra, anche dopo Stalin, la risata sul regime era un classico, e si rischiava pure parecchio, come dice appunto la barzelletta dei due giudici che parlano tra loro:
“Ah, oggi ne ho sentita una bellissima sul Politburo”.
“E come fa?”.
“Fa tre anni e sei mesi di Siberia”.
Raffinatezze russe, mentre nella Germania dell’Est si andava più terra-terra e fa ridere la storiella di Honecker che ordina di costruire una passerella sul lago per mostrare al suo popolo che sa camminare sulle acque. I tedeschi guardano la scena e commentano:
“Pensa come siamo messi, abbiamo un Segretario Generale che non sa nemmeno nuotare”.
Ora, diciamolo: non sono più i tempi adolescenti e belluini in cui si credeva che “una risata vi seppellirà”, però è innegabile che la risata contro il potere rimane un gesto eversivo. Persino quando la fa il potere stesso: perché sarà vero che l’aperto sghignazzo di Merkel e Sarkozy in faccia a Silvio buananima (ottobre 2011, memorabile) non era satira, però che l’abbiano seppellito non c’è dubbio.
Ma sia come sia, quello che viene dal basso, dalla pancia dolente delle persone qualunque, cittadini trasformati in sudditi, è un ridere amaro e strafottente, sempre al confine tra la satira e l’insulto, tra il sarcasmo e l’ironia, e del “buongusto” e del “politicamente corretto” ama fottersene alla grande.
Certo si può vietare la satira con le cattive o con le buone (blandendola, levandole il detonatore del coraggio, o della volgarità, o del cattivo gusto, o della sgradevolezza, insomma, ammaestrandola, rendendola digeribile), ma non ce se ne libererà mai veramente. Nemmeno nei casi più gravi, come dice la vecchia storiella russa dei due amici dissidenti:
“Senti, ho un brutto presentimento. Facciamo così, se mi deportano in Siberia io ti scrivo. Se scrivo con inchiostro nero è tutto vero, se scrivo con inchiostro rosso vuol dire che mi controllano e non devi credere a quello che dico, ok?”
“Ok”
Mesi dopo l’amico riceve una lettera dalla Siberia
“Caro Boris, ti scrivo finalmente dalla mia nuova casa. Qui è tutto bellissimo, si mangia bene, le ragazze sono gentili, un vero paradiso. Solo un piccolo difetto: non vendano inchiostro rosso”.
Ecco, siamo in un periodo in cui l’inchiostro rosso è meglio tenerselo stretto, e anche se il dibattito su quanto è sgradevole e scorretta la satira lo sentiamo dai tempi delle piramidi è bene dirlo ancora: trattasi di luogo libero, così libero che non c’è nulla su cui non si possa ridere, specie se potente. Corpi santi non ce n’è, spiacenti, né petto né coscia.
 Insomma, ora viene fuori che se non hai ricevuto un sms da Matteo Renzi non sei nessuno, che ci stai a fare al mondo? Sono così ambìti, i messaggini di Matteo, che le compagnie telefoniche cominciano a inserirli nelle offerte commerciali: 400 sms verso tutti e dodici da Matteo Renzi. Campionesse di scherma, autotrasportatori, suore, calciatori fino ai semipro, turnisti notturni del Pd, comitati per il Sì, industriali, attori e raccattapalle dei tornei di tennis, non c’è categoria che sia al riparo dal messaggino del premier. Ormai è un genere letterario, gli storici ci andranno a nozze. Ma si tratta di una straordinaria occasione per il Paese, e dunque va organizzata con qualche regola.
Insomma, ora viene fuori che se non hai ricevuto un sms da Matteo Renzi non sei nessuno, che ci stai a fare al mondo? Sono così ambìti, i messaggini di Matteo, che le compagnie telefoniche cominciano a inserirli nelle offerte commerciali: 400 sms verso tutti e dodici da Matteo Renzi. Campionesse di scherma, autotrasportatori, suore, calciatori fino ai semipro, turnisti notturni del Pd, comitati per il Sì, industriali, attori e raccattapalle dei tornei di tennis, non c’è categoria che sia al riparo dal messaggino del premier. Ormai è un genere letterario, gli storici ci andranno a nozze. Ma si tratta di una straordinaria occasione per il Paese, e dunque va organizzata con qualche regola.
Le prove – Non basta dire: Matteo mi ha scritto un messaggino. Bisogna evitare le vanterie e mostrare la schermata, anche se sono 27 schermate, perché il ragazzo si è fatto prendere la mano. Nei casi più gravi (sopra i 5.000 messaggini) si può acquistare un hard disc esterno che può contenere fino a un Terabyte di sms di Matteo Renzi (sconti nei negozi convenzionati per gli abbonati alla Leopolda).
Le quotazioni – I messaggi più rari sono quelli in cui Renzi ha sbagliato numero. Sotheby’s ha battuto l’altro giorno un rarissimo sms del premier alla cancelliera Merkel. Testo: “Un ce la mandiamo più Maria Elena in tivù, che l’è un disastro”, evidentemente scritto per qualcun altro. Storico il caso dell’sms di Matteo esposto al Louvre: “Oggi grande partita! Quando vieni a giocà a Firenze?”, inviato per errore a Giorgio Napolitano, che subito ha prenotato un treno per raggiungere gli allenamenti.
Meno quotati gli sms di complimenti: bravo qui, bravo là, il solito trucchetto per prendersi di riflesso un po’ di applausi e simpatia nella speranza che il destinatario li renda noti. Più interessanti quelli di incoraggiamento come il messaggio al generale Cadorna alla vigilia di Caporetto: “Vai tranquillo Luigi, domani sarà una passeggiata”.
I servizi – Febbrilmente concentrato sulla ripartenza del paese, Matteo Renzi sta pensando a un servizio a pagamento. Abbonandoti on line potrai ricevere sms per ogni bisogno e circostanza. Basterà accedere alla app dal telefonino e avrai un messaggio privato del premier, cose come: “Non facciamo i timidi, se è il primo appuntamento io metterei la gonna”. Oppure: “Ne hai già bevuti otto, forse è meglio che ti fermi e che non ti metti a guidare”. A richiesta (ma la tariffa aumenta) si può chiedere a Matteo Renzi di mandare sms al posto nostro, tipo “Buongiorno, sono Matteo Renzi, dice Gino che per quei cento euro che le deve dovrà aspettare ancora un po’”. Utile.
Convenzioni – Tutte le aziende possono usufruire del servizio, una volta stipulata una convenzione. Quando sono pronte le camicie in lavanderia sarai avvertito da un sms del Presidente del Consiglio, lo stesso per il meccanico quando è pronta la macchina. Uno speciale accordo con le banche permetterà a Matteo Renzi di inviarti un sms quando ti arriva un bonifico (“Visto? #Italiariparte!”). Quando compilate dei moduli e arrivate alla parte sulla privacy ricordatevi di barrare la casella che dice: Sì, desidero ricevere sms da Matteo Renzi, anche con proposte commerciali.
Tecnologia – Così come Mussolini riceveva 1.500 lettere al giorno (e si vantava di rispondere, anzi, aveva inventato un ministero apposta), Matteo Renzi potrebbe mandare, dicono i programmatori, almeno 15.000 sms all’ora. Questo contempla un adeguamento della tecnologia per evitare spiacevoli incidenti nella generazione automatica dei numeri, e qualche incidente c’è già stato. L’anno scorso, 1.700 pastori nepalesi hanno ricevuto un messaggino con scritto: “Mi raccomando, mettiamo la fiducia e anche stavolta li freghiamo così”. E fu notevole lo sconcerto dei funzionari del ministero delle Infrastrutture quando lessero un sms di questo tenore: “Uff, che palle, viene anche Lotti, ce l’hai un’amica carina?”.
 La pubblicità è l’anima del commercio, il testimonial è l’anima della pubblicità, ma se cercate l’anima del Testimonial siete nel posto sbagliato.
La pubblicità è l’anima del commercio, il testimonial è l’anima della pubblicità, ma se cercate l’anima del Testimonial siete nel posto sbagliato.
E non c’è oggi in Italia un testimonial più multitasking di lui, Matteo Renzi, che assomma a sé tre cariche importanti: segretario del Pd, Presidente del Consiglio e uomo-sandwich. Olimpiadi? Direzione di partito? Consiglio dei ministri? Tranquilli, lo spot c’è sempre, il brand è esibito, il consiglio all’investimento puntuale. A Rio, giovedì scorso, ha fatto un bel discorsetto benedicendo Pirelli (restauro del Cristo Redentore) e poi facendo i complimenti a Armani (belle le divise), non c’è riunione pubblica in cui non lo si veda maneggiare l’iPhone come un adolescente inquieto. O gioca alla Playstation, o sale sulla nuova Giulia. E poi gelati, macchine per palestra, piumini d’oca, titoli azionari, elicotteri, rubinetti. Manca solo il tonno che si taglia con un grissino e la pasta per dentiere, e poi siamo dalle parti del Testimonial totale.
Come un Fabrizio Corona che si scapicolla da una gelateria di Sondrio a una discoteca di Cefalù, anche Renzi accorre qui e là in veste di sponsor ambulante.
Eataly fu il primo segnale, e del resto è amore antico: quando la direzione del Pd si riunisce a Firenze (gennaio 2014) in un tripudio di nuovismo finalmente trionfante in biciletta (non c’era ancora il megajet), la grande innovazione è il pranzo al sacco di Eataly (tra l’altro: se andavano al ristorante risparmiavano), cosa che tutti notano, scrivono, riprendono e commentano in pensosi corsivi. Il premier smart mangia i panini! Fico! E poi inaugurazioni con tanto di marchio alle spalle, tipo i calciatori nelle interviste. Farinetti ospite fisso alle Leopolde e Renzi che sostiene il brand, un’affinità elettiva conclamata. Farinetti è uno che fa ispirate lezioni dicendo cose tipo: se pensi di trovare parcheggio e sei positivo lo troverai, un ottimismo a metà tra il mesmerismo e il Mago di Oz che è lo stesso di Renzi. Altra affinità tra azienda e testimonial: la prima ha avuto un grosso appalto Expo senza gara, il secondo ha avuto un grosso governo senza elezioni.
Più spesso le aziende servono per agili metafore, subito ricambiate. Nel dicembre del 2014 il set era una direzione nazionale Pd e Renzi faceva l’elogio di Moncler. Il capo dei piumini, Remo Ruffini, rispondeva compiaciuto del parallelo fatto dal premier tra una ditta di giacche a vento e un paese di sessanta milioni di persone: “Sì, l’Italia dovrebbe stare vicino al cliente e creare valore”. Urca! Un programma politico, insomma, o aziendale, che negli anni dell’era renzista fa lo stesso.
era una direzione nazionale Pd e Renzi faceva l’elogio di Moncler. Il capo dei piumini, Remo Ruffini, rispondeva compiaciuto del parallelo fatto dal premier tra una ditta di giacche a vento e un paese di sessanta milioni di persone: “Sì, l’Italia dovrebbe stare vicino al cliente e creare valore”. Urca! Un programma politico, insomma, o aziendale, che negli anni dell’era renzista fa lo stesso.
A volte il Testimonial fa lo spiritoso. Tipo quando l’Economist lo disegnò in copertina con la Ue che cola a picco e lui che mangia il gelato (agosto 2014). Vade retro, è un gelato confezionato, vergogna. Mentre Lui, il testimonial è per i sani valori contadini, l’alto artigianato, i pistacchi allevati a uno a uno. Insomma, fece arrivare un carretto di Grom nel cortile di palazzo Chigi per farsi fotografare ottimista (ci mancherebbe!) e con un cono “vero”. Del resto Guido Martinetti, patron di Grom, la sua leccatina al gelato l’aveva già data: con Renzi “c’è un linguaggio comune, la stessa velocità, la voglia di andare incontro a nuove strade”. Apperò!
E dunque il testimonial si è mangiato il gelato, ma non è stato l’unico, perché un annetto dopo il gelato di Grom se l’è mangiato la Unilever, multinazionale planetaria, il gelato alle mandorle superlusso allevate con amore lo trovate al supermercato e addio al made in Italy dello spot.
Pazienza, mica tutto può andare sempre liscio, anzi, a volte si scivola di brutto. Tipo il dispiegarsi di amorosi sensi per Marchionne. Il Testimonial adora l’azienda, l’azienda adora il Testimonial, il talento italiano non si discute, anche se di italiano c’è rimasto poco, tra sedi legali e sedi fiscali tra Olanda e Gran Bretagna e ora anche la Exxor che scappa. Insomma, l’Italia è un posto bellissimo, ma non ci terrei la cassaforte, ecco. #Italiariparte, e gli Agnelli prima di tutti: ciao ciao, e il Testimonial ricorda un po’ il Gassman de I soliti ignoti: “M’hanno rimasto solo, ‘sti quattro cornuti”
Eppure l’amore non muore, e anzi il testimonial esagera: il giorno della quotazione Ferrari (gennaio 2015) dice che il titolo appena quotato è “una straordinaria occasione per gli investitori”, anche se poi , in quaranta giorni, perdeva circa il venti per cento. Ops. E anche ora che si è un po’ ripreso sta due punti sotto la quotazione iniziale, non esattamente un investimento “straordinario”. E del resto, un Testimonial così impegnato non può azzeccare sempre il prodotto vincente: consigliare di investire in azioni del Monte Paschi a gennaio di quest’anno era un po’ come consigliare la stricnina come digestivo, e lui l’ha fatto. Comprereste un’auto usata da quest’uomo? Boh, ma sulle azioni di una banca ci penserei due volte.
Ma se l’ottimismo non arriva da solo come nella Weltanschauung renzista e nelle favolette morali di Farinetti, porca miseria, non restano che gli amici. E qui il taglio di nastri diventa apoteosi, il testimonial ce la mette tutta. Eccolo da Technogym (foto su tapis roulant con maglietta aziendale) dell’amico e finanziatore Nerio Alessandri. E poi la Sitael di Bari, che non è un brand noto né un settore glamour (aviazione e aerospazio), per dire come al solito che c’è un’Italia fichissima che funziona, e questo pezzettino qui è del suo amico Vito Pertosa che è un Leopoldo della prima ora, di cui Renzi ha visitato anche un altro sito, la MerMec di Monopoli, insomma, nel caso Bi-testimonial, che fatica. A Napoli, cercando di evitare le defatiganti passeggiate all’aperto, va alla K4A (elicotteri leggeri) di Dario Scaletta, altro amico suo, uno che i rumors volevano renzianamente indicato come sindaco di Napoli. E poi, per dire, la Ads, altra eccellenza e altri amiconi: ad attenderlo c’è Chicco Testa che siede nel Cda e si era già seduto a qualche Leopolda antemarcia.
Insomma, il Testimonial non si lascia scappare nessuna occasione, specie se si tratta di amici, partner, finanziatori di fondazioni e kermesse. Ecco, questa appartenenza aiuta, i compari sono sempre i compari, ma per il resto non c’è grande criterio nella scelta dei prodotti che il Testimonial maneggia. O forse sì, ed è la pubblicità con ritorno politico. Come quando (settembre 2014) per snobbare la finanza dei soliti noti al forum Ambrosetti disse che lui va dove si produce (sottotesto: mica dai torbidi finanzieri!) ed eccolo alle Rubinetterie Bresciane, anche lì però coi soliti noti: i Bonomi padroni dei rubinetti, e il capo in testa di Confindustria Giorgio Squinzi.
Qui sotto la bella intervista di Maria Grazia Rabiolo per la Rete due della Radio Svizzera Italiana (cliccare sull’immagine per l’audio)
 Ora che Matteo Renzi ha inaugurato la “strategia del sommergibile”, cioè rendersi invisibile perché se si avvicina troppo al referendum convince gli italiani a votare No, tipo un Re Mida all’incontrario, l’estate italiana perde uno dei suoi tormentoni preferiti, il finto nuovo all’assalto del vero vecchio. Insomma, indietro i soldi, lo spettacolo è noioso, il film brutto e gli attori sembrano proprio cani. Per dirla semplice siamo in ritardo: nell’estate italiana del 2016 manca tutto: la canzoncina canticchiata urbi et orbi, il delitto dell’estate, persino il ritornello dei “gufi”, abbandonato perché evidentemente porta sfiga (sostituito da un più colto “apocalittici”, apperò!). In più, si sperava in un’estate fremente di dibattito sul Sì, sul No, sullo scontro fine-di-mondo del referendum, e invece tutto viene rimandato, perché pare che si voterà a novembre, permettendo al populista di Rignano sull’Arno di regalare qualcosa a quasi tutti con la legge di stabilità, tentando di comprarsi il voto al referendum coi soldi nostri. I testimoni di Matteo con i loro opuscoli sotto il braccio che dovevano citofonare agli italiani (“Guardi che tramonto! Chi l’ha creato secondo lei? Matteo!”) non si sono visti e forse non si vedranno, con grave danno per la commedia all’italiana. Certo, qualche tentativo di vivacizzare c’è, tipo la nomina dei direttori dei Tg, ma non sono cose che scaldano i cuori.
Ora che Matteo Renzi ha inaugurato la “strategia del sommergibile”, cioè rendersi invisibile perché se si avvicina troppo al referendum convince gli italiani a votare No, tipo un Re Mida all’incontrario, l’estate italiana perde uno dei suoi tormentoni preferiti, il finto nuovo all’assalto del vero vecchio. Insomma, indietro i soldi, lo spettacolo è noioso, il film brutto e gli attori sembrano proprio cani. Per dirla semplice siamo in ritardo: nell’estate italiana del 2016 manca tutto: la canzoncina canticchiata urbi et orbi, il delitto dell’estate, persino il ritornello dei “gufi”, abbandonato perché evidentemente porta sfiga (sostituito da un più colto “apocalittici”, apperò!). In più, si sperava in un’estate fremente di dibattito sul Sì, sul No, sullo scontro fine-di-mondo del referendum, e invece tutto viene rimandato, perché pare che si voterà a novembre, permettendo al populista di Rignano sull’Arno di regalare qualcosa a quasi tutti con la legge di stabilità, tentando di comprarsi il voto al referendum coi soldi nostri. I testimoni di Matteo con i loro opuscoli sotto il braccio che dovevano citofonare agli italiani (“Guardi che tramonto! Chi l’ha creato secondo lei? Matteo!”) non si sono visti e forse non si vedranno, con grave danno per la commedia all’italiana. Certo, qualche tentativo di vivacizzare c’è, tipo la nomina dei direttori dei Tg, ma non sono cose che scaldano i cuori.
Così lo spettacolino estivo viene dalla destra: Parisi incaricato di crearne una più liberale (e dagli!) e moderna (uff!), il che contempla la speranza di liberarsi di Salvini Matteo, quello dalle molte cazzate e dai pochi voti. Ma siamo sempre lì, con il capo del Ku Klux Klan che mette i dischi in spiaggia a Milano Marittima siamo ancora all’avanspettacolo, e allo spettacolo vero non si arriva mai. E del resto si sa: per fare buon cinema serve la star, e le pellicole fatte solo coi caratteristi non convincono mai. Allora si prova con le vecchie glorie e i campioni del passato, che quando la gente li vede e li sente parlare dice: ah, ma toh!, ma questo è ancora vivo? Il dibattito è sempre lo stesso: fare qualcosa di nuovo dove però “Il leader è sempre Berlusconi”, che è come costruire una splendida fuoriserie superaccessoriata con le ruote di pietra come ne Gli Antenati. E vabbè. Per dare voce alle due anime – quella nuovista con Parisi e guida spirituale il vecchio Silvio e quella mesozoica con finanziatore il vecchio Silvio – si corre così a intervistare antichi campioni. Matteoli, per dire, uno che sta in Parlamento da quando c’erano le Signorie, o l’astuto Gasparri che ha un modo tutto suo di chiedere l’unità del centro-destra: “Ci servono anche quelli che fanno i rutti a tavola”. Ah, ecco, Alvaro Vitali gli fa una pippa. Tra quelli che spingono la corsa di Parisi, si legge con un certo sconcerto, ci sono talenti come Prestigiacomo Tajani e Micciché, che è un po’ come sperare di rilanciare la musica italiana con Mario Tessuto e Nico Fidenco. Tra chi frena, invece, ecco Romani e Toti, gente che starebbe in panchina anche durante scapoli-ammogliati.
Che noia, insomma: a sinistra (?) si posano i lanciafiamme e si applica il vecchio consiglio manzoniano del “troncare e sopire” nella speranza che un po’ di low profile faccia dimenticare l’arroganza; a destra (?) si discute su come restare berlusconiani facendo un degno funerale al povero Silvio. Niente guizzi, niente rivoluzioni, più che #italiariparte sembra #italiainletargo, dove tutto viene rimandato a dopo il referendum, che è rimandato anche lui a quando più sarà comodo a Matteo. La furiosa estate che ci avevano promesso non c’è, non si vede, il governo fermo e immobile sembra uno di quei governi balneari della prima Repubblica che Forlani, al confronto, sembrerebbe un indemoniato.
Qui sotto l’intervista di Annarita Briganti per Repubblica Milano sul Salone del libro. Cliccare sull’immagine
Qui sotto (cliccare) l’intervistya di Eleonora Aragona su Il Giornale OFF (il link è qui)
 Poche cose al mondo hanno un effetto psicotropo potente come il dibattito sulla legalizzazione della cannabis. L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: leggere gli emendamenti della signora Binetti o del signor Giovanardi causa nei giovani danni permanenti, distacco dalla realtà, vuoti di memoria e, nei casi più gravi, alopecia e gomito del tennista. La tesi è nota: chi si fa una canna è meglio che la compri da brutti ceffi, di nascosto, finanziando le mafie e rischiando una denuncia, piuttosto che annaffiare una piantina sul balcone. Non fa una piega: è come teorizzare che per fare il pieno alla macchina sia meglio bucare un oleodotto col trapano invece che andare al distributore.
Poche cose al mondo hanno un effetto psicotropo potente come il dibattito sulla legalizzazione della cannabis. L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: leggere gli emendamenti della signora Binetti o del signor Giovanardi causa nei giovani danni permanenti, distacco dalla realtà, vuoti di memoria e, nei casi più gravi, alopecia e gomito del tennista. La tesi è nota: chi si fa una canna è meglio che la compri da brutti ceffi, di nascosto, finanziando le mafie e rischiando una denuncia, piuttosto che annaffiare una piantina sul balcone. Non fa una piega: è come teorizzare che per fare il pieno alla macchina sia meglio bucare un oleodotto col trapano invece che andare al distributore.
In attesa che i millemila emendamenti facciano il loro corso, che la legge torni in commissione, poi in aula, poi in commissione, poi vada al cinema, al circo, poi di nuovo in aula, poi su Saturno (vedi il reato di tortura), ci preme segnalare al gentile pubblico altre sostanze psicotrope, libere e gratuite, su cui gli italiani possono contare senza rischi legali, ma con grandissimo rischio della propria salute mentale.
I discorsi di Salvini – Disponibili in forma scritta e orale, perfettamente legali anche in non modica quantità, producono nel consumatore una passeggera ondata di autostima. L’effetto sui neuroni è immadiato: davanti alle parole di Salvini, infatti, chiunque si sente improvvisamente più intelligente. L’effetto dura fino al prossimo discorso di Salvini, che il consumatore cercherà avidamente sui giornali, segno che quel sentirsi intelligenti era un’illusione.
Mario Adonolfi – Il simpatico situazionista ultracattolico è legalmente distribuito sui social network, alla portata anche dei più piccoli e indifesi. Al contrario della cannabis, genera assuefazione e dirige il giornale La Croce, che la cannabis dirigerebbe meglio. Controindicazioni: servono cartine enormi perché anziché in grammi, Adinolfi è distribuito a quintali. Secondo gli esperti, l’assunzione massiccia di Adinolfi causa disfunzioni sessuali, rende impossibile la masturbazione e il sesso prima del matrimonio di chiunque. In compenso genera crisi di riso irrefrenabili.
Denis Verdini – Tipica droga “prestazionale”, si assume quando servono voti al Senato, e quando non servono si finge di disprezzarla e di non conoscerla. Nonostante l’uso diffuso (ogni senatore Pd ne ha in tasca una bustina) non è esattamente una droga legale, come dimostrano i numerosi rinvii a giudizio. Sull’uso e abuso di Verdini il dibattito è aperto: i bersaniani restano proibizionisti, mentre la segreteria Pd è più elastica e ne teorizza la liberalizzazione per uso personale.
Debora Serracchiani – Speciale sostanza psicotropa di sostengno, ha conosciuto una grande popolarità nei primi tempi del renzismo, ma è stata ritirata dal mercato dopo il disastro delle elezioni amministrative, non si sa se per decisione delle autorità sanitarie o per disaffezione dei consumatori. Gli effetti sull’organismo erano di fatto nulli, se si eccettua una vaga ilarità nei primi minuti seguenti l’assunzione.
Edward Luttwak – Grazie alla sua diffusione di massa attraverso i talk show, questa droga sintetica può risultare pericolosissima per chi possieda droni, bombardieri, portaerei e missili a testata multipla, ma anche per tutti gli altri. Gli effetti sono aggressività e senso di onnipotenza: dopo aver assunto Luttwak in dosi massicce si tende a vestirsi come un marine ed invadere pasticcerie, bombardare ritoranti e provocare colpi di stato e cambi di gestione nelle lavanderie sotto casa. Secondo gli esperti, si tratta di una droga pericolosa perché il consumatore tende a passare a droghe più pesanti, cioè si comincia a farsi di Luttwak e si finisce a volere una dose di Trump.
Attenziò! Battagliò! Da lunedì 25 luglio, per una settimana, in vendita con Repubblica, alla misera cifrata di sette euro e qualcosa, trovate Questa non è una canzone d’amore, il primo episodio della saga (?) del Monterossi con tutti i suoi complici e amici… Il libretto, lo sapete, è andato benone e io non lo sapevo che poi sarebbero venuti gli altri, ma insomma, vabbè, il primo bambino è sempre un po’ speciale. Qui sotto il video uscito su Repubblica… Insomma, io ve l’ho detto, eh!
 Ho comprato una scatola di RiformaBoschi® e ho letto il bugiardino, quel foglietto scritto piccolo che ti dice come prenderla e cosa rischi. Vi faccio un sunto.
Ho comprato una scatola di RiformaBoschi® e ho letto il bugiardino, quel foglietto scritto piccolo che ti dice come prenderla e cosa rischi. Vi faccio un sunto.
Cos’è – RiformaBoschi® è un farmaco di grande efficacia, disponibile in pastiglie, gocce e supposte rivestite di propaganda protettiva. Nel caso di pazienti resistenti alle cretinate si consigliano le iniezioni. RiformaBoschi® ha lo stesso principio attivo di RiformaBerlusconi™, che fu ritirata dal mercato dieci anni fa perché tossica. Ora le crisi di rigetto dei pazienti del Pd sembrano in parte risolte.
Posologia – RiformaBoschi® va preso in un’unica soluzione, giù tutta in un fiato. Dovrebbe curare il bicameralismo perfetto creando una specie di bicameralismo che piace a Matteo Renzi, con comuni e regioni che nominano i senatori e se li scambiano con gli affarucci della politica locale (vedi AbolizioneProvince℠ in gocce). Tutto diventa più veloce nell’organismo e se dovete aiutare le banche o fare la guerra si fa più in fretta e, soprattutto, si fa come vuole il premier.
Effetti terapeutici – Secondo i ricercatori dell’Istituto Boschi, RiformaBoschi® è un farmaco adatto a curare molte patologie: terrorismo dell’Isis, doppie punte, sindrome da provincialismo (solo zona Firenze), affezione per la democrazia, controllo delle nascite, riforma dell’Europa, del Mondo e (a lungo termine) di Giove, trasversalismo politico e calli. Funziona anche con padri accusati di bancarotta. Ma soprattutto, come dice la nostra pubblicità in onda su tutte le reti, o si prende RiformaBoschi® o sarà il caos, il nulla, la Terra uscirà dal suo asse di rotazione e addio (lo spot con Napolitano disperato nella via lattea è in lavorazione)
Altri farmaci – Abbinata con Verdini™ (supposte) RiformaBoschi® può causare piccole crisi di rigetto nel paziente. Poi, se il paziente è del Pd, fa finta di niente, sopporta un po’ e va avanti con la cura. Secondo l’Istituto Boschi il farmaco sopporta piccole dose di Verdini™, e anzi se ne serve per la sua azione. Abbinata con Italicum©, Riforma Boschi produce repubblica presidenziale e uomo della provvidenza. Se il paziente é convinto di diventare lui presidente (confezione da 80 euro), può continuare con RiformaBoschi®,; se si teme che possa diventare presidente un altro, interrompere la cura e modificare il dosaggio di Italicum©. Se necessario consultare un bersaniano.
Pazienti a rischio – Alcuni pazienti affetti da altre patologie potrebbero aver problemi con RiformaBoschi®. Tra questi i precari sopra i trent’anni, gli obbligazionisti di banche toscane e chi ha difficoltà di crescita con le tutele crescenti del Jobs Act. In questi casi, si consiglia di assumere RiformaBoschi® lo stesso, magari turandosi il naso.
Effetti collaterali – Per quanto non ancora testata su animali (si aspetta ottobre, no, forse novembre, mah, forse dicembre, per il grande test si 60 milioni di cavie ), sono già noti alcuni effetti collaterali di RiformaBoschi®. Nel paziente molto convinto della terapia, un aumento dell’arroganza, fino a raggiungere il delirio di onnipotenza e all’intemperanza verbale. Ciò potrebbe alternarsi con fasi di depressione, ansia e paranoia, in cui il paziente pensa che i giornali ce l’abbiano con lui e tutti siano cattivissimi. Per tutti gli altri pazienti, si registra una perdita immediata di rappresentanza, peso politico e partecipazione, cose considerate molto positive dall’Istituto Boschi.
Evoluzione del prodotto – RiformaBoschi® agisce anche su forme di vita estinte e microorganismi. Per esempio per la prima volta dai tempi di Marie Curie si sente nominare l’Udc. RiformaBoschi® è stata presentata anche nelle principali capitali europee, dove non ci hanno capito un cazzo, ma hanno detto: “Carina, la scatola!”
Call Center – Per ogni dubbio su RiformaBoschi®, si può chiamare il numero verde, il centralino a Napoli, risponde un De Luca, ne hanno tanti e devono piazzarli.
 Invidio molto chi tiene un archivio e confesso: io non sono capace. Il mio archivio è la pila di giornali vecchi che diventa un grattacielo, poi una montagna, finché mi decido a far pulizia. Così mi capita di scorrere titoli antichi e notizie passate a miglior vita, da “L’italicum non si tocca” a “Se vince il no lascio la politica”; da “Investirei su Monte dei Paschi” a “Il patto del Nazareno non esiste”. Poi tutto finisce nella raccolta differenziata (carta), come è giusto che sia per dichiarazioni che durano lo spazio di un mese o due.
Invidio molto chi tiene un archivio e confesso: io non sono capace. Il mio archivio è la pila di giornali vecchi che diventa un grattacielo, poi una montagna, finché mi decido a far pulizia. Così mi capita di scorrere titoli antichi e notizie passate a miglior vita, da “L’italicum non si tocca” a “Se vince il no lascio la politica”; da “Investirei su Monte dei Paschi” a “Il patto del Nazareno non esiste”. Poi tutto finisce nella raccolta differenziata (carta), come è giusto che sia per dichiarazioni che durano lo spazio di un mese o due.
Non si può andare avanti così, e quindi c’è una sola decisione da prendere: portarsi avanti col lavoro.
22 luglio – Nel corso di una riunione allo Sheraton di Posillipo, Maria Elena Boschi annuncia la nascita dei comitati del Forse. Dopo aver ammesso che la riforma delle riforme con cui ci hanno scassato la uàllera per mesi e mesi è “imperfetta”, prevale il buon senso.
28 luglio – Carro del vincitore: spintoni e tafferugli vicino alle uscite di sicurezza. Qualcuno ha gonfiato il salvagente prima di imboccare la porta e la ressa si è fatta insostenibile. Grida di “Fatemi scendere” e “Lei non sa chi sono io”, seguite dall’immancabile: “Ma si che lo so, stronzo”
3 agosto – Grande censimento. I renziani della prima ora sono il 22 per cento, quelli della seconda ora il 36 per cento, i renziani dell’ultimo minuto il 24 per cento e sbertucciati da tutti come quelli che sono usciti con l’ombrello e la giacca a vento quando c’era il sole e quaranta gradi all’ombra.
7 agosto – Tutti guardano a Franceschini. Fraceschini è come quelle statuine che diventano azzurre o bianche al cambiare del meteo, ti dicono se pioverà o se farà caldo. Ora Franceschini è azzurro e i franceschiniani sono dati in grande ascesa. Il passaggio da renziano a franceschiniano è considerato una tappa fondamentale nell’éducation sentimentale del giovane dem. Spuntano i franceschiniani della prima ora. A casa Franceschini si costruisce un nuovo carro, ressa alle porte da cui si entra.
11 agosto – Renzi ai suoi “Mai stato renziano”
14 agosto – Renzi attacca la minoranza, ma questa volta parla ai renziani rimasti sul carro (si erano addormentati e hanno sbagliato fermata)
18 agosto – Aperto a Rignano sull’Arno il museo del renzismo. Polemiche per l’enorme statua del gufo all’ingresso. Renzi rilascia una dichiarazione alle agenzie: “Mai usata la parola gufo, è una mistificazione della stampa che ce l’ha con me”.
23 agosto – Nel corso di una burrascosa riunione, presente Renzi, un busto di Renzi, due foto incorniciate di Renzi e un grande cartonato di Renzi, si decide che sì, forse l’Italicum si può cambiare. Il dibattito è quando: prima del referendum? Dopo il referendum? Passa la proposta di cambiarlo durante: mentre gli italiani staranno votando, sei esperti di leggi elettorali sorteggiati tra i consumatori di bistecche alla fiorentina cercheranno una soluzione.
30 agosto – E’ deciso, il referendum sulla riforma costituzionale si terrà tra il 9 ottobre e il 23 aprile, ma in caso di pioggia verrà rinviato a giugno.
6 settembre – Sono passati esattamente mille giorni dalla famosa promessa “Mille asili in mille giorni”. Matteo Renzi li inaugura tutti in un colpo solo. Sono bellissimi, tutti in Lego con i tetti rossi e le finestrelle.
10 settembre – Dario Franceschini, ministro della cultura, inaugura una grande mostra a Roma. Titolo: “Il gusto della citazione”. All’ingresso campeggia una grande scritta in neon azzurro: #Matteostaisereno
22 settembre – Matteo Renzi convoca una conferenza stampa in cui elenca i suoi successi, quindi nessuno parla per ventisei minuti. Poi si alza e congeda i giornalisti con un sonoro: “Il mio invito è sempre lo stesso: votate No”.
 La splendida cornice e la toccante cerimonia, o’ sole, o’ mare e il roof garden, segnalato dai siti locali come ‘nu babbà per festeggiare San Valentino. Per l’Hotel Mediterraneo di Napoli, insomma, il tocco glamour non servirebbe, ché ce l’ha già. E invece lei ce lo porta lo stesso: Maria Elena Boschi, la fatina delle riforme, una che tutti abbiamo avuto come compagna di classe in seconda media, ci siamo innamorati, poi per fortuna ci hanno promosso in terza ed è finita lì.
La splendida cornice e la toccante cerimonia, o’ sole, o’ mare e il roof garden, segnalato dai siti locali come ‘nu babbà per festeggiare San Valentino. Per l’Hotel Mediterraneo di Napoli, insomma, il tocco glamour non servirebbe, ché ce l’ha già. E invece lei ce lo porta lo stesso: Maria Elena Boschi, la fatina delle riforme, una che tutti abbiamo avuto come compagna di classe in seconda media, ci siamo innamorati, poi per fortuna ci hanno promosso in terza ed è finita lì.
Ma insomma, al netto dell’affannosa raccolta di firme, della formazione un po’ al ralenti dei comitati per il Sì (Renzi ne ha promessi diecimila, che andranno “casa per casa”, incubo) e della ricerca di testimonial vip, dare una sensazione di attivismo fa sempre bene. Ed eccola, allora, la titolare del dicastero della Riforma-Fine-Di-Mondo, fare il giro delle sette chiese: sabato, ore 11, Napoli, appunto, città dove il Pd non è nemmeno arrivato al ballottaggio e dove ha invitato a votare la destra di Lettieri.
Corte ristretta, dicono le cronache che annunciano l’evento, ma certo Maria Elena non può essere lasciata sola. Accanto a lei ci saranno il sottoguru della comunicazione Francesco Nicodemo e un De Luca, notizia che induce sempre a chiedere: ah sì, quale?
Delusione in sala: non sarà il prorompente governatore della Regione Campania, quello che ormai imita Crozza che imita lui (ultima uscita: “bambolina imbambolata” alla neo-sindaca di Roma che li ha stracciati alle elezioni: l’hanno presa bene). Né il figliolo Roberto, piazzato assessore al comune di Salerno; ma l’altro rampollo, Piero, avvocato d’affari tra l’Italia e il Lussemburgo, che proprio a causa di certi affari non si riuscì a piazzare nelle liste bloccate del Pd per la Camera a Salerno. Ach!
Vero che il ragazzo non si è perso d’animo e ha continuato la sua resistibile ascesa, anche come socio di tale Emilio Ferraro, che aveva incarichi in società partecipate del comune di Salerno: essendo ai tempi il padre sindaco della città c’è da pensare alla mirabolante coincidenza. In più ebbe una consulenza dal gruppo Mcm di Lettieri, azienda privata che trattava col Comune una delocalizzazione industriale: altra coincidenza.
Per gli amanti del genere (il giallo familiare partenopeo, segno zodiacale Totò, ascendente Pulcinella), ci sarebbe anche il fallimento di una piccola società di consulenza, l’Ifil, sulla quale la procura di Salerno aprì un fascicolo, sospettando un intreccio tra finanziamenti alle campagne elettorali di papà e sostanziose consulenze ricevute dall’Esa, la società impegnata nel rifacimento di piazza Libertà per cui De Luca (padre, che casino, eh!) ha passato i suoi guai. In più, la procura vorrebbe sapere come mai e a quale titolo Piero De Luca riceveva dalla Ifil biglietti aerei per decine di migliaia di euro, e ci andava il Lussemburgo con la consorte. In soldoni (è il caso di dire): avviso di chiusura indagini e ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Un bel quadretto, una cosuccia sobria che pare il presepe (te piace o’ presepe?), con Nostra Signora delle Riforme alle prese con dicerie e malelingue. E’ vero che ha un po’ litigato con Matteo? E’ vero che lui ritiene meglio spedirla in giro a benedire comitati per il Sì invece che mandarla in tivù a discutere di Costituzione con la stessa inattaccabile credibilità con cui il vostro ferramenta discetterebbe di fisica quantistica? Chissà. Se si resta ai fatti, c’è un recente sondaggio Ipr Marketing che segnala la popolarità di Santa Maria Elena in caduta libera: dal 22 per cento di novembre all’11 per cento di oggi (peggio di lei fanno solo le ministre Madia e Giannini, ti piace vincere facile, eh!).
Ce n’è abbastanza per dire che la toccante cerimonia di Napoli, sabato ore 11, potrà dare buoni spunti: il figlio del potentissimo De Luca padre, la ministra che fu tanto amata e il sottoguru dal tweet facile. Andranno lì a dire che se vince il No ci saranno morte e distruzione, la scabbia e lo scorbuto. Mentre se vince il Sì ci teniamo loro. Ma sai che in fondo in fondo lo scorbuto…
 “Umile” sarebbe pure una parola nobile, a volerla guardare dal verso giusto, cioè dalla parte delle radici. Intanto perché deriva da humilis, e quindi da humus, terra, e insomma, va bene, un baobab, per dire, un pino secolare, non sono mica tanto umili, mentre l’erbetta sì, e infatti la calpestiamo senza tante storie.
“Umile” sarebbe pure una parola nobile, a volerla guardare dal verso giusto, cioè dalla parte delle radici. Intanto perché deriva da humilis, e quindi da humus, terra, e insomma, va bene, un baobab, per dire, un pino secolare, non sono mica tanto umili, mentre l’erbetta sì, e infatti la calpestiamo senza tante storie.
Poi si sa che le parole si evolvono, che inseguono la società, ma anche la società insegue loro: di solito per picchiarle. Così oggi “umile” è diventata una parola da calciatori. “Dobbiamo essere umili”, dicono i bomber delusi davanti ai microfoni con i capelli a cresta e il Rolex grosso come il Big Ben, poi se ne vanno con la Ferrari, che agli umili – quelli veri – fa sempre effetto. Insomma, diciamolo: come certe attività commerciali che non muovono una lira ma fanno da copertura a ricchissimi affari, anche la parola “umile” è diventata uno schermo, una specie di burqua indossato alla bisogna da chi è stato molto arrogante e per farsi perdonare – o per continuare a ingannare – si finge “umile”. Inutile dire che a un umile vero – umile come condizione sociale, cioè rasoterra, per restare all’etimo – non verrebbe mai in mente di vantare la propria umiltà: di solito lo fanno quelli che non sono umili per niente.
Non è un caso che la parola “umiltà” salti fuori come un pupazzo a molla ogniqualvolta qualcuno prende una facciata clamorosa. Dopo le elezioni amministrative, basta cercare in rete, si fece grande spreco della parola. “Matteo Renzi, umiltà dopo le comunali”, titolava l’Huffington Post, e Pierluigi Bersani dettava alle agenzie il suo monito da allenatore esonerato: “Renzi sia più umile”, “Renzi abbia l’umiltà di riflettere”, eccetera, eccetera. Mentre La Stampa titolava: “La svolta umile di Renzi”, avendo però l’accortezza di mettere “umile” tra virgolette, perché non si sa mai con la lingua toscana, e magari a Rignano sull’Arno “umile” vuol dire “Vai e spaccagli la faccia, Matteo”.
Insomma, tutto questo avveniva solo qualche settimana fa, quando gli “umili” delle periferie (clamorosamente a Roma, ma, umilmente anche in molti altri posti) bastonavano il Pd asserragliato nei quartieri-bene. Ma poi succede che certe parole sono come i buoni propositi della notte di Capodanno, che ti svegli il giorno dopo, mezzo sbronzo, e te li sei dimenticati alla grande. Ed ecco che nella direzione del Pd ripetutamente rinviata in modo che il voto amministrativo apparisse più lontano, quasi antico, diventava lontana e antica anche l’umiltà, evocata solo dal povero Cuperlo che pregava il sovrano di praticare la modestia “non solo nel tono della voce”.
Ecco fatto. Fine dell’umiltà e dell’autocritica, se mai ve ne fu. E anzi, ammonimenti e minacce, come quella di un Renzi modello hostess, che dice a chi scende dal carro del vincitore che poi – si avvertono i gentili passeggeri… –
non si risale più: una versione soft del famoso lanciafiamme (a proposito di umiltà).
Insomma, se c’è una cosa che gli umili sanno benissimo – intendo gli umili di condizione economica, gli umili pagati in voucher, gli umili che non meritano 80 euro perché troppo poveri – è di diffidare di chi sbandiera la propria umiltà. Capiscono che è un trucco, una trappola, un’operazione mimetica. Sono umili, mica sono scemi.
Che poi vorrei essere un po’ umile anch’io, corre l’obbligo di denunciare che non sono certo cose nuove, queste, e anzi si sanno da secoli, e già le diceva un certo Shakespeare nel Giulio Cesare: “L’umiltà è la scala di una giovane ambizione. Ma, come abbia raggiunto l’ultimo gradino, volge essa le spalle alla scala e rimira le nubi, spregiando i gradini più bassi ond’essa è ascesa”. Ecco fatto. E chi l’avrebbe mai detto che il vecchio bardo sapesse già come andava a finire, all’alba del 1600, una direzione del Pd di quattro secoli dopo.
 Insomma, ecco qui: abbiamo un problemino col popolo. A giudicare dai solenni scritti sul referendum britannico sembrerebbe una gran rottura di palle, e le analisi si concentrano sulla particolare composizione dell’elettorato inglese: da una parte i colti, benestanti, saggi, europei con casa in centro, libri e afflato democratico, e giovani; dall’altra buzzurri, contadini, anziani scontenti, razzisti, xenofobi e tutti quelli che fanno la doccia solo al giovedì. Non è facile trovare le parole per questo, ma si può sempre provare: quello buono è il popolo, e gli altri sono i populisti.
Insomma, ecco qui: abbiamo un problemino col popolo. A giudicare dai solenni scritti sul referendum britannico sembrerebbe una gran rottura di palle, e le analisi si concentrano sulla particolare composizione dell’elettorato inglese: da una parte i colti, benestanti, saggi, europei con casa in centro, libri e afflato democratico, e giovani; dall’altra buzzurri, contadini, anziani scontenti, razzisti, xenofobi e tutti quelli che fanno la doccia solo al giovedì. Non è facile trovare le parole per questo, ma si può sempre provare: quello buono è il popolo, e gli altri sono i populisti.
Ora, questa faccenda dei populisti sembra sistemare ogni cosa: tamponi sull’autostrada? Colpa dei populisti. Non ti viene il soufflé? Populismo!
E’ una nuova accezione della parola popolo che pare accettata a sinistra: come il colesterolo, c’è quello buono (progressista, che legge i giornali e vota come si deve) e quello cattivo (zozzoni). Un dibattito che non è solo inglese, basti pensare che la parola popolo qui si pronuncia “periferie”, cioè quelle che bellamente nelle recenti elezioni se ne sono andate facendo ciaone al Pd. Dopodiché, giù analisi sulle periferie che “le abbiamo abbandonate”, che “ora sono la priorità”, eccetera eccetera.
Il berlusconismo buonanima aveva risolto il problema privilegiando la “gente” a discapito del “popolo”, ma poi non aveva resistito al suo speciale populismo e si era battezzato Popolo delle libertà, un testacoda notevolissimo. Testacoda anche inglese, perché a chiamare il popolo a votare era stato quel Cameron (uno che ha studiato a Eton e Oxford, uno per cui il popolo è quello che ti sella il cavallo nella tenuta di campagna) che sperava nel plebiscito, e poi è passato da “dinamico leader” a “coglione conclamato”.
Eravamo abituati a pensare alla Gran Bretagna come a un posto decisamente fighetto, compostamente in coda alla Tate Gallery, e ormai quando qualcuno ci faceva vedere la vera Inghilterra (tipo Ken Loach) si mormorava: uh, che palle, ancora con questi poveri! E come sono brutti! Perché non si comprano qualcosa in Oxford Street?
Ma resta il problema: ammesso e non concesso che il 52 per cento dei britannici sia incolto, burino, razzista, ignorante, stupido ed egoista, quale democrazia matura mantiene più della metà del suo popolo in condizione di incultura, burinaggine, razzismo, ignoranza stupidità ed egoismo? E’ una specie di equazione della democrazia: se i poveri sono ignoranti bisognerà lavorare per avere meno poveri e meno ignoranti. Questo significa welfare e riduzione delle diseguaglianze, mentre invece da decenni – in tutta Europa e pure qui da noi – si è ridotto il welfare e si è aumentata la diseguaglianza. La sinistra dovrebbe portare il popolo alla Tate Gallery, non sputargli in un occhio dicendo che è diventato razzista. Eppure.
Che il popolo sia una gran rottura di coglioni è peraltro noto da sempre, chiedere a Luigi XVI, agli zar, ai tedeschi in ritirata sulla linea gotica. E in più ha una sua specifica tigna: o gli tocca qualche quota nella distribuzione della ricchezza e del benessere, oppure si incazza con modalità impreviste, anche deplorevoli. Ora va di moda dire che il popolo inglese ha seguito l’impresentabile Farage, che però vanta meno di un quarto dei consensi raccolti dalla Brexit. Così come qui prevale la moda di dire che il popolo poi sceglie Salvini, mentre Salvini conta, per fortuna, meno del due di picche. Insomma, abbiamo un problemino col popolo brutto, sporco e cattivo. Un tempo, quando si leggeva Marx (uh, che noia!) si sarebbe detto che siamo alle prese con una questione di classe. Oggi che tutto è più moderno e veloce, si sistema la questione archiviando il popolo come nemico, incolto, malvestito e un po’ ignorante. E’ più facile, è più smart, ma un po’ rischioso.
 Un esercito di piccoletti liberati dalla dittatura del voto, dall’ossessione delle medie, dall’ansia da prestazione prima che sia l’ora. Eccola qui la nuova giravolta della scuola elementare. C’erano i voti (fino al 1977), poi arrivarono i giudizi, poi arrivò la Gelmini e, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, ripristinò i numeri (2009), poi ecco, da domani (dal prossimo anno scolastico), le lettere. A, e sei il primo della classe, E, e sei un somaro conclamato. In mezzo B, C, D, che dicono che il riscatto è possibile. Se prendi AAA+, poi, puoi dire di avere un rating che Moody’s ti fa una pippa.
Un esercito di piccoletti liberati dalla dittatura del voto, dall’ossessione delle medie, dall’ansia da prestazione prima che sia l’ora. Eccola qui la nuova giravolta della scuola elementare. C’erano i voti (fino al 1977), poi arrivarono i giudizi, poi arrivò la Gelmini e, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, ripristinò i numeri (2009), poi ecco, da domani (dal prossimo anno scolastico), le lettere. A, e sei il primo della classe, E, e sei un somaro conclamato. In mezzo B, C, D, che dicono che il riscatto è possibile. Se prendi AAA+, poi, puoi dire di avere un rating che Moody’s ti fa una pippa.
Barbatrucco interessante (viene dall’America e da alcuni stati europei) per fare in modo che un quattro all’inizio dell’anno non ti freghi per sempre, e – effetto collaterale – per imbrogliare i genitori più distratti (“Essù, mamma, ho preso E, mica Z!, la bicicletta arriva lo stesso, vero?”). Ma sia: nulla deve spaventarci, figurarsi le piccole cosmesi alla pagella (anche perché, dice la riforma, alla fine dell’anno i numeri ve li beccate lo stesso). E così, addio alle alchimie dell’aritmetica, quei meravigliosi sei meno meno, i sette e mezzo che sembravano rapine al treno (“Era un otto, cazzo!”), i dieci (rari, sì, ma sui quali si poteva campare una vita). Con le lettere non si può fare la media aritmetica, e questo è bene, e c’è un sapore di speranza: coraggio, da E si può solo risalire. Riformina-ina-ina, ma con un suo piccolo valore: meno assurda competizione, meno ansia da performance, che poi, dopo, nella vita post- quinta elementare, non mancherà. E soprattutto, qui sì molto bene, non si boccerà più alle elementari che era, quella sì, una cattiveria dei grandi sui piccolini (e una faccenda, scusate il termine, di classe).
Tutto bene, allora? Quasi tutto, perché la minima dose di buonsenso contenuta nel passaggio dai voti ai numeri merita qualche apprezzamento, sì, ma non l’enfasi poderosa con cui certi esponenti della maggioranza la salutano esultanti. “Misurare con un numero la gioia di apprendere di un bambino è come misurare il cielo con un righello”, ha detto Francesca Puglisi, responsabile scuola del Pd. Ecco, anche meno, grazie. Perché altrimenti si rischia il voto in retorica (E) e pomposità (D), a meno che non si voglia valutare col metro (pardon, righello) dell’eloquenza da hasthtag che piace tanto ai giovinotti del ministero, qualcosa come #cambiaversoprendiA.
 Renzi non è solo, nella sconfitta elettorale. Con lui, un vasto schieramento di media con una capacità di fuoco enorme. E inutile
Renzi non è solo, nella sconfitta elettorale. Con lui, un vasto schieramento di media con una capacità di fuoco enorme. E inutile
La sconfitta è solitudine. Lo sconfitto se ne sta solo in un angolino, consolato dai fedelissimi, mentre l’altro, quello che ha vinto, lo cercano tutti. Fa eccezione Matteo Renzi dopo la sconfitta alle elezioni amministrative, perché nell’angolino dove è finito non sta proprio da solo, ma in buona compagnia. Alle analisi psichiatrico-politiche del voto nelle grandi città manca infatti un tassello che rende la sconfitta di Renzi ancora più grave, ed è questo: insieme a lui ha perso un micidiale, granitico, quasi unanime fronte dei media ufficiali. I grandi quotidiani (Repubblica, Corriere della Sera, Stampa) e le tivù generaliste (tutta la Rai, in modo intermittente Mediaset, quasi sempre Sky) hanno fin’ora oggettivamente “fatto il tifo” per Renzi, le sue politiche, la sua lettura dell’Italia, la sua azione innovatrice (?), il suo dinamismo, eccetera, eccetera. I “retroscena” (valga per tutti la firma di Maria Teresa Meli, riconosciuta portavoce del Capo) sono ormai veline del governo, indirizzate ora ai nemici, ora agli amici che non si allineano, ora ai nemici che si vorrebbe corteggiare, ora a soci e complici da cui dissociarsi a parole ma agire nei fatti (Verdini e compagnia).
Insomma, un conto è perdere le elezioni, un altro conto è perderle avendo dalla propria una capacità di fuoco impressionante, l’artiglieria pesante, l’aeronautica, i parà, i guastatori del genio: è una sconfitta doppia.
Ma intanto, mentre piccoli riposizionamenti si compiono, si mette tristemente a verbale una cosa piuttosto importante: i media non spostano più l’opinione pubblica come un tempo. Avere accanto il grande giornale, l’appoggio del Tg più ascoltato, l’opinione illustre in prima pagina, l’endorsement pompato, l’intervista-bomba (come fu quella di Napolitano al Corriere: “O vince il No o è il nulla”, minaccia nichilista) non assicurano automaticamente consenso.
Esiste dunque un canale di informazione (e propaganda, ovvio, e scemenza pressofusa, e trollismo militante, ma anche di circolazione di notizie e di idee) che vale più della “versione ufficiale”. E’ un fenomeno molte volte teorizzato (la rete, la rete, la rete, la democrazia dal basso, eccetera, eccetera), ma che forse per la prima volta si vede, qui e ora, perfettamente realizzato. Se un tam-tam su Facebook vale più di un fondo di Scalfari – non per buona lettura e forbito linguaggio ma per tasso di convinzione di chi legge – dove andremo a finire, signora mia?
Come al solito quando si parla di media e di sapere pubblico e diffuso, la distinzione è tra Apocalittici e Integrati, vecchie categorie che funzionano ancora (è una cosa che distingue le teorie sensate dalle mode culturali). Gli Apocalittici indicano il caso Trump, con i media schierati compattamente contro l’impresentabile candidato, mentre la rete – la famosa pancia del paese, un po’ buzzurra e concimata d’odio – lo fa volare nei sondaggi. Analogo per la Brexit, dove le voci istituzionali, elitarie, nobili dicono una cosa (restiamo) e la marmaglia (anche editoriale) dice il contrario (andiamocene). L’informazione dal basso – il passaparola, dicono gli editori, che fa vendere un libro più di cento recensioni positive – è vista come un inquinamento della narrazione ufficiale e autorizzata, un’irruzione della plebaglia armata di tablet, pc e telefonini nelle cantine dello zar, là dove girano le rotative.
Gli Integrati insistono sul valore democratico di quel flusso di commenti, pareri, polemichette, dichiarazioni, notizie false o presunte, ma anche vere e nascoste, e festeggiano la fine dei “poteri forti” dell’informazione. La verità starà da qualche parte nel mezzo, ma un fatto è evidente a tutti: la contro-narrazione sotterranea, una specie di samizdad, ha battuto quella ufficiale, ben confezionata, venduta in edicola, trasmessa in tivù. E questo per un motivo molto semplice: è più vicina alla realtà dello storytelling luminoso e progressivo della comunicazione renziana che molti media di rango hanno sposato.
E’ una faccenda con cui fare i conti: forse non lo farà Renzi, che ha già dichiarato il rilancio invece della marcia indietro, ma certo dovrebbero farlo gli editori che vedono scappare clienti, lettori e spettatori con la stessa velocità con cui Renzi perde elettori. Se sposi una narrazione, la fai tua, la diffondi, se continui a titolare “L’ira di Renzi…” quando le cose vanno male, o “Renzi ai suoi…” quando c’è da mandare un messaggio, a magnificare riforme discutibili, a diffondere cifre farlocche, o a cantare nel coro del “va tutto bene”, poi, all’apparir del vero, stai nell’angolino insieme allo sconfitto. Con un aggravante non da poco: che i comunicatori del cambiaverso (tutto nuovo, tutto luccicante!) si presentavano come, appunto, innovativi, come rottamatori del vecchi schemi, smart, smanettoni, whatsapp-dipendenti, twittaroli emetriti. E invece sono finiti aggrappati al Tg1 e ai grandi giornali come nella nei secoli dei secoli passati. Il dibattito – se sia solo un brutto inizio o già una brutta fine – è aperto.
 La serena analisi del voto da parte di Matteo Renzi somiglia allo scomposto lamento di John Belushi nei Blues Brothers: “Non è stata colpa mia! Ero rimasto senza benzina… la tintoria non mi aveva consegnato il tight… il terremoto, una tremenda inondazione… le cavallette!”. Diffonde il verbo Maria Teresa Meli sul Corriere: “Può essere che a qualche renziano sia chiesto di farsi da parte”, che in italiano significa “pagherà qualche gerarca pur di mettere in salvo il Capo”, roba già vista. Il resto lo fa la capacità mimetica del giovanotto: bravi i 5 stelle che hanno vinto perché vogliono innovare, proprio come fa lui, che sarebbe una specie di Vero 5 stelle, e gli elettori che protestano dovrebbero votare per lui, si sono semplicemente sbagliati, che disdetta. Avessero vinto le Carmelitane scalze oggi Renzi andrebbe in giro senza scarpe dicendo che la vera Carmelitana è lui.
La serena analisi del voto da parte di Matteo Renzi somiglia allo scomposto lamento di John Belushi nei Blues Brothers: “Non è stata colpa mia! Ero rimasto senza benzina… la tintoria non mi aveva consegnato il tight… il terremoto, una tremenda inondazione… le cavallette!”. Diffonde il verbo Maria Teresa Meli sul Corriere: “Può essere che a qualche renziano sia chiesto di farsi da parte”, che in italiano significa “pagherà qualche gerarca pur di mettere in salvo il Capo”, roba già vista. Il resto lo fa la capacità mimetica del giovanotto: bravi i 5 stelle che hanno vinto perché vogliono innovare, proprio come fa lui, che sarebbe una specie di Vero 5 stelle, e gli elettori che protestano dovrebbero votare per lui, si sono semplicemente sbagliati, che disdetta. Avessero vinto le Carmelitane scalze oggi Renzi andrebbe in giro senza scarpe dicendo che la vera Carmelitana è lui.
Eppure c’è un dato che Renzi ignora e che si sente palpabile nel paese, una specie di Questione Umorale: Renzi, il renzismo, la renzitudine e la renzità stanno sulle palle a una larga fetta della popolazione, per vari motivi. Il primo è, diciamo così, la sindrome di Silvio. Il sole in tasca, il “va tutto bene”, le fregnacce dell’Italia che riparte, la vecchia barzelletta made in Arcore che se dici che tutto procede per il meglio poi tutto procederà per il meglio. Dire queste cose mentre moltissimi vivono di voucher, pagano esami sanitari che prima erano gratuiti o vengono chiamati – da poveri – a rendere la mancia degli ottanta euro perché troppo poveri, fa piuttosto incazzare.
Ma questo è solo un lato della Questione Umorale. L’altro lato è, se possibile, ancora più irritante. E’ quel chiacchiericcio di gerarchi e gerarchetti del renzismo scatenati nei media e nel social network, quelli che, nel farsi portavoce del Capo, brillano per eccesso di zelo. Quelli che dicono “ciaone”, quelli che twittano che con Fassino a Torino arriveranno i Radiohead e invece con l’Appendino solo tristezza e strade deserte alla sera. Quelli che chiamano l’avversario #classedirigentemaddeché, o che sputano fiele su quello che era (un tempo) parte del loro elettorato. Quelli che irridono, che resuscitano in versione toscana quella spavalderia arrogante che fu la cifra del primo craxismo milanese. In soldoni, una classe politica di “nuovi e giovani” che nel vecchio Pci avrebbe a stento pulito i vetri della sezione, e oggi invece va in giro ostentando il cappello con le piume da statista. E’ questa, la vera #classedirigentemaddeché, uno spettacolo desolante per malagrazia verbale e pochezza culturale.
Ma il vero problema della Questione Umorale è che non è risolvibile. La cifra del renzismo conosce una sola modalità (la similitudine con Silvio è palese): quella della vittoria, della supremazia, della soddisfazione tronfia, della certezza di essere nel giusto. Se il renzismo mediasse, se ascoltasse, se guardasse la realtà, insomma, se facesse politica invece che propaganda, non sarebbe più renzismo, perché l’arroganza (come fu con Bettino) non è un orpello, ma un elemento strutturale, materia culturale e ideologica fondante. Tutti amano Mahammad Alì quando dice “lo stenderò alla terza ripresa”, ma questo avviene perché Alì, poi, lo stende davvero alla terza ripresa. Se fai costantemente il giro di campo alzando la coppa e perdi quattro a zero, la gente sugli spalti non batte le mani, ride, e dopo che ha riso va a votare per qualcun altro, senza rimpianti. Dunque il renzismo, e Renzi lo sa, non è emendabile: o così o niente, prendere o lasciare. L’unica opzione è il rilancio. Il renzismo fallisce? Più renzismo! Come l’autobus che va contro un muro a cento all’ora e l’autista che dice: acceleriamo!, e poi si stupisce e si offende se molti passeggeri scendono al volo.
 Spiace moltissimo che – oscurata dagli imminenti ballottaggi tra l’ipotesi del paradiso in terra (vincono i sindaci del Pd) e l’epidemia di pellagra e scorbuto (vincono i sindaci M5s) – non abbia giusto rilievo sui media la Dinasty salernitana di Vincenzo De Luca. Colpevolmente, fino ad oggi, della famiglia De Luca conosciamo soltanto i rami più solidi: Roberto (32 anni, figlio), neo superassessore al comune di Salermo, e Piero (figlio), seduto all’assemblea nazionale Pd e quasi certo della candidatura alle prossime elezioni politiche. Certi di fare cosa grata ai lettori, ecco gli altri De Luca che governano o governeranno con mano ferma la cosa pubblica.
Spiace moltissimo che – oscurata dagli imminenti ballottaggi tra l’ipotesi del paradiso in terra (vincono i sindaci del Pd) e l’epidemia di pellagra e scorbuto (vincono i sindaci M5s) – non abbia giusto rilievo sui media la Dinasty salernitana di Vincenzo De Luca. Colpevolmente, fino ad oggi, della famiglia De Luca conosciamo soltanto i rami più solidi: Roberto (32 anni, figlio), neo superassessore al comune di Salermo, e Piero (figlio), seduto all’assemblea nazionale Pd e quasi certo della candidatura alle prossime elezioni politiche. Certi di fare cosa grata ai lettori, ecco gli altri De Luca che governano o governeranno con mano ferma la cosa pubblica.
Gaetano De Luca – 11 anni. Già noto alle cronache per il suo progetto di costruire un lungomare in mattoncini Lego tra Sarno e San Giuseppe Vesuviano, raccoglie 14.564 preferenze nella sua scuola media. A chi fa notare che tra Sarno e San Giuseppe il mare non c’è, risponde con la frase “Maldicenze interessate di chi non ha a cuore lo sviluppo campano”.
Deluco De Luca – Feto (nascerà a settembre). Nonostante la tenerissima età, è già molto considerato in famiglia. Il suo progetto di realizzare una linea ad alta velocità tra Salerno e Sant’Egidio del Monte Albino (dove abita la sua futura baby sitter) suscita qualche perplessità per i costi (176 miliardi per una tratta di nove minuti). Ma lui – fa sapere dall’ultima ecografia – non ascolterà i gufi nemici della modernità.
Anacleto De Luca – 98 anni. Rimasto in ombra per quasi un secolo, punta oggi alla presidenza della commissione Nuove Tecnologie del Pd campano. Il suo sogno: cablare in fibra ottica il Taj Mahal di Nocera Superiore.
Cosimo De Luca – 17 anni, detto o’ principino. Suo l’ambizioso progetto (appoggiato strenuamente dal governo Renzi) di costruire il Taj Mahal a Nocera Superiore, il cui primo vantaggio sarà dare un lavoro al bisnonno Anacleto (vedi sopra).
Porfirio De Luca – 71 anni. Dopo vari anni passati in Sud America come commerciante di granaglie è tornato a Salerno con moglie e 18 figli, per i quali chiede 18 assessorati. Molto attivo nella Commissione Famiglia del Pd campano, che si occupa essenzialmente della sua.
Gustavo De Luca – 34 anni. Già consigliere della Commissione Edilizia del Pd campano, già guida turistica, già vicepriore del convento dei Frati Intemerati di Cava de’ Tirreni, punta tutto sul suo più ambizioso progetto: i mondiali di sci a Pontecagnano. A chi gli fa notare che a Pontecagnano ha nevicato l’ultima volta nel 1754 risponde: “Noi De Luca siamo abituati all’impossibile, e chi lo nega c’ha le corna”.
Federico Secondo De Luca – 4 anni. Forte dell’appoggio delle maestre e dei compagni di asilo, conduce da anni (quattro) la sua campagna contro le insidie della strada provinciale 27 che unisce Capezzano Inferiore a Capezzano Superiore (1,6 chilometri). La sua proposta di costruire due aeroporti che colleghino le due località raccoglie unanimi consensi nel Pd campano.
Geremia De Luca – 47 anni. Considerato l’estremista della famiglia, ha recentemente rivisto alcune sue posizioni e ceduto su alcuni fronti (voto alle donne, limiti di velocità, ius primae noctis), ma non intende derogare ad alcune ferree convinzioni che lo hanno reso popolare a Ponte Guazzariello (dove nonostante i 600 abitanti ha raccolto 785.982 preferenze). La più controversa: non ammettere alle elezioni chi non si chiama De Luca. Il Pd lo vuole fermamente nel comitato dei costituzionalisti per il Sì, ma lui nicchia e chiede due assessorati per i suoi cani, Lampo e Scheggia.
Alieno De Luca – Proveniente da Sukran (una luna di Altair IV) ha lanciato il progetto di realizzare enormi cerchi nel grano nelle pianure di Mandrizzo per contattare altri De Luca sparsi nell’Universo. E’ considerato un “aperturista” con grandi visioni.
 Secondo una ricerca dell’Università di Uppsala, prendere a merluzzate in faccia per due anni gran parte del tuo elettorato, alla lunga non ti fa vincere le elezioni. La ricerca (563 pagine) è durata tre minuti, il tempo di una telefonata in Italia. Ma basta con le analisi politiche! C’è un’intera società in movimento che marcia verso la fatidica data del 19 giugno. Ascoltiamola!
Secondo una ricerca dell’Università di Uppsala, prendere a merluzzate in faccia per due anni gran parte del tuo elettorato, alla lunga non ti fa vincere le elezioni. La ricerca (563 pagine) è durata tre minuti, il tempo di una telefonata in Italia. Ma basta con le analisi politiche! C’è un’intera società in movimento che marcia verso la fatidica data del 19 giugno. Ascoltiamola!
Psichiatri – l’Associazione Nazionale Psichiatri ha nominato Matteo Renzi presidente onorario. Uno che riesce a dire nella stessa frase “Noi non siamo come gli altri, quando perdiamo lo diciamo” e “Non abbiamo perso” è la miglior pubblicità per la categoria. Il paziente soffre anche della sindrome di sottrazione dell’ego: succede quando uno dice “Ci metto la faccia” e i suoi candidati al ballottaggio rispondono “No, no, per carità!”.
Mondine – A Milano, lo staff di Beppe Sala si interroga su come conquistare il voto disperso a sinistra. In parole povere, come convincere quelli di sinistra che lui e Renzi sono di sinistra. Le slide sono in preparazione. Molte le iniziative in corso: una mostra su “Stalin, quel brav’uomo”, da tenersi in area Expo per simulare la Siberia, una parata di mondine con canti popolari e l’obbligo di indossare il colbacco per tutti i candidati.
Bunker – Grande impennata del mercato delle ristrutturazioni a Roma. Vista la mappa del voto, con gli elettori Pd concentrati ai Parioli, gli assediati hanno deciso di passare all’azione: rinforzate le porte blindate, praticate apposite feritoie alle finestre da cui lanciare brioches al popolo inferocito, corsa alle provviste per resistere all’assedio, che finirà in ogni caso con il ballottaggio. I resistenti del bunker dei Parioli sono pronti a tutto, anche a reagire violentemente con un fitto lancio di Rolex all’indirizzo delle forze dell’ordine.
Cern – Il Cern di Ginevra, dopo numerose simulazioni, ha definito “Non quantificabile” la distanza tra la propaganda renziana e la realtà. “Avevamo provato a misurarla in anni luce – dice il responsabile dello studio – ma era molto più vicina Andromeda, che tra l’altro è piena di bersaniani”.
Salvini – Esperti di pediatria e psicologia infantile sostengono che la deterrenza non funziona. Dire a un bambino “Mangia la minestra, se no arriva il lupo” non funziona come in passato. Allo stesso modo dire a un elettore milanese “Vota Sala, se no arriva Salvini”, che pare l’argomento migliore a disposizione, potrebbe non funzionare.
Pentagono – Un materiale fortemente distruttivo, che erode le superfici e i partiti a cui viene applicato. Al Pentagono stanno studiando una nuova molecola che non lascerà scampo agli eserciti nemici. Basterà introdurre il nuovo materiale all’interno di un organismo per far scappare molti degli abitanti, militanti, elettori e simpatizzanti, e rovinare definitivamente le strutture. Le ricerche sono ovviamente top secret, ma qualcosa trapela: la sostanza che distrugge gli organismi dall’interno si chiamerà Verdini.
Renzisti anonimi – Boom di iscrizioni per la meritoria associazione di riabilitazione e sostegno. Come si sa, la disintossicazione avviene per gradi, ognuno racconta al gruppo la propria storia e la propria esperienza con il renzismo, e promette di smettere. La motivazione è tutto, in questo campo, per cui ogni renzista anonimo conta i giorni del suo successo (spillette con la scritta: “Non credo più a Renzi da 321 giorni”). Il segreto della disintossicazione sta nella fiducia in se stessi, ma soprattutto nel non essere giudicati per le proprie debolezze: “Mi sono affidato a Renzi in un momento di debolezza, ma ora ho capito che era la soluzione più semplice e sbagliata”. Applausi del gruppo. L’anonimato è fondamentale per permettere una totale sincerità del pentimento, anche se ogni tanto qualcuno grida: “Ehi, ma quello è Rondolino!”
 Ha ragione Matteo Renzi: gli 80 euro non sono una mancia. Infatti nessuno si sognerebbe mai di rientrare al ristorante e dire al cameriere: “Ehi, tu, ridammi la mancia!”. Invece con gli ottanta euro puoi farlo: scusa ho scherzato, ora ho fatto bene i conti di quanto guadagni e ho scoperto che non ti spettavano.
Ha ragione Matteo Renzi: gli 80 euro non sono una mancia. Infatti nessuno si sognerebbe mai di rientrare al ristorante e dire al cameriere: “Ehi, tu, ridammi la mancia!”. Invece con gli ottanta euro puoi farlo: scusa ho scherzato, ora ho fatto bene i conti di quanto guadagni e ho scoperto che non ti spettavano.
L’assurdo diventa grottesco se si pensa a quelli che devono restituire gli ottanta euro (960 in totale) con la soave giustificazione che sono troppo poveri per averne diritto. Non sarà una mancia, per carità, ma la frase “sei troppo sfigato per darti la mancia” ha una sua tragicomica perfezione. Ora ci compriamo i pop corn, ci sediamo sul divano e assistiamo all’impareggiabile spettacolo del governo dei regali costretto a chiedere indietro un po’ di regali. Come faranno? Ecco alcune ipotesi allo studio.
Comitati per il “Ricaccia 80 euro” – Saranno composti da volontari che gireranno casa per casa con appositi moduli. Dovranno convincere chi guadagna meno di 8.000 euro all’anno a renderne quasi mille sull’unghia. E’ una soluzione, ma pone due problemi tecnici: nessuno si offre volontario. E se si offrisse qualcuno bisognerebbe capire come equipaggiarlo (si suggerisce un casco per le padellate in testa). Molto critica la sinistra Pd, che chiede di essere ascoltata.
Rimborso forzoso – Emissari del ministero del Tesoro si apposteranno in luoghi strategici delle città e dei paesi, addestrati e professionali. Al comparire di un contribuente, gli sottrarranno in qualche modo qualche centinaia di euro, con il vecchio metodo della truffa agli anziani, o semplicemente a mano armata. Può funzionare, si dice in ambienti vicino a Verdini, mentre la sinistra Pd appare critica e chiede di essere ascoltata.
Rimborso con scasso – Individuati i cittadini incapienti che hanno una macchina, anche una vecchia scassatissima utilitaria, il Ministero dell’ Economia provvederà a sequestrare nottetempo la ruota anteriore sinistra. Soluzione interessante, ma di difficile attuazione. Al ministero si chiedono: “Dove metteremo tutte quelle ruote?”. I verdiniani rispondono: “Tranquilli, abbiamo un amico a Caserta che… dopo ti spiego, non al telefono, però!”. La sinistra Pd avanza qualche distinguo e chiede di essere ascoltata.
Rastrellamenti – Metodo forse un po’ cinico, ma non è forse cinica la politica fiscale? Convocare tutti gli incapienti con la promessa di dargli altri 80 euro, e una volta catturata la loro attenzione parlargli chiaro: “So dove va a scuola tuo figlio… rendimi i soldi che ti ho dato”. Oppure: “In questo momento a casa tua un nostro uomo tiene sotto tiro la tua famiglia, sbrigati, hai portato i soldi?”. Interrogato in proposito il presidente emerito Napolitano dice che sarebbe perfettamente costituzionale, e che anche se non lo è, garantisce lui che i vecchi padri costituenti la pensavano un po’ così. I verdiniani offrono mano d’opera specializzata. La sinistra Pd annuncia la sua netta opposizione e chiede di essere ascoltata.
Soluzione politica. Il segretario del Pd si riunisce con il presidente del Consiglio e decide di convocare una direzione del partito con importanti novità in materia fiscale. Il suo intervento sarà incentrato sulla necessità di considerare la solidarietà sociale più importante e decisiva di alcune leggi, tipo quelle fatte in fretta e furia per vincere le elezioni europee. Ora è il momento di mettere in pratica questa solidarietà, per cui l’assemblea vota che a rendere gli 80 euro degli incapienti – quelli che erano troppo poveri per meritarseli – siano i rappresentanti della sinistra Pd. Voto unanime a favore. Pieno appoggio dei verdini ani. La sinistra Pd non ha partecipato al voto perché si è recata a prelevare presso il più vicino bancomat. Ma fa sapere con un duro comunicato che dopo il versamento vorrà essere ascoltata.
 La questione della luna e del dito è lì dietro l’angolo, ed è un piccolo classico che si può riesumare ogni volta. Dunque a Napoli (e non solo) c’è una Camorra imbizzarrita e senza pace, ragazzini col mitra in mano, speranza zero, vite precarissime, disoccupazione, e tutti i grani del rosario. E si sa. Eppure si discute se Gomorra 2, la serie in onda su Sky, non contenga qualche rischio di emulazione e se i suddetti ragazzini con i suddetti mitra non comincino a pettinarsi come Genny, a parlare come Ciro e via così. Il dito, la luna. Banale.
La questione della luna e del dito è lì dietro l’angolo, ed è un piccolo classico che si può riesumare ogni volta. Dunque a Napoli (e non solo) c’è una Camorra imbizzarrita e senza pace, ragazzini col mitra in mano, speranza zero, vite precarissime, disoccupazione, e tutti i grani del rosario. E si sa. Eppure si discute se Gomorra 2, la serie in onda su Sky, non contenga qualche rischio di emulazione e se i suddetti ragazzini con i suddetti mitra non comincino a pettinarsi come Genny, a parlare come Ciro e via così. Il dito, la luna. Banale.
Meglio il vecchio Benigni che faceva Cioni Mario, quello delle origini, che se la prendeva con quei paesini toscani dove “Quando uno va al cinema a vede’ Hitler, dice: che fascista quell’attore!”. E prendersela con il male, insomma è un po’ più difficile che prendersela con chi lo racconta, lo descrive, ne sviscera i meccanismi, ne mostra la potenza. Ora, si sa che Roberto Saviano – che di Gomorra è il padre, il figlio ha ormai dieci anni, il film e la serie ne moltiplicano l’effetto – si difende benissimo da solo. Ha ragione a dire che le critiche sono strumentali e che contengono una dose letale di ipocrisia. E si sa anche che i ragazzini armati di Napoli continueranno a sparare. Si potrebbe arrivare addirittura a Picasso, con gli ufficiali nazisti davanti a Guernica che dicono: “Questo l’ha fatto lei?”. “No, questo l’avete fatto voi”. A posto.
Ma non è tutto qui, naturalmente. Si discute se Saviano, Gomorra 1 e 2 e tutti gli allegati non forniscano a quei ragazzini un’epica, un’estetica e un pathos. Insomma, se non sarebbe meglio fare qualcosa di più digeribile e edificante. Propongo al volo: Don Matteo parroco a Scampia, qualche poliziotto fascinoso che fa vincere i buoni, Padre Pio che trasforma le Vele in un Club Med, eccetera eccetera. La narrazione ufficiale si dia da fare. Per ora Gomorra trionfa, la seconda serie doppia di ascolti della prima. Per ora, la critica passa dalla questione etico-morale (urca! Ci sono i cattivi! E guarda come sono cattivi!) alla ferita all’orgoglio nazionale. Il presidente del Consiglio attuale va a Napoli a dire che “La città non è solo il set di Gomorra” (sic), e vabbé. Precedenti presidenti del consiglio (Silvio buonanima) dissero invece di voler strangolare Saviano perché in qualche modo infangava l’immagine dell’italia (che tanto stava difendendo lui coi gonnellini di banane, peraltro). Profonde sintonie.
Ma sia. Lasciamo la polemica contingente e cerchiamo di tracciare una linea. Dunque – e qui è l’autore di noir che parla – si dovrebbe raccontare il male con una certa qual moderazione. Intanto che non vinca. Poi che venga mostrato in tutta la sua neutralità: male e basta. Non male con delle radici, non male con delle spiegazioni economico-politico-culturali, o complicità del potere, o addirittura al servizio di certi poteri, ma solo male. E poi, preferibilmente, che venga un tizio un po’ hard-boiled che mette le cose a posto. Come scrive Edoardo Albinati nel suo La scuola cattolica, assistiamo all’ “ininterrotta creazione di commissari o detective (…) che tra un pranzo e l’altro risolvono l’enigna”. E sconfiggono il male.
E c’è però il solito problema delle linee e dei confini: dove si fissano, e chi li decide? E non si rischia come nel ventennio quando l’ansia di mostrare una società senza crimine spinse la censura a proibire, o almeno sconsigliare fortemente la letteratura noir? Si può chiedere lumi, nel caso, alla spietata biografia di Augusto De Angelis, che fu buon giallista negli anni Trenta, scrisse decine di romanzi col morto, venne incarcerato e poi ammazzato di botte da un fascista per futili motivi. Ecco, così impara a dire che scorre il sangue anche quando i treni arrivano in orario.
Linee teoriche e direttive culturali: un po’ come arrestare Dostoevskij invece di Rascol’nikov, incarcerare Marlon Brando per mafia, o sostenere che Robert De Niro rovina l’immagine degli Stati Uniti. Per tacere di Don Winslow che, per come ha raccontato l’epopea sanguinaria dei narcos messicani, dovrebbe stare perlomeno in un carcere del Sinaloa. Bel dibattito, sì.
Ma poi, siccome siamo qui, in Italia, non si può sfuggire a un sapore acido di strumentalizzazione. Così, il racconto del male che è stato considerato per anni sacrosanta denuncia, oggi lo si considera fascinazione (se va bene) e addirittura istigazione o apologia (se va male: vi avverto che qui va male spesso). Insomma, Gomorra non è solo narrazione del male, dei suoi meccanismi di dominio, delle sue regole, del suo strapotere, ma è anche la contro-narrazione al refrain in voga che va tutto bene, anzi benissimo. Incapaci di intervenire sulla realtà, a volte addirittura implicati in quella realtà, si rimprovera chi la racconta. Un po’ come andare da Victor Hugo e dirgli: “Ma insomma, ma guarda quanti Miserabili hai creato!”.
Nel frattempo – anche fuori onda e fuori dai palinsensi – i baby-boss di Camorra pippano, picchiano e puliscono il mitra. Uff, basta non raccontarli, no?
Qui c’è la recensione di CriticalLetteraria.org. Cliccare per leggere (il link è qui)
 Mancano almeno cinque mesi al referendum, e non si parla d’altro. Lo scontro sarà duro e come tale va affrontato. Il paese è diviso, è vero, ma è anche un’occasione per fare un sacco di soldi. Ecco le nuove professioni che vi faranno ricchi grazie allo scontro sulle riforme costituzionali.
Mancano almeno cinque mesi al referendum, e non si parla d’altro. Lo scontro sarà duro e come tale va affrontato. Il paese è diviso, è vero, ma è anche un’occasione per fare un sacco di soldi. Ecco le nuove professioni che vi faranno ricchi grazie allo scontro sulle riforme costituzionali.
Cercatori di citazioni. Con il vostro lavoro di spulciatori di Wikipedia potrete ingraziarvi la leadership e sperare quindi in lucrose contropartite. Notevole il caso di Piero C., farmacista di Pisa. In un raro nastro del primo dopoguerra ha captato le seguenti parole:
– Nilde: “Vuoi un caffè Palmiro?”
– Palmiro: “Sì, mi serve proprio”.
Due giorni dopo il paese è pieno di manifesti: “Anche Togliatti dice Sì”.
Due giorni dopo Piero C. è numero due dell’Eni.
Grafici pasticcionisti. Come ha tenuto a dire la signora Alessia Rotta, che nel Pd è responsabile di qualcosa (per quanto incredibile, credo della comunicazione), i manifesti con Ingrao e Berlinguer che votano Sì (vergognosa manipolazione della storia e delle memoria), “usano un logo diverso da quello ufficiale”. Cioè, basta cambiare l’inclinazione di una lettera, o un punto di colore nel verde o nel rosso e… oplà, il Pd potrà dire “non è roba nostra”. Astuto. E ora sotto con trasferelli e spirito d’impresa. La P un po’ tendente al giallino, la D rovesciata. Quando compariranno i manifesti con Kurt Cobain, Stendhal e Maria Curie che votano sì, voi sarete ricchi.
Assicuratori post catastrofe. Abusare della credulità popolare non è bello, e peggio ancora imbrogliare gli anziani. Se volete fare un’eccezione a queste due piccole regole morali, potreste girare per i palazzoni residenziali, bussare alle porte e truffare le vecchiette. Non ci sarà bisogno di spaventarle, perché lo ha già fatto abbondantemente la propaganda in corso. Se vince il No sparirà tutto, sarà il caos, dovremo scheggiare le selci per difenderci dalle fiere, ci saranno incendi e pestilenze e pioverà tutti i week end. La vecchietta lo sa già: gliel’ha detto Napolitano. Fatele firmare la polizza e prendete la prima rata (in contanti, mi raccomando).
Cacciatore di taglie. Come nelle fiere del Far West, tre scalpi un dollaro. Se portate al Nazareno un docente universitario che vota Sì vi fanno lo sconto alla Coop. Se portate cinque costituzionalisti (è valido anche stordirli con sostanze psicotrope) vi fanno sottosegretario. Per agevolare la raccolta, il governo sta pensando di consegnare lauree di diritto costituzionale già alle elementari, all’esame di quinta.
– Lo vuoi il gelato, quando hai finito qui?
– Sì.
Promosso costituzionalista, avanti un altro.
Correttore di gaffe. Lavoro usurante ma ben retribuito. Si tratta di vigilare sulle uscite della ministra Boschi e precipitarsi a scrivere, twittare, postare su Facebook, telefonate agli amici o dire in televisione che non erano gaffe. Non è un lavoro facile, perché dovreste essere sempre disponibili, conoscere i palinsesti televisivi ed assistere a ore di fregnacce approssimative. E saper cogliere l’attimo. Il consiglio è di installarsi una sirena sopra il letto: una volta svegliati di soprassalto, dovrete solo accendere il computer e scrivere: “No! Non ha fatto una gaffe! Quello era suo padre!”.
Trova ospiti. Fondamentale figura professionale che deve garantire la presenza in televisione e ai talk show di tutti gli schieramenti. Molto apprezzato chi trova sostenitori del No sordomuti: si rispetta la par condicio senza turbare troppo gli spettatori. Molto richiesto anche il ricercatore di figli e nipoti di partigiani disposti a dire “Mio padre partigiano avrebbe votato sì”. Lo ha fatto Oscar Farinetti, su, perché voi no?
 Metto qui di seguito qualche data per le presentazioni di Di Rabbia e di vento nel mese di giugno. Calendario intenso, diciamo…
Metto qui di seguito qualche data per le presentazioni di Di Rabbia e di vento nel mese di giugno. Calendario intenso, diciamo…
4 giugno, ROMA. Nell’ambito del festival RepIdee de la Repubblica, serata in giallo con Antonio Manzini e Maurizio De Giovanni. Alle 20 al Maxxi di Roma. Il programma del festival è qui
19 giugno, VIMERCATE. Festival di Vimercate (alle 18, sulla terrazza della libreria il Gabbiano, a Vimercate). Il programma del festival è qui
20 giugno, LECCO. Al Circolo La Ferriera, alle 21 (questi qui sono amici miei, ci tengo)
22 giugno, MILANO. Ore 19, cortile della Biblioteca Sormani di Milano
23 giugno, VOGHERA. Ore 21, libreria Ticinum
23 giugno VERBANIA. Ore 17.30 – Festival Letteraltura, Verbania
 Il format è quello vecchio, la nuova collocazione in palinsesto (la sera invece del pomeriggio) servirebbe a migliorare i miseri ascolti. Il conduttore sembra in trance agonistica ma un po’ in affanno. #MatteoRisponde, insomma, lo possiamo iscrivere d’ufficio nella categoria “talk show in crisi di idee”. E’ la fase più pericolosa: quando si vede il pubblico sciamare deluso verso l’uscita e allora le si spara grosse. La donna barbuta! La legge che vieta i terremoti! Un decreto per bloccare la pioggia nei week-end! Il bollo auto (se lo sparò Silvio buonanima come ultima cartuccia nel confronto televisivo con Prodi, anno di grazia 2008). O il funerale di Equitalia, che, dice Matteo, circonfuso nello streaming e griffato Apple, “al 2018 non ci arriva mica”.
Il format è quello vecchio, la nuova collocazione in palinsesto (la sera invece del pomeriggio) servirebbe a migliorare i miseri ascolti. Il conduttore sembra in trance agonistica ma un po’ in affanno. #MatteoRisponde, insomma, lo possiamo iscrivere d’ufficio nella categoria “talk show in crisi di idee”. E’ la fase più pericolosa: quando si vede il pubblico sciamare deluso verso l’uscita e allora le si spara grosse. La donna barbuta! La legge che vieta i terremoti! Un decreto per bloccare la pioggia nei week-end! Il bollo auto (se lo sparò Silvio buonanima come ultima cartuccia nel confronto televisivo con Prodi, anno di grazia 2008). O il funerale di Equitalia, che, dice Matteo, circonfuso nello streaming e griffato Apple, “al 2018 non ci arriva mica”.
Più che un programma, una sentenza.
Giubilo nelle strade e nelle piazze del Paese e dietrologia talmente facile da essere banale “davantologia”: se nel 2018 si vota, abolire Equitalia è un nuovo modo per dire “ottanta euro” e pure di più. Se accompagnate la promessa con quell’altra, parallela e speculare, di “abbassare le tasse al ceto medio” siamo vicini all’en plein. Manca quella cosa delle settanta vergini, che suona ancora un po’ troppo islamica, ma ci arriveremo.
Anche se la bomba Equitalia arriva insieme a decine di altre bombette, mischiata ad altre roboanti promesse, fa sempre il suo effetto, perché è difficile oggi trovare un italiano che simpatizzi per Equitalia. Il riscossore sta sulle palle a tutti, ovvio, e chi chiede soldi non è mai simpatico: basta vedere quel logo sulla lettera che vi arriva a casa per agevolare la crisi di itterizia. Poi ci pensa la solita commedia all’italiana, tipo i leghisti che minacciano rivolte e assalti alle sedi come fecero i loro amici col blindato fatto in casa al campanile di San Marco (ancora ridiamo). E ci sarebbero, un po’ più seriamente, i Cinque Stelle, che Equitalia la vogliono abolire da sempre e che a tal proposito presentarono una proposta di legge. La respinse il Pd alla Camera nel luglio del 2014, con grandi accuse di populismo e irresponsabilità. Brutti, zozzi e cattivi che attentavano a un’istituzione così preziosa per il paese. Passati nemmeno due anni, ecco Matteo dei miracoli decretarne la morte imminente, col linguaggio che si riserva di solito agli allenatori di calcio scarsi: Equitalia, al massimo tra due anni, non mangerà il panettone. Come Silvio, abbiamo il Renzi operaio, il Renzi imprenditore, il Renzi costituzionalista, il Renzi insegnante e, da ieri, pure il renzi grillino. Sono soddisfazioni.
Di suo, Berlusconi si limitava alle battute scherzose, e quando andò a inaugurare l’anno accademico dei futuri finanzieri disse: “Meglio io da voi che voi da me”. Almeno faceva ridere.
Matteo no. Matteo guarda in camera come un attore della réclame e la butta lì: Equitalia must die. Dietro, accanto, ci sarebbe tutto un ragionamento sul riordino delle agenzie, quella delle entrate che si riprende i suoi compiti, razionalizzazioni, riforme, ridisegni complessivi e complicati, numeri, calcoli. Ma che noia! Vuoi mettere col dare l’annuncio? Come dire, parliamoci chiaro: se volete meno tasse, un regalo al ragazzo che compie diciott’anni, l’eliminazione di Equitalia e altre cosucce (esilarante la riforma dell’Università “entro il 2016”, ma “non calata dall’alto”), dovete tenervi stretto questo conduttore di talk show. Diceva Enzo Biagi di Silvio: “Se avesse le tette farebbe anche l’annunciatrice”. Ecco. Matteo non ha le tette nemmeno lui. Però fa solo l’annunciatrice.
Qui c’è l’intervista di Gloria Ghioni per Il Libraio (cliccare per leggere, il link è qui)
 Le amministrative sono qui, il referendum-fine-di-mondo è là, sullo sfondo, e ci aspetta. In mezzo ci sarà un lunghissimo estenuante match di propaganda, colpi bassi, gomitate, ginocchiate nelle palle, falsità e o-vince-il-sì-o-moriremo-tutti. Va bene, questo si sa.
Le amministrative sono qui, il referendum-fine-di-mondo è là, sullo sfondo, e ci aspetta. In mezzo ci sarà un lunghissimo estenuante match di propaganda, colpi bassi, gomitate, ginocchiate nelle palle, falsità e o-vince-il-sì-o-moriremo-tutti. Va bene, questo si sa.
Ma intanto è bene controllare se chi propone la famosa riforma costituzionale ha ben presente il polso del paese, se, insomma, ha allacciato con l’Italia un’intesa ideale. Qualche tempo fa i guru della comunicazione di Matteo Renzi spingevano assai su questo tasto: creare una “connessione sentimentale” con i cittadini. E’ una bellissima sintesi, questa della “connessione sentimentale”, e infatti mica è loro, ovvio, è di Antonio Gramsci che ne parlava a proposito del rapporto tra intellettuali e popolo-nazione. Rubata in fretta e furia a Gramsci quella bandierina, si prese ad agitarla freneticamente e oggi forse – quasi due anni e mezzo dopo l’incoronazione del premier – si può verificare se quella “connessione sentimentale” c’è stata o no, se qualcosa è cambiato, se quel senso di nuovo dinamico e berluccicante che twittava “arrivo, arrivo” dalle stanze del Quirinale si è “connesso” con il paese.
Parrebbe di no.
Lentamente, inesorabilmente, il nuovo è un po’ invecchiato. La fiducia nei politici e nella politica in generale non sta messa meglio di prima, anzi. La sensazione che si siano intaccati certi privilegi non esiste, il concetto di rinnovamento della classe dirigente (rozzamente definito “rottamazione”) si infrange sulla ghigna verdiniana. Sul jobs act si sono date cifre false ed esagerate e qualcuno comincia a pensare che con 19 miliardi si sarebbe potuta aumentare l’occupazione in modi più efficaci. In compenso i vecchi lavoratori precari (precariato più volte dichiarato abolito dal premier) macinano voucher come antichi cottimisti delle filande.
Si potrebbe continuare, passare per la buona scuola, o per lo straordinario volano economico che l’Expo avrebbe messo in moto, che però non si vede, o per la famosa questione morale. O si potrebbe dire dell’incauto innamoramento governativo per la classe imprenditoriale, tutta quella retorica su il “fare impresa” e il “made in Italy”. Bello, rubare frasette a Gramsci e programmi a Confindustria, fa molto Partito della Nazione. Ma poi si scopre (notizia un po’ silenziata) che 60.000 aziende hanno truffato l’Inps per avere incentivi dal Jobs act, che i soliti noti hanno i soldi chissà dove (ma non qui), per tacere della ministra Guidi. Ecco, anche questa narrazione si è un po’ arenata contro quello scoglio insormontabile che è il principio di realtà.
Ora, se ti dicono che non sei più precario e ti ritrovi precario come o peggio di prima, fai un po’ fatica ad avere ‘sta famosa “connessione sentimentale”.
Ma non è finita. Il lavoro di costruzione della nostra Costituzione (1947) è stato un delicato, perfetto, precisissimo lavoro di cesello. Anche se nel Paese i Don Camillo e i Peppone si prendevano ancora sonoramente a legnate, una connessione sentimentale tra il paese e la sua legge principale – e con l’assemblea che faticosamente la scriveva – c’era eccome. Per la Costituzione che si propone ora no. La sua scrittura pare sciatta e frettolosa, gli argomenti con cui la si sostiene sono impostati come un testa o croce sul premier attuale. In poche parole: il paese è diviso, queste riforme sono divisive e quelli che cianciavano di “connessione sentimentale”, comunque vada, avranno di fronte un paese diviso e incattivito dallo scontro. Chi teorizzava, avvolto inn una bella frase gramsciana, un’armonica unità d’intenti del paese e un abbraccio di amorosi sensi tra cittadini e “nuovo corso”, ha finito per dividere e lacerare. Insomma, un’altra narrazione farlocca per il Partito della (mezza) Nazione.
 Certi di fare cosa grata ai cittadini, elenchiamo i principali appuntamenti dei comitati per il Sì al referendum di ottobre. Un primo calendario di eventi è stato rinvenuto nei caveau di Banca Etruria, l’unica porcheria che non sono riusciti a vendere. Il programma potrà subire piccole variazioni.
Certi di fare cosa grata ai cittadini, elenchiamo i principali appuntamenti dei comitati per il Sì al referendum di ottobre. Un primo calendario di eventi è stato rinvenuto nei caveau di Banca Etruria, l’unica porcheria che non sono riusciti a vendere. Il programma potrà subire piccole variazioni.
7 giugno. Apertura della campagna referendaria col botto. Due “Bonzi per il Sì” si danno fuoco davanti al Nazareno. Si cercano altri bonzi (pagamento in buoni benzina).
29 giugno. Convegno: “Le ragioni del Sì e perché quelli del No hanno la gobba e sono tutti pedofili”. Intervengono due costituzionalisti di una quinta elementare di Arezzo. Modera Maria Elena Boschi vestita da crocerossina.
3 luglio. Nonostante gli sgravi contributivi, non si trovano altri bonzi per il Sì. L’Ira di Renzi.
9 luglio. L’Unità pubblica in prima pagina un documento dell’Isis vergato dal califfo al Baghdadi. Il comunicato si chiude con: “per Allah e per la jihad, vota No”. Polemiche sul documento originale, che Rondolino ha macchiato di caffè mentre lo scriveva. Corsivo a firma di Maria Elena Boschi vestita da peshmerga: “Chi vota no è come l’Isis”
2 agosto. Cerimonia per le vittime della strage della stazione di Bologna. Duro editoriale in prima pagina su l’Unità: “Saranno stati quelli del no? Chiarezza subito”
9 agosto. Clamoroso a Padova: piange una statua della Madonna. Un’impiegata di Abano Terme ha assistito al miracolo e affermato che la statua ha detto: “Votate sì” e chiesto un caffè. Grazie allo Sblocca Italia nascerà il Santuario della Madonna del Sì, che verrà inaugurato da Maria Elena Boschi vestita da Giovanna d’Arco.
15 agosto. Il comitato “Bagnini per il Sì” annuncia che d’ora in poi non salverà più bagnanti intenzionati a votare no. Polemiche, perché si tratta di un provvedimento di difficile attuazione. Negli stabilimenti balneari compare la scritta: “Prima di immergersi, comunicare al bagnino le intenzioni di voto”.
27 agosto. Grande “Biciclettata per il Sì” con arrivo festante a Rignano sull’Arno. La manifestazione era inizialmente prevista per il 22 agosto, ma a palazzo Chigi non trovavano un elicottero che potesse trasportare una bicicletta.
2 settembre. Titolo a nove colonne su l’Unità “E’ provato: Al Capone, Dillinger, Bokassa e il boia di Treblinka voterebbero No”. Gaffe di Luca Lotti: “Ma Bokassa non era dei nostri? Mi pare di averlo messo in qualche commissione”. Poi smentisce, è stato frainteso.
14 settembre. Alla fiera dell’editoria per bambini grande successo per la riedizione illustrata di Cappucetto Rosso. Il lupo, un anziano costituzionalista, viene scuoiato con una lametta per le unghie dalla nonna, straordinariamente giovane e bionda, e gettato in un fosso. Un mese dopo, grazie a una variante del piano regolatore, la casetta nel bosco diventa un centro commerciale di sei milioni di metri quadrati.
26 settembre. Scoop de l’Unità. Titolo: “La saggezza degli antichi popoli ci guida verso il futuro con Matteo Renzi”. Grande foto di un’iscrizione “Vota sì” ritrovata in una tomba etrusca insieme a armi da taglio e vecchie monete. Gli archeologi si dividono, Le vecchie monete le tiene Verdini.
2 Ottobre. Il ministro Maria Elena Boschi vestita da cane lupo visita l’Istituto dei ciechi e grazie alle sue carezze tre giovani ospiti riacquistano la vista e dichiarano che voteranno Sì. Il governo annuncia un bonus di 5.000 euro per i ciechi che ritrovano la vista e vanno a votare Sì. Polemiche.
13 ottobre. Durissimo intervento di Giorgio Napolitano che accusa i costituzionalisti schierati per i No di essere anziani.
14 ottobre. In omaggio ai lettori dell’Unità un file audio originale di Gramsci che dice di votare Sì. A chi nota che negli anni Trenta non esistevano i file .mp3, il direttore spiega che si tratta di Storiografia 2.0.
Due o tre cosette a voi che passate ogni tanto di qua. Il libretto con quel fesso del Monterossi, la signorina Anna, povera, il Ghezzi e tutta la compagnia, pare stia facendo la sua porca figura (a proposito, grazie a chi ha detto, o ha scritto, o anche solo letto).
Di Di rabbia e di vento parleremo al Salone del libro, sabato 14 alle 20 (sala Azzurra). con Antonio Mazini, lui col suo Rocco Scvhiavone, io con mio Carlo Monterossi. In mezzo (onoratissimo!) c’è Lella Costa.
Per chi fosse interesssato, altra presentazione nel pomeriggio, alle 16.30 al Campus San Paolo. A breve avrò delle date che vi comunicherò in qualche modo.
Intanto, La Lettura del Corriere della Sera mi ha chiesto un raccontino (ino-ino), tipo immaginarsi il Monterossi al Salone del libro. Io ho detto sì e quello, il Monterossi, si è rimesso nei guai… Il raccontiono è qui sotto. Cliccare per leggere.
 Si sa che in rete c’è tutto, per divertirsi, dai giochetti elettronici ai video divertenti, dai gattini al porno. Quindi, che da qualche giorno ci sia anche il magico mondo di Matteo Salvini non dovrebbe impressionare, almeno finché non ci andate (e voi andateci! ilpopulista.it). Poi, effettuata la visita guidata, sezione per sezione, titolo per titolo sarete molto stupiti del fatto che c’è gente che va al circo, pagando il biglietto, invece di passare un’oretta lì dentro, gratis.
Si sa che in rete c’è tutto, per divertirsi, dai giochetti elettronici ai video divertenti, dai gattini al porno. Quindi, che da qualche giorno ci sia anche il magico mondo di Matteo Salvini non dovrebbe impressionare, almeno finché non ci andate (e voi andateci! ilpopulista.it). Poi, effettuata la visita guidata, sezione per sezione, titolo per titolo sarete molto stupiti del fatto che c’è gente che va al circo, pagando il biglietto, invece di passare un’oretta lì dentro, gratis.
Si sa che Salvini gioca volentieri coi social, dai quali abbaia la sua visione del mondo in modo a volte esilarante. Ma qui … ok, allacciate le cinture, si parte.
Dopo il titolo – il Populista – che forse vorrebbe suonare provocatorio (uff, dopo Renzi e Grillo, un altro populista? cheppalle!), si nota uno spirito rebelde che il sottotitolo dichiara subito: “audace, istintivo, fuori controllo”. Ecco, fuori controllo un po’ sì, perché le sezioni del sito visibili al volo sulla home si chiamano “l’incazzato” (salvinismo standard sul modello immigrato-stupra-suora); “il buonista” (salvinismo standard ma alla rovescia sul modello il-vescovo-aiuta-l’invasione); “il samurai” (sezione un po’ confusa, con l’editoriale del primo che passa per strada e bercia qualcosa, ma anche i successi commerciali dell’occhialeria lombarda), e altro. E siamo solo all’inizio, perché, addentrandovi nell’esplorazione (consiglio di indossare una tuta anti-cazzate, lo dico per voi) troverete le sezioni “gggiovani!” (sic), e persino un menu “sex and trash”, un po’ deludente (niente di hot), ma con buone intuizioni, tipo: “Penetrazione letale, quando il sesso ti toglie il respiro”. E vabbé.
Ma coraggio, amici, siamo solo all’inizio. Confezionato con un elegante fraseggio da spogliatoio maschile (mancano le osterie, ma si può rimediare), il magico mondo di Matteo è un enorme rotocalco popolare. Se Renzi gioca con gli hashtag (populismo di disintermediazione di target alto), qui si sta dalle parti della rivista da parrucchiere. Una narrazione che si può riassumere così: “Dove andremo a finire, signora mia”, e giù l’immigrato che ruba da mangiare, il papa che è troppo di sinistra, lo straniero che si fa le pippe davanti ai bambini e persino il revisionismo storico-penale, del tipo “E se Olindo e Rosa fossero innocenti?”. Eh? Ci avevate mai pensato?
Insomma, un mix abbastanza prevedibile tra la filosofia della fila alle poste di Varese, la xenofobia per condire la bresaola e la ricetta dei biscotti “cioccolatosi” (sezione “bello e buono”). Ottime le pagine della “cultura” (giuro) con i lombardi famosi, tipo quello che vive da solo da ventun anni in una casa su un prato. Braveheart gli fa una pippa (mi adeguo).
Ma, direte, voi: e la politica? Dipende.
La politica sta ovunque, in ogni riga, nella spassosissima, a tratti commovente, pratica di dividere tutto tra noi (che non ne possiamo più, paghiamo le tasse, vogliamo il putinismo in terra, viva Trump) e gli altri (neri, rom, vescovi, zecche di sinistra, centri sociali, Pd, Grillo, Silvio buonanima, prostitute che sfuggono al fisco eccetera, eccetera). Ma poi c’è anche una vera sezione “politica”, dove il magico mondo di Salvini è fatto di Le Pen, Meloni, proclami, annunci, intemerate e gogna per i nemici. La solita solfa.
Meglio la sezione “opinioni”, dove per ora campeggiano l’esperta di animali, l’ufologo che collabora anche con Notiziario Ufo (me’ cojons, ndr), e una tizia che parla di “forme e riforme”, mischiando la Costituzione agli arditi tubini della Boschi, con una capacità di elaborazione politica che il mio gatto supera di parecchie spanne.
In sostanza, se questo sito popolare e populista è lo specchio del salvinismo, non andiamo niente bene. Non c’è il garrulo burbanzoso filo-nazismo che si trova nei commenti ai suoi post su Facebook, non c’è il sangue, non c’è la forca, non c’è niente di veramente (cito) “audace, istintivo, fuori controllo”. No, nessuna sorpresa. Uff, è solo Salvini. E quindi, in soldoni, niente di che.
 Una strana ossessione si aggira nei quartieri generali del renzismo. E’ l’ossessione del passato. Uno sarebbe portato a pensare che un grande (sedicente) innovatore e rottamatore, ascendente Verdini con la luna in Leopolda, guardi al futuro (sedicente) luminoso che sta costruendo. Invece, opplà, si casca sempre con un piede indietro. Con l’affermazione che “dopo 63 governi” l’Italia finalmente viene considerata in Europa, Matteo Renzi compie un’operazione abbastanza semplice. Non essendo sufficientemente luminoso il futuro che sta per venderci, non così gradito a tutti, non così chiaro, deve dimostrare per prima cosa che sarà sempre meglio del passato. E ora che è arrivato lui, quei 63 governi impallidiscono e svaporano nell’inconsistenza. E’ una variante di “dopo di me il diluvio” che suona così: “Prima di me il deserto”. Qualcosa di simile a: ehi, amici, vi ricordate che fatica quando non esisteva la ruota? Beh, meno male che ora l’ha inventata Matteo.
Una strana ossessione si aggira nei quartieri generali del renzismo. E’ l’ossessione del passato. Uno sarebbe portato a pensare che un grande (sedicente) innovatore e rottamatore, ascendente Verdini con la luna in Leopolda, guardi al futuro (sedicente) luminoso che sta costruendo. Invece, opplà, si casca sempre con un piede indietro. Con l’affermazione che “dopo 63 governi” l’Italia finalmente viene considerata in Europa, Matteo Renzi compie un’operazione abbastanza semplice. Non essendo sufficientemente luminoso il futuro che sta per venderci, non così gradito a tutti, non così chiaro, deve dimostrare per prima cosa che sarà sempre meglio del passato. E ora che è arrivato lui, quei 63 governi impallidiscono e svaporano nell’inconsistenza. E’ una variante di “dopo di me il diluvio” che suona così: “Prima di me il deserto”. Qualcosa di simile a: ehi, amici, vi ricordate che fatica quando non esisteva la ruota? Beh, meno male che ora l’ha inventata Matteo.
In un’altra occasione, ancora più illuminante (era il settembre del 2015) disse che il Paese aspetta la sua riforma, sua e della fatina delle riforme Boschi, da settant’anni. Cioè: Togliatti e De Gasperi, per dire, ancora stavano studiando la Costituzione (quella vera, nata dalla Resistenza), che già aspettavano con ansia le modifiche di Matteo. Una specie di macchina del tempo, insomma, usata sempre nello stesso modo: il passato fa tutto schifo, prima di me non c’è stato niente e l’intero dopoguerra italiano è stato solo un confuso periodaccio d’attesa dell’uomo del destino.
Che sia un po’ un’ossessione, questa del passato, sta cominciando a diventare evidente. Uno potrebbe anche tirare in ballo lo slogan del Partito (della Nazione?) che si inventò George Orwell in 1984: “Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato”, che non era niente male. Ma forse sarebbe troppo, scomodare Orwell, e allora accontentiamoci di letterature più recenti, come per esempio lo slogan coniato per il lancio de l’Unità (estate 2015): “Il passato sta cambiando”. Ecco, mai slogan aveva somigliato tanto a un’aspirazione: cambiare il passato significa anche sbeffeggiare come irrilevanti 63 governi precedenti, o immaginare che le tue riforme le aspettavamo come la manna anche prima che ci fosse qualcosa da riformare. In attesa di essere il futuro, come spera lui, e seduti su un presente che traballa un po’, Renzi e i suoi autori decidono che intanto è meglio sputare su tutto quello che c’era prima, e molti smemorati (per insipienza o convenienza) potrebbero cascarci.
Dopodiché si potrà notare che alcune delle riforme più importanti per la vita del Paese si fecero proprio in passato, alcune quando Renzi ancora non era nato. Lo Statuto dei lavoratori (1970), o il Servizio Sanitario Nazionale (1974) , per dirne solo due, si fecero addirittura con il bicameralismo perfetto, oggi indicato come causa di lentezza, e addirittura con leggi elettorali proporzionali (altro che il chi-vince-piglia-tutto dell’Italicum).
E, sempre per restare ai due esempi appena citati, è un po’ vero, sì, “il passato sta cambiando”, come diceva lo slogan de l’Unità, ma in peggio, perché le picconate allo Statuto dei lavoratori sono lì da vedere (Jobs Act), e quanto al Servizio Sanitario Nazionale, beh, lo sanno tutti quelli che ora pagano analisi che pochi mesi fa erano gratuite. Voilà. In più, l’ossessione del passato che guiderà la campagna referendaria (basta! Via! Tutto nuovo!) contiene una sua contraddizione interna: si grida che serve una nuova Costituzione per fare le riforme, che questa che c’è ci rende immobili, ma nel contempo si celebrano come epocali e strabilianti le riforme in corso. Un po’ come dire: guarda! Ho una gamba sola!, e intanto vantarsi di vincere i cento metri.
 Alla ventiduesima fotografia del presidente del consiglio accanto ai bronzi di Riace diffusa dal ministero della propaganda, uno poteva pensare: “Ma guarda, sto Renzi, pure scultore! E anche bravo!”. Invece era l’ultimo taglio di nastro, inaugurazione finale di una cosa in parte già inaugurata (il ministro Bray nel dicembre 2013). Bello davvero, il museo archeologico di Reggio Calabria, a cui si lavora dai tempi di Prodi (e forse per quello contiene anche reperti del paleolitico). Il meglio, però, nella sala principale: le tre facce di bronzo più famose d’Italia, due sul loro piedistallo antisismico, l’altra impegnata nella campagna promozionale del suo governo. Firma del patto per la Calabria con il sindaco di Reggio, Falcomatà, la promessa di strade e treni veloci, il ministro Delrio al seguito, il ministro Franceschini che dice uh che bello, e come dargli torto. E chissà che piacere Renzi nel vedere le vestigia di tutte quelle civiltà rottamate dalla storia, chissà se ha chiesto “Dov’è la teca di Bersani?”.
Alla ventiduesima fotografia del presidente del consiglio accanto ai bronzi di Riace diffusa dal ministero della propaganda, uno poteva pensare: “Ma guarda, sto Renzi, pure scultore! E anche bravo!”. Invece era l’ultimo taglio di nastro, inaugurazione finale di una cosa in parte già inaugurata (il ministro Bray nel dicembre 2013). Bello davvero, il museo archeologico di Reggio Calabria, a cui si lavora dai tempi di Prodi (e forse per quello contiene anche reperti del paleolitico). Il meglio, però, nella sala principale: le tre facce di bronzo più famose d’Italia, due sul loro piedistallo antisismico, l’altra impegnata nella campagna promozionale del suo governo. Firma del patto per la Calabria con il sindaco di Reggio, Falcomatà, la promessa di strade e treni veloci, il ministro Delrio al seguito, il ministro Franceschini che dice uh che bello, e come dargli torto. E chissà che piacere Renzi nel vedere le vestigia di tutte quelle civiltà rottamate dalla storia, chissà se ha chiesto “Dov’è la teca di Bersani?”.
Ma passiamo alla propaganda vera. La parola che più risuona è il Sì. Bisogna dire Sì, la solita solfa. C’è un’Italia che dice Sì e ancora, maledizione, un’Italia che dice No. Dal discorso non si capisce bene a cosa sì e a cosa no: ai Bronzi? Ai meteoriti? Al Crotone in serie A? Al referendum di ottobre? Insomma siamo la patria dove il Sì risuona e prepariamoci, perché ci attendono mesi di consimili spettacolini per dire che il Sì è bello e il No brutto, vecchio e cattivo. Esercizio già fatto pubblicando sull’Unità astrusi calcoli per dire che i tanti – quasi tutti – costituzionalisti che dicono No alla riforma Boschi sono vecchi (nell’era renzista, un reato federale, a meno che non vi chiamate Napolitano). E il tutto, il giorno dopo che un aitante, giovane e rinnovatore portatore di nuovo come Denis Verdini è entrato nella maggioranza di governo. E così nella sala dei bronzi, le facce di bronzo diventavano quattro: tre presenti e molto fotografate, e una aleggiante come un fantasma in attesa di prescrizione.
Divertente il siparietto della sciarpa del Crotone. Prima la chiede per piacionismo applicato, poi fa il tipo da bar che se ne intende (c’è un tizio di Firenze che gioca nel Crotone e lui lo rivorrebbe indietro). E poi quando la sciarpa gliela danno, torna politico con una rapida derapata, e dice che non bisogna mai cambiare squadra. Dato che il suo governo vive grazie a molti che hanno cambiato squadra confluendo nella sua, il discorso si faceva scivoloso… ops.
Insomma, il “Renzi Porca Miseria Si Vota Tour” ha dato il meglio di sé. Per finire con il tocco di genio: la moratoria sulle polemiche. Parlava della Calabria, certo, ma anche di tutto il resto: “Per i prossimi due anni le polemiche lasciamole ai professionisti della polemica”. Traduzione: io mi prendo Verdini, prendo a pesci in faccia tutto quello che trovo alla mia sinistra, vi faccio ciaone, e adesso… Stop polemiche per due anni! Beh, in quanto a faccia di bronzo persino i bronzi erano ammirati.
Qui c’è la recensione di Omnimilanolibri.com. Cliccare per leggere. Il link è qui
 Gli scienziati del Cern, in collaborazione con la Settimana Enigmistica, stanno mettendo a punto un generatore automatico di frasi di Matteo Renzi, un prezioso strumento che agevolerà i comunicatori del Pd in vista dei prossimi appuntamenti politici. Come si sa, è invalso in questo paese l’uso che ogni cosa si debba decidere sarà un referendum pro o contro Renzi, dalle trivelle alle amministrative, fino alla madre di tutte le battaglie, il referendum di ottobre sulle riforme costituzionali.
Gli scienziati del Cern, in collaborazione con la Settimana Enigmistica, stanno mettendo a punto un generatore automatico di frasi di Matteo Renzi, un prezioso strumento che agevolerà i comunicatori del Pd in vista dei prossimi appuntamenti politici. Come si sa, è invalso in questo paese l’uso che ogni cosa si debba decidere sarà un referendum pro o contro Renzi, dalle trivelle alle amministrative, fino alla madre di tutte le battaglie, il referendum di ottobre sulle riforme costituzionali.
In chiaro affanno nel dimostrare che il capo ha sempre ragione, i guru della propaganda faticano a tenere il passo con le esternazioni del premier e hanno modificato i loro computer in modo che schiacciando un solo tasto ne escano frasi già costruite. L’auspicio è che anche i cittadini italiani, oltre ai più grandi giornali del regno, installino sui loro computer questo piccolo aggiornamento. La propaganda ne sarà agevolata, ma soprattutto si risparmierà tempo. Ecco i tasti dedicati.
F4: L’ira di Renzi – Qualcosa non va? Qualcosa non funziona? C’è qualche dettaglio che, nonostante la frenetica opera del Capo rimane negativo? Niente paura, schiacciando il tasto F4 si genererà automaticamente la frase “L’ira di Renzi”, e basterà poi riempire lo spazio bianco con il motivo di quell’ira. Esempi? A decine. Prendete Davigo e le sue dichiarazioni. Ecco “L’ira di Renzi” (Messaggero). L’Unità perde soldi? Ecco “L’ira di Renzi verso i circoli” (Corriere della Sera). Qualcuno copre le statue perché arriva il presidente iraniano? “L’ira di Renzi, qualcuno pagherà” (La Repubblica). Le ferrovie del Sud-est non funzionano? “L’ira di Renzi…” (Gazzetta del Mezzogiorno). Il tasto F4 velocizza e sintetizza il discorso. L’ira di Renzi è una piccola frase che dice: se fosse per lui sarebbe tutto perfetto e a posto, invece… maledizione! La frase è perfetta, non a caso fu un classico del fascismo: l’ira del duce contro i gerarchi serviva a scaricare la responsabilità dal capo ai sottoposti, che in fondo sono pagati per quello.
F5: Renzi ai suoi – Non è mai facile, anche in condizioni estreme, pubblicare una velina. Non sono più, ahimé, i tempi del Minculpop, e qualche presa di distanza dalle comunicazioni ufficiali bisogna pur fare finta di prenderla. Ci viene incontro in questo caso il tasto F5. Basta schiacciarlo e comparirà la scritta “Renzi ai suoi”, con la linea da seguire. In questo caso, la libera informazione prenderà due piccioni con una fava: comunicherà la linea, e al tempo stesso fingerà di aver scoperto cose nascoste (che invece sono arrivate con un sms).
F6: E’ finito il tempo di… – Altra frase comoda e diretta, adatta per ogni situazione e utile a sottolineare le promesse (un grazie a Flavio Bini che le ha messe in fila su l’Huffington Post). “E’ finito il tempo delle chiacchiere” (su Facebook), “E’ finito il tempo della tasse” (esilarante, Sky Tg24), “E’ finito il tempo del sei politico” (che comunque era finito già ai tempi dello sbarco sulla Luna, Porta a Porta), “E’ finito il tempo degli alibi” (al Forum di Cernobbio). Insomma, è arrivato lui ed è finito il tempo di un sacco di cose. La gente comincia a chiedersi: urca, ma prima come facevamo? Avvertenza: cosa sia finito è abbastanza irrilevante, quel che conta è l’accorato grido iniziale: “E’ finito il tempo di… (riempire a piacere)
F7: Democrazia decidente – Nuova formula per dire che la democrazia vecchia era brutta e immobile, e la nuova democrazia renzista invece è bella e decide. Il tasto F7 velocizza la propaganda in vista del referendum costituzionale di ottobre e fa risparmiare sul tempo di scrittura (si schiaccia un tasto solo, una volta sola, invece di molti tasti per 20 volte), e soprattutto evita refusi ed errori di battitura (qualora vi scappasse di scrivere “democrazia decadente”)
Qui (magari ci mette un po’ a caricarsi, eh!) c’è l’audio dell’intervista al microfono aperto di Radio Popolare. Si parla di libri, di Milano, di sinistra e un po’ di quello che vogliamo fare (e dovremmo deciderci a dirlo) delle nostre vite. Grazie a Michele Migone e a tutti gli ascoltatori che hanno telefonato
Qui la bella recensione di Francesca Cingoli sul blog di IO Donna del Corriere della Sera (il link è qui)
A grande richiesta, la processione di Santa Maria Elena Boschi
Crozza nel paese delle meraviglie è un programma di Maurizio Crozza scritto con Vittorio Grattarola, Andrea Zalone, Alessandro Robecchi, Francesco Freyrie, Claudio Fois, Alessandro Giugliano e Luca Restivo. Orchestra del Maestro Silvano Belfiore. La regia è di Massimo Fusi.
 Una foto notturna e sfocata, pubblicata con grande evidenza. Un titolo a nove colonne: “E’ Matteo Renzi quello che entra alle tre di notte nella sede di Scientology?”. Immaginate di leggerlo, che so, sul Corriere della Sera, o su Repubblica, o di vederlo nell’apertura di un telegiornale. Immaginate (dai, questo è facile) che il giorno dopo Renzi dica: no, non sono io quello nella foto e che chieda una rettifica. E già che ci siete immaginate anche che i responsabili della bufala dicano: no, non rettifichiamo, perché questo è Giornalismo 2.0.
Una foto notturna e sfocata, pubblicata con grande evidenza. Un titolo a nove colonne: “E’ Matteo Renzi quello che entra alle tre di notte nella sede di Scientology?”. Immaginate di leggerlo, che so, sul Corriere della Sera, o su Repubblica, o di vederlo nell’apertura di un telegiornale. Immaginate (dai, questo è facile) che il giorno dopo Renzi dica: no, non sono io quello nella foto e che chieda una rettifica. E già che ci siete immaginate anche che i responsabili della bufala dicano: no, non rettifichiamo, perché questo è Giornalismo 2.0.
Ecco fatto, è andata proprio così. Dopo aver pubblicato un video della serie “Meno male che Silvio c’è”, e aver titolato “E’ la Raggi quella nel video?”, richiesto di una rettifica, il direttore de l’Unità, Erasmo De Angelis ha risposto: “No, perché non è un’operazione politica, ma è Giornalismo 2.0”. Riassumo. C’era un giornalismo 1.0 che trovava le notizie, le verificava, si accertava bene di non dire una cazzata o una falsità e poi la pubblicava. Avendo in una vita precedente lavorato all’Unità e in vite successive in altri giornali, so che c’era sempre qualcuno, collega anziano o burbero caporedattore, che diceva: “Controlla bene, eh!”. Che palle, sta cosa di controllare le notizie. Ora finalmente arriva l’upgrade, il Giornalismo 2.0 che semplifica le cose all’utente: prendi la prima puttanata che trovi in rete e che ti fa comodo, e la pubblichi con un punto di domanda. Tipo: “Era Giorgio Napolitano il graffitaro che ieri notte ha imbrattato la metropolitana?”. All’Unità dicono che si può fare, e chi sono io per smentirli? Che poi, a pensarci bene, non è che l’applicazione di un altro programma già operativo da secoli, Lettere Anonime 2.0 (”Era tuo marito l’altra notte al night con una minorenne?” Firmato: un amico).
Naturalmente un caro pensiero va ai tanti colleghi che si affannano per difendere questo povero mestiere che era il Giornalismo 1.0, quelli che fanno i convegni su giornali e web, quelli che ti obbligano ai corsi di deontologia professionale. Tutto superato dal Giornalismo 2.0 messo a punto nella software house fondata da Antonio Gramsci e oggi diretta da Erasmo De Angelis.
Ma come si sa l’evoluzione tecnologica è veloce, frenetica, supera in rapidità anche i nostri stupori. Così quando ancora noi saremo qui a perplimerci per il Giornalismo 2.0, sarà già allo studio il Giornalismo 3.0, pure quello con punto di domanda: “Siamo stati noi a rigare la macchina alla Raggi?”. Oppure si potrebbe arrivare a ribaltare alcune sane tradizioni comuniste che cancellavano la gente dalle foto ufficiali (Trotsky che scompare dalle foto con Lenin), aggiungendole, invece che levarle, con abili fotomontaggi. Facile immaginare i titoli dell’Unità: “Che ci faceva Fassina a cena con il mostro di Rostov?”. Oppure: “Ma è per caso Landini questo boia dell’Isis?”. Chiedendo smentite e rettifiche ci risponderanno: ma no! È Giornalismo 5.0… ma tranquilli, stiamo elaborando il Giornalismo 6.0, quello in cui si aspettano gli avversari politici direttamente sotto casa con una mazza da baseball. Se la cosa prenderà piede sarà come agevolare il traffico abolendo gli stop e i semafori e dotando le auto di mitragliette sui parafanghi. Sarà una specie di Trasporto Urbano 2.0. Va detto che in confronto al Giornalismo 2.0 che ci insegna il direttore de l’Unità, il “metodo Boffo” tanto vituperato solo qualche anno fa (e per cui si alzarono cori unanimi di condanna) sembra un trattato di etica giornalistica. Ma chi siamo noi per fermare il progresso? Si arriverà all’estremo, persino al grottesco. Esagero: si arriverà all’assurdo, a chiedersi in un titolo a nove colonne, con una foto sotto: “Ma è questo il giornale fondato da Antonio Gramsci?”. Non serve rettifica.
Si è sparato in testa. E’ morto così. Aveva 37 anni. Ha lasciato scritto: “Voi che restate, siate felici”. E voi leggetelo bene, La nuvola in calzoni. Qui c’è la figurina di un rivoluzionario che voleva una rivoluzione più bella
https://www.youtube.com/watch?v=J1kjUn1oHok
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 Certi di fare ai lettori cosa grata, segnaliamo l’apertura del nuovo museo dell’hashtag, visitabile anche con audioguida (orari 9-19, ridotto per scolaresche e petrolieri). Aperto in origine come deposito di hashtag dismessi, parole d’ordine, esortazioni, inni all’ottimismo e cifre farlocche sul mondo del lavoro non più utilizzabili nel dibattito politico, l’idea di farne un museo ha preso piede rapidamente, fino all’inaugurazione di domani.
Certi di fare ai lettori cosa grata, segnaliamo l’apertura del nuovo museo dell’hashtag, visitabile anche con audioguida (orari 9-19, ridotto per scolaresche e petrolieri). Aperto in origine come deposito di hashtag dismessi, parole d’ordine, esortazioni, inni all’ottimismo e cifre farlocche sul mondo del lavoro non più utilizzabili nel dibattito politico, l’idea di farne un museo ha preso piede rapidamente, fino all’inaugurazione di domani.
In anteprima, ecco le principali attrazioni del museo.
#labuonapolitica – E’ la sala da cui parte la visita, tutta improntata alla nostalgia. Il visitatore ripercorre il breve periodo dell’entusiasmo renzista, quando si propagandavano riunioni all’alba, biciclette, panini di Eataly mangiati al tavolo di lavoro. Ministri e sottosegretari si chiamavano per nome e il governo sembrava una succursale dei boys scout. Il premier arrivava in Smart e viaggiava in treno. Suggestivi i richiami, anche audiovisivi, alla Leopolda, dove un finanziere ricco con sede a Londra teorizzava tagli per pensionati poveri con sede in Italia.
#cambiaverso – Come avverte l’audioguida (tasto 2, per l’inglese tasto 3, per l’inglese letto da Renzi tasto 459#@y776) si tratta della sala più controversa della mostra, anche se è stato rimosso il grande ritratto di Denis Verdini che accoglieva il visitatore appena varcata la soglia. Le numerose innovazioni del governo sono qui ben evidenziate: dalla bicicletta ai superjet, dal jobs act ai tagli alla sanità, dagli inviti all’astensionismo agli emendamenti notturni in favore del fidanzato di questa e di quello. Si consiglia il visitatore di seguire correttamente il percorso della mostra (per dire: il pannello “dimissioni Lupi” va ammirato prima della bella installazione in 3D sul padre della ministra Boschi che va a scuola a piedi carico solo della sua tradizione contadina). Purtroppo il grande arazzo “ministra Guidi al telefono” non è visibile essendo in prestito ad un’altra grande mostra, quella su “Etica e classe imprenditoriale”, allestita a Confindustria.
#Italiariparte – Grande sala affrescata con i numeri forniti dal ministro Poletti. Secondo alcuni critici, un omaggio al centenario del dadaismo
#lavoltabuona – (audioguida, tasti 5 e 6) bella sala multimediale dedicata ad annunci, promesse, previsioni, auspici, tutti accompagnati dall’hashtag sul fatto che questa volta il colpo riuscirà. Parola d’ordine cara a detenuti che progettano l’evasione, imputati in attesa di prescrizione e governo Renzi. La sala risuona di musiche allegre e garrule risate, un intenso profumo di rose esce da apposite prese d’aria e un ricco buffet serve alcolici, in modo che, dopo il quarto prosecco, tutta la sala possa assumere una sua pur ondeggiante credibilità.
#millegiorni – Sala ampliata in fretta e furia, perché inizialmente l’hashtag era #centogiorni, poi prudenzialmente moltiplicato per dieci. Come spiega l’audioguida (tasto 1.000), si tratta di uno speciale percorso tra tutte le cose che succederanno grazie al governo Renzi tra mille giorni, anche se l’allestimento prevede altre ristrutturazioni (esempio: #diecimilagiorni per la legge sul conflitto di interessi).
#amicigufi – Una sala che piacerà ai bambini. Istruttiva la storia di questo hashtag molto usato, perfetto per catalogare come nemici chiunque avanzi dubbi sull’azione di governo e al contempo per irridere gli sconfitti in qualunque campo, dalla politica al calcio, al biliardo. La sala presenta variazioni sul tema (audioguida tasto 45), come il famoso hashtag #classedirigentemaddeché, molto usato dalla comunicazione governativa e improvvisamente dimesso per decenza insieme alla ministra Guidi.
Il museo degli hashtag dismessi apre domani con una piccola cerimonia. Per seguire l’evento sui social media l’hashtag è: #viabbiamopresoperilculo.
Va bene, volete una canzone d’amore. Vi capisco. Eccola
Crozza nel paese delle meraviglie è un programma di Maurizio Crozza scritto con Vittorio Grattarola, Andrea Zalone, Alessandro Robecchi, , Francesco Freyrie, Claudio Fois, Alessandro Giugliano e Luca Restivo. Orchestra del Maestro Silvano Belfiore. La regia è di Massimo Fusi.
 A ciascuno a seconda dei propri riferimenti culturali e da ciascuno a seconda delle citazioni di cui è capace. E quindi potete oscillare a piacere tra Il tradimento dei chierici (Julien Benda, 1927) e Notte prima degli esami (Fausto Brizzi, 2006), oscillazione spaventosa, diciamo. Ma insomma, quando si annuncia una lista lunga-lunga che si prevede fitta di nefandezze fiscali, lo spirito è quello: chi ci sarà?, chi non ci sarà?, ed è inevitabile il conteggio degli amori che si incrineranno come il parabrezza in un incidente.
A ciascuno a seconda dei propri riferimenti culturali e da ciascuno a seconda delle citazioni di cui è capace. E quindi potete oscillare a piacere tra Il tradimento dei chierici (Julien Benda, 1927) e Notte prima degli esami (Fausto Brizzi, 2006), oscillazione spaventosa, diciamo. Ma insomma, quando si annuncia una lista lunga-lunga che si prevede fitta di nefandezze fiscali, lo spirito è quello: chi ci sarà?, chi non ci sarà?, ed è inevitabile il conteggio degli amori che si incrineranno come il parabrezza in un incidente.
Ma sì, diciamolo: dai vip del pianeta non ci aspettiamo niente. Politici, re e primi ministri, famiglione di gran cognome, e la finanza “che tremare il mondo fa”, più i famosi imprenditori sempre portati ad esempio finché non si impantanano… Sì, potremo alzare le spalle e dire: non mi stupisce. Anche se sapere che i vertici del Partito Comunista Cinese e i narcos, il premier islandese e Barbara D’Urso avessero lo stesso commercialista fa ridere un bel po’. Nulla è più divertente di beccare qualcuno coi pantaloni calati, specie se è uno di quelli che teorizzano che bisogna tenerli addosso e ben allacciati (e questo è per monsieur Le Pen e mister Cameron), ma il problema è quando la delusione scoppia accanto a te e ai tuoi amori.
Almodovar? E, dalle parti nostre, in piccolo ma mica tanto, Carlo Verdone? Lionel Messi? Kubrick (vabbé, le figlie…)? Non scherziamo, gente. Già si sa che scorrendo i nomi (italiani, ma anche no), si innesterà il braccio di ferro tra affetti e indignazione, tra ammirazione e scandalo. Tutti possono tollerare che un arrogante padrone delle ferriere nasconda soldi all’estero, e rallegrarsi quando lo beccano, ma agli effetti collaterali del tradimento di un idolo ci avete pensato? Scoprire che magari nella vostra cameretta da ragazzi avevate il poster di uno che ora porta i soldi alle Isole Vergini, alle Seychelles, a Panama? Tristezza. Messi, il campione umano che regala magliette ai piccoli Messi disagiati del mondo, perderà la sua aura di piccola santità, e questo è ovvio. A Seedorf, per esempio, avevo giurato di perdonare tutto e per sempre dopo quella doppietta alla Juve. E ora?
La caduta degli dei. La valuta degli dei.
Quali amori ci si chiederà di ridiscutere? Il cantante preferito? Il regista che abbiamo amato? L’attore che ci ha fatto sognare? So cosa succederà: baratteremo un po’ del nostro furore morale con trucchetti buoni a placarci l’anima, cose come “la sacralità dell’arte”, per dire. Perché chi se ne frega se elude il fisco, quello era comunque un gran film, un ottimo disco, una grande interpretazione. Come scriveva Gregory Corso a proposito della guerra “La pietà si appoggia / al suo bombardamento preferito / e perdona la bomba”. Ecco, faremo così: saremo inflessibili nell’indignarci, ma tenteremo di salvare gli idoli – ognuno i suoi – relativizzando la delusione, perdonandoli nella costernazione. Sapendo che tra i banditi troveremo alcuni banditi che abbiamo amato. Peggio per loro. Peggio per noi.
Qui c’è l’intervista di Carla Colledan per Manglaibri.com. Cliccare per leggere. Se volete il link è qui
 C’è un passaggio, nel discorso di Matteo Renzi alla direzione del Pd, che illumina tutto come un faro sulla costa, come un flash sparato nel buio. E’ quando dice: “Noi non siamo come gli altri”, una frase che – quando senti l’impellente bisogno di dirla – ti rende esattamente come gli altri. Certo si conoscono le basilari motivazioni psicologiche: se continui a dire come in un mantra “Noi siamo di sinistra”, ripetendolo in ogni istante anche senza assumere la posizione del loto, vuol dire che qualche dubbio ce l’hai. Dunque: “Noi non siamo come gli altri”, non confondeteci, noi siamo quelli bravi, carini, che quando li beccano si dimettono (oddio, non tutti), che fanno le riforme, che sbloccano le opere, eccetera eccetera.
C’è un passaggio, nel discorso di Matteo Renzi alla direzione del Pd, che illumina tutto come un faro sulla costa, come un flash sparato nel buio. E’ quando dice: “Noi non siamo come gli altri”, una frase che – quando senti l’impellente bisogno di dirla – ti rende esattamente come gli altri. Certo si conoscono le basilari motivazioni psicologiche: se continui a dire come in un mantra “Noi siamo di sinistra”, ripetendolo in ogni istante anche senza assumere la posizione del loto, vuol dire che qualche dubbio ce l’hai. Dunque: “Noi non siamo come gli altri”, non confondeteci, noi siamo quelli bravi, carini, che quando li beccano si dimettono (oddio, non tutti), che fanno le riforme, che sbloccano le opere, eccetera eccetera.
Tutte interessantissime faccende contingenti, mentre in quella frasetta c’è una piccola giravolta della storia, perché questo andirivieni ideologico tra l’essere uguali e diversi è un divertente tormentone della sinistra italiana. Il Pci, vecchia gloria del pugilato politico europeo, costruì la sua granitica credibilità sull’essere diverso dagli altri. Non solo quando quella diversità ti portava in galera, in via Tasso o alla fucilazione, ma anche dopo, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, “in seno al popolo”, come dicevano, e oggi sorridiamo. Poi ci fu un’altra fase, recente, di veloce de-ideologizzazione. La gestione del potere, l’avvicinamento a quelli che si chiamano “i poteri forti”, la vocazione maggioritaria che scivola nel partito della nazione, insomma, il partito recente. L’obiettivo, anche antropologico, era opposto: diventare come gli altri. Rassicurare che sì, si rimane di sinistra, alcuni addirittura di provenienza comunista (lo so, suona come un film di Buster Keaton, eppure…), ma non mangiamo i bambini, abbiamo la macchina, ci piace spassarcela e insomma, non abbiate paura di noi. Persone perbene, che avevano letto dei libri, si adeguavano allegramente al gentismo degli “altri”, specie in materia culturale, pur di non sembrare diversi. Volevano, in quella fase che va più o meno da Occhetto a Veltroni, essere uguali agli altri, essere accettati, smussare gli angoli, sfumare le differenze. Salvo tornare diversi quando le cose si mettevano male, quando gli “altri” erano un po’ troppo impresentabili per essere imitati.
Ma insomma, questo desiderio di essere come tutti, un vero manifesto ideologico, ha scavato e lavorato. Ora puoi dirti di sinistra ed esaltare Marchionne, o dire che sblocchi l’Italia perché agevoli i petrolieri. Missione compiuta: in meno di trent’anni, eccoli veramente diventati come gli altri.
E ora questo accorato appello del segretario Renzi: “Noi non siamo come gli altri”. Questa volta la rivendicazione non è ideologica, ma smaccatamente commerciale, di comunicazione. Gli early user sono, nel gergo del marketing, quegli utenti più rapidi e attenti che hanno sempre per primi il nuovo prodotto, che lo fanno diventare trendy, che lo fanno desiderare a tutti gli altri. Il Pd renziano lo è stato per qualche tempo. Smart, camice bianche, panini di Eataly, gelati di Grom, chiamarsi per nome (Matteo, Maria Elena…) e tutto lo spettacolino che abbiamo visto. Ora quello spettacolino non basta più, è già vecchio. Il grido orgoglioso “Noi non siamo come gli altri” somiglia alla frustrazione del fighetto con il nuovissimo telefonino quando si accorge che quel modello che lo rendeva unico, fico, trend setter, e cool, ora ce l’hanno tutti e non fa più impressione a nessuno. Dannazione. La narrazione del renzismo, non avendo basi ideologiche, ma soltanto estetico-caratteriali, perde in fretta di intensità e freschezza. Se il fatto che sei diverso dagli altri devi dirlo e ripeterlo, vuol dire che non si vede al volo, un bel guaio, per i narratori.
Qui la recensione di Thrillercafé.it. Cliccare per leggere, il link è qui
Era il 4 aprile, come oggi, moriva Martin Luther King. Qui la sua Figu… buona visione
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
Traci Andrighetti, sul suo sito Italicissima. com, analizza il linguaggio di Di rabbia e di vento per lettori non italiani… Interessante… ho imparato delle cose che… beh, il testo è qui sotto (cliccare), il link è qui
Qui la bella recensione di Elisabetta Bolondi su SoloLibri.net (cliccare sull’immagine per leggere, se volete il link è qui)
 Forse un giorno leggeremo su Wikipedia che Matteo Salvini ha creato una nuova corrente filosofica. Il Salvinismo consiste nell’interpretare il Superomismo nietzschiano ebbri di vin brulé, le guance arrossate dal freddo, e lo sguardo determinato in una sola, poderosa, tonante domanda: grappa ce n’è?
Forse un giorno leggeremo su Wikipedia che Matteo Salvini ha creato una nuova corrente filosofica. Il Salvinismo consiste nell’interpretare il Superomismo nietzschiano ebbri di vin brulé, le guance arrossate dal freddo, e lo sguardo determinato in una sola, poderosa, tonante domanda: grappa ce n’è?
Ma mi sbaglio e mi scuso: questo è solo il Salvinismo dei giorni di Pasqua, quando Matteo abbracciava alcuni pescatori, prima di inerpicarsi in vetta e lanciare giocherellone! – un concorso fotografico di cime innevate (testo: “Dai, chi pubblica la foto che prende più like vince una cena con la #Boldrini”). Seguiva un’altra fotina in cui chiedeva al popolo: “Che dite, lo faccio il lancio col parapendio?” (una sorta di nichilismo democratico autopromozionale). E poi, finalmente, la fotina del Salvini volante che tutti i giornali hanno riportato, chi ammiccando un po’ ironicamente, chi assumendo quel tono serio delle diagnosi: sì, il paziente è piuttosto grave.
Insomma, abbiamo visto, niente ci sarà risparmiato.
Ovviamente sono millenni che il capo per sentirsi capo deve essere il più tosto, il più rapido con la clava, il più solerte nel twittare, il più coraggioso, sicuro di sé, burbanzoso, virile e macho. E’ il motivo per cui Putin si fa fotografare stile Rambo nella neve, a caccia di tigri, di orsi, a cavallo o coi pettorali scolpiti. Il sottile messaggio è: questo è il nostro Capo, forte e indomito. Corrono poi, come sempre, sottili differenze, come per esempio che uno viene da Kgb e l’altro da Radio Padania, ma insomma, il Salvinismo è anche quello: un’arte in sedicesimo, una miniatura, un piccolo fregio sulla realtà dei giorni nostri.
Niente foto istituzionali, liftate e instagrammate, messaggi col cuore in mano come quell’altro Matteo (che per queste cose ha uno staff poderoso). No, il Salvinismo prevede una certa ruspante naïveté che comincia con lo spirito del taglialegna e prosegue con il tradizionalissimo vittimismo italiano. In ogni cosa che fa e dice e fotografa e diffonde Salvini c’è il marameo ai “sinistri”, lo sberleffo ai “compagni”, la ginocchiata alla Boldrini (è la teoria dei gufi vista, appunto, con la logica del ruspante taglialegna). Insomma, il capo dev’essere, oltre a tutto quello che si è detto sopra, anche un po’ rissoso. Ma a volte – qui casca l’asino, e avviso Salvini che è un modo di dire, niente di personale – un pochino esagera. Per esempio quando scrive: “Confesso, non ho l’iPhone, ma ho un Nokia66 vecchio di anni, cosa che magari ai compagni può dar fastidio”. Eh? Come? Ammetto di essermi perso per qualche minuto, di aver provato una vertigine: ma perché cazzo a me “compagno” (poniamo), dovrebbe dar fastidio se Salvini ha un telefono piuttosto che un altro? Può uno aspirare al superomismo, sia pure nella caricaturale variante salvinista, e occuparsi di simili dettagli che già un tredicenne considererebbe infantili? Dopo le foto di Bruxelles (abbondantemente sbertucciate dalla rete), è evidente che il salvinismo prevede di diventare una specie di culto della personalità per gente che sta, volente o nolente, davanti a uno schermo tutto il giorno. Ma questo si scontra con il culto del Capo che gli piacerebbe tanto: un capo dev’essere anche temuto e autorevole, e se invece diventa un panda che gioca nella neve, un gattino di Facebook, o un pupazzo buono per la colonnina destra dei giornali a caccia di clic, perde un po’ questa sua potenza di fuoco. La corrente filosofica del salvinismo si trova dunque in mezzo al guado, al momento della drammatica scelta: può fare la faccia trucida che inneggia alla ruspa liberatrice, faro dell’umanità, oppure può essere l’affabile piccoloborghese che manda a tutti le foto della montagna: urca, va’ che bel sole, quando si mangia?
Qui c’è la recensione di Pietro Cheli su Amica.it. Pietro è un amico e un critico attento, due cose temibilissime, se volete saperlo. Per leggere cliccare sull’immagine. Se volete il link, è qui
La recensione del Corriere. Firma Ranieri Polese. Monterossi e la crisi di coscienza. Ecco (cliccare per leggere)
 Ciao a tutti, il librino va bene, fa cucù nelle classifiche, e qualche critico ha avuto parole buone… Ma è appena partito e quindi, che dire. Buon viaggio.
Ciao a tutti, il librino va bene, fa cucù nelle classifiche, e qualche critico ha avuto parole buone… Ma è appena partito e quindi, che dire. Buon viaggio.
Intanto, grazie a chi – qui, o sulla pagina Facebook, e su Twitter – ha detto la sua. Contento che vi sia piaciuto.
Chi è a Milano sabato 2 aprile e non ha niente di meglio da fare, parliamo del libro io e Pietro Cheli a Book Pride, a Milano (alle 17, via Bergognone 34). E’ sempre un piacere parlare con Pietro, che ha già presentato Questa non è una canzone d’amore e Dove sei stanotte, è un amico e un critico acuto (scegliete voi la cosa più pericolosa). Dettagli qui.
Sabato 9 aprile, alle 17.30, invece, si parla di Di rabbia e di vento alla libreria Area Libri di Seregno. Aperitivo e presentazione, che volete di più?
Altri appuntamenti saranno comunicati in tempo. Detto questo, grazie a chi è venuto alle presentazioni, a chi ha letto, a chi legge o leggerà…
 “Domani facciamo i conti” è una a frase che ci siamo sentiti dire tutti almeno una volta nella vita. Da mamma quando perdevamo il quaderno di matematica (correva la seconda elementare, credo), dal compagno di classe, forse persino dall’allenatore quando si batteva la fiacca e si veniva minacciati di dieci giri di campo punitivi. Beata gioventù. Poi, crescendo, “domani facciamo i conti” è una frase che non abbiamo sentito più, perché, da adulti, una simile provocatoria arroganza risulta irricevibile: è una di quelle cose che si dicono ai sottoposti, ai succubi e ai sudditi, una sottolineatura di potere che chi ha il potere veramente non userebbe. Pensare che “domani facciamo i conti” fosse l’esergo, la mirabile premessa, di una discussione interna del Pd mette una certa tenerezza a chiunque sappia vedere il lato B dell’arroganza, cioè la debolezza e l’insicurezza. Ma come al solito, è meglio portarsi avanti col lavoro e analizzare le prossime dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio, che è anche segretario del Pd, che è anche l’ispiratore della soave narrazione corrente. Ecco dunque alcune parole d’ordine che guideranno nei prossimi giorni la discussione nel partito di governo.
“Domani facciamo i conti” è una a frase che ci siamo sentiti dire tutti almeno una volta nella vita. Da mamma quando perdevamo il quaderno di matematica (correva la seconda elementare, credo), dal compagno di classe, forse persino dall’allenatore quando si batteva la fiacca e si veniva minacciati di dieci giri di campo punitivi. Beata gioventù. Poi, crescendo, “domani facciamo i conti” è una frase che non abbiamo sentito più, perché, da adulti, una simile provocatoria arroganza risulta irricevibile: è una di quelle cose che si dicono ai sottoposti, ai succubi e ai sudditi, una sottolineatura di potere che chi ha il potere veramente non userebbe. Pensare che “domani facciamo i conti” fosse l’esergo, la mirabile premessa, di una discussione interna del Pd mette una certa tenerezza a chiunque sappia vedere il lato B dell’arroganza, cioè la debolezza e l’insicurezza. Ma come al solito, è meglio portarsi avanti col lavoro e analizzare le prossime dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio, che è anche segretario del Pd, che è anche l’ispiratore della soave narrazione corrente. Ecco dunque alcune parole d’ordine che guideranno nei prossimi giorni la discussione nel partito di governo.
Ti rigo la macchina. Posizione moderata e interlocutoria rivolta a chi voglia votare (votare sì, ma anche solo votare) al referendum sulle trivellazioni del 17 aprile. Un referendum indetto tra gli altri da alcuni governatori del Pd sul quale il Pd, senza discussione, ha invitato ad astenersi. Annunciato da una serafica e svaporata dichiarazione della Serracchiani, l’ordine del giorno ha aperto un dibattito nella sinistra del partito: andare il taxi, a piedi, o non andare?
Ti metto la trielina nello spritz. Amichevole avvertimento a chi, a sinistra, sta valutando l’ipotesi di non votare i candidati renzisti alle imminenti amministrative. Non si tratta di una minaccia, certo, ma di una forma di pressione politica del tutto legittima della maggioranza del partito rispetto ad elementi fastidiosamente dissidenti. Si spera, con questo argomento denso di sostanza politica, di allineare la minoranza ai voleri della segreteria, vogliosa di ripianare con un sorriso il dibattito interno.
Ti abbandono in autostrada. Altra parola d’ordine per il sereno e costruttivo confronto interno al Pd. Gli hashtag consigliati dai guru della comunicazione per sostenere questo volonteroso invito al dialogo sono #luridigufi, #tisputo e #cosedigulag, parole distensive che dovrebbero – secondo le intenzioni del segretario – invogliare gli elettori riottosi o perplessi a sostenere convinti la segreteria. I membri della minoranza interna valutano l’apertura, apprezzano l’ammorbidirsi del toni e lodano la volontà di mediazione, ma ancora non si fidano del tutto.
Ti rompo una rotula. Finalmente un ordine del giorno della segreteria Pd che dichiara apertamente la voglia di confronto sereno e pacato con la minoranza. Dedicato a chi, all’interno del Pd, storce un po’ il naso per le vicende della famiglia Boschi, per l’accusa di bancarotta fraudolenta al padre della ministra diventato vicepresidente di banca dopo che lei è diventata ministra, una bizzarra coincidenza. Per la discussione, i tempi sono stati severamente contingentati, tutti potranno parlare per tre minuti, ma i membri della segreteria più vicini al premier potranno farlo utilizzando una mazza da baseball. La minoranza interna accetta in dibattito munita di vistose ginocchiere in ghisa.
Al termine di queste articolate discussioni, la direzione del Pd incassa il voto favorevole dei suoi membri e si rivolge alla sinistra interna, di cui ha bisogno per Sala a Milano, Giachetti a Roma e Valente a Napoli, con un appello che distende il clima e rasserena gli animi: “Siamo tutti una grande famiglia, vero, bastardi?”.
Ecco qui la recensione di Corrado Augias su Il venerdì di Repubblica… come dire… vabbé, non dico niente… (solo grazie)
 Non è del tutto vero che il settimo giorno si riposò come si dice in giro. Sì è vero, nei sei giorni prima, sabato compreso, creò il mare, la terra, le montagne, eccetera eccetera. Poi gli animali, poi l’uomo e la donna, tutto come si sa, un lavoretto fatto per bene. E poi alla domenica mattina, durante il brunch, preso da un piccolo attacco di sadismo, creò le primarie, gettando tutto quello che aveva fatto prima nel caos più totale.
Non è del tutto vero che il settimo giorno si riposò come si dice in giro. Sì è vero, nei sei giorni prima, sabato compreso, creò il mare, la terra, le montagne, eccetera eccetera. Poi gli animali, poi l’uomo e la donna, tutto come si sa, un lavoretto fatto per bene. E poi alla domenica mattina, durante il brunch, preso da un piccolo attacco di sadismo, creò le primarie, gettando tutto quello che aveva fatto prima nel caos più totale.
Ora non è più questione di creazione e di natura, ma di bookmaker. Bertolaso è dato contosei a uno come sindaco di Roma, mentre le sue gaffes hanno quote molto più basse. Dopo quella sulle mamme (notevole) si aspetta “I neri hanno il ritmo nel sangue”, che è data due a uno, mentre “Gli ebrei sono tutti banchieri” è data quasi alla pari, insomma, scommettere su Bertolaso non conviene, se si vince si vince pochissimo. Ma tranquilli, non si vince.
Poi ci sono Salvini che dice a Silvio che ha più voti di Silvio, Silvio che lo insulta, Giorgia Meloni che aspetta gli eventi, e che dice che può fare il sindaco anche da mamma dopo aver detto che non avrebbe potuto fare il sindaco perché mamma, Marchini che ride e Storace che insulta tutti indifferentemente, a caso, mentre salta nel cerchio di fuoco. Un bel quadretto, e siamo soltanto a Roma, pensate nel resto dell’universo. Sempre a Roma c’è Giachetti, quello che tira il risciò con Renzi e che fa incazzare D’Alema, ma c’è pure Marino in cerca di rivincite, e pure la sinistra di Fassina che aspetta gli eventi acquattato chissà dove. E poi c’è la signorina Raggi dei Cinquestelle che basta stia ferma e buona, non faccia autogol, non dica cose astruse, ed è favorita.
A Napoli è partita invece un’entusiasmante gara a pesci in faccia tra quelli che vogliono una sindaca renzista, Valeria Valente, e quelli che vogliono un sindaco bassoliniano, cioè Bassolino. Sembrerebbe una faccenda interna di difficile soluzione, visto che i più strenui sostenitori della Valente erano bassoliniani fino a cinque minuti prima. In ogni caso, Bassolino sta per battere il record mondiale di ricorsi respinti per futili motivi, che ancora non si capisce se sia un’aggravante o un’attenuante. A Roma come a Napoli, come a Milano, pare che la segreteria Renzi sia, come dicono i politologi “divisiva”, cioè impone il suo candidato e fa inviperire tutti gli altri. Forse si intende questo quando si dice che Renzi è di sinistra: sta facendo di tutto perché nasca finalmente qualcosa a sinistra, alternativo a Verdini.
E poi c’è Milano, dove infuria la battaglia tra due capiufficio, ognuno impegnato ad essere più capufficio dell’altro e quindi la solenne dialettica politica si concentra sul fondamentale argomento “Sono più manager io” (Sala), “No, sono più manager io” (Parisi). Piuttosto desolante, e nient’altro all’orizzonte, perché Passera non è pervenuto, non perviene e non perverrà, i Cinquestelle sono impegnati a capire se la loro candidata Bedori sia stata cacciata da Casaleggio o da lei medesima, offesa dalle pressioni della stampa, e la sinistra passa le sue giornate a chiedere in ginocchio a questo e a quello se per caso si vuole candidare contro Sala. Il quale, peraltro, ogni giorno che passa vede erodersi un po’ la sua rendita di posizione, visto che se il Pil salirà nel 2016 soltanto dello 0,4 per cento (Renzi sparava nel Def un mirabolante 1,6) vuol dire che quello straordinario indotto di Expo non è esattamente l’Eldorado che ci hanno venduto (perdite operative a parte).
Ora, naturalmente, non resta che sedersi, mettersi comodi e procurarsi dei pop-corn per assistere allo spettacolo desolante di una politica senza politica, senza idee e senza parole, dove gli unici gesti atletici degni di nota sono lo schiaffo del soldato, lo sgambetto e la pernacchia. Buona visione.
Marozzi capì dove buttava il vento e per ammorbidire i toni della discussione usò l’espediente che gli aveva suggerito Sisti. Parla della “fase”, gli aveva detto. A dei comunisti, se gli parli della fase e gli dici con convinzione che questa è una fase che richiede prudenza vedrai che si calmano…
 Provvidenza rossa, il bel romanzo di Lodovico Festa (Sellerio, 2016) è davvero strabiliante. È un giallo, vero, ma la storia noir quasi svapora a fronte del contesto in cui è immersa, il Pci degli anni Settanta, la fittissima ragnatela di burokratia e di apparato, il breznevismo de facto dove ognuno risponde all’altro, poi all’altro, le sezioni, le federazioni, il provinciale, i probi viri, la direzione nazionale, la segreteria, addirittura al Comitato Centrale. La Ditta – per dirla con Bersani Pierluigi, parlandone da vivo – alla sua massima, macchinosa e rassicurante potenza. Avendo passato anni all’Unità di Milano quando ancora tutto quel mesozoico togliattian-dadaista funzionava, leggevo con un misto di nostalgia e stupore: era successo davvero? Davvero c’è stato un giorno in cui a noi comunisti (sic) bastava parlare della “fase” per imbesuirci?
Provvidenza rossa, il bel romanzo di Lodovico Festa (Sellerio, 2016) è davvero strabiliante. È un giallo, vero, ma la storia noir quasi svapora a fronte del contesto in cui è immersa, il Pci degli anni Settanta, la fittissima ragnatela di burokratia e di apparato, il breznevismo de facto dove ognuno risponde all’altro, poi all’altro, le sezioni, le federazioni, il provinciale, i probi viri, la direzione nazionale, la segreteria, addirittura al Comitato Centrale. La Ditta – per dirla con Bersani Pierluigi, parlandone da vivo – alla sua massima, macchinosa e rassicurante potenza. Avendo passato anni all’Unità di Milano quando ancora tutto quel mesozoico togliattian-dadaista funzionava, leggevo con un misto di nostalgia e stupore: era successo davvero? Davvero c’è stato un giorno in cui a noi comunisti (sic) bastava parlare della “fase” per imbesuirci?
Ma era una domenica piovosa, e tra il libro e la tivù il tempo passava, e a un certo punto compariva sulla rete ammiraglia berlusconica Canale 5 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Parlava con Barbara D’Urso, sacerdotessa della sottocultura catodica pomeridiana, e lo faceva nel miglior Silvio-style mai visto. Spiritoso e affabile, rassicurante e ciarliero fino al cialtronismo tutt’altro che involontario, anzi: rivendicato. A un certo punto, parlando di pensioni, si rivolgeva alla «signora Maria che sta stirando mentre ci guarda»… Ecco. Fulmine. Stava parlando della “fase”. Se gli dici con convinzione che questa è una fase… ecco. Cortocircuito totale: i comunisti della sezione Sempione, a Milano, negli anni Settanta, le signore Marie che stirano guardando il peggio della tivù commerciale nel 2016… la narrazione della “fase” funziona sempre, funziona ancora. Vertigine.
Le telecamere di Canale 5 non erano le uniche in funzione domenica 6 marzo.C’erano, all’opera, anche quelle di Fanpage, sito indipendente che andava a curiosare fuori dalle sezioni Pd di Napoli, dove si celebrava la “grande festa della democrazia” (sic) delle primarie per il sindaco. Un vaso di Pandora da cui usciranno per giorni vergogne grandi e piccole. Consiglieri e capigruppo del Pd che forniscono ai passanti qualche euro per votare («Vota la femmina», cioè la candidata renziana Valeria Valente), e poi cosentiniani ed esponenti della destra più zozza che cammellano gente al voto, porcherie grandi e piccole. La “femmina” (lo sapremo a tarda sera) vincerà per pochi voti (452) battendo il grande vecchio Bassolino.
L’apparato – senza tirare in ballo la fase – farà la faccia stranita dicendo che il risultato non si tocca (Serracchiani), o parlando di piccoli episodi (Orfini), o coprendosi di ridicolo sostenendo che si prestavano spiccioli agli amici per votare secondo coscienza (Francesca Puglisi, senatrice Pd). La sensazione, insomma, è che di quella poderosa macchina burocratico-ideologica che fu la maggior forza della sinistra sia rimasta oggi nel partito volatile di Renzi solo e soltanto la narrazione della “fase”, soave bugia per tener buona la base, e poco importa se la base non c’è più, la «signora Maria che stira mentre ci guarda» ne farà le veci alle urne. Almeno si spera. Il resto, zero.
Ciò che era partecipazione e confronto, persino barocco nella sua gerarchia di apparati, è oggi un partito in franchising. La Ditta è polverizzata, concessa in gestione a questo e a quello, affidata ai potentati vincenti: i cuffariani in Sicilia, i verdiniani a Roma, i renzisti di derivazione fighetto-bancaria (Lotti, Boschi) in Toscana, il giglio magico democristiano a Palazzo Chigi e al Nazareno. Di quell’antico apparato – grottesco nella sua complessità gerarchica – non rimane più nulla se non, appunto, la narrazione spinta, l’indorare la pillola, lo storytelling della “fase”. Come si sia passati in poco più di trent’anni dalle grotte umide del piciismo ai padiglioni post-ideologici del renzismo-verdinismo sarebbe difficile – e lungo – raccontare.
Ma è un fatto, la distanza è siderale: di là il piombo, di qua la plastica, di là i mammut, di qua gli androidi replicanti. Con la “fase” sempre uguale, però: non attaccare troppo se all’opposizione (la fase richiede prudenza), non spingere troppo se al governo (la fase richiede prudenza). Una grande forza, ieri poderosa oggi dinamica. Ieri corrucciata oggi smart, ieri ideologica oggi jovanottesca. Ma, alla fine, una grande forza immobile. La “fase” è sempre quella. Non gridare troppo, non pretendere troppo, non irritare i poteri forti, le rendite di posizione, il capitalismo straccione ma ancora potente. Che alle fregnacce sulla fase — ieri e oggi — non ci ha mai creduto, per un fatto molto semplice: è lui “la fase”, e non bisogna disturbarlo.
 Totò, Peppino e le primarie (Napoli, 2011) era già un bel film. Totò, Peppino e vota la femmina (Napoli, 2016) è pure meglio, una specie di sequel, ma questa volta la regia è più attenta, le telecamere sono nascoste, la sceneggiatura è solo una traccia da seguire, un canovaccio, e gli attori recitano a braccio come i grandi comici. Per quanto chiamare i futuri elettori a scegliere il futuro candidato sia “una festa della democrazia”, si sa come va alle feste: c’è sempre quello che si sbronza, che rompe i bicchieri, che esagera, dà fastidio alle ragazze e alla fine si va a casa dicendo: sì, bella festa, peccato che…
Totò, Peppino e le primarie (Napoli, 2011) era già un bel film. Totò, Peppino e vota la femmina (Napoli, 2016) è pure meglio, una specie di sequel, ma questa volta la regia è più attenta, le telecamere sono nascoste, la sceneggiatura è solo una traccia da seguire, un canovaccio, e gli attori recitano a braccio come i grandi comici. Per quanto chiamare i futuri elettori a scegliere il futuro candidato sia “una festa della democrazia”, si sa come va alle feste: c’è sempre quello che si sbronza, che rompe i bicchieri, che esagera, dà fastidio alle ragazze e alla fine si va a casa dicendo: sì, bella festa, peccato che…
La vicenda è nota: se nel 2011 le primarie napoletane vennero annullate per una sospetta, massiccia affluenza di cinesi, quest’anno se ne discute per la presenza davanti ad alcuni seggi, di generosi personaggi, tra cui un capogruppo Pd e un consigliere comunale, che fornivano ai votanti l’obolo di un euro da portare alla festa della democrazia e la gentile indicazione su chi votare. Essendo i voti di scarto tra chi ha vinto (Valeria Valente, “’a femmina”) e chi ha perso (Antonio Bassolino, “o’nonno”) appena 452, cioè un soffio, ed essendo documentato che chi gentilmente donava un euro ai votanti lo faceva a favore della prima, verrebbe da pensare che alla famosa festa qualcuno ha portato lo spumante al metanolo. Divertente (i colpi di scena virano al grottesco) che a farsi inquadrate dalle telecamere nascoste per – diciamo così – in – dirizzare e correggere il voto, fossero dei renziani rinati, bassoliniani fino a poco prima, fulminati sulla via di Damasco come San Paolo, anzi, sulla via di Scampia o di San Giovanni a Teduccio. Lo zelo dei convertiti è sempre pericoloso ed estremo, pensate a chi fumava cinquanta sigarette al giorno, ha smesso e ha come missione nella vita rompere le palle a chi ne fuma tre. La commedia, insomma, si snoda tra immagini sgranate e battute da avanspettacolo. La procura dice che aprirà un fascicolo, e che però, che non essendo elezioni vere ma una specie di cerimonia privata, non potrà fare granché, che è come dire che se a una festa uno vuole mangiare cibo avariato invece della torta, la faccenda si configura, usando un giro di parole, come “sono cazzi suoi ” . Giusto. Quanto al partito della legalità e della trasparenza –quello che ha organizzato la festa della democrazia –pare non avere dubbi, almeno stando alle parole della vicepresidente del partito, Debora Serracchiani: “Nessuna circostanza può però inficiare il voto ”. Insomma, vedremo, faremo, valuteremo, ma il risultato non cambia. Un po’ come dopo quelle partite in cui una squadra ha avuto sei rigori inesistenti a favore, tre fuorigioco non fischiati, qualche episodio dubbio, due avversari espulsi, ma alla fine ha vinto, e pare poco sportivo chi non accetta il verdetto del campo. Il risultato non cambia, insomma, per “nessuna circostanza”. Discorso chiuso.
Ora va da sé che Totò, Peppino e vota la femmina avrà qualche strascico polemico, e come sempre in questi casi il pubblico apprezzerà, mentre la critica storcerà il naso, minimizzerà e dirà che si tratta di piccoli episodi. Poi partirà la solita girandola di accuse e controaccuse: i grillini grideranno alla truffa, i renzisti risponderanno irridendo le loro consultazioni in rete in cui votano in ventisette, e via così. Scenario già visto appena qualche giorno fa, quando i due maggiori partiti del paese si insultavano rimproverandosi a vicenda vicinanze con mafie, ‘ndranghete e camorre varie. Una specie di stato di trance collettivo in cui si gioca al vecchio tormentone “il più pulito c’ha la rogna”. Quanto alle varie “feste della democraz ia ”, dette primarie, qualcuno nota che ci va sempre meno gente. Visto quest’ultimo film – a Napoli, ma anche a Roma – non si fatica a capire perché.
Bene, per chi vuole e chi può… prima presentazione di Di rabbia e di vento. L’appuntamento è per martedì 15 marzo alla Feltrinelli Duomo di Milano, alle 18.30… vi aspetto…
 Prima le notizie. E dunque, anche se la folla plaudente sta a Cologno Monzese e non a piazza Venezia, diciamolo: la dichiarazione di guerra non è stata consegnata nelle mani di Barbara d’Urso. Lei, circonfusa dalla luce bianca che azzera i segni del tempo, esulta: “L’Italia non andrà in guerra in Libia!”. Lui, Matteo Renzi, che quelle stesse luci virano all’arancione, corregge un po’ “Non andremo in guerra in Libia con cinquemila uomini…”. Un po’ come dire: Barbara, paraculi te salutant!
Prima le notizie. E dunque, anche se la folla plaudente sta a Cologno Monzese e non a piazza Venezia, diciamolo: la dichiarazione di guerra non è stata consegnata nelle mani di Barbara d’Urso. Lei, circonfusa dalla luce bianca che azzera i segni del tempo, esulta: “L’Italia non andrà in guerra in Libia!”. Lui, Matteo Renzi, che quelle stesse luci virano all’arancione, corregge un po’ “Non andremo in guerra in Libia con cinquemila uomini…”. Un po’ come dire: Barbara, paraculi te salutant!
Ecco fatto, smentito via Barbara l’ambasciatore Usa che aveva parlato via Corriere della sera, il resto è un burbanzoso scollinare verso l’ottimismo obbligatorio. L’Oscar a Morricone, il bonus bebé, i diritti civili con lo sconto delle adozioni, l’omicidio stradale, fino all’imbarazzante metafora del bicchiere che non è nemmeno mezzo pieno, ma pieno per tre quarti. L’altro quarto se lo sono bevuti loro, si direbbe, e si vede che era roba forte. Tutto bene, tutto bello, tanto che quando Barbara lancia la pubblicità uno si chiede: perché, fino ad ora cos’era? E uno distratto potrebbe confondere banche (tutto bene, tranquilli) e glutei tonici, Salerno-Reggio Calabria (tutto bene, tranquilli) e nuvole di cioccolato… l’anima del commercio. Silvio, insomma, era solo vent’anni di prove generali: lo show vero è questo qui. Notizie brutte? Sì, una: nonne e zie non ci diranno più “vai a lavorare in banca che è un posto sicuro”. Il resto è la sua condanna: “Non posso inventarmi sogni miei, perché devo finire quelli degli altri”. Lo trovaste nei Baci Perugina pensereste: che banalità. E poi le pensioni: tutto bene, tranquilli. Poi, alla fine, uno sprazzo di sincerità: il presidente del consiglio annuncia Ivana Spagna, e tocca dargli ragione: i politici non sono tutti uguali. Qualcuno è pure peggio.
Max Ferrario, che cura il sito Mixtura, ha letto al volo Di rabbia e di vento. Recensione cliccando l’immagine
La prima recensione di Di rabbia e di vento: Francesca Frediani su D di Repubblica… grazie (cliccare per leggere)
 Riassumiamo per chi era distratto o si è perso strada facendo. Silvio vuole Bertolaso, Salvini vuole Marchini, la Meloni vuole la Meloni, Storace corre per disturbare tutti gli altri, Irene Pivetti ha fatto dire a molti romani la fatidica frase “Ah, ma esiste ancora Irene Pivetti?”. La corsa per trovare un candidato del centrodestra, della destra, dei leghisti e di Irene Pivetti a Roma è complicata ed entusiasmante, pare la stiano studiando alla Nasa per essere pronti, tra qualche anno a incontrare gli extraterrestri: se capiscono questa capiranno anche tutto il resto. Per chi dice che la satira è morta, una notazione in margine: lo slogan di Guido Bertolaso per la corsa alla poltrona di sindaco è: “Uniti si vince”, battuta irresistibile. La parola chiave comunque è “primarie”. Senza dirlo a nessuno della sua coalizione, Salvini ha organizzato le sue, per giungere alla conclusione che non ha vinto nessuno (ha vinto Marchini, per la cronaca) e che bisogna fare le primarie. Ecco dunque i prossimi appuntamenti politici della destra nella Capitale.
Riassumiamo per chi era distratto o si è perso strada facendo. Silvio vuole Bertolaso, Salvini vuole Marchini, la Meloni vuole la Meloni, Storace corre per disturbare tutti gli altri, Irene Pivetti ha fatto dire a molti romani la fatidica frase “Ah, ma esiste ancora Irene Pivetti?”. La corsa per trovare un candidato del centrodestra, della destra, dei leghisti e di Irene Pivetti a Roma è complicata ed entusiasmante, pare la stiano studiando alla Nasa per essere pronti, tra qualche anno a incontrare gli extraterrestri: se capiscono questa capiranno anche tutto il resto. Per chi dice che la satira è morta, una notazione in margine: lo slogan di Guido Bertolaso per la corsa alla poltrona di sindaco è: “Uniti si vince”, battuta irresistibile. La parola chiave comunque è “primarie”. Senza dirlo a nessuno della sua coalizione, Salvini ha organizzato le sue, per giungere alla conclusione che non ha vinto nessuno (ha vinto Marchini, per la cronaca) e che bisogna fare le primarie. Ecco dunque i prossimi appuntamenti politici della destra nella Capitale.
GIOVEDÌ 3 MARZO. Primarie dei Balilla. Sono 31, undici dei quali ancora autosufficienti, i Balilla e le Giovani Italiane che voteranno in un gazebo a piazza Venezia, assistiti dalle suorine della carità. I candidati sono tutti morti (favorito Farinacci), ma l’app un tamento ha un grande valore simbolico.
VENERDÌ 4 MARZO. Secondo primarie di Salvini. Soddisfatto dell’affluenza delle prime primarie (quasi 108 persone, ma qualcuno ha votato due volte), Matteo Salvini insiste con la sua idea di chiedere lumi agli elettori. Questa volta i candidati sono un macellaio col porto d’armi pronto a sparare a chiunque non ordini filetto, un tranviere di Bolzano che non aveva mai visto Roma e approfitta delle primarie per visitarla, e Irene Pivetti. Si tratta di primarie aperte, gli elettori dovranno però dimostrare di saper indicare la Brianza su una cartina dell’Europa.
SABATO 5 MARZO. Le primarie di Bertolaso. Vota solo Bertolaso, ma per sbaglio annulla la scheda.
DOMENICA 6 MARZO. Primarie di Giorgia Meloni. Tutti i romani sono invitati. A margine della manifestazione, giochi ginnici, prove di forza, salti nel cerchio di fuoco e premi alle famiglie numerose. Candidati: Giorgia Meloni e Meloni Giorgia, grande incertezza sui risultati, anche se Giorgia Meloni si dice ottimista.
LUNEDÌ 7 MARZO. Primarie di Casa Pound. La simpatica compagine di fancazzisti pelati ha deciso di fare delle primarie private, protette dalle forze dell’ordine e semiclandestine. Incertezza sull’esito delle votazioni, ma si prospetta un testa a testa tra Priebke e Kesselring. Cordoglio per l’esplosione di un gazebo in via Rasella. Lo spoglio dei voti avverrà in via Tasso, dove le schede nulle e bianche saranno torturate per tutta la notte.
MARTEDÌ 8 MARZO. Terze primarie di Salvini. Non contento delle prime due primarie organizzate nella Capitale, il leader leghista ha deciso di riprovarci. I candidati sono un busto in marmo del Foro Italico, in omaggio alla tradizione, un piccolo produttore di taleggio della Val Brembana e il campione nazionale di pesca con la mosca, nomi forti per la rinascita della Capitale. Le operazioni di voto si protrarranno fino a giugno per aumentare l’affluenza ai gazebo, che dovrebbe raggiungere a quel punto almeno le 300 persone, tutte giunte in pullman da Brescia.
Altre manifestazioni elettorali del centrodestra saranno organizzate nei prossimi giorni. Prima però, si terrà un vertice tra gli alleati per decidere alcuni dettagli, come per esempio chi dovrà versare del cianuro nel caffè di Bertolaso, il candidato ufficiale già impegnato nella campagna elettorale e lealmente sostenuto da tutti gli alleati perché, come tutti sanno, “uniti si vince”.
 Bene, gente. Eccolo qui, il nuovo romanzo, il terzo capitolo della serie di Carlo Monterossi, Di rabbia e di vento (Sellerio). Esce tra pochi giorni, il 3 marzo.
Bene, gente. Eccolo qui, il nuovo romanzo, il terzo capitolo della serie di Carlo Monterossi, Di rabbia e di vento (Sellerio). Esce tra pochi giorni, il 3 marzo.
Giallo, noir, fate voi che io non so mai dire la differenza, ma insomma, fa sempre impressione quando un libro va in libreria: non è più tuo, è di tutti quelli che lo leggono, ed è giusto così.
Dico subito che ritroverete il buon Carlo (ovvio) e altri protagonisti che stavano già nei due libri precedenti, come il vicesovrintendente Tarcisio Ghezzi, attivissimo anche fuori servizio, il misterioso Oscar Falcone e altri. E che questa volta l’avventura è nera e dura, una brutta storia di cattivi molto cattivi e di buoni che, come si sa, non sono mai del tutto buoni, ma insomma, è la vita, no?
Milano, per l’occasione, è fredda e battuta da un vento che non se ne va (“E perché c’è quel vento, da giorni, che non smette mai, che frusta tutti, che rende nervosi, che gli vuol dire qualcosa. Ma cosa? Cosa?”). Lo scenario, insomma, è quello solito della città aspirante metropoli, che pare un po’ stordita dopo la festa, l’incoronazione a “capitale morale”, l’ubriacatura di modernità, il ritorno con i piedi per terra: una città con tutto il suo male dentro, dove tutti combattono da soli la loro battaglia. L’inchiesta è difficile, ci si insinuano dentro cose complicate come… vabbé Monterossi la prende sul personale, insomma è rabbioso.
Questa volta non cerca giustizia per sé, ma per una vittima di cui si sente in qualche modo responsabile, di un’innocente che “non se lo meritava” (ma chi se lo merita, poi?). Non dico altro, naturalmente, (qui c’è il risvolto di copertina che farà capire qualcosa di più).
Il libro arriva il 3 marzo nelle librerie del regno. Non so dire perché ci tengo molto, era nato come una specie di blues e poi è andato per la sua strada, perché quando si lasciano in giro dei fili e delle storie poi succede che si riannodino da sé.
Spero di esserci riuscito e che vi piaccia.
I vostri commenti sono sempre graditi.
Buona lettura.
 Si volesse darne una definizione scientifica, ecco qui: “Dicesi Angelino Alfano il vino che manca dal bicchiere mezzo vuoto”. Una questione risolta a sinistra – nella sinistra governativo-renzista, non essendone disponibili altre – con un semplice ribaltamento di senso: il bicchiere è mezzo pieno, e piantatela di rompere le scatole.
Si volesse darne una definizione scientifica, ecco qui: “Dicesi Angelino Alfano il vino che manca dal bicchiere mezzo vuoto”. Una questione risolta a sinistra – nella sinistra governativo-renzista, non essendone disponibili altre – con un semplice ribaltamento di senso: il bicchiere è mezzo pieno, e piantatela di rompere le scatole.
Così si assiste a numerosi testacoda. Il tweet esultante di Matteo Renzi sulla “svolta storica”, e il rapido accodarsi di chi per un’altra legge (la Cirinnà originaria, con adozioni e tutto) si era battuto, forse davvero, forse per finta, nel Partito della Nazione. O alle proteste delle associazioni Lgtb fuori da Senato contrapposto all’accontentarsi dei loro referenti politici dentro al Senato.
Proprio mentre si legifera sulla famiglia (o su una specie di succedaneo per omosessuali), il famoso motto che Longanesi voleva sulla bandiera (“Tengo Famiglia”) andrebbe cambiato e sostituito con “Meglio di niente”. L’ultima trovata sull’obbligo di fedeltà, perdonate il tocco medievale, aggiunge grottesco a grottesco, si voleva differenziare l’unione civile dal matrimonio etero, ed ecco fatto: niente adozione, separazioni più rapide, niente fedeltà. Matrimoni di serie B. Italiani di serie B. Con la postilla che “Meglio di niente” si può dire di tutto, ma non dei diritti, considerati non negoziabili ma, come si vede, negoziabilissimi, e pure al ribasso.
L’unione civile più riuscita, alla fine, è quella tra Matteo Renzi e Denis Verdini: uno accoglie in maggioranza l’altro al grido di “chi ci sta ci sta”, l’altro sembra il gatto col sorcio in bocca. Il “meglio di niente” rimbomba negli echi della propaganda, mentre Verdini e i suoi – la continuazione del berlusconismo con altri mezzi – sembrano dire “meglio di così non poteva andare”.
Resta l’amarissimo sapore di una “questione di coscienza” diventata una questione di fiducia e di allineamento, di disciplina di partito, di bicchiere mezzo vuoto che tocca dichiarare mezzo pieno. Vince Alfano, insomma, e qui si potrebbe divagare. Perché, insomma, si buttò a mare il proporzionale per non dover sentire più parlare di ago delle bilancia e di compromessi, quando l’ago della bilancia aveva il dieci per cento.
E ora, modernissimi ed efficienti, l’ago della bilancia ha lo zero virgola, qualche ministro, molti sottosegretari e guida, di fatto, il governo “più di sinistra degli ultimi trent’anni”, cit. Matteo Renzi, febbraio 2014). E succede così che riflettori, applausi, consenso e piaggeria siano riservatI a Renzi, mentre invece governa Alfano, il vino che manca al bicchiere mezzo vuoto.
(clicca sull’immagine per leggere dal sito di pagina99)
 Attenzione, concentrati, seguite. Test per solutori più che abili. Se ti sposi una donna e sei un uomo hai obbligo di fedeltà. Se sei una donna che sposa un uomo, uguale. Se sei un uomo che si sposa un uomo puoi fare – lo dico in francese – un po’ il cazzo che vuoi, avere sei amanti, due concubine, sei gatti, la moto e un servo muto come Zorro.
Attenzione, concentrati, seguite. Test per solutori più che abili. Se ti sposi una donna e sei un uomo hai obbligo di fedeltà. Se sei una donna che sposa un uomo, uguale. Se sei un uomo che si sposa un uomo puoi fare – lo dico in francese – un po’ il cazzo che vuoi, avere sei amanti, due concubine, sei gatti, la moto e un servo muto come Zorro.
Questa strabiliante libertà cesserà nel momento in cui l’uomo lascia il suo uomo e si sposa con una donna. O una donna lascia la sua donna e si sposa con un uomo. In quel caso, fine pacchia, obbligo di fedeltà con timbro dello Stato. Possono sposarsi tra loro anche i due lasciati, ovvio, ma in quel caso dovranno giurarsi fedeltà (una specie di upgrade). Voluta dall’astuto Alfano e dai suoi concubini dell’Ncd per distinguere le unioni gay da quelle etero (avevano provato prima negando l’obbligo di barba), la norma rischia di scatenate l’Armageddon.
Le coppie etero infedeli invidieranno il finto matrimonio dei gay, le coppie gay fedeli invidieranno il matrimonio vero tra etero, tutti faranno in ogni caso, com’è giusto che sia, quello che gli pare, con la certezza granitica che uno Stato che non sa dare diritti uguali a tutti, non sa dare nemmeno uguali doveri.
 Comunque finisca la questione dei diritti delle coppie omosessuali, una cosa è certa: si è passati in due giorni dal voto “di coscienza” al voto di fiducia, un testacoda notevole dettato da un grave lutto in famiglia: è morto il super-canguro, una creatura inquietante che si nutriva di emendamenti (per lo più gli dava da mangiare Calderoli con le sue milionate di stupidaggini generate da un software, come se Calderoli avesse bisogno di un software per produrre cazzate). Ecco dunque una democrazia matura che riesce ad approvare le sue leggi solo in due modi: o con trucchetti regolamentari come il canguro, o con la fiducia, e vabbé. Ma non sottilizziamo, corriamo ai ripari, piuttosto. Urge cercare altri espedienti tecnici da applicare al Senato in caso di votazione, ora che il canguro è tristemente defunto. Ecco qualche suggerimento.
Comunque finisca la questione dei diritti delle coppie omosessuali, una cosa è certa: si è passati in due giorni dal voto “di coscienza” al voto di fiducia, un testacoda notevole dettato da un grave lutto in famiglia: è morto il super-canguro, una creatura inquietante che si nutriva di emendamenti (per lo più gli dava da mangiare Calderoli con le sue milionate di stupidaggini generate da un software, come se Calderoli avesse bisogno di un software per produrre cazzate). Ecco dunque una democrazia matura che riesce ad approvare le sue leggi solo in due modi: o con trucchetti regolamentari come il canguro, o con la fiducia, e vabbé. Ma non sottilizziamo, corriamo ai ripari, piuttosto. Urge cercare altri espedienti tecnici da applicare al Senato in caso di votazione, ora che il canguro è tristemente defunto. Ecco qualche suggerimento.
Il topo morto – Nascosta nelle pieghe del regolamento, questa procedura parlamentare consente al presidente di turno di sgomberare l’aula per questioni igienico-sanitarie e, nel parapiglia, di votare velocemente a favore del governo. Prassi poco seguita finora, ma considerata legittima da tutti i più grandi costituzionalisti che abbiano partecipato alla Ruota della Fortuna. Spiace un po’ per i titoli dei giornali che saranno più o meno così: “Topo morto, passa la legge”, o addirittura: “La maggioranza vive grazie al Topo morto”, ma si potrà rimediare con una legge sulla stampa (facendola passare al Senato con il Topo morto, ovvio).
Bagni a scomparsa – Piccola forzatura regolamentare, considerata “legittima” da tutti i costituzionalisti toscani. L’installazione a Palazzo Madama di nuovi servizi sarà occasione di conferma e rilancio per la maggioranza di governo al Senato. Si tratta di speciali toelette riservate all’opposizione, a cui però, purtroppo, si blocca la maniglia dall’interno. Attivate nelle ore prima del voto dovrebbero garantire un discreto margine alla maggioranza, tanto più che i cinquestelle, per risparmiare sull’acqua dello scarico e salvare il pianeta, ci entrerebbero in gruppo. Per motivi umanitari e per garantire il sereno svolgimento della democrazia, i commessi riapriranno le porte dei bagni a votazione avvenuta.
Il coguaro – Se il super-canguro sapeva saltare tutti gli emendamenti dell’opposizione, questo qui, semplicemente, se li mangia. Scovato da un oscuro deputato pd all’articolo 3.451, comma 610, riga 11, con rimando alla nota di pagina 813, casualmente scritta in islandese, si tratta di una procedura abbastanza semplice: chi presenta più di un emendamento verrà chiuso in una stanza con il coguaro, opportunamente tenuto a digiuno per giorni. Approvato da tutti i costituzionalisti che recitano poesie di Borges che chissà di chi sono, il coguaro snellirà di parecchio le procedure di votazione.
La peste nera – Rintracciata in un antico regolamento del Senato datato 1634 (un falso?, si chiede qualcuno), questa inconsueta prassi parlamentare consiste nell’infettare gli emendamenti sgraditi al governo e aspettare gli eventi. Quando i senatori dell’opposizione verranno portati via dai monatti, si potrà dare il via alle votazioni. Tutti i costituzionalisti tifosi della Fiorentina sostengono che la prassi è un po’ desueta, ma in fondo corretta e funzionale al buon svolgimento della democrazia parlamentare.
Verdini da riporto – Se tutte le procedure democratiche sopra descritte non dovessero funzionare, non resta che l’estrema ratio: affidarsi a Denis Verdini. Partendo alla mattina di buon ora, attraverso i campi, nella bruma, Verdini porterà a casa verso il tramonto qualche senatore disposto a votare con la maggioranza. Si tratta di una prassi parlamentare a metà strada tra l’evangelizzazione, l’ipnosi e la caccia al fagiano. Tutti i costituzionalisti dotati di slide concordano: funziona.
 L’impressionante ottovolante delle Borse, ieri meno settantadue, oggi più dodici, deciso rimbalzo, miliardi bruciati, doccia scozzese, eccetera eccetera (riempite a piacere), getta tutti in uno stato di profonda incertezza. Molti credono che questo non avrà alcuna incidenza sulla vita quotidiana delle persone, ma si sbagliano. Abbiamo chiesto alle maggiori agenzie di rating un voto su alcuni dei principali asset italiani, ed ecco il risultato.
L’impressionante ottovolante delle Borse, ieri meno settantadue, oggi più dodici, deciso rimbalzo, miliardi bruciati, doccia scozzese, eccetera eccetera (riempite a piacere), getta tutti in uno stato di profonda incertezza. Molti credono che questo non avrà alcuna incidenza sulla vita quotidiana delle persone, ma si sbagliano. Abbiamo chiesto alle maggiori agenzie di rating un voto su alcuni dei principali asset italiani, ed ecco il risultato.
Banchiere italiano – Questo titolo, molto contrastato, non sembra dare le garanzie adeguate. Il banchiere italiano passa metà del suo tempo a dire ai giornali che va tutto benissimo e l’altra metà in sala rianimazione dopo aver visto le quotazioni del suo istituto. Se avete questo titolo in portafoglio, vendere subito o affibbiare a qualche obbligazionista inesperto, magari cieco. Giudizio: BB–
Banchiere italiano toscano – Per una stranissima distorsione psicogeografica, le banche situate nel raggio di cinquanta chilometri da Rignano sull’A rno, misteriosamente, vanno benissimo. Qualcuno dice che il fenomeno sia dovuto alle onde gravitazionali, qualcuno invece dice che c’entra il sottosegretario Lotti. L’investitore valuti attentamente, ma il consiglio è di comprare. Giudizio: AAA+++
Vedova con pensione di reversibilità – Titolo in picchiata in questi giorni. Anche se il governo smentisce, il ministro Poletti smentisce, tutti negano, non è poi così difficile per gli italiani veder volare all’orizzonte un enorme uccello padulo chiamato “r a z i on a l i zz a z i o ne ”. Il prospetto illustrativo dice taglio non ci sarà, tranquilli. Un po’ come accaduto alla Sanità: il taglio non c’è – e vergogna chi lo dice –ma intanto, guarda un po’, vi pagate le analisi. Titolo rischiosissimo anche a lungo termine, vendere subito. Giudizio B—
Ricercatore italiano – Titolo molto interessante, perché assai vivace su molti mercati. Per esempio va forte in Olanda, Germania, Gran Bretagna, mentre in Italia potete osservarlo nelle Università, impegnato a litigare per due matite e un microscopio. Per diventare re del listino, questi titoli devono superare decine di dure prove: emigrare, lavorare all’estero, ottenere premi, riconoscimenti, finanziamenti da istituzioni internazionali, fino alla pacca sulla spalla della ministra Giannini, fiera di non averli finanziati lei. Consiglio: comprare ma non reimmettere sul mercato italiano dove finirebbero a scannarsi per due buoni pasto. Giudizio AA+
Cassintegrato – Ecco un investimento un po’ rischioso, che si consiglia di bilanciare nel proprio portafoglio, ma soprattutto, attenti alle quotazioni! Secondo le slide del promotore, le ore di cassa integrazione sono quasi dimezzate, mentre secondo gli osservatori più attenti si sono dimezzate solo le provincie che forniscono i dati, per cui il valore del titolo non è chiaro, e i cassintegrati sono molti di più di quanto si dica ufficialmente. Titolo sconsigliato per investimenti a lungo termine. Giudizio BB–
Diciottenne italiano – Investimento dinamico e interessante, incassa un dividendo di 500 euro come regalo di compleanno. Titolo adatto alla speculazione di breve termine, perché già a diciannove anni sarà sospeso per eccesso di ribasso. Giudizio: AA++
Ministro – Fino a poco fa titolo solido e di sicuro realizzo, sta lentamente perdendo appeal, ma resta tra gli asset migliori. Pochi governi al mondo hanno un ministro degli Interni che lotta come un leone da mesi contro un disegno legge del governo, per esempio, e non mancano i casi Franceschini (inseguito dagli archeologi) o Giannini (inseguita dai ricercatori), o Poletti (inseguito dai numeri). Il consiglio è sempre quello: cercare di bilanciare gli investimenti. Per un ministro che parla troppo, per esempio, acquisire un paio di sottosegretari centristi o verdiniani. Giudizio: AA–
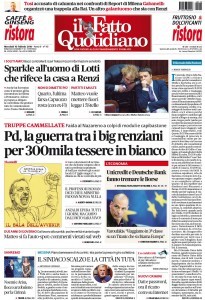 Si intitola #ventiquattro. Dura due minuti e 54 secondi, la musichetta è evocativa e incalzante stile pubblicità delle merendine. È un videoclip per collezionisti di kitsch, estimatori del culto della personalità e renzisti post-ironici. Se non avete ben sviluppate queste caratteristiche riderete un bel po’, perché Kim Jong-Un, Silvio Berlusconi, Maradona, e Gengis Khan, in quanto a ego, ne escono come dilettanti.
Si intitola #ventiquattro. Dura due minuti e 54 secondi, la musichetta è evocativa e incalzante stile pubblicità delle merendine. È un videoclip per collezionisti di kitsch, estimatori del culto della personalità e renzisti post-ironici. Se non avete ben sviluppate queste caratteristiche riderete un bel po’, perché Kim Jong-Un, Silvio Berlusconi, Maradona, e Gengis Khan, in quanto a ego, ne escono come dilettanti.
Il video è piazzato in bella mostra nel sito ufficiale-ufficialissimo del governo italiano. E “ventiquattro” sarebbero i mesi del governo di Matteo Renzi, che vedrete nel video. Nel senso che uno vorrebbe anche guardare la clip celebrativa di cotanta abilità di comando, ma purtroppo c’è sempre Renzi in primo piano, si finisce a vedere solo lui e vien da dire: oh, spostati, non vedo niente! C’è Matteo con (prendete fiato): bambini, operai, alpini, pallavoliste, Obama, mamme, imprenditori, Cameron, marinai, astronauti, registi ex “de sinistra”, tenniste, frecce tricolori, Putin, Bono degli U2, pompieri, studenti, leader mondiali e tornitori. Da deplorare l’assenza di trapezisti, vigili urbani e serial-killer, ma non si può avere tutto. L’unico che compare senza Matteo al fianco è il presidente Mattarella durante il giuramento e si intende: questo l’ha fatto Matteo, prima mica esisteva. Non si parla quasi mai, ma se si parla – indovinate! – parla lui: di quanto sono belle le riforme, di quanto è bravo, di quanto a tratti commosso e turbato, che l’attore – se serve – ha pure i toni drammatici. Il video si può vedere anche su Youtube, ovvio, perché la propaganda è virale. Siamo smart, pop e friendly. E anche un po’ paraculy, dato che sotto il filmato campeggia la scritta: “I commenti sono disabilitati per questo video”. Censura preventiva, insomma. A prova di gufo.
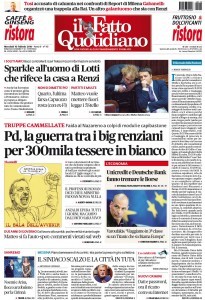 Ora che Giuseppe Sala (Beppe) è ufficialmente il candidato sindaco di Milano per la sinistra, il centro sinistra, il centro-centro-sinistra, il centro, i liberali, gli imprenditori, gli immobiliaristi, i poteri deboli, i poteri forti, e Matteo Renzi (astenute le mondine), può cominciare a comporsi il grande Risiko delle elezioni per il sindaco della capitale morale. Già sul palco del teatro milanese in cui è stato proclamato vincitore delle primarie si intrecciavano piani arditi e spericolate strategie. Esempio? La sinistra voterà per Sala? E se no per chi? E Sala saprà fare ciò per cui è stato incoronato, cioè attrarre i moderati di destra? E la destra saprà fare qualcosa di meglio che candidare a sindaco una specie di Sala in sedicesimo che faccia e dica tutto quello che fa e dice Sala, ma con dietro il sorriso beato del fu Silvio? Tutte domande che avranno risposta in pochi mesi, ma intanto, per portarci avanti col lavoro (siamo pur sempre a Milano…) conviene esplorare la nuova frontiera, cioè il divertente puzzle di liste civiche, liste di fiancheggiamento, gruppi di sostegno, candidature di appoggio e altro ancora. Ecco una mappa possibile.
Ora che Giuseppe Sala (Beppe) è ufficialmente il candidato sindaco di Milano per la sinistra, il centro sinistra, il centro-centro-sinistra, il centro, i liberali, gli imprenditori, gli immobiliaristi, i poteri deboli, i poteri forti, e Matteo Renzi (astenute le mondine), può cominciare a comporsi il grande Risiko delle elezioni per il sindaco della capitale morale. Già sul palco del teatro milanese in cui è stato proclamato vincitore delle primarie si intrecciavano piani arditi e spericolate strategie. Esempio? La sinistra voterà per Sala? E se no per chi? E Sala saprà fare ciò per cui è stato incoronato, cioè attrarre i moderati di destra? E la destra saprà fare qualcosa di meglio che candidare a sindaco una specie di Sala in sedicesimo che faccia e dica tutto quello che fa e dice Sala, ma con dietro il sorriso beato del fu Silvio? Tutte domande che avranno risposta in pochi mesi, ma intanto, per portarci avanti col lavoro (siamo pur sempre a Milano…) conviene esplorare la nuova frontiera, cioè il divertente puzzle di liste civiche, liste di fiancheggiamento, gruppi di sostegno, candidature di appoggio e altro ancora. Ecco una mappa possibile.
Gli anti-Sala per Sala – Sconfitti alle primarie ma non paghi, brillano per realismo e pragmatismo e sperano di ottenere buoni risultati con i quali poi condizionare Sala, pur essendo contrari a Sala. Il diabolico piano è di non amare Sala ma di vantarsi il giorno dopo le elezioni comunicando al mondo che se Sala ha vinto è anche merito loro.
Forza Italia per Sala – Spesso la calma è la virtù dei forti, ma nel caso della destra milanese pare più la virtù dei morti. Il geniale intento di presentare un candidato sindaco qualche giorno dopo l’elezione del sindaco (giugno? Ma fa caldo, forse settembre) era suggestiva ma un po’troppo creativa. Dunque, pare, si dice, si mormora, insomma è certo, che la destra presenterà Stefano Parisi, un manager (come Sala), che ha lavorato per una giunta di destra (come Sala), ma senza la medaglietta dorata di Expo. In sostanza una fotocopia sbiadita, che spingerà molta parte dell’elettorato di destra a votare per l’originale (Sala) e non per la copia (precedente: quando al comune di Firenze la destra verdiniana oppose al candidato Renzi un ex portiere del Milan).
I gondolieri per Sala–Essendo una delle proposte forti di Sala ( l’unica che si sappia) quella di riaprire i Navigli, la lobby dei possessori di gondole lo appoggerà senza meno. Si tratta dello 0,0000001 degli elettori milanesi, più di quelli di sinistra con le idee chiare, ma meno dei cinesi.
Corrado Passera per Sala – Se anche la destra milanese avesse per avventura qualche chance di vittoria, ci pensa l’a itante ex-banchiere a distruggerla. Da settimane la città è tappezzata di manifesti con Corrado Passera che dice “Basta con la sinistra”, cioè la stessa cosa che direbbe un candidato berlusconian-salviniano. Vedere la destra fare quello che di solito fa la sinistra (cioè dividersi su due liste contrapposte) stringe il cuore e riempie di speranza. Si tratta in ogni caso di un oggettivo appoggio a Sala.
5Stelle per Sala –Candidando una perfetta sconosciuta, Patrizia Bedori, grazie al voto di trecento militanti, il movimento di Grillo decide in pratica di non giocare la partita milanese, ricordando a tutti che non giocare è il modo migliore per non perdere. Può essere, come dice qualcuno, che i 5Stelle diranno la loro in un eventuale ballottaggio, dividendosi tra chi andrà al mare e chi andrà in montagna.
Sala per Sala – È la componente più forte a sostegno di Giuseppe Sala. Comprende lui, i famigliari, i militanti del Pd che obbediscono alle indicazioni di Renzi, una buona fetta di Cielle, liberali, moderati, ex elettori di destra ed ex assessori della giunta Pisapia in cerca di lavoro.
 Sono le 23 e sei minuti quando Giuseppe Sala, detto Beppe, entra tra gli applausi nel Teatro Elfo Puccini, acclamato come nuovo sindaco di Milano e non – come la cronaca vorrebbe – soltanto candidato. Parte a tutto volume Heroes di David Bowie, e vabbé, dettagli. La forbice che lo divide dalla seconda classificata. Francesca Balzani, non è ampia come si credeva (24.961 voti contro 20.056), e anche il terzo classificato, Pierfrancesco Majorino se l’è cavata bene (13.589). Del quarto aspirante, Antonio Iannetta, votato più o meno dai parenti (432), non è il caso di dire, ma insomma, quel che si mormora in teatro, dalla parte degli anti-Sala, è che il tafazzismo ha vinto ancora e che le due sinistre di Balzani e Majorino, correndo divise, consegnano Milano al manager spinto da Renzi, votato da Cl, endorsato da Verdini e incoronato re dell’Expo.
Sono le 23 e sei minuti quando Giuseppe Sala, detto Beppe, entra tra gli applausi nel Teatro Elfo Puccini, acclamato come nuovo sindaco di Milano e non – come la cronaca vorrebbe – soltanto candidato. Parte a tutto volume Heroes di David Bowie, e vabbé, dettagli. La forbice che lo divide dalla seconda classificata. Francesca Balzani, non è ampia come si credeva (24.961 voti contro 20.056), e anche il terzo classificato, Pierfrancesco Majorino se l’è cavata bene (13.589). Del quarto aspirante, Antonio Iannetta, votato più o meno dai parenti (432), non è il caso di dire, ma insomma, quel che si mormora in teatro, dalla parte degli anti-Sala, è che il tafazzismo ha vinto ancora e che le due sinistre di Balzani e Majorino, correndo divise, consegnano Milano al manager spinto da Renzi, votato da Cl, endorsato da Verdini e incoronato re dell’Expo.
Corsi e ricorsi: cinque anni fa (era il 31 maggio del 2011), in quello stesso teatro si celebrava il battesimo di una delle pochissime cose di sinistra funzionanti in Italia, l’esperienza arancione di Giuliano Pisapia. E oggi, senza malizia, se ne celebra il funerale. Il candidato sindaco del centro sinistra a Milano (o del pd tout-court) è stato per anni il direttore generale del Comune gestione Moratti. Come dire un ribaltone notevolissimo. Lo spirito quasi risorgimentale che aveva accolto Pisapia muta oggi in Restaurazione piena, il che – dice qualcuno – racconta bene di come la moderna città di Milano non sia così diversa dalla morta gora della politica romana: un uomo di destra alla guida della sinistra.
Sul palco del Teatro Elfo Puccini domina quel che ha dominato – al netto di qualche minuscolo sgambetto – durante la campagna elettorale, cioè un appiccicoso fair-play. Nessuno tira in ballo i cinesi beccati a fotografare la scheda elettorale – come si fa in certi posti calabri e siciliani – e la loro massiccia partecipazione (le interviste e i filmati sono a tratti esilaranti), ed è giusto così: nessuna polemica, nessun complottismo. Milano, da sempre laboratorio politico nazionale (da qui venne Craxi, da qui venne Silvio buonanima, da qui venne anche l’eccezione Pisapia), si mostra oggi allineata e coperta alle scelte nazionali, e Sala è un sindaco perfetto per il renzismo: non è un politico (basta Lui), non è uno stratega (basta Lui), è un funzionario (basta a Lui), una specie di prefetto, una continuazione di Matteo Renzi con altri mezzi. Perfetto. Assai divertente lo scenario se verrà confermato come sfidante di destra quello Stefano Parisi che fu anche lui direttore generale della Milano morattiana, una specie di derby Milan-Milan, o Inter-Inter. Insomma, due candidati, uno di destra e uno di sinistra, con la stessa identica storia: di destra. Fin qui la bella serata a teatro.
E poi c’è Milano. A votare alle primarie sono andati in 60.900, bella cifra anche se lontana dai 67.000 che votarono a quelle vinte da Pisapia. Più che i numeri, in questo caso parla il clima: poco entusiasmo, battimani moderati, nessuna esultanza, come avviene in quelle partite di cui si sa già il risultato. E anche le promesse elettorali, tutte un po’ annacquate: scoperchiare i Navigli (Sala) o mezzi pubblici di superficie gratis (Balzani) non sono cose che scaldano i cuori come cacciare la “junta” Moratti dalla città. Non si farà né l’una né l’altra cosa, ovvio, e anche tutte le belle parole sulle periferie resteranno periferiche. Milano, con un certo spirito conservativo, si aggrappa al suo sogno appena finito, l’Expo, si affida a chi l’ha saputo portare fino in fondo e a chi ne ha sostenuto la narrazione di operazione vincente. Anche le richieste di far vedere i conti di quella vittoria, per ora soltanto presunta, sono cadute nel vuoto, e si capisce ora che erano soltanto piccole schermaglie. Brindano oggi i renziani di stretta osservanza, Cl che si credeva ferita a morte e ha ora un candidato sindaco vincente, i poteri forti che con un manager tratteranno come in un consiglio d’amministrazione, e i critici del “partito della Nazione” che potranno tuonare il loro noiosissimo “io l’avevo detto”.
Il teatro si svuota lentamente tra chiacchiere e sigarette fumate al freddo: qui c’era stato il battesimo della sinistra al governo della città, qui si è svolto il festante funerale, e di sinistra a Milano non si parli più. Anzi no. Al bar del teatro, se chiedi una Coca-cola ti dicono che hanno solo quella de L’Altromercato, equo e solidale. Ecco. Parola d’ordine: accontentarsi.
 E dunque bene, bello, evviva. Il piccolo Murtaza incontrerà Leo Messi. Il calciatore più famoso del mondo (da anni) abbraccerà il bambino più famoso del mondo (da giorni), un piccolo, tenerissimo cinquenne, afghano della provincia di Ghazni. Suo zio (afghano che vive in Australia) ha postato su Facebook le foto di Murtaza che gioca nella neve con una casacca ricavata da una busta di plastica, a righe bianche e azzurre (nazionale argentina), il numero dieci, il nome di Messi. Tenerezza planetaria e missione umanitaria: la Federcalcio afghana fa sapere che Murtaza volerà a Barcellona (che Messi possa volare in Afghanistan è escluso), e noi vedremo presto altre foto: un bambino felice, un campione tanto umano. Rallegriamoci. Il piccolo Murtaza, insomma, ha svolto egregiamente (e da innocente, ovvio) il ruolo che su Facebook e nella grande fabbrica delle emozioni collettiva svolgono i gattini. Teneri, fragili, innocenti, un po’ pazzi. Un bambino (meglio: un bambino povero che tira calci a un pallone nella neve), un sogno, una fotografia, una grande consolazione per tutti.
E dunque bene, bello, evviva. Il piccolo Murtaza incontrerà Leo Messi. Il calciatore più famoso del mondo (da anni) abbraccerà il bambino più famoso del mondo (da giorni), un piccolo, tenerissimo cinquenne, afghano della provincia di Ghazni. Suo zio (afghano che vive in Australia) ha postato su Facebook le foto di Murtaza che gioca nella neve con una casacca ricavata da una busta di plastica, a righe bianche e azzurre (nazionale argentina), il numero dieci, il nome di Messi. Tenerezza planetaria e missione umanitaria: la Federcalcio afghana fa sapere che Murtaza volerà a Barcellona (che Messi possa volare in Afghanistan è escluso), e noi vedremo presto altre foto: un bambino felice, un campione tanto umano. Rallegriamoci. Il piccolo Murtaza, insomma, ha svolto egregiamente (e da innocente, ovvio) il ruolo che su Facebook e nella grande fabbrica delle emozioni collettiva svolgono i gattini. Teneri, fragili, innocenti, un po’ pazzi. Un bambino (meglio: un bambino povero che tira calci a un pallone nella neve), un sogno, una fotografia, una grande consolazione per tutti.
Un altro bambino famoso: Aylan, un’altra foto, la spiaggia di Lesbo e lui riverso lì come un fagotto. Scosse le coscienze, si disse, scosse il mondo. Venne usato in ogni modo. Matteo Renzi, che in altre occasioni ha tuonato la sacrosanta frase «non si strumentalizza chi muore», lo mostrò alla folla durante il comizio di chiusura della festa dell’Unità a Milano (6 settembre scorso) dicendo alla regia: «Franco fai vedere la foto di quel bambino?…». Aylan era in quel caso un simbolo e un memento, e una tragedia certo. Ma era una tragedia che serviva mostrare. Aylan ha salvato altri bambini? Oppure è servito solo per la polemica e la battaglia politica? E i bambini che ora annegano nell’Egeo, perché ci sembrano meno annegati di quelli che annegavano (e ancora annegheranno) nel Canale di Sicilia? Forse perché siamo cinici? O perché la commozione, come i gattini di Facebook, dura pochi secondi? O perché non siamo bambini, forse?
Fatto personale: nel 2003 in un corsivo per Ballarò, mostrai, in un veloce montaggio, piccoli afghani nascosti in una grotta sotto i bombardamenti americani. Carlo Giovanardi, ai tempi favorevole a quelle bombe che portavano democrazia (s’è visto…) si imbizzarrì di brutto e diede dei “nazisti” agli autori del corsivo, dicendo che i nazisti, Hitler, Goebbels, usavano i bambini per la propaganda. Anni dopo (oggi) Carlo Giovanardi è (ri)sceso in piazza insieme ad altre migliaia di persone per dire che i bambini non possono essere adottati da una coppia omosessuale, che hanno bisogno di un papà e una mamma, che non possono nascere da uteri in affitto, ma solo di proprietà, con l’argomento forte che ‘sto affitto si paga a madri poverissime – ma sul perché le madri siano poverissime, e come aiutarle, nemmeno una parola.
Visto? I bambini servono sempre. Potevi bombardarli, sì, ma non dargli due genitori dello stesso sesso. I bambini non sono uomini piccoli, anzi. Sono uomini che valgono di più, a livello simbolico. Sono gattini su Facebook. Sono una molla sicura non tanto di indignazione, ma di pietà. Sì, sono perfetti generatori di compassione. E allora ecco: i bambini siriani dietro i fili spinati europei. O che lavorano in Turchia per le griffe della moda. Quelli “costretti a farsi esplodere” da Boko Haram, quelli che piangono quando Angela Mekel dice «Non possiamo accogliere tutti», e poi però vengono accolti e arriva il fotografo.
Ecco fatto. I bambini piacciono sempre, inteneriscono, sono la perfetta incarnazione dell’innocente davanti all’adulto colpevole. Ma tutto questo funziona per i singoli bambini. Murtaza. Aylan. Non i bambini, insomma, ma quel bambino, in quella particolare situazione, in quella particolare foto, in quel particolare contesto, dove possa essere tirato di qua e di là a seconda degli intenti politici, o polemici, o di propaganda. Poi ci sono i bambini. Gli altri, tutti gli altri. Per esempio i tre milioni di bambini sotto i cinque anni che ogni anno muoiono per fame e malnutrizione, per acqua putrida, perché il mondo non è attrezzato per nutrirli. Ottomila al giorno. Difficili persino da immaginare, troppi gattini per una pagina Facebook, meglio commuoversi sui casi singoli, il privato paga sempre, il collettivo disturba, la massa non fa notizia. E dunque? Una moratoria sui bambini? Silenzio stampa? Cinismo e far finta di niente?
Non è un discorso per bambini, certo, è un discorso per mass-media, e quindi morirà nel vuoto, chissenefrega, irrilevante, che noia, pussa via. Perché sarà anche vero che i bambini ci guardano, ma è soprattutto vero che noi guardiamo loro. Che li usiamo, che li esibiamo alla bisogna. Sofferenti, o morti, o vivi ma vietati, o vivi ma da regolamentare, con o senza stepchild adoption. Che servono per la pancia e per i cuore. Che servono ai sospiri e alle lacrime, a placare le coscienze e a confermarci la nostra precaria umanità contemplativa.
 “Pianga, Malaussène, pianga in modo convincente. Sia un buon capro”. Chi ricorda le avventure di Benjamin Malaussène, il capro espiatorio perfetto di Daniel Pennac, può farsi un’idea abbastanza precisa del potere e dei suoi costi umani. Costi per i capri espiatori, ovvio, gente sacrificabile ai piani bassi o medi della piramide, utilissimi per salvare il vertice irritato dagli errori dei sottoposti, che deve risultare intonso. Così, quando riecheggia il classico dei classici, la frase ultimativa e minacciosa “chi ha sbagliato pagherà”, staffilata nei comunicati e nelle dichiarazioni dal Lider Maximo, c’è qualcuno che trema: l’antica saggezza popolare sa che forse qualcuno pagherà, sì, ma non necessariamente chi ha sbagliato. Anzi, pagherà chi è sacrificabile e disposto a sacrificarsi. In soldoni, e tagliando la questione con l’accetta, chi è pagato per pagare nel caso (frequente) vada storto qualcosa. Il mondo ha bisogno di Malaussène, e il mondo renziano ancor di più.
“Pianga, Malaussène, pianga in modo convincente. Sia un buon capro”. Chi ricorda le avventure di Benjamin Malaussène, il capro espiatorio perfetto di Daniel Pennac, può farsi un’idea abbastanza precisa del potere e dei suoi costi umani. Costi per i capri espiatori, ovvio, gente sacrificabile ai piani bassi o medi della piramide, utilissimi per salvare il vertice irritato dagli errori dei sottoposti, che deve risultare intonso. Così, quando riecheggia il classico dei classici, la frase ultimativa e minacciosa “chi ha sbagliato pagherà”, staffilata nei comunicati e nelle dichiarazioni dal Lider Maximo, c’è qualcuno che trema: l’antica saggezza popolare sa che forse qualcuno pagherà, sì, ma non necessariamente chi ha sbagliato. Anzi, pagherà chi è sacrificabile e disposto a sacrificarsi. In soldoni, e tagliando la questione con l’accetta, chi è pagato per pagare nel caso (frequente) vada storto qualcosa. Il mondo ha bisogno di Malaussène, e il mondo renziano ancor di più.
Ora, ci siamo mestamente abituati all’idea che nel Paese dei misteri non si sappia ancora tutto su cosucce come Piazza Fontana, Ustica, le grandi stragi, il sequestro Moro, varie ed eventuali. Però stupisce che non si riesca a sapere bene e con esattezza chi ha fatto installare pannelli nascondi-cazzo alle statue del musei capitolini in occasione della visita del presidente iraniano, un’indagine per cui, obiettivamente, non servirebbero Philip Marlowe o Sherlock Holmes. Le ultime notizie dicono che pagherebbe (con una specie di commissariamento e poi col pensionamento) il capo del Cerimoniale di Palazzo Chigi, signora Ilva Sapora, anche se la dinamica dei fatti non è chiara, e la relazione interna (la famosa inchiesta annunciata come una specie di Armageddon, condita di “chi ha sbagliato pagherà” e di “l’ira di Renzi”) parla di misunderstanding (in inglese fa fico, sì, ma vuol dire che ci sono state incomprensioni). Quali incomprensioni risulta incomprensibile, non ce le dicono, non le chiariscono nemmeno ora che sarebbero chiarite. Insomma, basta un po’ di fantasia per immaginare i quiproquò, gli ordini incrociati che si confondono, le entrare e le uscite come in una pièce di Feydeau, le direttive capite male, applicate peggio e via così. Niente, non sapremo mai, a conferma che – grandi o piccoli – i misteri restano misteri.
Sul capro espiatorio di turno, intanto si addensano le nubi del sospetto e si rilanciano colpe: la signora Sapora-Malaussène non sa l’inglese, dettaglio che lei stessa ammette e che crea grande scandalo sui media. Possibile? Davero-davero? Dunque l’ordine di coprire le statue è stato dato in inglese? Ed è per confonderla e gettarla nello sconforto che nella severissima (!) indagine interna si usa la parola misunderstanding, invece di dire semplicemente “confusione”? E se la signora – provvidenzialmente vicina alla pensione – non sa l’inglese (reato federale) non lo sapeva nemmeno prima, giusto? Quando faceva, senza confusioni e misunderstanding il suo lavoro di capo del Cerimoniale di Palazzo Chigi.
Insomma, il tutto non pare una cosa seria, ma intanto la faccenda è scivolata dalla prima pagina (dove campeggiava anche sulla stampa estera) alle pagine interne, poi smotterà nei trafiletti delle “brevi”, vicino al cane che sa contare e al prosciutto di maiale clonato, e noi resteremo lì, felicemente immemori, senza risposte a una faccenda che ha avuto eco mondiale e che tra qualche giorno sarà derubricata a quisquilia. Perfetto. Il “chi ha sbagliato pagherà” resterà sospeso come la nebbia sui campi al mattino presto, “l’ira di Renzi” si concentrerà su nuove questioni, altri Malaussène si faranno strada, in attesa di essere sacrificati, e chi ricorderà la faccenda in futuro sarà considerato un fastidioso provocatore. Insomma, tutto chiarissimo.
 Ruspante come una sagra di paese e sbuffante come una trebbiatrice in action, il ministro del lavoro Giuliano Poletti lo aveva detto: i ragazzi italiani fanno troppe vacanze, non come lui che mungeva le mucche a sei anni, o i suoi figli che d’estate andavano a spostare le cassette della verdura. Insomma, una lezione di vita, una madeleine degli anni Cinquanta, tipo quei nonni che dicono ai nipoti: “a te ti ci vorrebbe una bella guerra”. Ecco, il folklore è sistemato, e passiamo alle leggi dello Stato, piuttosto folkloristiche anche loro. Perché con la famosa “buona scuola” dovrebbe partire anche quella “innovazione storica” (cfr, la ministra Giannini) che è l’alternanza scuola-lavoro, diventata obbligatoria. Un discreto numero di ore (400 per gli istituti tecnici e 200 per i licei, su tre anni) in cui i ragazzi, alla fine della scuola, cioè a giugno, verranno smistati in aziende, consorzi, associazioni, istituzioni culturali, fabbriche, cascine, musei, start-up (sempre metterci le start-up, che fa fico) eccetera, eccetera. Quanti ragazzi? Almeno mezzo milione quest’anno e, a regime, un milione e mezzo: una specie di migrazione biblica.
Ruspante come una sagra di paese e sbuffante come una trebbiatrice in action, il ministro del lavoro Giuliano Poletti lo aveva detto: i ragazzi italiani fanno troppe vacanze, non come lui che mungeva le mucche a sei anni, o i suoi figli che d’estate andavano a spostare le cassette della verdura. Insomma, una lezione di vita, una madeleine degli anni Cinquanta, tipo quei nonni che dicono ai nipoti: “a te ti ci vorrebbe una bella guerra”. Ecco, il folklore è sistemato, e passiamo alle leggi dello Stato, piuttosto folkloristiche anche loro. Perché con la famosa “buona scuola” dovrebbe partire anche quella “innovazione storica” (cfr, la ministra Giannini) che è l’alternanza scuola-lavoro, diventata obbligatoria. Un discreto numero di ore (400 per gli istituti tecnici e 200 per i licei, su tre anni) in cui i ragazzi, alla fine della scuola, cioè a giugno, verranno smistati in aziende, consorzi, associazioni, istituzioni culturali, fabbriche, cascine, musei, start-up (sempre metterci le start-up, che fa fico) eccetera, eccetera. Quanti ragazzi? Almeno mezzo milione quest’anno e, a regime, un milione e mezzo: una specie di migrazione biblica.
C’è anche il manuale d’uso, complesso e trionfalistico (vi risparmio la retorica renzista e le parole inglesi), ricco di spiegazioni. Ad esempio si istituisce il “Registro nazionale delle imprese” disposte a fornire accoglienza e formazione, ma poi si dice (pagina 16) che non è necessario stare in quell’elenco per ospitare studenti in cerca di stage: basta che ve li pigliate.
Tutto pomposo e trionfante, tutto bello e luccicante. Finché non si entra in una scuola.
Se gli istituti tecnici conoscono un po’ la questione, la sarabanda riguarda i licei. Dove mandare migliaia di sedicenni affamati di vacanze dopo nove mesi di lezioni? Dove fargli incontrare il mondo del lavoro che li stupirà con il suo sistema etico, produttivo, culturale? Mistero. Nelle circolari dei presidi, nelle assemblee dei genitori, nelle mail accorate che girano tra le famiglie c’è un’agitazione che somiglia al panico. Musei, associazioni, istituzioni culturali non possono assorbire una simile massa di “volontari” obbligati ad esserlo, e a volte non vogliono, o non possono. Perché, dannazione, serve un tutor (eh, già) educativo, e anche un tutor (eh, già) aziendale… insomma, serve gente che ci lavori, e chi paga non si sa. I ragazzi, ovvio, lavorerebbero gratis, che forse è il fine ultimo del disegno: abituarli. E poi servono assicurazioni varie, che un liceale di Caserta o di Sondrio non esploda in un laboratorio di chimica o non finisca sotto un trattore.
Nelle scuole, specie nei licei, è il si salvi chi può. Genitori perplessi si chiedono come mai il figlio, piegato per mesi su Ovidio, debba finire in una stalla o in un ufficio a completare il proprio “percorso formativo”, i ragazzi ridono e scuotono la testa, i presidi fanno miracoli di creatività. Tipo inventare “l’impresa simulata”, cioè in molti casi finirà con gli studenti in classe, in giugno, che fanno finta di fare un’azienda: siamo a un passo dall’Allegro chirurgo, ma meno divertente e, soprattutto, obbligatorio. Le belle parole inglesi, la strabiliante riforma, le sorti luminose e progressive, i toni da rivoluzione culturale (via, via, tutti spostare cassette, non avete sentito il sor Poletti?) si infrangono contro la realtà. Le lettere dei presidi ai genitori per chiedere se non abbiano per caso un’aziendina, un’attività, un laboratorio dove piazzare qualche alunno e far bella figura nelle statistiche, stringono il cuore. La buona scuola, l’alternanza, la formazione, il project work, il problem solving, l’action-oriented learning finiscono lì: dai, su, prendete qualche liceale, fategli fare le fotocopie ed è fatta: siamo o non siamo modernissimi?
 “Affiliato” non è una bella parola, in italiano. Non è colpa del vocabolario, ma della storia: “affiliato” sa di società segrete, di club non proprio commendevoli, di patti oscuri. Dunque diciamo che Denis Verdini, che maneggia bene quasi tutto – finché non lo beccano – lascia un po’ a desiderare per quanto riguarda le scelte lessicali: “Non saremo una componente del Pd, ma qualcosa che si affilia”. E ancora: “Andremo per conto nostro ma affiliati”. Insomma, una sottomarca, un farmaco generico: vuole l’aspirina? Oh, no, l’aspirina no, mi dia una cosa uguale ma con un altro nome. Et voilà Verdini y los Verdinos. Spesso il linguaggio giornalistico è pigro e si ferma al primo canone, e quindi Verdini y los Verdinos diventano “stampella” di Renzi, del suo governo, delle sue riforme eccetera eccetera, una specie di pronto intervento, di squadra di emergenza che aspetta col motore acceso, e se qualcuno del pd dovesse fare i capricci e battere i piedi, ecco che arriverebbero loro – magari con le sirene e i lampeggianti – a risolvere la questione: è bello avere degli amici, pardon, degli affiliati.
“Affiliato” non è una bella parola, in italiano. Non è colpa del vocabolario, ma della storia: “affiliato” sa di società segrete, di club non proprio commendevoli, di patti oscuri. Dunque diciamo che Denis Verdini, che maneggia bene quasi tutto – finché non lo beccano – lascia un po’ a desiderare per quanto riguarda le scelte lessicali: “Non saremo una componente del Pd, ma qualcosa che si affilia”. E ancora: “Andremo per conto nostro ma affiliati”. Insomma, una sottomarca, un farmaco generico: vuole l’aspirina? Oh, no, l’aspirina no, mi dia una cosa uguale ma con un altro nome. Et voilà Verdini y los Verdinos. Spesso il linguaggio giornalistico è pigro e si ferma al primo canone, e quindi Verdini y los Verdinos diventano “stampella” di Renzi, del suo governo, delle sue riforme eccetera eccetera, una specie di pronto intervento, di squadra di emergenza che aspetta col motore acceso, e se qualcuno del pd dovesse fare i capricci e battere i piedi, ecco che arriverebbero loro – magari con le sirene e i lampeggianti – a risolvere la questione: è bello avere degli amici, pardon, degli affiliati.
Denis Verdini usa immagini più ficcanti e fantasiose: “Sono l’idraulico di Renzi”. Nel senso che se il rubinetto del Pd a sinistra perde un po’ (mugugni e grida), lui fa la valvola di sicurezza a destra: Perdite? Infiltrazioni? Fastidiosi sgocciolamenti? Niente paura c’è l’idraulico Verdini, pronto intervento servizio accurato, lavoro ben fatto. Sarebbe interessante sapere i prezzi, e se fa la fattura.
Se l’idraulico affiliato Pd parlasse solo della situazione parlamentare – quando non avete in numeri al Senato arrivo io – la cosa non sarebbe poi così strabiliante: un governo nato con una manovra di palazzo non si scandalizzerà certo per l’arrivo di una pattuglia che lo sostiene, e la sensazione è che se votassero le riforme potrebbero affiliarsi anche i venusiani, i seguaci di Pol Pot e i reduci della prima guerra mondiale. Ma Verdini va oltre, non parla solo di eletti, ma di elettori, con un ragionamento assai semplice: qualcuno avrà dei problemi a votare Renzi, perché è del Pd, allora voterà per noi, e noi porteremo a Renzi i suoi voti. Un voto per procura, insomma, una cosa tipo: senti, fammi un favore siccome mi sta sulle palle il panettiere vai tu a comprarmi il pane. Verdini è convinto in questo modo – affiliandosi – di portare a casa trenta-quaranta parlamentari, quanto basterebbe per il pronto intervento idraulico nel caso il rubinetto a sinistra perdesse, pur in presenza di un premio di maggioranza mostruoso come quello previsto dall’Italicum. Il discorso quindi si sposta: non il povero Verdini y los Verdinos, ma il povero elettore ignoto che vuole votare Renzi, ma anche non vuole, è incerto, dilaniato, non sa che fare, vacilla, tentenna, teme di finire per votare “i comunisti” (ahah) e allora sai che fa: vota Verdini e ci pensi lui. Non è solo una lezione sul cinismo della politica, ma un saggio sulla confusione mentale. Anche perché non si capisce cosa possa frenare un elettore di destra nel dare il suo voto a Renzi. Una questione di principio? Un dogma religioso? Un tabù alimentare? Un voto alla Madonna? Sia come sia, l’idraulico affiliato Verdini vede laggiù, pronti ad andare alle urne, molti italiani che vogliono mangiare la torta renziana, che – essendo di destra – la ritengono buona e nutriente, ma non vogliono andare a comprarla al negozio. Mandano Denis, servizievole e disponibile. Affiliato. Sulla cerimonia di affiliazione, poi, sarebbe bello sapere: una cosa alla buona coi grembiulini e i compassi? O una di quelle cerimonie con patto di sangue e giuramento? Chi lo sa. Intanto vale quello che diceva Woody Allen: “Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico alla domenica”. Uff, mica è difficile, basta “affiliarlo”.
 Cari tutti, dopo molte presentazioni in giro per l’Italia, eccone una a Milano.
Cari tutti, dopo molte presentazioni in giro per l’Italia, eccone una a Milano. Mercoledì 20 gennaio (alle 18.30) sarò alla libreria Claudiana, noto covo di Valdesi, che mi ha invitato per un “incontro con l’autore” (sarei io, vedi a volte le disgrazie come succedono…). “Dove sei stanotte” è uscito da un bel po’ ormai, quindi non è proprio una “presentazione”, ma insomma, si parlerà di questo e anche del libro prima (“Questa non è una canzone d’amore”), e magari di altro. Tutti invitati, naturalmente: chi l’ha letto e chi non l’ha letto. Ne approfitto per dire che tra poco (a fine febbraio) uscirà il nuovo romanzo, un’altra avventura di Carlo Monterossi, ma su questo vi dirò meglio più avanti.
Mercoledì 20 gennaio (alle 18.30) sarò alla libreria Claudiana, noto covo di Valdesi, che mi ha invitato per un “incontro con l’autore” (sarei io, vedi a volte le disgrazie come succedono…). “Dove sei stanotte” è uscito da un bel po’ ormai, quindi non è proprio una “presentazione”, ma insomma, si parlerà di questo e anche del libro prima (“Questa non è una canzone d’amore”), e magari di altro. Tutti invitati, naturalmente: chi l’ha letto e chi non l’ha letto. Ne approfitto per dire che tra poco (a fine febbraio) uscirà il nuovo romanzo, un’altra avventura di Carlo Monterossi, ma su questo vi dirò meglio più avanti.
Le recensioni di “Dove sei stanotte” le trovate qui
Le recensioni di “Questa non è una canzone d’amore” le trovate qui
Ci vediamo mercoledì, chi può e chi vuole
 Che bisogno c’è di surrealismo e nonsense quando ci sono i sondaggi? Sul famoso referendum che deciderà del destino delle riforme costituzionali – si usano chiamare così le tracce di cingoli sulla Costituzione – i numeri che girano sembrano il teatro dell’assurdo. Solo il venti per cento degli elettori dice di aver capito esattamente di cosa si parla, e il sessanta per cento degli stessi elettori dichiara che voterà sì. Come dire che due italiani su tre tra quelli favorevoli voteranno sulla base del sentito dire, dell’aria che tira e della propaganda. Certo, mancano dieci mesi e possono cambiare molte cose, cambieranno anche questi numeri così grotteschi, forse, ma per ora, mentre si prende la rincorsa, la situazione è questa: un paese intero che si accinge a votare una cosa che non ha capito bene, come se comprasse una macchina usata senza sapere quanti chilometri ha fatto, come sono le rate, se una volta avviata sarà in grado di frenare.
Che bisogno c’è di surrealismo e nonsense quando ci sono i sondaggi? Sul famoso referendum che deciderà del destino delle riforme costituzionali – si usano chiamare così le tracce di cingoli sulla Costituzione – i numeri che girano sembrano il teatro dell’assurdo. Solo il venti per cento degli elettori dice di aver capito esattamente di cosa si parla, e il sessanta per cento degli stessi elettori dichiara che voterà sì. Come dire che due italiani su tre tra quelli favorevoli voteranno sulla base del sentito dire, dell’aria che tira e della propaganda. Certo, mancano dieci mesi e possono cambiare molte cose, cambieranno anche questi numeri così grotteschi, forse, ma per ora, mentre si prende la rincorsa, la situazione è questa: un paese intero che si accinge a votare una cosa che non ha capito bene, come se comprasse una macchina usata senza sapere quanti chilometri ha fatto, come sono le rate, se una volta avviata sarà in grado di frenare.
Tutti ai blocchi di partenza, dunque, sapendo che nei prossimi dieci mesi l’argomento sarà quello: realtà (che cos’è davvero questa riforma) contro percezione (nuovo! nuovo! nuovo! E gufo chi non ci sta), e sarà interessante vedere se nel dibattito avrà qualche diritto di cittadinanza la par condicio, oppure se i media suoneranno la grancassa per il sì, cosa che sembrerebbe già in atto.
Il problema è che la percezione rischia di essere più forte della realtà, come quella faccenda delle temperature estive, che fa caldo, sì, ma il caldo “percepito” è molto di più. Prepariamoci dunque alla raffica di varianti dello storytelling renzista: o sei favorevole a una riforma che di fatto consegna poteri mai visti al governo e al presidente del Consiglio, oppure sei antico, conservatore, non vuoi cambiare, sei immobilista e, di fatto, sostieni la “casta” (parola questa, agile come un pallina da flipper, che dove va va, e la si usa a piacimento). Siccome in questi due anni si è venduto per moderno l’antico e per nuovo il vecchissimo, il gioco può funzionare. Moderno e innovativo il lavoro senza diritti, nuova di zecca la scuola più classista, efficienti e sciccose la pensioni più basse, si suppone che il giochetto continuerà sulla stessa falsariga. Meno senatori, che figata! Senza la seccatura di votarli, bello! E via così. Chi non ci sta, sarà automaticamente catalogato come “conservatore”, pratica già collaudata con chiunque si sia messo di traverso, basti pensare ai sarcasmi sul sindacato e il mondo del lavoro (i gettoni del telefono, i rullini della macchina fotografica, mentre chi vuole tornare al cottimo ostenta playstation e smartphone contemporanei). Gran parte della partita, insomma, sarà giocata sul concetto di nuovo contro vecchio, cambiare contro non cambiare, spingere contro frenare. I “problematici” che vorranno parlare della riforma nel merito verranno bollati come i soliti noiosi cacadubbi che rallentano il paese, mentre dall’altra parte ci saranno i dinamici innovatori che “non si perdono in chiacchiere”, uno schema già visto – a suo modo già vecchio – che raggiungerà la sua massima espansione prima dell’autunno. La trappola è lì, già bella pronta e innestata: efficientismo (fare, decidere senza troppi ostacoli e discorsi) versus complessità (sentire tutti, mediare, comporre), che in sostanza significa autoritarismo versus democrazia. Basterà rendere inconsistente e polverosa quella parola (democrazia) e lucidare le cromature dell’efficientismo decisionista, vendere “l’uomo solo al comando” come novità prodigiosa: in pratica prendere il vecchio e riverniciarlo. Un po’ come sostituire le antiche scritte sui muri con le slide: dal “me ne frego” al “ce ne faremo una ragione”. Vuoi mettere come suona nuovo?
 I prodigi dell’autocertificazione semplificano tutto, snelliscono le procedure, velocizzano l’analisi, dichiarano l’appartenenza e morta lì. Fatto! Rapido e indolore. E così Giuseppe Sala, il grande manager di Expo che Matteo Renzi chiama Beppe – per dire quanto sono amici e quanto questa fiducia lo farà casualmente finire a fare il sindaco di Milano – si è fatto la sua targhetta coi trasferelli, se l’è attaccata al bavero della giacca e ha proclamato al mondo: “Io sono di sinistra”. Il valore dell’autocertificazione, in questo caso, sta tutto nella credulità di chi ascolta. Molti annuiscono e sono contenti, altri alzano il sopracciglio e si chiedono… eh? Ma nel modulo dell’autocertificazione di appartenenza politica mancano quelle due righette che dicono: le dichiarazioni devono essere veritiere. Già, in fondo, cosa diavolo vuol dire “sono di sinistra” ai tempi del renzismo, a parte che si è diventati renzisti? Lo fece Andrea Romano, quando attraversò faticosamente il deserto (20 centimetri di deserto) che separava Scelta Civica dal Pd di Matteuccio nostro: “Sono sempre stato un po’ di sinistra”. Ecco, bene, un po’, perché a volte basta. Attraversando altri deserti, arrivò anche Gennaro Migliore che era di sinistra senza se e senza ma, e anche senza un sacco di altre cose, ma disse che aveva fatto le sue valutazioni e la sua analisi e “in questa fase” era meglio stare con Matteuccio. Un caso di certificazione per sottrazione, in cui si decide che è meglio essere “un po’ meno” di sinistra.
I prodigi dell’autocertificazione semplificano tutto, snelliscono le procedure, velocizzano l’analisi, dichiarano l’appartenenza e morta lì. Fatto! Rapido e indolore. E così Giuseppe Sala, il grande manager di Expo che Matteo Renzi chiama Beppe – per dire quanto sono amici e quanto questa fiducia lo farà casualmente finire a fare il sindaco di Milano – si è fatto la sua targhetta coi trasferelli, se l’è attaccata al bavero della giacca e ha proclamato al mondo: “Io sono di sinistra”. Il valore dell’autocertificazione, in questo caso, sta tutto nella credulità di chi ascolta. Molti annuiscono e sono contenti, altri alzano il sopracciglio e si chiedono… eh? Ma nel modulo dell’autocertificazione di appartenenza politica mancano quelle due righette che dicono: le dichiarazioni devono essere veritiere. Già, in fondo, cosa diavolo vuol dire “sono di sinistra” ai tempi del renzismo, a parte che si è diventati renzisti? Lo fece Andrea Romano, quando attraversò faticosamente il deserto (20 centimetri di deserto) che separava Scelta Civica dal Pd di Matteuccio nostro: “Sono sempre stato un po’ di sinistra”. Ecco, bene, un po’, perché a volte basta. Attraversando altri deserti, arrivò anche Gennaro Migliore che era di sinistra senza se e senza ma, e anche senza un sacco di altre cose, ma disse che aveva fatto le sue valutazioni e la sua analisi e “in questa fase” era meglio stare con Matteuccio. Un caso di certificazione per sottrazione, in cui si decide che è meglio essere “un po’ meno” di sinistra.
Ognuno poi si fa le sue ragioni su cosa voglia dire essere di sinistra. Giuseppe Sala, per esempio, sostiene che lui, avendo fatto l’Expo e “creato lavoro”, è di sinistra. Esattamente come Henry Ford con gli operai, Remo Gaspari coi postini abruzzesi, Silvio Berlusconi con i dipendenti Mediaset, l’imperatore Hiro Hito con i kamikaze giapponesi e Pablo Escobar con i suoi sicarios colombiani. Insomma, se accettiamo che “creare lavoro” ti colloca automaticamente nel campo della sinistra, non se ne esce.
Ma dunque torniamo lì, all’autocertificazione del “sono di sinistra”, magari accompagnata, come ha fatto Sala, dalla piccata aggiunta a verbale: “Basta con gli esami del sangue!”. Come dire, ok, sono di sinistra, lo dico io e non menatemela più con questa storia.
Ma poi una simile autocertificazione necessita di autoconvincimento, di autoipnosi, di un “a me gli occhi”. E’ allora che l’autocertificazione diventa una specie di mantra, di cantilena ripetuta all’ossessione in cui ci si dichiara di sinistra fino a convincersene. Mai si è visto, ad esempio, un segretario di un partito di sinistra (ehm…) ripetere così ossessivamente “noi siamo di sinistra” come fa Renzi. Diciamo che Berlinguer non ne aveva bisogno, e che se Togliatti avesse chiuso un comizio dicendo “Noi siamo di sinistra”, la platea avrebbe vacillato nello sconcerto.
Quel che non si capisce, alla fine, è il perché. Si sa chi voterà Sala come sindaco di Milano: destra, berlusconiani rinati, morattiani del settimo giorno, quelli del Pd di strettissima osservanza expo-ottimista, chi vuole il manager credendo che sappia governare e la maggioranza silenziosa. Tutta gente che non ha bisogno della certificazione, e molti, anzi, spinti piuttosto al dubbio e al sospetto verso uno che dice: “sono di sinistra”. C’è da pensare che Sala lo faccia per essere accettato nel club, oppure per ordine di scuderia, oppure perché oggi “di sinistra” ha lo stesso significato di “da agricoltura biologica”, cioè basta metterci un’etichetta e poi vai a sapere che c’è dentro. Che poi, in tempi grami, è di sinistra anche la quotazione in Borsa della Ferrari, un grande passo verso il riscatto delle masse oppresse. Venceremos! Come da modulo allegato.
 L’emergenza smog nelle principali città italiane è drammatica. I dati sulle patologie polmonari sono impressionanti, gli effetti collaterali terribili. Tra questi, la ricomparsa, a Milano, dell’ex sindaco Albertini, che suggerisce di spegnere le caldaie e di mettersi la maglia della salute, segno che i danni dell’inquinamento possono essere anche cerebrali. A Roma l’azione dell’ex prefetto di Milano Tronca è stata rapida e decisa, quasi fulminea: un minuto per decidere le targhe alterne e due giorni per mettere a punto le deroghe. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini romani, eccone un parziale elenco.
L’emergenza smog nelle principali città italiane è drammatica. I dati sulle patologie polmonari sono impressionanti, gli effetti collaterali terribili. Tra questi, la ricomparsa, a Milano, dell’ex sindaco Albertini, che suggerisce di spegnere le caldaie e di mettersi la maglia della salute, segno che i danni dell’inquinamento possono essere anche cerebrali. A Roma l’azione dell’ex prefetto di Milano Tronca è stata rapida e decisa, quasi fulminea: un minuto per decidere le targhe alterne e due giorni per mettere a punto le deroghe. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini romani, eccone un parziale elenco.
Sandro Bondi. Può circolare quanto gli pare, dove gli pare e con qualsiasi targa, purché esca dal tunnel della poesia e sostenga il governo Renzi. Se fermato dalle pattuglie potrà facilmente dimostrare di trasportare merce deperibile: la moglie che passa anche lei sa Silvio a Denis, direzione Matteo. Vada, vada pure, circolare.
Francesco Paolo Tronca. Ovvio che il commissario che guida Roma, coadiuvato valorosamente dal prefetto Gabrielli che vorrebbe commissariarlo con la nomina di varie figure commissariali, abbia la sua deroga. Muoversi liberamente per la città, con qualsiasi targa, gli è assolutamente necessario, visto che per contratto deve andare a fare il baciamano al papa ogni venticinque minuti. E poi, vuole visitare la città prima che i cittadini comincino a riconoscerlo.
Raffaele Cantone. Inserito in varie categorie – praticamente tutte – il famoso magistrato nemico della corruzione può circolare liberamente con qualunque targa ed esibire il suo speciale permesso di “intervento emergenziale” che riguarda: salvataggio banche, parto di bovini, assistenza agli anziani, caldarrostaio, moderatore di centurioni inferociti e commissario speciale ai venditori di rose nei ristoranti.
Denis Verdini. Con la sua agenzia adibita al trasporto di profughi da Forza Italia alla maggioranza di governo, può vantare una deroga di carattere umanitario. Per i transfughi non automuniti che devono raggiungere il Nazareno, infatti, è sconsigliato l’uso dei mezzi pubblici. “Con l’efficienza della metropolitana capitolina – dicono gli esperti – ci sono deputati e senatori che resterebbero in Forza Italia fini alla colonizzazione di Giove, e questo sarebbe un vulnus alla democrazia”.
Pellegrini del Giubileo. Desiderosi di farsi perdonare i peccati, potranno girare in macchina quanto gli pare. Una deroga che ha fatto discutere, ma forse in modo eccessivo. Infatti, per ora, sono sette (una famiglia di Bratislava e due single di Pavia) e la loro incidenza sull’inquinamento della capitale appare trascurabile.
Spettatori del grande concerto di San Silvestro. Prima negato dal commissario Tronca, poi autorizzato da più alti poteri (Matteo Renzi), il concerto di Capodanno sarà un surprise party: la location sarà comunicata trenta secondi prima dell’inizio della prima canzone, quindi gli spettatori dovranno andarci in auto, godendo di una speciale deroga. Trattandosi di un concerto che si protrarrà oltre la mezzanotte – in virtù del decreto Happy Days – potranno recarsi al concerto con due macchine: una a targa pari per l’andata e l’altra a targa dispari per il ritorno.
Occasione irripetibile. Chi passerà con la sua Panda sputacchiante sotto una delle porte sante potrà vederla trasformata in un fiammante Suv euro 6, per il quale, grazie a una speciale deroga, sarà consentita la circolazione. Basterà apporre un santino sul parabrezza e assicurare le pattuglie di controllo che la lezione di Milano è stata perfettamente capita. Per questo sono già in vendita speciali adesivi con la scritta: “Il Giubileo sarà un enorme successo, alla faccia dei gufi”.
 Elezioni in Spagna? In Francia? Puapua Nuova Guinea? Tranquilli: due compresse di Italicum prima del voto e passa la paura. Il refrain della settimana è questo: siccome il bipolarismo non esiste più (tendenza europea conclamata), facciamo una legge elettorale che lo imponga a martellate alla festante popolazione, che così avrà finalmente in dono il bene che più desidera: la stabilità politica. Risolto con la fiction il problema del bipolarismo, si affiderebbe il potere, con scarsissimi contrappesi, a un partito solo, che a quel punto sarebbe super-maggioritario in Parlamento e decisamente minoritario nel paese. Sembrerebbe la vecchia storia della coperta corta: volete più libertà o più sicurezza?, si chiede per lottare contro il terrorismo. Analogamente nella politica si chiede: volete più stabilità o più rappresentanza?
Elezioni in Spagna? In Francia? Puapua Nuova Guinea? Tranquilli: due compresse di Italicum prima del voto e passa la paura. Il refrain della settimana è questo: siccome il bipolarismo non esiste più (tendenza europea conclamata), facciamo una legge elettorale che lo imponga a martellate alla festante popolazione, che così avrà finalmente in dono il bene che più desidera: la stabilità politica. Risolto con la fiction il problema del bipolarismo, si affiderebbe il potere, con scarsissimi contrappesi, a un partito solo, che a quel punto sarebbe super-maggioritario in Parlamento e decisamente minoritario nel paese. Sembrerebbe la vecchia storia della coperta corta: volete più libertà o più sicurezza?, si chiede per lottare contro il terrorismo. Analogamente nella politica si chiede: volete più stabilità o più rappresentanza?
Esiste però in questa semplice equazione una specie di errore di base, un peccato originale, una gamba del tavolo non solidissima. Che è proprio lì: stabilità. Ma è così vero che l’Italia è la patria dell’instabilità politica? Che le divisioni frenano il paese? Che non si riesce a governare? E non è bizzarro che chi dice che così non va bene, che non si governa, siano proprio quelli che governano, e dicono di farlo bene e con efficienza? Il ragionamento zoppica. Anche perché, a guardare i suoi sviluppi generali, la stabilità politica italiana è strabiliante. Persino quando si cambiava un governo ogni sei mesi, ai tempi della prima repubblica, la stabilità era a prova di bomba, si davano il cambio attori e comparse nella stanza dei bottoni, ma il disegno restava più o meno identico. Facevano i turni, i vecchi volponi della prima repubblica, ma il lavoro era sempre quello.
Se si guardano per esempio le politiche sul lavoro degli ultimi vent’anni, non c’è niente di più tremendamente stabile. Cominciò il governo Prodi (1996) a sventolare la bandiera della “flessibilità”, senza la quale, ci dissero, saremmo morti tutti. L’allora ministro Treu stappò il vaso di Pandora del lavoro flessibile e precario, che dilagò nel paese, che si impose senza freni e controlli, fino alla sua regolamentazione finale con il Jobs act: tutti un po’ precari, cioè licenziabili a un costo minimo, tutti demansionabili eccetera, eccetera. Si può dunque dire che nel giro di una ventina d’anni, con strappi improvvisi e lunghe pause, con governi di destra e di sinistra, con i fini economisti prodiani e con la compagnia di giro del poro Silvio, il disegno di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro si è perfettamente compiuto. Impeccabile opera di stabilità politica: chiunque governasse, il disegno era quello, ed è stato eseguito.
Ci sarebbero altri esempi, ovviamente, non ultimo il fatto che abbiamo sempre mandato aerei, armi e soldati dove ci hanno chiesto di mandarli, altro esempio di stabilità. Insomma, non siamo così instabili, diciamo anzi che specie nelle politiche economiche siamo stabilissimi, come dimostra il fatto che le diseguaglianze sociali sono aumentate, negli ultimi anni, piuttosto costantemente, e non diminuite: un capolavoro a cui hanno concorso tutti, chi più chi meno, altro esempio di continuità politica niente male.
L’Italicum come garanzia di stabilità, dunque, lascia perplessi. Indicare la Spagna dicendo: “Visto? Col nostro trucchetto non sarebbe successo” è suggestivo ma non porta lontano. E’ vero: col trucchetto dell’Italicum Rajoy finirebbe per formare un governo, in solitudine e maggioranza assoluta: un governo con superpoteri che sarebbe espressione di un elettore su quattro. Una spallata abbastanza decisa al concetto di democrazia rappresentativa. E vabbé, non facciamola lunga, avrete un po’ meno democrazia, ma vuoi mettere la stabilità?
 Ho perso il treno per Firenze e non me lo perdonerò mai. Avrei potuto essere tra quei giovani virgulti chiamati a fare le domande ai ministri del governo, nello show room delle idee di Matteo Renzi. Per esempio, adeguandomi al clima di aspro confronto, avrei potuto chiedere alla ministra Boschi: “Parliamo un po’ di suo padre. Alla mattina, caffélatte o ginseng?”. Bisogna avere coraggio quando si fanno domande ai potenti.
Ho perso il treno per Firenze e non me lo perdonerò mai. Avrei potuto essere tra quei giovani virgulti chiamati a fare le domande ai ministri del governo, nello show room delle idee di Matteo Renzi. Per esempio, adeguandomi al clima di aspro confronto, avrei potuto chiedere alla ministra Boschi: “Parliamo un po’ di suo padre. Alla mattina, caffélatte o ginseng?”. Bisogna avere coraggio quando si fanno domande ai potenti.
Matteo Renzi lo aveva detto: “I ministri saranno interrogati dai partecipanti alla Leopolda in un modo innovativo e divertente”, e in effetti ci siamo divertiti. Abbiamo visto in action quello che si vorrebbe dalla libera stampa. Niente che non si fosse già sentito nelle polemiche sui cattivi talk show o nelle solite lamentazioni contro “i giornali” (e questo in particolare), ma insomma, vedere così plasticamente rappresentato il sogno del “giornalismo di rinnovamento” (copyright Marianna Madia) è stato istruttivo. Ecco, avrei voluto essere lì, adeguarmi, entrare nel mood lepoldo: “Caro ministro dei trasporti, e del cambio Shimano che mi dice? Lei ce l’ha sulla bicicletta?”. Nei casi estremi, tipo con il ministro Poletti, mi sarei limitato, come fanno i professori umani, a dire: “Mi dica un tema a sua scelta”, certo che quello si sarebbe incasinato da solo.
Per farla breve: esiste una linea invisibile superata la quale la propaganda diventa autocaricatura, spesso è una linea sottile, difficile da individuare, ma va dato atto agli strateghi renzisti di aver superato quel confine di alcuni chilometri. Alla Leopolda mancava la piramide di Panseca, quella che rese monumentali (e poi monumentalmente ridicoli) i tronfi trionfi craxiani. Ma il resto c’era tutto, compresa la lezione di question time come lo desidererebbe qualunque potente sulla terra: “Compagno Stalin, ci conferma che nei gulag si mangia benissimo?”.
Ora, su tutto questo si può fare satira e umorismo, ma come restare indifferenti alle vicende umane? Come non provare un moto di tenerezza per quei giovani chiamati ad agevolare le passerelle ministeriali con il loro umile lavoro di comparse? Uno si può immaginare l’angoscia della vigilia, la febbrile compilazione delle domande, i mille dubbi: non avrò osato troppo? Non sembrerò scomodo e importuno? “Ministra Giannini, come si può rendere magnifica la già meravigliosa riforma della scuola, forse con dei lapislazuli?”. Beh, mi pare una domanda equilibrata …
Ecco, siccome l’esempio vale più di mille discorsi, ci hanno fatto proprio l’esempio, ci hanno mostrato come si fa. Presentarsi con il nome di battesimo, essere informali, dare del tu al ministro. E poi trafiggerlo con argomenti inoppugnabili e domande che non lasciano scampo: “Panettone o pandoro?”.
Ma forse la commedia dell’arte leopolda non era per tutti e alcune cose erano, diciamo così, ad uso interno, come quelle campagne pubblicitarie che tendono a fidelizzare il cliente. Se le precedenti Leopolde dovevano far conoscere il prodotto, questa qui appena conclusa aveva un altro scopo: convincere i clienti a non andarsene, giurare che il prodotto funziona, stimolare il consumatore. E per fare quello, motivare i venditori. E in più ancora, mostrare che ci sono nuove leve di venditori che premono, che si fanno notare, che incalzano con severità e spirito battagliero: “Ministro, cosa si prova a cambiare il paese?”. Brivido.
Se è questo che volevano, i grandi comunicatori, ci sono riusciti in pieno: la chiesa di Renzology ne esce perfettamente rappresentata, i suoi sacerdoti sono stati interrogati da adepti intimoriti, il Ron Hubbard di Rignano ha scritto un altro capitolo e indicato nuovi nemici: i giornali cattivi che durante la messa – maledetti – scrivevano di banche.
Ho conosciuto Mario Dondero, faceva delle foto splendide (molte per il manifesto), aveva sempre in mano una macchina fotografica d’altri tempi e scattava e tutti ci chiedevamo se c’era dentro una pellicola davvero. Cantava meravigliose canzoni francesi di lotta e di guerra, ma anche d’amore. Era gentile. Era una miniera di racconti e davanti a una sua foto, anche di venti, trent’anni prima, poteva spiegarti come e perché l’aveva scattata, e c’era sempre una storia dietro. Insomma, non si sa mai cosa dire, in queste occasioni. Io dirò che Mario Dondero era un compagno libero e un uomo speciale, e che mi dispiace tanto.
 La Leopolda tipo prima alla Scala. Chi c’è, chi non c’è, eccetera. La narrazione del “siamo molto fighi” nella sua massima potenza. Sarebbe interessante sapere, però, perché Samantha Cristoforetti, AstroSamanta, la ragazza che è stata lassù (là fuori?), tra le stelle, va alla riunione di una corrente di partito, ammesso che alla fine ci vada davvero. A termini di regolamento non potrebbe: l’Esa (Agenzia Spaziale Europea), vieta ai suoi membri di partecipare ad attività politiche (Articolo 3.2 del regolamento dell’Agenzia). Mah, ci sarà qualche sensatissima deroga. Resta il fatto: perché? Un conto è stringere mani a presidenti della Repubblica, ricevere onorificenze e fare chiacchierate dallo spazio con il capo del governo (ah, i vecchi francobolli sovietici con l’astronauta e l’operaio!), ma perché presenziare a una convention politica?
La Leopolda tipo prima alla Scala. Chi c’è, chi non c’è, eccetera. La narrazione del “siamo molto fighi” nella sua massima potenza. Sarebbe interessante sapere, però, perché Samantha Cristoforetti, AstroSamanta, la ragazza che è stata lassù (là fuori?), tra le stelle, va alla riunione di una corrente di partito, ammesso che alla fine ci vada davvero. A termini di regolamento non potrebbe: l’Esa (Agenzia Spaziale Europea), vieta ai suoi membri di partecipare ad attività politiche (Articolo 3.2 del regolamento dell’Agenzia). Mah, ci sarà qualche sensatissima deroga. Resta il fatto: perché? Un conto è stringere mani a presidenti della Repubblica, ricevere onorificenze e fare chiacchierate dallo spazio con il capo del governo (ah, i vecchi francobolli sovietici con l’astronauta e l’operaio!), ma perché presenziare a una convention politica?
C’è da pensare che Samantha Cristoforetti avrà la sua ostensione, che sarà esibita come una specie di Madonna pellegrina. Il che fa naturalmente parte della fiction, perché AstroSamanta ha preparato le sue missioni, e ha studiato per farlo, quando Renzi ancora faceva il boy scout.
Probabile che dirà cose interessanti sul futuro, la ricerca, lo spazio. Forse, chissà, dirà anche che è un peccato che si taglino fondi agli enti internazionali di ricerca (ai suoi colleghi dell’Eso, quelli che le stelle le guardano dal deserto del Cile, la legge di stabilità ha appena sforbiciato 3 milioni da qui al 2018). In ogni caso, AstroSamanta parteciperà, se davvero andrà alla Leopolda, a un’operazione di propaganda volta a dire che tutto va bene, che siamo carini, bravi e tosti. Lei, che è carina e brava e tosta davvero, rischia così, mettendosi al servizio di una propaganda precisa, di svilire i suoi successi, un po’ come i grandi attori che finiscono a fare gli spot del tonno in scatola.
 Un fantasma si aggira per l’Italia, che è sempre meglio di quelli che si aggirano per l’Europa (madame Le Pen) o per il mondo (certo califfi che te li raccomando). Ma insomma, un’entità indistinta e inafferrabile, difficile da vedere se non per trasparenze e rumori lontani, nuvola di previsioni che si intrecciano alle speranze, che a loro volta si collegano al famoso bicchiere mezzo pieno e all’ottimismo obbligatorio. E’ il fantasma dell’indotto, che va molto di moda e che richiede un atto di fede del cittadino in materia di economia, materia effettivamente magica e mesmerica come poche altre. In principio, si sa, era l’Expo. Certi documenti molto sbandierati alla vigilia facevano intravvedere un futuro che più luminoso non si poteva. Certo, una spesa, ma poi vedrai l’indotto… e giù cifre sui posti di lavoro, il pil, il gettito fiscale aumentato grazie al boom che un documento della Bocconi indicava addirittura in 11 miliardi e passa (da qui al 2020), ottenuto grazie “All’effetto sviluppo sull’economia italiana”. Insomma, più affari, più incassi per il fisco, bingo. Ecco, non conoscendo ancora, a un mese e mezzo dalla chiusura dei cancelli l’incasso preciso, e quindi l’entità delle perdite o dei guadagni, tutto è rimandato al famoso indotto, con un sottotesto che dice: “vedrai che figata”. Peccato che l’indotto sia difficile da quantificare, che sia un calcolo con migliaia di varianti, che sia tutto in mano alle “previsioni” degli esperti, e che gli stessi esperti cambino le loro congetture con frequenza quasi quotidiana. La riduzione delle previsioni del pil nel terzo trimestre (una piccola limatura, ma pur sempre una limatura) e le proiezioni sul quarto (per arrivare secondo l’Istat a un 0,7-0,8 annuo) non direbbero che l’indotto si stia muovendo proprio come un cavallo al galoppo. Insomma, è richiesto l’atto di fede.
Un fantasma si aggira per l’Italia, che è sempre meglio di quelli che si aggirano per l’Europa (madame Le Pen) o per il mondo (certo califfi che te li raccomando). Ma insomma, un’entità indistinta e inafferrabile, difficile da vedere se non per trasparenze e rumori lontani, nuvola di previsioni che si intrecciano alle speranze, che a loro volta si collegano al famoso bicchiere mezzo pieno e all’ottimismo obbligatorio. E’ il fantasma dell’indotto, che va molto di moda e che richiede un atto di fede del cittadino in materia di economia, materia effettivamente magica e mesmerica come poche altre. In principio, si sa, era l’Expo. Certi documenti molto sbandierati alla vigilia facevano intravvedere un futuro che più luminoso non si poteva. Certo, una spesa, ma poi vedrai l’indotto… e giù cifre sui posti di lavoro, il pil, il gettito fiscale aumentato grazie al boom che un documento della Bocconi indicava addirittura in 11 miliardi e passa (da qui al 2020), ottenuto grazie “All’effetto sviluppo sull’economia italiana”. Insomma, più affari, più incassi per il fisco, bingo. Ecco, non conoscendo ancora, a un mese e mezzo dalla chiusura dei cancelli l’incasso preciso, e quindi l’entità delle perdite o dei guadagni, tutto è rimandato al famoso indotto, con un sottotesto che dice: “vedrai che figata”. Peccato che l’indotto sia difficile da quantificare, che sia un calcolo con migliaia di varianti, che sia tutto in mano alle “previsioni” degli esperti, e che gli stessi esperti cambino le loro congetture con frequenza quasi quotidiana. La riduzione delle previsioni del pil nel terzo trimestre (una piccola limatura, ma pur sempre una limatura) e le proiezioni sul quarto (per arrivare secondo l’Istat a un 0,7-0,8 annuo) non direbbero che l’indotto si stia muovendo proprio come un cavallo al galoppo. Insomma, è richiesto l’atto di fede.
La faccenda dell’indotto è dunque al tempo stesso spinosa e comoda. Spinosa perché si parla di cifre totalmente ipotetiche, e comoda per lo stesso motivo: nessuna valutazione sarà possibile fino a che non si calcolerà per bene l’indotto, il che sposta in là la questione di una decina d’anni e poi, a babbo morto, si vedrà. E a quel punto, a chi fregherà più qualcosa?
Applicare lo stesso ragionamento al Giubileo non è così immediato: meno infrastrutture costruite, nessun terreno pagato a peso d’oro. Ma anche qui la stessa necessità di spargere ottimismo a piene mani e (oggi un po’ sottotono, ma un mese fa molto in voga) la sfida: “Sarà un successo come l’Expo”. Ecco, appunto, quindi non lo sapremo mai: sarà un successo sulla parola. Anche qui girano cifre e previsioni. Il turismo, ovvio, il pil, l’occupazione. E i frutti che si vedranno chissà quando e se non si vedranno nessuno avrà poi voglia o memoria di chiederne conto. Come si vede, il fantasma è proprio un fantasma: c’è? Non c’è? C’è ma non ce ne accorgiamo? Non c’è e ce ne accorgeremo? La sensazione è che tutto congiuri a tacere dei risultati, l’orizzonte si sposta sempre più in là, le valutazioni aspettano l’indotto, il benedetto indotto ci può mettere anche dieci anni, e alla fine finisce tutto in una nebbia indistinta in cui non si sa se la spesa è stata un investimento o una perdita secca. Non diversamente dalle riforme, peraltro, dove non si riesce mai a tracciare una riga: era buona? Sì? No? Ha funzionato? I tre miliardi di decontribuzioni del Jobs act che hanno portato per ora la miseria di duemila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato sono stati ben spesi? Non sarà troppo caro? Risposta standard: uh, è presto per dirlo… aspettiamo l’indotto. Ecco, appunto, aspettiamo, che è un antico sinonimo per dire: non lo sapremo mai.
 Corso a Rozzano a difendere il presepe, con la capannuccia della sacra famiglia in mano e indomito accorruomo delle tradizioni, Matteo Salvini ha tuonato come suo solito da un marciapiede irto di microfoni e telecamere: “Giù le mani dal presepe”. Agenzie e giornali riportano con dovizia di particolari la scena degna di un quadro di Hieronymus Bosh, compresa la signora col bambinello in mano che grida a quell’altra: “Zitta tu che sei straniera”, e quella di rimando: “Ma io sono siciliana!”. Meraviglia.
Corso a Rozzano a difendere il presepe, con la capannuccia della sacra famiglia in mano e indomito accorruomo delle tradizioni, Matteo Salvini ha tuonato come suo solito da un marciapiede irto di microfoni e telecamere: “Giù le mani dal presepe”. Agenzie e giornali riportano con dovizia di particolari la scena degna di un quadro di Hieronymus Bosh, compresa la signora col bambinello in mano che grida a quell’altra: “Zitta tu che sei straniera”, e quella di rimando: “Ma io sono siciliana!”. Meraviglia.
Naturalmente il linciaggio bipartisan del professor Marco Parma, preside laico assurto per un paio di giorni a nuovo terrorista antipresepe (che non si è mai sognato di vietare, tra l’altro) ha dato la stura al peggio, che come si sa è sempre in agguato. Ma lasciamo da parte per una volta tutto il divertissement: Renzi che bacchetta anche lui il preside, gli intellettuali di sinistra che cantano nel coro, la signora Gelmini che intona “Tu scendi dalle stelle” per lottare da leonessa qual è contro il relativismo. Tutto bello e divertente. Ma concentriamoci su Salvini: a volte è anche studiando creature più sfortunate che si capisce il mondo.
E dunque: “Giù le mani dal presepe”. Va bene, ben trovata. E’ la modalità salvinica dominante, quella che parte di default quando si avvia il programma preinstallato. Quel “giù le mani”, Salvini se lo dovrebbe scrivere sulle felpe, tanto lo usa di frequente. Sono passate appena un paio di settimane quando correva in aiuto del sindaco di Padova Bitonci, eroico, a suo vedere, di opporsi a una teoria che non esiste, quella del gender. E allora (11 novembre) Salvini tuonava: “Giù le mani dai bambini”. E ci mancherebbe.
Qualche giorno prima (era il 20 ottobre), difendendo il pensionato che ha ucciso un ladro a pistolettate, in quel di Vaprio D’Adda, Salvini scendeva in campo senza se e senza ma, tuonando questa volta: “Giù le mani da chi si difende”. Mentre in maggio, affacciandosi al balcone (uh, che brivido!) del ministero dell’Economia temporaneamente occupato, Salvini gridava in favore di telecamera: “Giù le mani dalle pensioni”. In marzo, per contestare un centro di accoglienza per migranti, erano i suoi tifosi a confezionare striscioni e coniare slogan: “Giù le mani da Taranto”, e “Giù le mani dalla Puglia”. Mese pieno, quel marzo, perché Salvini mise agli atti anche uno strabiliante: “Giù le mani da Banca Etruria”. E poi, andando indietro nell’archivio, si trova un salvinissimo “Giù le mani dal Tar di Catania” (luglio 2014), un meraviglioso: “Politici e giornalisti, giù le mani dalla Lega e dal Piemonte” (gennaio), e potremmo continuare ad libitum: il gioco di Salvini che alza il dito ammonitore e dice “Giù le mani” da qualcosa è praticamente infinito.
La popolazione civile sembra ormai abituata. Massaie con la sporta della spesa, elettrauti, passanti generici, panettieri, studenti in gita e disoccupati a passeggio si aspettano ormai di incontrare ovunque un mesto corteo di troupe televisive con al centro Salvini che dice “Giù le mani”. Che questa modalità comunicativa abbia successo è tutto da vedere. “Giù le mani”, infatti, è un’intimazione difensiva, che punta a difendere le cose come stanno, a lasciarle lì come sono e anzi ammonisce chiunque anche soltanto a sfiorarle (giù le mani!). Volessero allargare la clientela, le grandi società di scommesse on-line dovrebbero dare le quote per le prossime uscite di Salvini. Giù le mani dall’inquinamento globale? Giù le mani dalla polenta taragna, radice culturale del bergamasco? Giù le mani dallo scatto alla risposta per le compagnie telefoniche? Insomma, passa Salvini, la gente si accalca, i curiosi sbirciano, qualcuno chiede: “E’ lui? Davvero? Ha già detto ‘giù le mani’?”.
Qui c’è il pezzo per pagina99 sugli ultimi episodi della serie Vatileaks 2. Questa è la versione lunga, per quella corta (pubblicata sul sito del giornale) cliccate sulla foto
 Ok, gente, avevo quasi finito The walking dead ed ero in pari con True detetive, per cui dovevo cercarmi un’altra serie interessante. Però volevo una cosa un po’ trucida… e anche basta con tutti ‘sti eroi, datemi un po’ di vita vera, sotterfugi, sesso. E allora seguo Vatileaks 2. Bello, anche se la sceneggiatura fa dei salti qui e là che a volte stupiscono. Si sa che ci sono vari modi di seguire la fiction televisiva a episodi. Il primo, tradizionale, è quello di aspettare la puntata. Il secondo, moderno, quello di chiudersi in casa a vederle tutte perché si è in affanno con la conversazione in ufficio. Il terzo è quello di seguire in differita. Un articolo qua, un’intervista là, commenti, critiche e apprezzamenti al bar: “Hai visto? Dava la cugina da scopare al monsignore!”. “Ah, non ho ancora visto, non dirmi niente”.
Ok, gente, avevo quasi finito The walking dead ed ero in pari con True detetive, per cui dovevo cercarmi un’altra serie interessante. Però volevo una cosa un po’ trucida… e anche basta con tutti ‘sti eroi, datemi un po’ di vita vera, sotterfugi, sesso. E allora seguo Vatileaks 2. Bello, anche se la sceneggiatura fa dei salti qui e là che a volte stupiscono. Si sa che ci sono vari modi di seguire la fiction televisiva a episodi. Il primo, tradizionale, è quello di aspettare la puntata. Il secondo, moderno, quello di chiudersi in casa a vederle tutte perché si è in affanno con la conversazione in ufficio. Il terzo è quello di seguire in differita. Un articolo qua, un’intervista là, commenti, critiche e apprezzamenti al bar: “Hai visto? Dava la cugina da scopare al monsignore!”. “Ah, non ho ancora visto, non dirmi niente”.
Vi avviso che la trama è intricata e non mi proverò nemmeno a riassumere. Negli episodi di questa settimana tutto girava intorno alla inarrivabile commedia umana: la signora Francesca Immacolata (ahah) Chaouqui che offre a monsignor Lucio Angel Vallejo Balda la cugina, trentaseienne “morbida”, e a quanto pare piuttosto porca, perché nel suo frenetico wazzappare la signora Chaouqui dice anche cose come “Silvana vuole trombare” e “Martedì viene a casa tua a trombare”. Abbastanza da far dire allo spettatore: “Mbè, datece er numero de sta Silvana!”.
Il prelato, che nicchia e resiste a cotanta benedetta offerta (“Non c’è cosa più divina / che scoparsi la cugina”) ci porta un po’ nella parte nobile della trama: è combattuto? E’ lacerato dalla sua fede? Sente le fiamme dell’inferno lambirlo, insieme ad altre fiamme che eventualmente porterebbe Silvana? Certo, tutto questo. Ma poi cala l’asso e vince la partita con un argomento definitivo: “E’ brutta”.
Fine dell’episodio
Due parole sullo sfondo. La serie ha una location interessante. Il papa, i prelati, la riforma delle finanze della Santa Sede, l’attico di Bertone, le sudate offerte dei fedeli che spariscono come lo champagne al Crazy Horse. Due giornalisti italiani che raccontano tutto questo (Nuzzi e Fittipaldi) e che finiscono sotto processo in un stato straniero, senza potersi scegliere l’avvocato. Non so se la parte diplomatica verrà negli episodi che seguono, può darsi che qualcuno si svegli e dica che processare così dei giornalisti italiani ci crea qualche perplessità. Forse nella seconda serie ci ricorderemo anche di questo dettaglio della libertà di stampa in un paese modernissimo che presto farà il culo alla Germania (cit). Per ora, niente.
Nuovo episodio.
Per ora – in attesa di leggere qualcosa su soldi e potere e informazione – la trama si concentra ancora sugli aspetti romantici della faccenda. La cugina non si sa, ma lei – lei la Chaouqui – sì che lo stende il monsignore, a Firenze, tre giorni dopo Natale, l’anno scorso. Colpo di scena e svolta improvvisa. Anche perché lui, monsignor Balda, lo scrive in un memoriale difensivo che consegna al processo. Insomma, si fa sedurre (ahah) e poi si pente, una modalità di narrare l’amore già esplorata dalla coppia Banfi-Fenech. Ma sia. Puntatona ricca di balzi sul divano. Lei – lei la seduttrice – si difende. Dice che non ha sedotto nessuno e che quello, quello il monsignore, era andato un po’ fuori di testa portando fior di prove: “Era andato al concerto di Ligabue”. Lo dice, la Chaouqui, come si trattasse di peccato mortale (in effetti…).
Qui però, un severo rimprovero agli sceneggiatori, Ma come, prima gliela dà alla grande, poi tenta di dargli pure quella della cugina, e poi arde di fuoco morale perché quello va ai concerti? Eddai!
Allora gli sceneggiatori rimediano, e la nostra eroina estrae la pistola fumante: non poteva venire a letto con me (il monsignore) perché non gli piacciono le donne. Wow! E nemmeno le cugine delle donne! Gioco, partita, incontro.
Quanto a lei, Francesca Immacolata, tiene a far sapere che se proprio volesse concedere le sue grazie, consce emiri e miliardari, tanto per far girare il tassametro (no disoccupati, astenersi precari).
Basta? No. Per spiegare tutto il casino, il monsignore dice che pensava che lei (lei la venditrice porta a porta di cugine) fosse dei servizi segreti.
Bene. E’ una buona serie, la consiglio. Poi ora c’è il Giubileo e tutti quanti passano sotto una porta e gli viene perdonato tutto, quindi nessuno si farà male. Sì, restano in sospeso cosucce come le finanze vaticane, i giornalisti sotto processo, il potere, i soldi, e altri piccoli dettagli, ma chissà, nei prossimi episodi…
Insomma, basta con il Novecento, e “le otto ore vi sembran poche”, chi vi credete di essere, le mondine? Ora, guidata come una trebbiatrice dal ministro Poletti arriva l’idea moderna: pagare a risultato. Una cosa modernissima che si chiama “cottimo”. Nel caso, cottimo e abbondante. Una prassi che cambierà le nostre vite, il linguaggio, i rapporti interpersonali. “A che ora torni, caro?”. “Uh, come sei antica! Ancora legata alle ore! Arrivo quando ho raggiunto il risultato, come impone la nuova etica del lavoro”. “Quindi?”. “Boh, facciamo un giovedì di dicembre, ma non so quale”.
Ecco, niente orari. Preparatevi a un futuro di paste scotte e microonde. Perché ve lo diciamo con una mano sul cuore: in questo modo polettiano di intendere il lavoro, le ore non saranno mai meno, ma sempre di più. Rottamando la paga oraria assisteremo finalmente a una guerra continua con ufficiali e graduati travestiti da capufficio. “Signorina, faccia questi otto miliardi di fotocopie”. “Guardi che io stacco alle sei!”. “No lei stacca quando ha finito”. Di colpo, in ufficio, si finirà di lavorare quando finirà il toner, mai prima. Bello! Sembrerà di essere nei Marines. Del resto il ministro Poletti l’ha detto l’altro giorno: si lavora in un modo nuovo e a lui capita di leggere le mail anche all’una di sabato notte, a letto. Abolendo le ore e puntando ai risultati, un risultato lo si otterrà di sicuro: si lavorerà sempre, giorno e notte, a letto, in macchina, al cinema. La doccia sembrerà l’ultimo rifugio dove si può stare senza tablet o cellulare e forse questo migliorerà la vita: “Caro, ti devo parlare”. “Presto, andiamo sotto la doccia, se no devo finire la relazione e mandarla al capo”. Peccato che accadrà solo per pochi minuti. Ma del resto, pensateci: cosa sono i minuti se aboliscono le ore?
 Ben pensata, vecchia volpe. La mossa di mettere insieme nello stesso discorso (e forse nello stesso pacchetto di spese) sicurezza e cultura è quasi da manuale. Matteo Renzi l’ha annunciato nel discorso di ieri l’altro: più sicurezza ma anche più cultura. E consistenti regali: 80 euro ai poliziotti, per esempio, e 500 euro da spendere in libri, cinema, teatri e altro per chi compie 18 anni.
Ben pensata, vecchia volpe. La mossa di mettere insieme nello stesso discorso (e forse nello stesso pacchetto di spese) sicurezza e cultura è quasi da manuale. Matteo Renzi l’ha annunciato nel discorso di ieri l’altro: più sicurezza ma anche più cultura. E consistenti regali: 80 euro ai poliziotti, per esempio, e 500 euro da spendere in libri, cinema, teatri e altro per chi compie 18 anni.
Poco importa che il ministro Padoan ora debba mettersi a cercare coperture in fretta e furia, e già si dice che i soldi per chi diventa maggiorenne (auguri) siano aggrappati a quella speranza di contribuito europeo per i migranti (tranquilli, non daranno 500 euro ai migranti). Ma insomma, l’annuncio è fatto, gli applausi partiti e, come sanno i sovrani, l’intendenza segue.
Può stupire in effetti che l’investimento “culturale” (da mettere a debito nei conti pubblici, comunque) sia un regalo, una specie di buono-acquisto, universale e uguale per tutti. Stupisce anche di più che un capo del governo annunci un dono per tutti i cittadini che voteranno la prima volta. Interpretazione maliziosa, ma non campata per aria: dicono i sondaggi che i diciottenni o non hanno voglia di votare (55 per cento) o votano i 5 stelle (37 per cento). Dunque una specie di campagna acquisti presso l’elettorato concorrente, in contanti. Il Dash promette soldi a chi compra il Dixan.
Altro legittimo sospetto sull’annuncio, l’universalità della mancia: reddito basso, o alto, o altissimo, tutti uguali. Il figlio del bracciante contribuirà con la sua quota di debito pubblico ad acquistare libri al figlio del notaio. Dovendo comprare libri, ragazzi, suggerirei Don Milani, là dove dice che fare parti uguali tra diseguali è una grossa ingiustizia. Prevale, insomma, la gentile concessione rispetto al diritto, in un Paese in cui le tasse universitarie salgono, le borse di studio calano e 58 italiani su cento non prendono in mano un libro nemmeno sotto minaccia armata.
La battaglia mediatica è in corso. Sui social, la pancia del Paese – almeno la pancia dei pasdaran renziani – argomenta che meglio a tutti che a nessuno (un po’ debole). Qualcuno dice «Ah, li avessi avuti io non avrei dovuto fare la barista per pagarmi il corso d’inglese», senza pensare che il corso d’inglese te lo dovrebbe dare la scuola pubblica. La nomenklatura del Pd si schiera a testuggine respingendo insinuazioni di tipo elettorale.
Come ha scritto su Twitter uno dei guru della comunicazione, Francesco Nicodemo: “Chi chiama mancia elettorale il bonus 500euro ai 18enni manca di rispetto innanzitutto ai ragazzi. Come se dicesse loro ‘vi fate comprare’”. Bello, un po’ coda di paglia, ma efficace (e che non esclude per niente il tentativo di acquisto). L’altro guru, invece, Filippo Sensi, si affanna a diffondere le reazioni internazionali alla promessa equazione sicurezza più cultura, titolo affascinante soprattutto se visto da lontano. Anche se, pure a distanza, c’è chi annusa aria di propaganda, come per esempio Le Monde: “Iniziativa abile, almeno di fronte all’opinione pubblica”. Insomma, come dire, bravo ma ti abbiamo sgamato.
Maurizio Ferrera, invece, sul Corriere della Sera di oggi critica aspramente la norma, contestando proprio la logica del bonus uguale per tutti (titolo: Il bonus per la cultura utile (forse) ma non equo). Insomma, la logica del regalo al posto del diritto, della munificenza governativa al posto dell’investimento mirato, la mancia, già visto ad esempio con il bonus bebé prima promesso a tutti e poi ovviamente, e giustamente, riportato a erogazioni basate sul reddito.
Comunque sia, l’annuncio c’è stato, ora si vedranno le procedure: dal 2016 può essere che i neo-diciottenni avranno (coi soldi di tutti) un regalo “culturale” da Matteo. Se poi se ne ricorderanno nel segreto della cabina elettorale è tutto da vedere: ai tempi di Lauro si poteva andare a reclamare la scarpa destra dopo aver votato, oggi è tutto sulla parola. Di Matteo, tra l’altro. Auguri.
 Due doverose premesse. La prima: bisogna sconfiggere una volta per tutte e per sempre quelli che vanno sparacchiando per le nostre città (e anche per le loro, peraltro) e si fanno scoppiare vicino a gente che non vuole esplodere per niente. La seconda: adoro i gattini e le foto di gattini. Sono buffi, ispirano tenerezza e – insuperabile motivo di simpatia – sono decisamente matti. Detto questo, c’è qualcosa che stride e nell’operazione “gattini” messa in atto dai media (i social, twitter soprattutto, ma anche giornali, emittenti, agenzie…) belgi nella notte del #BrusselsLockdown. La faccenda è nota: con un’operazione di caccia all’uomo e “repulisti” in corso (che non è stata, a giudicare da fermi e arresti, un successone), la polizia belga ha chiesto ai giornali di non diffondere notizie sull’argomento, chiedendo in pratica il silenzio stampa. Dai social (ma anche dai giornali) è arrivata la risposta: obbedendo all’invito, ma con ironia, ecco spuntare al posto delle notizie migliaia di gattini. Il gattino su Facebook, si sa, appartiene alle piccole cose di pessimo gusto, una specie di statuetta di Capodimonte in plastica da mettere sul comò (pure su quello degli altri, dannazione!). Ma in questo caso aveva un’altra valenza, e qui le letture divergono. Chi dice fosse sarcasmo “Ci vorreste così, a postare gattini…”, chi invece un concreto, rassicurante, ironico stringersi alle forze dell’ordine nel momento del bisogno. La polizia belga ha ringraziato il giorno dopo postando una ciotola di crocchini, dedicata a tutti i gattini comparsi sui media. Cioè a tutti quelli che si sono astenuti dal dare notizie. Tutto molto bello e molto edificante (se anche molto utile non lo sapremo mai).
Due doverose premesse. La prima: bisogna sconfiggere una volta per tutte e per sempre quelli che vanno sparacchiando per le nostre città (e anche per le loro, peraltro) e si fanno scoppiare vicino a gente che non vuole esplodere per niente. La seconda: adoro i gattini e le foto di gattini. Sono buffi, ispirano tenerezza e – insuperabile motivo di simpatia – sono decisamente matti. Detto questo, c’è qualcosa che stride e nell’operazione “gattini” messa in atto dai media (i social, twitter soprattutto, ma anche giornali, emittenti, agenzie…) belgi nella notte del #BrusselsLockdown. La faccenda è nota: con un’operazione di caccia all’uomo e “repulisti” in corso (che non è stata, a giudicare da fermi e arresti, un successone), la polizia belga ha chiesto ai giornali di non diffondere notizie sull’argomento, chiedendo in pratica il silenzio stampa. Dai social (ma anche dai giornali) è arrivata la risposta: obbedendo all’invito, ma con ironia, ecco spuntare al posto delle notizie migliaia di gattini. Il gattino su Facebook, si sa, appartiene alle piccole cose di pessimo gusto, una specie di statuetta di Capodimonte in plastica da mettere sul comò (pure su quello degli altri, dannazione!). Ma in questo caso aveva un’altra valenza, e qui le letture divergono. Chi dice fosse sarcasmo “Ci vorreste così, a postare gattini…”, chi invece un concreto, rassicurante, ironico stringersi alle forze dell’ordine nel momento del bisogno. La polizia belga ha ringraziato il giorno dopo postando una ciotola di crocchini, dedicata a tutti i gattini comparsi sui media. Cioè a tutti quelli che si sono astenuti dal dare notizie. Tutto molto bello e molto edificante (se anche molto utile non lo sapremo mai).
A farla breve, mettendosi in testa un gattino invece di un elmetto, la stampa belga, Le Soir in testa, è diventata per una notte embedded. Giusto? Sbagliato? Gli esperti di mass media rifletteranno a lungo, e li lasciamo al loro dibattito. Una cosa è certa, però: d’ora in poi all’apparire in rete di una dose di gattini eccedente il normale, a un profluvio di gattini, a uno tsunami di gattini, un brivido ci correrà per la schiena: significa che è in corso qualcosa di cui non dobbiamo sapere, le notizie sono, in qualche modo, vietate.
Come sempre accade nella vita, il precedente è accettabile (andiamo, tra un poliziotto belga e un jihadista pronto a colpire si sta col primo, no?), mentre quello che seguirà il precedente, invece, chissà, speriamo bene. Questioni di tattica, si direbbe. Ma non tanto. Dopo una settimana di comprensibile orgogliosa rivendicazione del nostro “stile di vita” che i terroristi non cambieranno, dopo che tanti intellettuali hanno detto (giustamente) che noi continueremo a bere, ballare, scopare, gioire dell’esistenza, si scopre che invece per le notizie, ecco, magari una piccola moratoria si può fare.
Qualcosa stride, in effetti, e lo capiranno bene giornalisti e lettori di vecchia scuola, quelli ancora fissati con le notizie, se sono notizie, da qualunque parte vengano. Dunque, belli i gattini, teneri, pelosi, placidi o isterici a seconda del loro “stile di vita”, ma non vorremmo in futuro dover attivare uno speciale gattinometro che ci segnali ora questo ora quel silenzio stampa, richiesto da questa o da quella autorità, per questa o quella emergenza contingente. Insomma, sarebbe meglio non abituarsi a un ritmo troppo serrato di gattini, come sono costretti a fare in certi paesi che controllano l’opinione pubblica, meno gentilmente della polizia belga e senza poi nemmeno ringraziare con una ciotola di crocchini.
 «Io sono per taggare i terroristi». Pronunciata da Matteo Renzi sabato 21 novembre al “Digital day” di Torino, la frase non avrà forse diritto di cittadinanza tra i motti celebri del Nostro di Firenze. Insomma, non è esattamente un hashtag, né uno slogan, né precisamente un intento programmatico. Parrebbe una boutade buona per quei titoli che si leggono ogni tanto: «Lo Zingarelli contiene la parola supercazzola!», si gira pagina e si passa ad altro.
«Io sono per taggare i terroristi». Pronunciata da Matteo Renzi sabato 21 novembre al “Digital day” di Torino, la frase non avrà forse diritto di cittadinanza tra i motti celebri del Nostro di Firenze. Insomma, non è esattamente un hashtag, né uno slogan, né precisamente un intento programmatico. Parrebbe una boutade buona per quei titoli che si leggono ogni tanto: «Lo Zingarelli contiene la parola supercazzola!», si gira pagina e si passa ad altro.
Ma bene. Premesso che chiunque vorrebbe “taggare” i terroristi, e poi magari pure arrestarli (quelli veri, però, non il povero Touil, catturato innocente tra le ovazioni di Presidente del Consiglio e del Ministro degli Interni, e poi scarcerato con tante scuse, taggato a vuoto, insomma), sarà consentita una nota semantica. “Taggare” appartiene a un linguaggio tecnico/giovanilistico, chiaro segno di adattamento dell’uomo all’ambiente. Ha detto “taggare” perché stava lì, ovvio. Avesse parlato alla Federcaccia avrebbe detto “impallinare”, perché il contenuto liquido, si sa, si adatta al contenitore. Ma c’è dell’altro.
C’è, dietro l’angolo, la sempiterna ansia di disintermediazione che necessita di costante semplificazione. E dunque “taggare” i terroristi, e magari, in un secondo tempo, “defolloware” gli stati che li finanziano e con cui facciamo buoni affari, intanto mettere un preferito alla retorica sul nostro “stile di vita” e “wazzappare” a voce il popolo impaurito. Tutto facile, tutto immediato, tutto filante e scivoloso sulla superficie, mai sotto.
Una neolingua che basta a se stessa, della quale si notano le parole (“Uh, ha detto taggare! Moderno!”) e si perde il senso: controllare meglio, controllare tutto. Intanto – come mostrano foto e documenti non smentibili – “postare” bombe all’Arabia Saudita che le usa per conflitti non approvati dall’Onu (in Yemen, per esempio). Ma questo appartiene già alla profondità ed è meglio non parlarne. Come dicono in tivù: il pubblico a casa non capirebbe (quel cretino del pubblico a casa).
Qui c’è la prima copertina di pagina99 che domani (sabato 21) sarà in edicola. Settimanale di lotta e di lettura. Non ve ne pentirete. Promesso.
Cari tutti, sabato questo (il 21 novembre) torna nelle edicole pagina99. Vi risparmio la retorica su un nuovo giornale che nasce, la democrazia, la pluralità di voci, ecco, diciamo che la do per scontata e non voglio farla lunga. Il come e soprattutto il perché di fare un nuovo giornale in tempi difficili lo spiegano benissimo i direttori Luigi Spinola e Roberta Carlini, qui, e io non ho molto da aggiungere. Pagina99 era stata una bellissima avventura alla sua prima uscita, e meritava di riprovarci. Ci sarà il settimanale di carta (in edicola il sabato, qui per abbonarsi) e il sito (sempre aperto). Ci saranno visioni del mondo, letture, economia, idee e notizie. Insomma, ci sarà quel complicato organismo che è un giornale, che vive dei suoi lettori, e ci saranno lettori che lo usano e lo leggono, credete, è parecchio.
Io ci sarò, in qualche modo (nel primo numero, un pezzo su mister Bob Dylan), e sicuramente da lettore.
Dunque, a sabato. In bocca al lupo a tutti.
 Ogni conflitto ha i suoi effetti collaterali, e questo si sa. Non deve stupire dunque che in Italia l’effetto collaterale abbia un nome e un cognome: Oriana Fallaci. Resuscitata grazie agli assassini di Parigi nelle classifiche dei libri e nel rumore di fondo dei social network, la sora Oriana si è meritata anche una specie di panegirico sul Corriere della Sera, con tanto di “scusaci Oriana” e “risarcimento postumo”, e altre amenità confezionate con il noto barbatrucco de “la rete dice”. Insomma, ad ogni pallottola sparata da assassini integralisti, ci tocca per contrappasso rileggere brani degli integralisti nostri: i Salvini, i Belpietro e compagnia belligerante (armiamoci e partite, ça va san dire), con sottofondo delle intemerate un po’ isteriche della nota scrittrice, una che metteva nello stesso fumante calderone chi si fa esplodere nei mercati e chi fa pipì vicino ai monumenti di Firenze, per dire della profondità di analisi.
Ogni conflitto ha i suoi effetti collaterali, e questo si sa. Non deve stupire dunque che in Italia l’effetto collaterale abbia un nome e un cognome: Oriana Fallaci. Resuscitata grazie agli assassini di Parigi nelle classifiche dei libri e nel rumore di fondo dei social network, la sora Oriana si è meritata anche una specie di panegirico sul Corriere della Sera, con tanto di “scusaci Oriana” e “risarcimento postumo”, e altre amenità confezionate con il noto barbatrucco de “la rete dice”. Insomma, ad ogni pallottola sparata da assassini integralisti, ci tocca per contrappasso rileggere brani degli integralisti nostri: i Salvini, i Belpietro e compagnia belligerante (armiamoci e partite, ça va san dire), con sottofondo delle intemerate un po’ isteriche della nota scrittrice, una che metteva nello stesso fumante calderone chi si fa esplodere nei mercati e chi fa pipì vicino ai monumenti di Firenze, per dire della profondità di analisi.
E va bene, prendiamo atto. Dunque, la versione riveduta e corretta è che bisogna chiedere scusa alla signora Fallaci, ma scusa di cosa, alla fine non si capisce. Riassumiamo: all’indomani dell’11 settembre 2001, il primo clamoroso, spettacolare, micidiale, schifoso atto di guerra dell’integralismo, la signora Fallaci diede voce alla pancia del mondo, parlando di guerra di civiltà, occidente colpevole di “buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà”, insomma precedendo di un decennio abbondante le sottili argomentazioni di un Salvini. Bene. Quelle scenate da anziana signora – tipiche dei molto spaventati che dicono: non ho paura – furono diffuse per pagine e pagine sul primo quotidiano nazionale, rilanciate, sottoscritte. I libri con quelle ricette moderate (dichiariamogli guerra e sterminiamoli tutti, con tanto di insulti alla religione di un miliardo di persone sul pianeta) vennero stampati in milioni di copie, fecero per qualche tempo la fortuna dell’editore (lo stesso del Corriere, peraltro), divisero e fecero discutere, assumendo un valore di gran lunga superiore alla loro sostanza.
E ora si scopre che dovremmo dire “scusaci Oriana”. Ma scusaci di cosa? No, perché di solito si chiede scusa quando uno dice una cosa giusta, non lo si ascolta, si fa il contrario, e dopo anni si scopre che aveva ragione lui e allora si dice: scusa. E qui casca l’asino. Perché invece, negli anni che seguirono l’11 settembre 2001 non si fece il contrario di quello che predicava la sora Oriana, ma si fece esattamente quello che chiedeva lei. Una guerra “di civiltà” che fece almeno centomila morti civili in Afghanistan, cui seguì una guerra illegale in Iraq con un milione di morti civili, la deposizione di un dittatore con conseguente consegna del paese e della regione a bande armate e assassini che adesso se ne vanno sparacchiando per l’Europa e il mondo. Insomma: non è che Oriana suggerì di dispensare fiori e cioccolatini. No. Suggerì invece esattamente quello che mister Bush e mister Blair (supportati da alcuni personaggi minori tra cui l’esimio Berlusconi) fecero: una guerra indiscriminata e feroce che non risolse nulla e che peggiorò la situazione. Tanto che anche mister Blair – inspiegabilmente rimasto faro per qualche blairiano rinato che abita e governa qui – ha candidamente ammesso che fu proprio quella guerra a determinare le condizioni per la nascita dell’Isis. Insomma, a tirare le somme, l’assunto per cui la Fallaci aveva ragione e non le si diede retta è fortemente campata per aria. Anzi è proprio il contrario: la Fallaci aveva torto e le si diede fin troppo retta, ed eccoci dove siamo. Il che a rigor di logica dovrebbe tradursi in una condizione speculare e contraria: non Oriana scusaci, ma Oriana (e tutti i fallaci fallaciani) chiedete scusa.
Ieri (giovedì) Gianni Barbacetto, su Il Fatto Quotidiano, si chiedeva con vari argomenti come mai i Saggi del Pd hanno messo “il grande successo di Expo” nella Carta dei Valori scitta per le primarie milanesi. Pur non essendo né saggio né del Pd, ho cercato di rispondere alla domanda… (Il Fatto di oggi). Il pezzo come al solito lo trovate qui sotto. Se volete leggere quello di Gianni Barbacetto, invece, cliccate qui.
 La domanda gentile e pignola di Gianni Barbacetto (ieri su questo giornale) avrà, speriamo, risposta. Era questa: perché diavolo nella Carta dei Valori che dovrà sottoscrivere ogni partecipante alle primarie del Pd milanese c’è una specie di riconoscimento del “Grande successo di Expo”? Successo, com’è noto, tutto da provare, conti (ancora segreti) alla mano. Ora, in attesa di leggere cosa diranno i saggi che hanno scritto la Carta, si può solo avanzare un’ipotesi politica e psicologica insieme: inserire l’Expo (pardon “il successo di Expo”) in una “Carta dei Valori” è un riflesso condizionato. Che l’Expo sia stato un successo è ormai scolpito a lettere di fuoco ovunque, non c’è esponente Pd che non lo dica dei talk (anche se sta parlando, poniamo di pensioni), non c’è discorso di Matteo Renzi che non lo sottolinei ed enfatizzi. Ormai pare un saluto obbligatorio anche dal verduraio: “L’Expo è stato un successo signor Gino”. “L’Expo è stato un successo a lei, signora Marisa! Li vuole i carciofi?”. Ecco.
La domanda gentile e pignola di Gianni Barbacetto (ieri su questo giornale) avrà, speriamo, risposta. Era questa: perché diavolo nella Carta dei Valori che dovrà sottoscrivere ogni partecipante alle primarie del Pd milanese c’è una specie di riconoscimento del “Grande successo di Expo”? Successo, com’è noto, tutto da provare, conti (ancora segreti) alla mano. Ora, in attesa di leggere cosa diranno i saggi che hanno scritto la Carta, si può solo avanzare un’ipotesi politica e psicologica insieme: inserire l’Expo (pardon “il successo di Expo”) in una “Carta dei Valori” è un riflesso condizionato. Che l’Expo sia stato un successo è ormai scolpito a lettere di fuoco ovunque, non c’è esponente Pd che non lo dica dei talk (anche se sta parlando, poniamo di pensioni), non c’è discorso di Matteo Renzi che non lo sottolinei ed enfatizzi. Ormai pare un saluto obbligatorio anche dal verduraio: “L’Expo è stato un successo signor Gino”. “L’Expo è stato un successo a lei, signora Marisa! Li vuole i carciofi?”. Ecco.
Il perché di questo riflesso condizionato è presto detto con una piccola serie di addizioni. Il partito, cioè il Pd, è il governo. Un governo molto leaderistico dove il capo del governo è anche il capo del partito. I successi del governo vanno sostenuti in ogni sede e sono, ovviamente, i successi della Nazione. Dunque, se dubiti del “grande successo di Expo” o chiedi di vedere i conti, eccoti automaticamente antipatriottico. Diciamo che c’è una gran voglia di far coincidere i ruoli: il partito, il governo, la Nazione, lo Stato. Si richiede alla stampa di essere “responsabile”. Si richiede alla magistratura di essere allineata alla situazione economica del paese (penso agli attacchi alla Corte Costituzionale quando disse che bisognava rendere i soldi ai pensionati). Accanto all’accentramento di poteri politici (commissari di qui e di là) procede quello che gli ideologi renziani chiamano “ricostruire la connessione sentimentale con il Paese”. Bello, eh! E’ propaganda, va bene, ma esattamente, cosa vuole propagandare? Un partito? La sua nuova gestione? Il governo? Il sistema Italia? La Nazione? Il leader? Questo sovrapporre livelli e confondere ruoli non farà bene, alla lunga.
Il “grande successo di Expo”, che è tutto da dimostrare, ricorda un altro grandissimo successo italiano: quello del Mondiale di Spagna (anno di grazia 1982). Partito tra sospetti mai chiariti (biscottone col Camerun), il mondiale fu un trionfo, vincemmo noi, imprevedibili e matti come italiani. Non si usava la parola “gufo”, ma chi aveva denunciato i passaggi iniziali, poco limpidi e gloriosi, di quell’avventura fu zittito dal coro unanime. E ti credo: successo conclamato, Pertini, Bearzot, e l’Italia che ripartiva – anche allora! – ricompattata nel nome dello Stellone e di Paolo Rossi che segnava al Brasile. In quel caso – pur senza senza spin doctor – la “narrazione” fu agevolata e cavalcata per il bene della Nazione. Mentre, al contrario, per Italia 90, dove fallimmo sia sul campo che nella disastrosa gestione dell’evento, la narrazione trionfalistica fallì. E’ comprensibile che chi “ha messo la faccia” (sic) sull’Expo (il solito mazzetto di asparagi: leader, partito, governo, Nazione, Stato) voglia convincere tutti di somigliare più al Mondiale spagnolo dell’82 che al pasticcio italiano del ‘90. Questo non si fa mostrando correttamente i conti, rispondendo nel merito alle critiche, analizzando ricadute economiche, ma semplicemente chiedendo un atto di fede, come una lunga ininterrotta velina che avvolge il Paese in un rassicurante abbraccio di positività e di ottimismo che hanno un solo difettio: sembrano obbligatori. Motivo per cui “il grande successo di Expo” ce lo ritroveremo ovunque. Anche nella carta dei valori per elettori milanesi democratici.
 E venne il giorno del dibattito culturale. Eh, sì, mi sa che vi tocca. E, al netto delle fregnacce propagandate dal Minculpop renzista (noi siamo felici e gli altri sono tristi, notevole densità di pensiero), la faccenda riguarda Happy Days, sì, la famosa situation comedy, quella di Fonzie, e merita un supplemento di indagine. Riassumendo: Fassina dice che il modello Renzi è Happy Days, Orfini lo rivendica dicendo che era divertente, Renzi dice che attaccano Happy Days perché “si sentono lontani dalla felicità”. In questi casi, di solito, arrivano gli infermieri e li portano via.
E venne il giorno del dibattito culturale. Eh, sì, mi sa che vi tocca. E, al netto delle fregnacce propagandate dal Minculpop renzista (noi siamo felici e gli altri sono tristi, notevole densità di pensiero), la faccenda riguarda Happy Days, sì, la famosa situation comedy, quella di Fonzie, e merita un supplemento di indagine. Riassumendo: Fassina dice che il modello Renzi è Happy Days, Orfini lo rivendica dicendo che era divertente, Renzi dice che attaccano Happy Days perché “si sentono lontani dalla felicità”. In questi casi, di solito, arrivano gli infermieri e li portano via.
E però la polemica su Happy Days non è nuova nella sinistra italiana e anzi sta diventando un classico che travalica i secoli. Disse Nanni Moretti, nel suo film Aprile, 1998: “Io me li ricordo alla Fgci, sono cresciuti vedendo Happy Days, è la loro formazione politica, morale e culturale”. Passati vent’anni, riecco la sinistra, o sedicente o presunta tale, rinfacciarsi ancora Happy Days.
Vorrei notare, en passant, una cosetta spaventosa: dirigenti di partiti politici italiani nel 2015 assumono o attaccano come Zeitgeist e spirito ispiratore un telefilm americano girato negli anni Settanta e ambientato negli anni Cinquanta. Quanto a sudditanza culturale, provincialismo e colonizzazione, ce n’è abbastanza da nutrire il pianeta.
Eppure il parallelo tra la Weltanschauung renzista e le vecchie avventure della famiglia Cunningham non sono così peregrine. In Happy Days va tutto bene, la società non esiste, se esiste infila monetine nel juke boxe, la trasgressione è un giubbotto di cuoio, tutti sorridono o, se piangono, è per futili motivi che li faranno ridere dopo, e il capofamiglia va alla Loggia del Leopardo, una specie di P2 di paese.
In Happy Days – molto happy, in effetti – non si vede un nero (Milwakee è una citta a maggioranza nera, tra l’altro), non si vede un povero, il conflitto non esiste, l’universo è limitato al ceto medio bianco, educato e rispettoso dell’autorità. C’è da stupirsi che in nessun episodio della serie il governo si presenti a consegnare ottanta euro. Qui è successo.
E’ questo aspetto, e non la propaganda e le fregnacce sulla felicità, che collega strettamente il renzismo all’ideologia Happy Days. Il vivere tra il college e il frappé da Arnold come se la società non avesse sobbalzi, mugugni o motivi di scontento. Il conflitto, semplicemente non c’è, non è previsto, non è contemplato. E non solo. Happy Days veniva realizzato in un’America inquieta e incattivita, un’America appena uscita dal Vietnam, sconfitta e ferita. E allora si guardava indietro, si tornava alla rassicurante verginità degli anni Cinquanta così come la pensava il ceto medio bianco di quegli anni. Un balsamico e carezzevole rituffarsi nel buonumore che fu, per non intristirsi con le lacerazioni del presente. C’è un po’ dello spirito renzista dei tempi nostri: va tutto bene, ridi, gioca alla playstation, sii positivo, credici. E soprattutto tieniti alla larga da quello che non funziona, dalla diseguaglianza che cresce invece di calare. La narrazione renziana, dunque sì, deve al vecchio telefilm con Fonzie qualcosa di denso e ideologico, tutto è decoroso e soddisfacente, il migliore dei mondi possibili. Come diceva Moretti nel ’98 una formazione “politica, morale e culturale”. Vent’anni dopo, siamo ancora lì, a litigare su Fonzie e a rivendicarlo come modello. Il dibattito culturale nella sinistra italiana, al momento è questo, comprese le risate del pubblico.
 L’Italia che riparte non solo innova, stupisce il mondo e aprirà un Eataly su Giove, ma genera anche nuove professionalità con cui rivitalizzare il mondo del lavoro, creare nuovi posti e avanzare nella civiltà. Ecco alcune professioni in ascesa. Ragazzi, pensateci! Il futuro è nelle vostre mani!
L’Italia che riparte non solo innova, stupisce il mondo e aprirà un Eataly su Giove, ma genera anche nuove professionalità con cui rivitalizzare il mondo del lavoro, creare nuovi posti e avanzare nella civiltà. Ecco alcune professioni in ascesa. Ragazzi, pensateci! Il futuro è nelle vostre mani!
Commissario. Carriera di sicuro avvenire, nell’ottica dell’accentramento dei poteri e delle nomine governative. Commissario di qualcosa è sempre meglio che stare al tornio o in cassa integrazione. Se le cose vanno bene si fa il salto da commissario a politico, se vanno male… non è previsto: il compito del commissario è esattamente quello di dire che va tutto bene, che la sfida è vinta, che siamo orgogliosi. A dire che conquisteremo la galassia sarà il Premier. Entrato nel giro dei Commissari non ne uscirai più: alla peggio farai il Commissario a qualcos’altro. Attenti, ragazzi! Non è tutto rose e fiori: pensate che è commissario di qualcosa anche Orfini. Per la disponibilità di posti di Commissario vedi anche voce successiva.
Commissario alla Spending Review. Posto di lavoro prestigioso ma assai precario. Mediamente il paese consuma un Commissario alla Spending Review ogni sei mesi, ciò vuol dire, nei prossimi due millenni, almeno quattromila posti sicuri. Funziona così: si fa una lista di sprechi e tagli, la si porta a Palazzo Chigi, si osserva mentre la fanno in pezzettini piccoli, e poi si finisce a tagliare a Regioni e Comuni. Il vostro avanzamento di carriera dipenderà da come saprete sorridere mentre stracciano il vostro lavoro di sei mesi.
Tatuatori. Categoria in grande ascesa, molti posti di lavoro disponibili. Chi, oggi, non vuole tatuarsi sulla pelle la frase “L’Expo è stato un grande successo”? Molto richiesti altri fortunati slogan, hashtag vari, frasi del Capo, e per i più virili e arditi anche il tradizionale #cenefaremounaragione, succedaneo del più famoso #menefrego. Per tatuarsi #IoeroallaLeopolda è necessario il certificato di renzista antemarcia, rilasciato dal partito.
Gestori di file. Appurato con il grande successo di Expo che stare in fila otto ore rappresenta una gioia e un’occasione di socializzazione, si cercano animatori per file alla posta, in banca, al pronto soccorso, o per prestazioni varie. Se aspettate una Tac da trentadue anni, vi chiamerà ogni tanto questo entusiasta professionista, per ricordarvi che fate parte di una grande e gioiosa comunità: quelli che aspettano la Tac. Intervistati dai media direte: è bellissimo stare in fila per la Tac, si socializza! Si avvisano gli aspiranti gestori di file che lavoreranno in un call-center (mica che vi aspettate di diventare sindaco di Milano, eh!).
Citazionisti. La moda di inserire in discorsi e interviste fantasiose citazioni scende dal Massimo Vertice e arriva agli ultimi vice-assessori di provincia. Il paese ha bisogno di citazionisti, gente che sappia setacciare internet alla ricerca di frasi storiche da far dire al leader o ai “suoi”. Va bene tutto, dai baci Perugina a Fantozzi, dal filosofo nepalese al telefilm di moda (scusate: serie), da Kant a Franco e Ciccio. Roosevelt? Va bene! Il cantante Zucchero? Bene uguale! Purché la citazione sia sprezzante nei confronti degli avversari, oppure leggera, speranzosa e colma di fiducia se si riferisce al futuro e a chi lo realizza per benino. Non so, qualcosa tipo: “Il futuro è ciò che costruiamo”, frase di Tim Berners-Lee, che naturalmente non ho la più pallida idea di chi sia, e l’ho trovato su Wikipedia. Visto? È facile!
Che poi, alla fine, il Caro Leader ha una visione, no?
Crozza nel paese delle meraviglie è un programma di Maurizio Crozza scritto con Vittorio Grattarola, Andrea Zalone, Alessandro Robecchi, , Francesco Freyrie, Claudio Fois, Alessandro Giugliano e Luca Restivo. Orchestra del Maestro Silvano Belfiore. La regia è di Massimo Fusi.
Bene, il tour continua, eccetera eccetera. Sabato (alle 17, BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, 4/3 A) si parla di Dove sei stanotte con Daniele Bacci. Poi non dite che non ve l’ho detto, eh!
 Come tutti i grandi viaggiatori da Marco Polo in poi, anche Matteo Renzi tiene un diario di viaggio, e la trasferta sudamericana offre spunti di racconto, riflessione, incantamento. E le stelle? Ah, le stelle, a chi non piacciono le stelle? Basti pensare che con quella parola “stelle”, un fiorentino minore d’altri tempi chiuse tutte e tre le parti della sua Commedia. Dico, non vorrete che un fiorentino maggiore come Renzi non si faccia affascinare dal cielo stellato, no? E infatti. Molto fotografata dagli addetti alla propaganda e molto celebrata da lui stesso medesimo, la visita ai grandi e meravigliosi telescopi dell’Eso (European Southern Observatory) a Paranal, nel deserto di Atacama, un centinaio di chilometri da Antofagasta, Cile. Lì in effetti il cielo è una cosa speciale, le stelle stanno a guardare e noi guardiamo loro con tecnologie avanzatissime. Insomma c’è tutto: un po’ di retorica celestiale, la tecnologia, gli Italiani in prima fila, l’orgoglio del Paese e tutto il campionario. E lui? Lui ci mette del suo, nella sua pagina Facebook che rilancia e racconta la sua odissea sudamericana. Testuali parole: “Vedendo a Paranal – la capitale dell’astronomia mondiale – i telescopi migliori del mondo che si immergono nell’abisso dell’universo dal cielo limpido del Cile e pensando alla dedizione con cui mani e cervelli, spesso in maggioranza italiani, li hanno voluti costruiti e usati penso a quanto grande sia il nostro Paese”. Bello. E poi Matteo Renzi ha anche cenato con alcuni giovani ricercatori per “sentire le loro storie e proposte”. Ce n’è abbastanza perché gufi patentati e disfattisti militanti vedano incrinarsi le loro certezze… Insomma, stelle, l’abisso dell’universo (apperò!) e giovani ricercatori: la narrazione renzista non poteva trovare di meglio.
Come tutti i grandi viaggiatori da Marco Polo in poi, anche Matteo Renzi tiene un diario di viaggio, e la trasferta sudamericana offre spunti di racconto, riflessione, incantamento. E le stelle? Ah, le stelle, a chi non piacciono le stelle? Basti pensare che con quella parola “stelle”, un fiorentino minore d’altri tempi chiuse tutte e tre le parti della sua Commedia. Dico, non vorrete che un fiorentino maggiore come Renzi non si faccia affascinare dal cielo stellato, no? E infatti. Molto fotografata dagli addetti alla propaganda e molto celebrata da lui stesso medesimo, la visita ai grandi e meravigliosi telescopi dell’Eso (European Southern Observatory) a Paranal, nel deserto di Atacama, un centinaio di chilometri da Antofagasta, Cile. Lì in effetti il cielo è una cosa speciale, le stelle stanno a guardare e noi guardiamo loro con tecnologie avanzatissime. Insomma c’è tutto: un po’ di retorica celestiale, la tecnologia, gli Italiani in prima fila, l’orgoglio del Paese e tutto il campionario. E lui? Lui ci mette del suo, nella sua pagina Facebook che rilancia e racconta la sua odissea sudamericana. Testuali parole: “Vedendo a Paranal – la capitale dell’astronomia mondiale – i telescopi migliori del mondo che si immergono nell’abisso dell’universo dal cielo limpido del Cile e pensando alla dedizione con cui mani e cervelli, spesso in maggioranza italiani, li hanno voluti costruiti e usati penso a quanto grande sia il nostro Paese”. Bello. E poi Matteo Renzi ha anche cenato con alcuni giovani ricercatori per “sentire le loro storie e proposte”. Ce n’è abbastanza perché gufi patentati e disfattisti militanti vedano incrinarsi le loro certezze… Insomma, stelle, l’abisso dell’universo (apperò!) e giovani ricercatori: la narrazione renzista non poteva trovare di meglio.
Dunque, con animo più leggero, dopo la lettura del diario di viaggio, ognuno può tornare alle proprie occupazioni, allegre o noiose che siano, come, che so, leggere la legge di Stabilità finalmente giunta al Senato. E proprio nella copia in pdf scaricata dal sito del Senato si può leggere (articolo 33, comma 18) che il ministero degli esteri e della cooperazione ha preso in mano le forbici per tagliare un po’ di finanziamenti. Dall’allegato 4, che rimanda all’articolo 33 comma 18 si può apprendere che all’Eso così celebrata verranno tagliati finanziamenti per un milione di euro nel 2016, un altro milione nel 2017 e un terzo milione nel 2018. Perbacco. E l’abisso dell’Universo? E i giovani ricercatori invitati a cena? Lo sapranno? L’Eso ha un bilancio intorno ai 130-140 milioni. L’Italia (membro dal 1982) ne sgancia più o meno quindici all’anno. Quindi tre milioni in meno in tre anni non sono poca cosa. La questione è semplice: la propaganda ci informa sulle sorti meravigliose dei nostri sforzi italiani e ottimisti di guardare l’Universo, la legge di stabilità taglia fondi e stanziamenti. Non male.
Naturalmente le stelle servono sempre. Renzi le usa, nel suoi diari di viaggio, anche per bacchettare i cattivi: “C’è un’Italia di cui essere orgogliosi, insomma. E non è l’Italietta delle polemiche di parte della politica o della comunicazione, vecchia e nuova. E l’Italia che è rispettata per il carico di civiltà che rappresenta e per la voglia di futuro che esprime”. Che belle parole! Matteo Renzi, come Marco Polo, scrive il suo “Milione”. Poi ne taglia tre in tre anni, di milioni, proprio al posto che va a decantare. E le stelle? Mah, le stelle stanno a guardare.
Venticinque anni fa moriva Ugo Tognazzi. Era il conte Mascetti, era quello de La vita Agra, era il capo delle Br… un sacco di cose. Qui c’è la sua figu. Buona visione.
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 Un nuovo genere letterario si sta imponendo con grande successo: l’elogio della coda. Di colpo, dopo aver sentito bestemmiare in più lingue ogni volta che bisogna mettersi in fila anche solo per due minuti, ecco spuntare Oh! di ammirazione e applausi scroscianti a mezzo stampa. Fanno sette ore di coda per il padiglione Giapponese! Che bravi! Quattro per Padiglione Italia! Molto bene! Ora per spiegare questa tendenza, vediamo qualche tipo di coda e come lo storytelling corrente possa farla diventare gradevole.
Un nuovo genere letterario si sta imponendo con grande successo: l’elogio della coda. Di colpo, dopo aver sentito bestemmiare in più lingue ogni volta che bisogna mettersi in fila anche solo per due minuti, ecco spuntare Oh! di ammirazione e applausi scroscianti a mezzo stampa. Fanno sette ore di coda per il padiglione Giapponese! Che bravi! Quattro per Padiglione Italia! Molto bene! Ora per spiegare questa tendenza, vediamo qualche tipo di coda e come lo storytelling corrente possa farla diventare gradevole.
Le code all’Expo. Trattasi di valutazione ideologica. Essendo diventata l’Esposizione Universale una disputa socio-antropologico-politica (la solita: furbi contro gufi), si è diffusa la furbata che l’Expo sia un successo sulla base dei biglietti venduti. E’ questo il motivo per cui da almeno un mese te li tirano dietro (il due per uno è il minimo, a volte sono veri e propri regali). Folle oceaniche, e code spaventose, salutate come la risposta della nazione al successo del grande evento. Dunque, si esalta la coda come sinonimo di successo (quattro ore! Sette ore! E giù battimani), mentre solitamente chiunque sta in coda è un po’ seccato dalla disorganizzazione che ha creato così tante code (su un flusso atteso, sbandierato, propagandato da mesi). Alcune prestigiose istituzioni come i parchi Disney, ma anche Gardaland, hanno risolto il problema alla vecchia maniera, cioè con la cara, intramontabile questione di classe: se paghi di più salti la fila (si chiama fast-pass, o se preferite, Capitalismo, il ricco passa davanti al povero). Ma resta il genere letterario dell’elogio della coda (titolo di un grande quotidiano: “Rassegnati alla lunga attesa ma felici”), dove si scambia un disagio dell’utente pagante per garrulo entusiasmo.
Che la coda faccia pubblicità è noto. Ma solitamente – a differenza delle code all’Expo – i media ne parlano con malcelata ironia. La code per comprare il nuovo telefonino vengono stigmatizzate dai grandi pensatori dell’oggi come manifestazioni di ottusità popolare. E quando in un centro commerciale di Roma finì a botte per le offerte speciali, l’ondata di sdegno fu totale, qualcosa di simile a “come sono ineleganti questi poveri che si menano per una lavatrice in saldo”. Esistono servizi per evitare le code. In estate, durante i grandi esodi di vacanzieri, ci si affanna a mettere bollini rossi e neri sulle date a rischio, ad avvertire: occhio che se parti domani stai in coda. Con la logica dell’Expo bisognerebbe invece esultare: ehi, guarda che successo quest’anno le vacanze, il signor Gino ha fatto tre chilometri in sei ore, fico, eh! L’Italia riparte!
Tra le code famose dei giorni nostri ci fu quella dei turisti fuori dal Colosseo chiuso per assemblea. Per qualche giorno un’assemblea sindacale fu trattata come l’Armageddon, la piaga purulenta che frena la nostra crescita. Contemporaneamente, si chiudono al pubblico musei e regge per “eventi privati”, o incontri istituzionali, e sulla fila dei turisti fuori, esclusi, nessuna notizia.
Ora il pericolo è che questa divertente narrazione che stare in coda è bello e aiuta le sorti del Paese si trasferisca ovunque. Uno scenario tipo: Franca la coda per la mammografia è lunga due anni! Oh, che bello, Gino, vedi quanta gente vuole fare gli esami? E’ segno che il paese riparte, che c’è entusiasmo! Naturalmente anche lì c’è il fast-pass: se paghi la mammografia la fai domani. Dove si dimostra che le ideologie sono tutt’altro che morte. Anzi, fanno la coda.
Diciamo così: una specie di “stato della nazione” visto da un taxi… guida Verdini…
Crozza nel paese delle meraviglie è un programma di Maurizio Crozza scritto con Vittorio Grattarola, Andrea Zalone, Alessandro Robecchi, , Francesco Freyrie, Claudio Fois, Alessandro Giugliano e Luca Restivo. Orchestra del Maestro Silvano Belfiore. La regia è di Massimo Fusi.
 Non avevano torto i romani antichi quando dicevano “la verità sta nel mezzo”. Lo capiscono bene i romani moderni: la verità sulle primarie romane del Pd sta da qualche parte tra “Una grande festa della democrazia” (tendenza Renzi 2013) e “Un’immane rottura di coglioni” (tendenza Renzi 2015). Per agevolare i lettori riassumiamo i principali punti del dibattito e le proposte finora emerse.
Non avevano torto i romani antichi quando dicevano “la verità sta nel mezzo”. Lo capiscono bene i romani moderni: la verità sulle primarie romane del Pd sta da qualche parte tra “Una grande festa della democrazia” (tendenza Renzi 2013) e “Un’immane rottura di coglioni” (tendenza Renzi 2015). Per agevolare i lettori riassumiamo i principali punti del dibattito e le proposte finora emerse.
Primarie di coalizione. Buona idea, che serve al Pd per dimostrare che il candidato sindaco sarà del Pd (indicato da Matteo Renzi), ma facendo finta che lo vogliano anche gli alleati del Pd. Parte quindi una spasmodica ricerca di alleati del Pd disposti a un decisivo ruolo nella coalizione, tipo portare i caffè o lavare i vetri. Alle ultime primarie per il sindaco di Roma vinse Ignazio Marino, alla grande, relegando altisonanti nomi del partito a percentuali miserrime. Paolo Gentiloni, per dire, che appena il 15 per cento dei votanti voleva sindaco, fa oggi il ministro degli esteri, perché vincere le primarie da esterno del Pd porta molta sfiga (Marino), ma perderle malamente porta parecchia fortuna.
Primarie di ratifica. Idea renziana quant’altre mai: decidere chi le vincerà (lo deciderebbe Matteo Renzi) e solo successivamente indire le primarie. Qualche difficoltà tecnica: bisogna trovare un nome sicuro e un paio di pupazzi disposti alla figuraccia da comprimari (da premiare semmai dopo con qualche incarico, in separata sede, per il sacrificio), quindi incrociare le dita e sperare che il “nome sicuro” sia sicuro per davvero, sapendo che il Pd romano è oggi appena un po’ più litigioso della gang giovanili di Guatemala City.
Primarie di consolazione. Sarebbe finalmente una novità della politica italiana. Il sindaco lo sceglie Matteo Renzi – come tutto quanto il resto nell’Universo – e le primarie si fanno per il vicesindaco. Una figura che diventerebbe centrale qualora il papa, o i cardinali, decidessero di bastonare il sindaco in carica e di cacciarlo. E’ chiaro a tutti che in un posto dove il capo di uno stato straniero può licenziare il sindaco di una città, la figura del vicesindaco diventa preziosa (nel caso, suggerirei un vescovo).
Primarie post-coitum. Un po’ di fantasia! Un po’ di inventiva! Dove sta scritto che le primarie bisogna farle prima delle elezioni? Perché non farle dopo? Evidenti i vantaggi: la consultazione non interferirebbe con l’elezione del sindaco (un nome indicato da Matteo Renzi), ma servirebbe comunque a raccattare un po’ di moneta e a far sfogare quelli che si beano della frase “io l’avevo detto”. Altro inestimabile vantaggio: avendo già un sindaco, le primarie post-coitum sarebbero totalmente irrilevanti, risolvendo così il problema della “Grande festa della democrazia”.
Primarie apertissime. Come tradizione del Pd (inaugurata da Matteo Renzi), le primarie saranno aperte a tutti, cioè per decidere il candidato sindaco del Pd potranno votare anche i sostenitori di Giorgia Meloni, di Alfio Marchini, di Alemanno o dei nazisti dell’Illinois. E’ infatti storicamente provato che far votare la destra per decidere i candidati di sinistra sia il metodo migliore per l’affermazione di un renziano di stretta osservanza, se non addirittura di Matteo Renzi in persona. Comunque vada, sarà un successo.
Nel frattempo, si spaleranno un po’ di milioni su Roma per il Giubileo, da usare come propaganda modello Expo e poi dire: visto che bravi? L’equivalente degli ottanta euro annunciati prima delle europee e distribuiti subito dopo. Funziona.
il 9 ottobre di 48 anni fa veniva assassinato Ernesto Che Guevara. Sì, lo so, la retorica, le magliette, ma insomma… anche un po’ di rispetto e memoria. Qui c’è la sua figurina (andò in onda nella stagione di Figu 2010-2011)
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 E’ passato un annetto giusto giusto da quando il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi emetteva il suo sfumato giudizio: “Il governo Renzi realizza tutti i nostri sogni”. Il problema è che da allora l’attività onirica di Squinzi, Confindustria e imprenditori italiani è stata frenetica: la logica prevalente è quella che se si aiutano i padroni (uh, parolaccia), si aiutano anche i loro dipendenti, un sillogismo piuttosto bislacco, a dire il vero, ma accettato come un dogma. Così, per fare un esempio, mentre si mascherano i tagli alla sanità con una variante del Comma 22 (non ti pago gli esami se non sei grave, ma per sapere se sei grave devi fare gli esami), si annunciano tagli alle tasse sui profitti d’impresa. I famosi vasi comunicanti, solo che comunicano in un verso solo: dal pubblico al privato, dal welfare al profitto, dai tanti ai pochi, dal basso all’alto della piramide sociale.
E’ passato un annetto giusto giusto da quando il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi emetteva il suo sfumato giudizio: “Il governo Renzi realizza tutti i nostri sogni”. Il problema è che da allora l’attività onirica di Squinzi, Confindustria e imprenditori italiani è stata frenetica: la logica prevalente è quella che se si aiutano i padroni (uh, parolaccia), si aiutano anche i loro dipendenti, un sillogismo piuttosto bislacco, a dire il vero, ma accettato come un dogma. Così, per fare un esempio, mentre si mascherano i tagli alla sanità con una variante del Comma 22 (non ti pago gli esami se non sei grave, ma per sapere se sei grave devi fare gli esami), si annunciano tagli alle tasse sui profitti d’impresa. I famosi vasi comunicanti, solo che comunicano in un verso solo: dal pubblico al privato, dal welfare al profitto, dai tanti ai pochi, dal basso all’alto della piramide sociale.
Chissà se prende qualcosa, pillole, gocce, per sognare tanto, ma insomma, sta di fatto: il padronato italiano ha ora un nuovo sogno e il governo si accinge a realizzarlo. Per la verità non è un sogno nuovissimo ma un vecchio pallino: “superare” il contratto collettivo di lavoro e lasciare che ogni azienda se la veda da sé nelle vertenze sui rinnovi contrattuali. Contestualmente, si dovrebbe varare il salario minimo, cioè una linea di semigalleggiamento sotto cui non sarà possibile andare (né campare). Ora, per tradurre in italiano: l’operaio metalmeccanico (poniamo) della piccola media azienda non potrà più contare sulle lotte comuni e condivise di tutti i metalmeccanici, e quindi su una forza poderosa per sostenere le trattative, ma dovrà vedersela col singolo consiglio di amministrazione. Non è difficile immaginare, dunque, che il potere contrattuale penderà clamorosamente dalla parte degli imprenditori ed è piuttosto fantascientifico immaginare che l’operaio di una piccola azienda di Crotone avrà un domani gli stessi diritti (e lo stesso stipendio) di un collega che lavora in una grande fabbrica del Nord. Dal punto di vista tecnico-economico si tratta di una nuova rapina ai danni del mondo del lavoro, dal punto di vista storico-culturale è invece il definitivo omicidio di concetti come unità dei lavoratori, l’unione fa la forza, uniti si vince eccetera, eccetera, tutte cosucce che ingombrano il disegno thatcheriano in corso.
I narratori delle gesta renziste si affanneranno a dire che – wow! – arriva il salario minimo, e lo venderanno come progresso e cambiaverso in una selva di hashtag osannanti, il che rappresenta, ovviamente una fregatura parallela. Perché tra poco, per essere in regola, basterà offrire ai lavoratori un salario minimo appena sufficiente a campare, e tutto il resto (il salario accessorio) dipenderà dai risultati, dalla disponibilità (straordinari, festivi, notti, doppi turni, obbedienza). Insomma, a farla breve, dalla discrezionalità di chi guida le aziende, con le ovvie e prevedibili ricadute in termini di ricatto economico: fai così o prendi due lire, ubbidisci o ripiombi in un lumpenproletariat da inizio secolo. Riassumendo: sei demansionabile (Jobs act), licenziabile a costi risibili (sempre Jobs act), i tuoi diritti sono determinati dall’umore del datore di lavoro, il tuo salario è variabile a seconda di come ti comporti, e tra poco si metterà mano a una restrizione del diritto di sciopero. Niente male, per un governo – destra e sinistra Pd, Ncd, sor Verdini e compari – che si affanna a dire a tutti che è “di sinistra”.
 Il deputato Pd Michele Anzaldi, intervistato da questo giornale, ha fatto una sua speciale critica televisiva alla scaletta di un talk show. Nei cahiers de doléances di Anzaldi sono finiti – mischiati a varie vittime civili, diciamo così – anche due scrittori: Nicola Lagioia, recente premio Strega, accusato di “dire che in Italia fa tutto schifo” (reato federale!) e Roberto Saviano, definito “deprimente”. Non si tratta di avversari politici a cui contestare minutaggi di esposizione mediatica o passaggi televisivi. No, si tratta proprio di una contestazione nel merito degli argomenti, un dissenso sui contenuti, si sarebbe detto una volta: di un attacco ideologico. E’ un classico del nostro tempo: dire che va tutto male, o anche solo negare che tutto sia bellissimo e in via di cambiaverso, o (peggio!) essere deprimenti, è considerato antinazionale, forse antipatriottico, certamente antigovernativo e sconveniente alle magnifiche sorti e progressive che sarebbe opportuno – in attesa che diventi obbligatorio – decantare.
Il deputato Pd Michele Anzaldi, intervistato da questo giornale, ha fatto una sua speciale critica televisiva alla scaletta di un talk show. Nei cahiers de doléances di Anzaldi sono finiti – mischiati a varie vittime civili, diciamo così – anche due scrittori: Nicola Lagioia, recente premio Strega, accusato di “dire che in Italia fa tutto schifo” (reato federale!) e Roberto Saviano, definito “deprimente”. Non si tratta di avversari politici a cui contestare minutaggi di esposizione mediatica o passaggi televisivi. No, si tratta proprio di una contestazione nel merito degli argomenti, un dissenso sui contenuti, si sarebbe detto una volta: di un attacco ideologico. E’ un classico del nostro tempo: dire che va tutto male, o anche solo negare che tutto sia bellissimo e in via di cambiaverso, o (peggio!) essere deprimenti, è considerato antinazionale, forse antipatriottico, certamente antigovernativo e sconveniente alle magnifiche sorti e progressive che sarebbe opportuno – in attesa che diventi obbligatorio – decantare.
In un Paese dove gli scrittori contano poco e sono ascoltati pure meno, criticarli per loro opinioni sembrerebbe un controsenso, un esercizio sterile. Eppure, nell’era della narrazione renziana è comprensibile che finiscano nel mirino proprio i narratori, considerati concorrenti in grado di narrare meglio, e più realisticamente, l’epoca dell’ottimismo, della volta buona, dell’Italia che riparte e di tutta la retorica boriosa e trionfalistica che ci viene consegnata ogni giorno. Nulla che si opponga allo storytelling corrente (stupiamo il mondo, saremo più forti della Germania, crediamoci, coraggio, rimbocchiamoci le maniche, basta con piagnisteo, attacchiamo la Kamchatka!) verrà risparmiato, fossero anche i poveri scrittori che nella scala dell’opinione pubblica contano meno di uno spot di Eataly (a meno che non lo scrivano loro).
Il prode Anzaldi non è un fulmine isolato. Un altro scrittore, Erri De Luca, è a processo per un reato d’opinione, accusato di aver fomentato rivolte contro interessi superiori, quelli della Tav. Un altro scrittore, Stefano Benni, ha rifiutato un prestigioso premio dicendo chiaro e tondo che non lo avrebbe ritirato dalle mani di un ministro della cultura di un governo che la cultura la calpesta spesso e volentieri. Alla risposta piccata del ministro Franceschini, irta di numeri e soave burocrazia, Benni ha risposto da par suo, con ironia sottile: segno che un buon narratore non accetta narrazioni precotte e, tra l’altro, identiche da decenni. Ma resta il fatto: siamo vicini a quella speciale critica letteraria che fanno i regimi: scrittori, siete disfattisti, e “deprimenti”, remate contro, non vi adeguate. Ancora una volta, sottotraccia, c’è la vecchia storia dei “cattivi maestri”, mentre si dichiara che sarebbero graditi solo maestri buoni, certificati, con il timbro e la garanzia di non disturbare i lavori in corso. Non si tratta, per una volta della solita battaglia tattica per il controllo dei media, due minuti a me, due minuti a te, ma di una vera indicazione d’intenti. Il “deprimente”, il “sabotatore”, quello che dice “va tutto male”, quello che non ritira il premio per polemica, e chissà quanti altri scrittori che non seguono l’onda, risultano esplicitamente sgraditi, e questo senza che il mondo della cultura abbia molto da ridire. Forse è questo il “rimettere al centro la cultura” di cui si parla tanto. Al centro del mirino. E s’avanzi, tra gli applausi, l’intellettuale “comodo”.
 Chissà chi è il senatore del Pd (“non voglio comparire”) che ha detto a Fabrizio Roncone del Corriere: “Sappia che a RaiTre, tra un po’, entreremo col lanciafiamme”. Parole ben scelte, comunque (complimentoni), rispetto alle quali le uscite del governatore De Luca (”camorrismo giornalistico”) sembrano un paterno rimbrotto. Sono passati ventun anni da quando (marzo 1994) Silvio Berlusconi disse “In Rai non sposterò nemmeno una pianta”, e appena un paio, anche meno, da quando Matteo Renzi twittava: “Via i partiti dalla Rai”. Forse intendeva: gli altri. Ora aspettiamo, come dice il senatore anonimo, l’irruzione col lanciafiamme, e intanto mettiamo un po’ d’ordine nella geografia del futuro confino. Iacona potrebbe finire a Ventotene, dove già andò Pertini, e per Giannini di Ballarò consiglierei Lipari. Si fidi, Giannini, Lipari non è male: Nitti, Lussu e Carlo Rosselli riuscirono a scappare in motoscafo e a raggiungere avventurosamente la Francia, e così speriamo di lei. A qualcuno toccherà Ustica, ma come si sa sono disponibili anche le Tremiti e Ponza, dove furono ospitati Nenni, Terracini e altri, che nemmeno lavoravano al Tg3, manco alla cronaca locale. E non è detto poi che ci si fermerà a una rete, perché l’attacco ai talk show (per esempio) è globale e riguarda tutte le reti tranne quelle più smaccatamente governative, cioè le reti Mediaset. Come si sa, meglio Rambo, che almeno è un tipino a modo, e in un film solo può ammazzare fino a trecento gufi.
Chissà chi è il senatore del Pd (“non voglio comparire”) che ha detto a Fabrizio Roncone del Corriere: “Sappia che a RaiTre, tra un po’, entreremo col lanciafiamme”. Parole ben scelte, comunque (complimentoni), rispetto alle quali le uscite del governatore De Luca (”camorrismo giornalistico”) sembrano un paterno rimbrotto. Sono passati ventun anni da quando (marzo 1994) Silvio Berlusconi disse “In Rai non sposterò nemmeno una pianta”, e appena un paio, anche meno, da quando Matteo Renzi twittava: “Via i partiti dalla Rai”. Forse intendeva: gli altri. Ora aspettiamo, come dice il senatore anonimo, l’irruzione col lanciafiamme, e intanto mettiamo un po’ d’ordine nella geografia del futuro confino. Iacona potrebbe finire a Ventotene, dove già andò Pertini, e per Giannini di Ballarò consiglierei Lipari. Si fidi, Giannini, Lipari non è male: Nitti, Lussu e Carlo Rosselli riuscirono a scappare in motoscafo e a raggiungere avventurosamente la Francia, e così speriamo di lei. A qualcuno toccherà Ustica, ma come si sa sono disponibili anche le Tremiti e Ponza, dove furono ospitati Nenni, Terracini e altri, che nemmeno lavoravano al Tg3, manco alla cronaca locale. E non è detto poi che ci si fermerà a una rete, perché l’attacco ai talk show (per esempio) è globale e riguarda tutte le reti tranne quelle più smaccatamente governative, cioè le reti Mediaset. Come si sa, meglio Rambo, che almeno è un tipino a modo, e in un film solo può ammazzare fino a trecento gufi.
Cosa si rimprovera al Tg3 e a tutta la Terza Rete, tradizionalmente frequentata da un pubblico di “ceto medio riflessivo” (traduco: vagamente di sinistra, presumibilmente elettore Pd) è presto detto. E anzi scolpito nel marmo dalle parole di un deputato Pd che siede in Vigilanza Rai, Michele Anzaldi: Rai Tre e il Tg3 “non hanno seguito il percorso del Partito Democratico, non si sono accorti che è stato eletto un nuovo segretario, Matteo Renzi, il quale poi è diventato anche premier”. Chiuse virgolette.
Distratti forte, eh! Dunque si certifica che “Fuori i partiti dalla Rai” era una battuta da avanspettacolo, piazzata tra i boys che scendono le scale e la gara di barzellette, e che il servizio pubblico dovrebbe seguire non solo la spartizione politica, ma addirittura quella correntizia, e mutare al mutare del segretario di un partito. Accidenti, che lavoraccio. E che del resto un simile pensiero sia condiviso nel partito renziano al governo è un dato di fatto: solo un paio di timide voci si sono alzate dal Pd per criticare l’attacco di De Luca, e per il resto silenzio di tomba. La macchina della propaganda, immobile o distratta: non una riga dai guru della comunicazione, non si pretende di condanna, ma almeno di perplessità e prudenza.
La guerra è dichiarata, insomma, e il terreno su cui si combatte è quello della “narrazione” renziana: chi la contrasta, e anche propone un’altra visione dei fatti, o semplicemente li racconta e li commenta senza ascoltare troppo gli ordini di scuderia, finisce nel mirino. Oltre al confino, urgerà ridisegnare i palinsesti, invitare nuovi ospiti preventivamente autorizzati, scegliere con cura gli argomenti. Suggeriamo qualche titolo per le future inchieste: “Abbondante vendemmia del Barolo grazie alle riforme di Matteo Renzi”, o “L’acqua su Marte! E poi dicono che le riforme di Matteo Renzi non servono!”. Lo spazio dei commenti – roba vecchia, di sinistra – potrebbe essere dedicato agli applausi, o a canti e coreografie in onore dell’Italia che riparte. Dovesse alzarsi qualcuno a protestare, le batterie di siluri contro il sindacato o la “casta” dei giornalisti sono piazzate, cariche, pronte a sparare. Tranquilli, la guerra sarà breve: tutto dovrà essere spianato in tempo per le elezioni politiche e per un eventuale ballottaggio. Il lanciafiamme è carico. Buona visione.
 In principio fu: “Arrivo, arrivo!”. Un tweet di burbanzosa, garrula, giovanile allegria lanciato dalle stanze del Quirinale, mentre stava ancora a colloquio con Giorgio Napolitano. Il paese fuori che aspetta, giornalisti e telecamere, lo sgarro a Enrico Letta appena consumato con abile manovra di Palazzo, e oplà: Matteo Renzi che fa il ragazzino. Visibilio. Da allora – era il 21 febbraio 2014 – l’immagine di Matteo ha fatto qualche giravolta, segnato qualche novità e tanti voti di fiducia senza che nessuno facesse un fiato, Napolitano, per dire, aveva sgridato Monti per molto meno. Mattarella non pervenuto.
In principio fu: “Arrivo, arrivo!”. Un tweet di burbanzosa, garrula, giovanile allegria lanciato dalle stanze del Quirinale, mentre stava ancora a colloquio con Giorgio Napolitano. Il paese fuori che aspetta, giornalisti e telecamere, lo sgarro a Enrico Letta appena consumato con abile manovra di Palazzo, e oplà: Matteo Renzi che fa il ragazzino. Visibilio. Da allora – era il 21 febbraio 2014 – l’immagine di Matteo ha fatto qualche giravolta, segnato qualche novità e tanti voti di fiducia senza che nessuno facesse un fiato, Napolitano, per dire, aveva sgridato Monti per molto meno. Mattarella non pervenuto.
Era un altro Renzi, lo dice lui stesso (giugno 2015) quando fa il discorsetto del “Renzi uno e Renzi due”, ma intanto sono cambiate molte cose, e tra queste l’ordine del discorso renziano: parole, trucchetti, pause, calembours, figure retoriche. Di gufi e rosiconi si è detto fino alla nausea: il buono che fa, i cattivi che remano contro, un dato saliente della narrazione renzista, l’anticamera dialettica del vecchio, caro “Non mi lasciano lavorare”, un allontanamento delle responsabilità da se stesso che ricorda Jessica Rabbit, “Io non sono cattiva, è che mi disegnano così”. Chi? I gufi.
Si perdoni la citazione “bassa”, ma, per così dire, mi adeguo al pop-speaking del premier frou-frou, quello che sulla legge elettorale diceva “Se non va bene chiamate Goldrake” (gennaio 2014), che citava Mazinga, che mischiava Tarantino e Disney (“Non penso di essere Mr. Wolf, ma neanche Paperoga”, ottobre 2014). Quello che, addirittura, se la prendeva con i Simpson (ottobre 2013) che parlavano di corruzione italiana, roba da matti, e questo ben due anni prima di attaccare i talk-show cinici e bari: Bart e Omer come Floris e Giannini.
va bene chiamate Goldrake” (gennaio 2014), che citava Mazinga, che mischiava Tarantino e Disney (“Non penso di essere Mr. Wolf, ma neanche Paperoga”, ottobre 2014). Quello che, addirittura, se la prendeva con i Simpson (ottobre 2013) che parlavano di corruzione italiana, roba da matti, e questo ben due anni prima di attaccare i talk-show cinici e bari: Bart e Omer come Floris e Giannini.
E per chi non gradisce, o non capisce, il pop spinto dei cartoon c’è sempre l’uso à la carte della citazione raccattata qui e la, va bene tutto, La Pira e Samuele Bersani, Clint Eastwood e Giliola Cinquetti (citò “Non ho l’età…”, nel discorso di insediamento al Senato, il 24 febbraio 2014), o statisti, o filosofi, scelti alla bisogna, copiaincollati da Wikipedia.
Ma questa è la superficie. A scavare un po’ si arriva presto a quello che Pierre Bourdieu chiamava “linguaggio autoritario”, cioè parole che si impongono per la loro stessa forza, senza bisogno che i contenuti le confermino o le sorreggano. Frequente quindi l’uso della figura retorica della paronomasia. Tranquilli, niente di complesso: si tratta di accostare parole simili per fonetica e lontane per significato. “Un partito pensante e non pesante”, oppure “esistere, non resistere”, “La Ue non si può solo commuovere, si deve muovere”, fino al mirabolante “Non tramo ma non tremo”, spettacolare parodia involontaria (?) del mussoliniano “Marciare, non marcire”. Chapeau. Erano quelli che Maurizio Crozza, forse il più attento osservatore delle modalità del linguaggio renziano, chiamava “I renzini… le praline dell’ovvio”. Ma che tanto ovvie non sono. C’è infatti, dietro quei giochi di parole degni di un enigmista pazzo, la volontà di lasciare un segno a prescindere dal contenuto. Un segno di forma, come il finale di una barzelletta. Perché con tutta la pretesa di “disintermediazione” (“Matteo parla al Paese, non ai giornali”) c’è invece la pretesa di fare addirittura i titoli, dei giornali, dettandoli con la frasetta a effetto, regalando quello che i vecchi cronisti chiamavano “il punto-titolo”. Una velina pubblica, insomma, parallela alle veline private che iniziano con “Renzi ai suoi…”.
 E così si potrebbe continuare. Il “noi” ostentato e reiterato, anche se non si capisce mai bene noi chi (noi Pd? Noi ggiovani? Noi del governo? Boh…), purché ci sia un “loro” fatto di cattivi. E poi il vecchio giochetto di personalizzare il discorso, per cui non “gli insegnanti” o “i docenti” (generico, impersonale), ma “Chi quotidianamente va nelle nostre classi…”. I precari che diventano Marta… Insomma, trucchetti.
E così si potrebbe continuare. Il “noi” ostentato e reiterato, anche se non si capisce mai bene noi chi (noi Pd? Noi ggiovani? Noi del governo? Boh…), purché ci sia un “loro” fatto di cattivi. E poi il vecchio giochetto di personalizzare il discorso, per cui non “gli insegnanti” o “i docenti” (generico, impersonale), ma “Chi quotidianamente va nelle nostre classi…”. I precari che diventano Marta… Insomma, trucchetti.
Ma poi si fa difficile, alla lunga, distinguere gli stilemi dalle ossessioni. E qui troviamo sempre più spesso un Renzi ultimativo e volitivo, burbero e decisionista: di Bettino gli mancano solo le mirabili pause nell’eloquio, e il resto c’è tutto. L’uso smodato del “mai più”, per esempio. Un punto esclamativo che sottolinea ora frementi ultimatum, ora semplici speranze. “Mai più inciuci o larghe intese” (detto da lui… giugno 2015). “Mai più rimborsopoli” (marzo). “Mai più ultimi nella cooperazione internazionale” (settembre). “Mai più cultura ostaggio dei sindacati” (attacco ai lavoratori del Colosseo). Sembra di vedere il mascellone che sporge dall’elmetto. Il che fa scopa, per dire, con l’uso dell’intimazione e dell’ordine imperativo: “Basta con…”. E anche qui è un florilegio notevole: “Basta con il derby ideologico sulla giustizia” (giugno 2015), “Basta con il ping-pong Camera-Senato” (aprile). “Basta con l’impunità negli stadi” (maggio), persino l’autografo a un esponente della Coldiretti, all’Expo: “Dal 2016 basta Imu!”. I media rilanciano estasiati. E poi, ovvio, tanto per tenere insieme l’imperativo categorico e i gufi: “Basta con chi protesta e non fa nulla per cambiare”.
E’ un gioco facile, un ribaltamento, perché siccome da che mondo è mondo a dire basta è chi si oppone, chi protesta, lui compie l’astuto testacoda: il responsabile del governo del paese dice un sacco di “basta!”, giocando così il ruolo del potere e, insieme, quello di intransigente oppositore. Essere al contempo quello che decide e quello che protesta, insomma: il suo sogno, il partito – o il leader – che tutto contiene, proposta e protesta, il discorso della Nazione prima ancora del Partito della nazione.
Ma qui arriva il culmine: cosa dà fastidio veramente? Cosa c’è nel mirino del discorso renziano? Semplice: la complessità. Il discutere, il riflettere, il pensarci, considerato un imbelle perder tempo. E’ qui che l’ordine del discorso renziano diventa, più che autoritario, quasi violento. “I professoroni” “I professionisti della tartina” (maggio 2014). E’ vero, c’è in queste frasi una vecchia tradizione del potere italiano, dal “culturame” evocato da Scelba agli “intellettuali dei miei stivali” di Bettino buonanima. Ma c’è anche di più: c’è l’insofferenza per il dialogo e la discussione. “Basta con i convegni sul lavoro, le cose da fare le sappiamo”, dice a Napoli in giugno; “Basta con le discussioni interne”, dice a Milano chiudendo la festa dell’Unità in settembre. E’ un leit-motiv ricorrente che ha sempre – implicita o esplicita – la sua chiosa paternalista: discutiamo, va bene (detto con sopportazione), ma poi si decide (punto esclamativo). Che, tradotto, significa: discutiamo finché volete purché alla fine si faccia come dico io. Così sulla scuola: “Sentiremo tutti”, “Una grande campagna di ascolto” (poi pose la fiducia). Così sulle riforme: “Si dialoghi, ma alla fine vince il sì”. Fino a titoli esilaranti nella loro contorsione semantica come “Apre al dialogo ma esclude modifiche”, che è come dire: dammi cento euro, dialoghiamo, discutiamo, confrontiamoci, basta che alla fine mi dai cento euro.
Democrazia, per carità, ma non esageriamo, che si perde tempo.
 “Se siete in cerca di guai siete nel posto giusto”, diceva Elvis Presley durante i concerti, e il posto giusto è stato, per qualche giorno, il Colosseo. Niente belve feroci – da mo’ – ma lo spettacolo circense sì, una vera sagra di bugie e furbizie truffaldine, pardon storytelling, con annessi e connessi. La vicenda è nota e non mi dilungherò: un’assemblea sindacale (convocata con tutti i crismi della legge), nessuno che avverte, due ore e mezzo di ritardo sull’apertura e turisti in attesa, fino al ministro Franceschini che sbotta “ora basta” e si fa saltare il tappo, e Matteo che lo segue a ruota, ribaldo e craxistico come sa essere lui quando c’è da picchiare i lavoratori. E va bene, tutto noto. Noto anche (la cosa viene fuori piano piano durante il week end) che i lavoratori in assemblea non vedevano loro soldi, legittimamente guadagnati, da più di un anno. E va bene anche questo, è così che si scatenano le guerre: tensione prima, incidente abilmente sfruttato poi, e subito partono i missili, un decreto d’urgenza in consiglio dei ministri.
“Se siete in cerca di guai siete nel posto giusto”, diceva Elvis Presley durante i concerti, e il posto giusto è stato, per qualche giorno, il Colosseo. Niente belve feroci – da mo’ – ma lo spettacolo circense sì, una vera sagra di bugie e furbizie truffaldine, pardon storytelling, con annessi e connessi. La vicenda è nota e non mi dilungherò: un’assemblea sindacale (convocata con tutti i crismi della legge), nessuno che avverte, due ore e mezzo di ritardo sull’apertura e turisti in attesa, fino al ministro Franceschini che sbotta “ora basta” e si fa saltare il tappo, e Matteo che lo segue a ruota, ribaldo e craxistico come sa essere lui quando c’è da picchiare i lavoratori. E va bene, tutto noto. Noto anche (la cosa viene fuori piano piano durante il week end) che i lavoratori in assemblea non vedevano loro soldi, legittimamente guadagnati, da più di un anno. E va bene anche questo, è così che si scatenano le guerre: tensione prima, incidente abilmente sfruttato poi, e subito partono i missili, un decreto d’urgenza in consiglio dei ministri.
Effetti collaterali. Esilarante il tweet di Flavio Briatore che ricorda al governo “più di sinistra degli ultimi trent’anni” (cfr. Renzi, febbraio del 2014) che “i dipendenti devono essere pagati”, ma va? E sul sottosegretario Barracciu che parla di “reato” e poi si corregge con “reato in senso lato” cali pure un velo pietoso.
Ma passiamo ai dettagli, dove si annida il diavolo. Il primo, decisamente divertente: per sostenere la tesi del “danno al paese” e dei “lavoratori che non amano l’Italia”, l’attesa di due ore dei turisti fuori dal Colosseo è diventata una specie di tortura cinese. A sentire i raccontini populisti-renzisti (pardon, storytelling), era una moltitudine piagata dal sole, moribonda, afflitta, sul punto di accasciarsi. Sarà. Peccato che poi giri la pagina del giornale e trovi il grande vanto italiano: le ore di coda all’Expo, dove i turisti sotto il sole per quattro ore sono invece garruli e felici di partecipare all’evento. Insomma, c’è coda e coda: intollerabile quella dovuta ad assemblea sindacale (vergogna! Puzzoni! Nemici dell’Italia!) e invece benedetta e trionfale quella al ristorantone sulla tangenziale (420 minuti di coda! Successo! Hurrà!). E va bene. Per non dire quando monumenti come Ponte Vecchio a Firenze furono chiusi per consentire feste private a maggior gloria del made in Italy: in quel caso i turisti in coda – perdonate il francesismo – non se li cagò nessuno.
Altro dettaglio notevolissimo, e non meno esilarante, l’impennata di provincialismo: vero testacoda. Perché la narrazione corrente dei renzisti è che bisogna smetterla di dire che qui non funziona niente, e che nel resto del mondo va tutto bene. Insomma, piantiamola di buttarci giù! E invece nel caso specifico, contrordine compagni, lo storytelling imponeva di dire che qui si trattano male i turisti con scioperi e assemblee, e nel resto del mondo no. Notevole autogol: il sottosegretario Scalfarotto, che ironizzava sui “famosissimi scioperi del Louvre”, negandoli con sarcasmo, è stato sommerso da ritagli di giornale, titoli, cronache pescate su Google. Eh, già, dannazione, dal Louvre alla National Gallery, dalla Tour Eiffel, al museo nazionale di Edimburgo, si scopre che tutti, prima o poi, scioperano lasciando i turisti fuori (proprio ieri il parigino Musée d’Orsay), e nessun governo tuona che i lavoratori non amano la Francia, o la Gran Bretagna, o la Scozia, o… Provincialismo e tristezza. Tristezza segnalata in aumento quando si vanno a vedere gli investimenti sulla cultura: l’Italia è ultima in Europa, spende l’1,1 per cento del Pil, la metà della media europea, peggio della Grecia (1,2). E nessuno che sbotti indignato: ecco! Non amate l’Italia! Ora basta!
Ehilà! Rieccoci con un paio di appuntamenti con Dove sei stanotte… Venerdì sera (il giorno 25, alle 20.30) si mangia, finalmente! Nel senso che alla Cascina di Mattia (che sta a Cantù, in via Ovidio 32) si terrà una “cena con l’autore” (che sarei io, eh!). Dicono che il menu sarà ispirato al libro e… vabbé… nel caso qualcuno voglia osare, la locandina è qui.
Sabato sera, invece (il 26… uff, devo dirvi tutto!), al Castello di Masnago (Varese), nell’ambito di “Week end in giallo” si parlerà di gialli, noir, cronaca nera e altro. Chiacchiere dalle 19, poi dibattito. Titolo: sbatti il mostro in prima pagina… (la locandina è qui). Insomma, on the road again, eccetera eccetera…
 Vorrei pubblicamente ringraziare Jeremy Corbyn per il servizio reso alla politica e all’informazione. No, non alla politica e all’informazione britanniche (questo si vedrà) ma a quelle di casa nostra. Grazie per aver rivelato ancora una volta come tutto quanto – ma proprio tutto, dallo sbarco sulla luna e pure prima – venga distorto e reso caricatura se visto da qui, provincialissima provincia, periferia dell’impero. Le ironie sul “papa straniero” sono già state fatte, ogni volta identiche. C’è una sinistra culturalmente ostaggio di un centro-centro-centro-sinistra che ogni volta si innamora perdutamente di chiunque sappia fare la sinistra meglio di lei. E prima Zapatero, e poi Tsipras, e ora Corbyn. e così via, forse aspettando un leader socialista in Kamchatka o alle isole Fiji, in modo che il pellegrinaggio sia più esotico e avventuroso. E vabbé. E poi ci sono tutti gli altri: grandi giornali e leader moderati, renzisti di prima, seconda, terza generazione, Blairisti rinati del Settimo Giorno, e tutto il resto. Va da sé che mister Corbyn non c’entra niente, è solo un detonatore. E’ come se, incapace di affrontare in modo autonomo il dibattito ideologico (uh, parolaccia!) tra le varie sinistre possibili, ci si aggrappi a chi, ovunque nel mondo, quel dibattito lo pratica nei fatti.
Vorrei pubblicamente ringraziare Jeremy Corbyn per il servizio reso alla politica e all’informazione. No, non alla politica e all’informazione britanniche (questo si vedrà) ma a quelle di casa nostra. Grazie per aver rivelato ancora una volta come tutto quanto – ma proprio tutto, dallo sbarco sulla luna e pure prima – venga distorto e reso caricatura se visto da qui, provincialissima provincia, periferia dell’impero. Le ironie sul “papa straniero” sono già state fatte, ogni volta identiche. C’è una sinistra culturalmente ostaggio di un centro-centro-centro-sinistra che ogni volta si innamora perdutamente di chiunque sappia fare la sinistra meglio di lei. E prima Zapatero, e poi Tsipras, e ora Corbyn. e così via, forse aspettando un leader socialista in Kamchatka o alle isole Fiji, in modo che il pellegrinaggio sia più esotico e avventuroso. E vabbé. E poi ci sono tutti gli altri: grandi giornali e leader moderati, renzisti di prima, seconda, terza generazione, Blairisti rinati del Settimo Giorno, e tutto il resto. Va da sé che mister Corbyn non c’entra niente, è solo un detonatore. E’ come se, incapace di affrontare in modo autonomo il dibattito ideologico (uh, parolaccia!) tra le varie sinistre possibili, ci si aggrappi a chi, ovunque nel mondo, quel dibattito lo pratica nei fatti.
Una grossa mano, a mister Corbyn, l’ha data Tony Blair, certo. La sua dichiarazione agli iscritti del Labour (“Anche se mi odiate non votate per lui”) è stata una specie di benedizione: ai laburisti inglesi sta talmente sulle palle Blair per come li ha snaturati che avrebbero votato chiunque pur di seppellire una volta per tutte il suo fantasma cinico e traffichino. Qui da noi, invece – l’unico angolo del mondo in cui c’è gente che si dice ancora blairista (che è un po’ come dirsi Borbone, o filo-uno) – è partita la sistematica distruzione del personaggio Corbyn. Passi per i renzisti di stretta osservanza. La loro narrazione è semplice e lineare, in qualche modo coerente: vincere è l’unica cosa che conta, per vincere bisogna essere destra, quindi Corbyn non vincerà (sottotesto: noi sì). Un sillogismo di prima figura che li fece sentire tanto furbi già al liceo.
Con Corbyn c’è qualche variante. Intanto (successe già con Tsipras) si fa grande uso della formula “estrema sinistra”, il che è assai rivelatore: siamo così poco abituati a leader che dicono cose di sinistra che quando ne vediamo uno dobbiamo dargli del pericoloso estremista. E populista, va da sé, che è ormai l’insulto standard per chi non va in deliquio ai tweet (quelli sì, populisti) di Matteuccio nostro. In Gran Bretagna, il primo ministro definisce il capo del Labour “pericoloso”. Hurrà! Era ora: che il leader della sinistra sia “pericoloso” per la destra pare una boccata d’aria fresca, oppure – a seconda delle angolazioni – un vento gelido, per un paese come l’Italia dove un leader di “sinistra” capo del governo è considerato una risorsa e un toccasana da Verdini, Cicchitto, Berlusconi, Confindustria, più Fede Emilio, parlandone da vivo. Corre a rinforzo la grande stampa: Corbyn si veste male. Corbyn non mette donne nel suo governo-ombra (falso, ma tant’è). Aspettiamo con apprensione “Corbyn posteggia in seconda fila” e “Corbyn si lava i piedi solo al giovedì”, sempre temendo l’attacco frontale: “Corbyn non fa la raccolta differenziata”. Per “Corbyn non sa l’inglese” e “Corbyn ruba nei supermercati” è presto, ma chissà, forse aspettano un sms che inizia con: “Renzi ai suoi”.
Pier Vittorio Tondelli oggi avrebbe sessant’anni. Gli auguri non gli servono, ricordarlo (e leggerlo) sì. Qui c’è la sua figurina
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
Oggi Franz Beckembauer compie 70 anni, è uno chje ha vinto parecchie cose, e qui c’è la sua figurina
Figu è un programma di Alessandro Robecchi e Peter Freeman con Cristiana Turchetti trasmesso da Rai Tre
 Siccome non smette un attimo la furiosa gara alla rottamazione del Novecento – miti, ideologie, simboli, bandiere – per una volta si può davvero gioire per un oggetto che dimostra, finalmente, la sua poderosa inutilità. Prima dei peana per la signora Merkel e delle pive nel sacco di razzisti e xenofobi europei di fronte al sussulto umanitario, va notata una cosa: il filo spinato – scusate il francesismo – non serve a un cazzo. Questa icona del Novecento, questa barriera per uomini considerati animali, questa difesa fisica che serve a non far scappare o a non far entrare, se ne va tra gli sberleffi di chi l’attraversa e la gioia di chi non la voleva costruire. A guardarla in timelapse, con le immagini accelerate, la recente vicenda ungherese sembra davvero un film di Ridolini: prima il grande sforzo di costruire barriere in acciaio uncinato, e poi, questione di minuti, il suo tsunamico superamento da parte delle moltitudini. Ecco fatto, i simboli contano, ma le azioni che li fanno a pezzi contano di più: un continente che ha festeggiato la caduta del muro di Berlino doveva già saperlo, ma insomma, repetita juvant.
Siccome non smette un attimo la furiosa gara alla rottamazione del Novecento – miti, ideologie, simboli, bandiere – per una volta si può davvero gioire per un oggetto che dimostra, finalmente, la sua poderosa inutilità. Prima dei peana per la signora Merkel e delle pive nel sacco di razzisti e xenofobi europei di fronte al sussulto umanitario, va notata una cosa: il filo spinato – scusate il francesismo – non serve a un cazzo. Questa icona del Novecento, questa barriera per uomini considerati animali, questa difesa fisica che serve a non far scappare o a non far entrare, se ne va tra gli sberleffi di chi l’attraversa e la gioia di chi non la voleva costruire. A guardarla in timelapse, con le immagini accelerate, la recente vicenda ungherese sembra davvero un film di Ridolini: prima il grande sforzo di costruire barriere in acciaio uncinato, e poi, questione di minuti, il suo tsunamico superamento da parte delle moltitudini. Ecco fatto, i simboli contano, ma le azioni che li fanno a pezzi contano di più: un continente che ha festeggiato la caduta del muro di Berlino doveva già saperlo, ma insomma, repetita juvant.
Ora, naturalmente, saranno liberissimi i razzisti europei di aggrapparsi à la Salvini, a qualche fatto di sangue, a qualche disfunzione del sistema, con la patetica pretesa di combattere la Storia con la cronaca nera, ma sarà come svuotare il mare con un cucchiaio, auguri. Il fatto è che superando il concetto di filo spinato – se veramente si farà – l’Europa importerà il suo futuro. Ma sì, certo, ovvio, anni e anni di politica europea sconclusionata, litigiosa, dissociata e miope ci hanno insegnato che le frasi a effetto lasciano il tempo che trovano. Nessuno è straniero, benvenuti, restiamo umani, eccetera eccetera, sono belle parole che scaldano il cuore, ma poi la palla passa inevitabilmente ai fatti. E i fatti dicono che domani, nel 2050, se si tenesse teso il filo spinato intorno alla fortezza, in Europa ci sarebbero due lavoratori per ogni pensionato: semplicemente impossibile da sostenere. E dunque, anche se ci piacciono molto gli attestati di umanità che ci attribuiamo e attribuiamo ai governi e leader improvvisamente illuminati, per una volta ci piacciono di più le analisi macroeconomiche. Qui, nella vecchia Europa, servono urgentemente almeno duecento milioni di lavoratori nel prossimo mezzo secolo. Una cifra che gli anziani e sazi europei non raggiungerebbero nemmeno mettendosi a figliare come conigli. E dunque le braccia e le teste e i cuori che passano il filo spinato ungherese, le onde del canale di Sicilia, le barriere tra Ceuta e Gibilterra, ci servono come il pane, o meglio, se è lecito il paradosso, ci servono per avere pane anche domani. Mi rendo conto che gli studi dell’Ocse, le cifre di Bloomberg, le analisi degli economisti e dei ricercatori possano togliere poesia e letteratura alla retorica dell’accoglienza e forse darle una patina di cinismo. Ma meglio così: è risaputo che l’egoismo funziona più dei buoni sentimenti e dunque egoisti di tutta Europa unitevi, accogliete migranti e rifugiati se volete mantenere tra qualche decennio una parvenza di stato sociale, per voi e per loro. Per avere nei prossimi trent’anni duecento milioni di nuovi europei serviranno scuole, case, ospedali, servirà tutto e bisognerà costruirlo. E quindi insieme alle loro speranze e ai loro bambini, migranti e rifugiati ci portano pure l’unica cosa che serve davvero: un New Deal europeo per il ventunesimo secolo.
 Ma per quanto possa piacere la nostalgia, il ricordo del tempo passato, il piccolo tepore della rimembranza, diciamolo una volta per tutte: nemmeno Proust si sarebbe mangiato una petite madeleine vecchia di sessant’anni. E invece ora eccoci qui, immersi nella turbo modernità postideolgica, produttivista e “di sinistra”, a masticare biscottini vecchi di oltre mezzo secolo. Uno per tutti, quello sfornato da Giorgio Squinzi, boss di Confindustria, a proposito dei sindacati che sarebbero “un fattore di ritardo, che ha fatto tardare tanto l’ammodernamento e l’efficienza complessiva del Paese”. Ah, il vecchio sapore delle cose di una volta! Come tornare bambini. Io imparavo ad andare in bici e già si diceva “è colpa dei sindacati”. C’era il boom economico e comunque era colpa dei sindacati, poi la crisi petrolifera mondiale ed era colpa dei sindacati. Poi venne un’era di latte e miele: l’economia tirava, c’era il sor Bettino e giravano mazzette come coriandoli a capodanno e, niente… era colpa dei sindacati. E così tra alti e bassi, eccoci qui nell’anno due dell’era renzista, dove tutto luccica di speranza e belle frasette a effetto e: indovinate? È colpa dei sindacati. Lo scioglimento dei ghiacciai e quello dei Beatles, l’immigrazione interna e le crisi cicliche del capitalismo, le ristrutturazioni e i licenziamenti di massa, i Righeira, la disoccupazione giovanile al suo picco storico e siamo ancora lì. E che la frase più stantia della politica italiana di sempre venga poi pronunciata tra gli applausi alla festa dell’Unità è anche quello un buon contrappasso: veniamo da lontano, andiamo lontano, poi c’è ‘sto curvone a U, parabolico, che ci riporta lì, alla maggioranza silenziosa, alla marcia dei quarantamila, al dottor Romiti, a la Malfa e Malagodi.
Ma per quanto possa piacere la nostalgia, il ricordo del tempo passato, il piccolo tepore della rimembranza, diciamolo una volta per tutte: nemmeno Proust si sarebbe mangiato una petite madeleine vecchia di sessant’anni. E invece ora eccoci qui, immersi nella turbo modernità postideolgica, produttivista e “di sinistra”, a masticare biscottini vecchi di oltre mezzo secolo. Uno per tutti, quello sfornato da Giorgio Squinzi, boss di Confindustria, a proposito dei sindacati che sarebbero “un fattore di ritardo, che ha fatto tardare tanto l’ammodernamento e l’efficienza complessiva del Paese”. Ah, il vecchio sapore delle cose di una volta! Come tornare bambini. Io imparavo ad andare in bici e già si diceva “è colpa dei sindacati”. C’era il boom economico e comunque era colpa dei sindacati, poi la crisi petrolifera mondiale ed era colpa dei sindacati. Poi venne un’era di latte e miele: l’economia tirava, c’era il sor Bettino e giravano mazzette come coriandoli a capodanno e, niente… era colpa dei sindacati. E così tra alti e bassi, eccoci qui nell’anno due dell’era renzista, dove tutto luccica di speranza e belle frasette a effetto e: indovinate? È colpa dei sindacati. Lo scioglimento dei ghiacciai e quello dei Beatles, l’immigrazione interna e le crisi cicliche del capitalismo, le ristrutturazioni e i licenziamenti di massa, i Righeira, la disoccupazione giovanile al suo picco storico e siamo ancora lì. E che la frase più stantia della politica italiana di sempre venga poi pronunciata tra gli applausi alla festa dell’Unità è anche quello un buon contrappasso: veniamo da lontano, andiamo lontano, poi c’è ‘sto curvone a U, parabolico, che ci riporta lì, alla maggioranza silenziosa, alla marcia dei quarantamila, al dottor Romiti, a la Malfa e Malagodi.
Si dirà che il classico va sempre, che la giacca blu e la frase “è colpa dei sindacati” non tramonteranno mai. Si dirà anche che ora si apre una stagione di rinnovi contrattuali, e che quindi la formuletta torna di moda per motivi tattici. E si dirà anche che una classe imprenditoriale che in questi anni (tutti questi anni) ha dato il peggio di sé – l’altra metà della corruzione, dove la mazzetta è l’anello di congiunzione tra la politica e l’impresa – se la cava con i saldi, indicando un capro espiatorio: il solito.
Eppure c’è anche qualcosa di inedito. Ai “nuovi” che secondo Squinzi “realizzano tutti i nostri sogni” (ottobre 2014) di sogno ne sarebbe sfuggito uno: quello di calpestare i sindacati. E Squinzi poderosamente lo ricorda proprio alla loro festa, quella che una volta era un appuntamento per l’orgoglio dei lavoratori e oggi pare una piccola Leopolda dove si teorizza che i diritti sono una seccatura che rallenta. Non è il luogo comune che stupisce (niente è meno sorprendente dei luoghi comuni) ma la sua nuova declinazione. Se il blairismo proseguiva il lavoro della Thatcher marciando sulle macerie del concetto di protezione sociale, qui i poveri gestori dell’esistente devono fare due lavori insieme: devono fingersi Blair (che già…) e agire da Thatcher, difendere il nome della sinistra nel logo della ditta (che già…) e intanto fare la faccia dura di Margaret. Un lavoraccio. A chi chiedere appoggio? A che affidare un pezzettino della narrazione antioperaia? Ma naturalmente agli imprenditori, santificati negli ultimi anni come salvatori della patria che poi, siccome la patria non si sta salvando per niente, puntano il dito contro altri. Facile. Elementare. Si fa da sessant’anni, perché cambiare?
 Solenne promessa: non parlerò del meeting di Rimini, di Cl, degli applausi a Renzi. Cioè, volendolo fare basterebbe fotocopiare gli articoli degli ultimi anni, forse degli ultimi secoli, visto che l’attività prevalente nel noto festival di misticismo&affari è battere le mani. Lì sono stati applauditi, e salutati come salvatori della patria, tutti, ma proprio tutti: Berlusconi e Monti, Formigoni e Renzi, il commissario Basettoni, Odoacre re degli eruli (V secolo d.C), protomartiri, alpinisti, guidatori di carrozze, economisti, gente che fa il cubo di Rubik in sei secondi. Si presentasse Tom Cruise vestito da alpino: applausi. Comparisse Balotelli: ovazione. Dunque niente, farò obiezione di coscienza, almeno fino a quando (speriamo mai, eh!) non verrà ospitato al meeting qualche Califfo dello Stato Islamico: battimani sfrenato, perché dopotutto anche lui è molto religioso. E va bene: è il segnale che a quelli lì, tanto devoti, il mondo va bene così com’è, basta che uno comandi qualcosa, dall’economia planetaria alla municipalizzata, e loro sono contenti, e lo appoggiano convinti.
Solenne promessa: non parlerò del meeting di Rimini, di Cl, degli applausi a Renzi. Cioè, volendolo fare basterebbe fotocopiare gli articoli degli ultimi anni, forse degli ultimi secoli, visto che l’attività prevalente nel noto festival di misticismo&affari è battere le mani. Lì sono stati applauditi, e salutati come salvatori della patria, tutti, ma proprio tutti: Berlusconi e Monti, Formigoni e Renzi, il commissario Basettoni, Odoacre re degli eruli (V secolo d.C), protomartiri, alpinisti, guidatori di carrozze, economisti, gente che fa il cubo di Rubik in sei secondi. Si presentasse Tom Cruise vestito da alpino: applausi. Comparisse Balotelli: ovazione. Dunque niente, farò obiezione di coscienza, almeno fino a quando (speriamo mai, eh!) non verrà ospitato al meeting qualche Califfo dello Stato Islamico: battimani sfrenato, perché dopotutto anche lui è molto religioso. E va bene: è il segnale che a quelli lì, tanto devoti, il mondo va bene così com’è, basta che uno comandi qualcosa, dall’economia planetaria alla municipalizzata, e loro sono contenti, e lo appoggiano convinti.
Ma quest’anno il Meeting di Rimini ha presentato – subito nascosto e scopato sotto il tappeto – anche un siparietto satirico di discreto impatto. Protagonista e capocomico, il predicatore domenicano Giorgio Carbone, quello che ha citato una ricerca danese secondo cui le coppie omosessuali hanno più problemi cardiovascolari rispetto alle coppie etero. Molto divertente. Va detto che nel timore – anzi nella certezza – che il pubblico ciellino applaudisse anche lui, l’organizzazione è corsa ai ripari e gli ha vietato ulteriori spettacoli. Peccato. Dunque lasciatemi protestare vibratamente contro questa censura: non si interrompe un’emozione! In altre affollate riunioni di devotissimi, chissà, padre Carbone avrebbe forse illustrato uno studio dell’università di Tubinga (i gay non vincono al lotto) o un dotto trattato di qualche ateneo del Wisconsin (i rapporti prematrimoniali sono dannosi per il menisco). Insomma, a Rimini resta la noia degli applausi scontati e viene vietato il garrulo buonumore del teatro dell’assurdo, e questo è male. Si aggiunga una notazione, per così dire, di natura mediatica: non ci aspettavamo da religiosi così studiosi e colti il ricorso al noto trucchetto della “ricerca”. Ma sì, quella cosa che serve a fare titoli ad effetto e a guadagnare clic nelle colonnine a destra dei giornali online. Il trucco è semplice: si cita una ricerca, un’università a caso, un pool di studiosi, un nome roboante, e gli si attribuisce qualcosa di grandiosamente insensato. Chi mangia funghi è portato per la matematica. Gli zoppi ce l’hanno grosso. Le bionde tradiscono più spesso. Eccetera eccetera. Il resto è affidato alla morbosità (o al dadaismo) del lettore, che clicca e ride. E’ un trucco recentemente tracimato nei talk show e nel dibattito politico: chi è a corto di argomenti butta lì i risultati di una fantomatica ricerca, tipo: secondo prestigiosi ricercatori di Uppsala bisogna tagliare la sanità. Argomento inattaccabile, soprattutto per il fatto che tutto resta in superficie, e qualcuno che si va a leggere la fantomatica ricerca non c’è mai (che due palle! Ammesso che esista, sarà in inglese, lunga, coi grafici… mah, facciamo a fidarci che si fa prima). Stupisce dunque che religiosi tanto rigorosi e studiosi (hanno persino una casa editrice) si pieghino a certi trucchetti così banali, ma spiace comunque per la censura a padre Carbone e ai suoi fratelli. Male, molto male. Sarebbe stato meglio un bel dibattito pubblico, magari dal titolo “Dice una ricerca paraguaiana che siano tutti molto stupidi e in malafede”. Ospiti illustri, disquisizioni, ispirati interventi, qualche preghiera. Ah, e poi – dimenticavo – applauso finale con standing ovation.
Allora, ecco qualche nuovo appuntamento per Dove sei stanotte. Domenica 23 agosto (domani) al festivan Ventimilarighesottoimari in giallo, a Senigallia. E’ quasi un appuntamento fisso. Alle 21.30 nel cortile della Rocca Roverasca, presentazione del libro con Maria Francesca Alfonsi (qui il programma). Venerdì 28 agosto, invece, al Festival delle Storie, che è un festiva diffuso di libri, storie e altro nel cuore della Ciociaria, nella valle di Comino. L’incontro è ad Atina, alle 11 (caffetteria Mancini, largo San Rocco). Il giorno prima un incontro con gli iscritti alla facoltà di scienza delle comunicazioni. Insomma, non sarà il neverending tour di zio Bob, ma…
 Notevole lo sconcerto del paese per l’assunzione di sette direttori di museo con cittadinanza straniera. Qualcuno si è stupito: “Ah, cazzo, abbiamo più di sette musei?”. I più colti, invece, non si capacitano che quelli che vengono qui a fare qualcosa di utile non siano solo centrocampisti o schiavi per la raccolta dei pomodori. Il ministro Franceschini incassa lodi e critiche in egual misura, quindi rispetto ai suoi standard le lodi sono raddoppiate. Ma soprattutto un grido si alza dalla popolazione: “Fateci sognare!”. Un incoraggiamento che sottintende un pensiero forte e coraggioso: “Ma perché solo nei musei?”
Notevole lo sconcerto del paese per l’assunzione di sette direttori di museo con cittadinanza straniera. Qualcuno si è stupito: “Ah, cazzo, abbiamo più di sette musei?”. I più colti, invece, non si capacitano che quelli che vengono qui a fare qualcosa di utile non siano solo centrocampisti o schiavi per la raccolta dei pomodori. Il ministro Franceschini incassa lodi e critiche in egual misura, quindi rispetto ai suoi standard le lodi sono raddoppiate. Ma soprattutto un grido si alza dalla popolazione: “Fateci sognare!”. Un incoraggiamento che sottintende un pensiero forte e coraggioso: “Ma perché solo nei musei?”
In effetti la suggestione di un’Italia gestita da stranieri è densa di fascino, anche se non ci sarebbe niente di nuovo: l’economia la dirigono a Berlino, il welfare viene ridisegnato secondo i dettami del Fondo Monetario Internazionale con sede a Washington, e chiunque diventi Presidente del Consiglio per prima cosa va a baciare la pantofola alla signora Merkel, più internazionali di così…
Quanto alle relazioni sindacali, fanno notare a Palazzo Chigi con grande soddisfazione, le indirizza Marchionne, che ha la cittadinanza svizzera, e lavora a Detroit in un’azienda con sede legale in Olanda e sede fiscale in Gran Bretagna. “E’ il cambiaverso – scrive l’Unità – ora non resta che pagare gli operai italiani come quelli polacchi, ci siamo quasi”. Sullo spinoso capitolo del sindacato, anzi, si registra addirittura un deciso entusiasmo negli ambienti del governo: “Alla Fiom vorremmo un cinese, uno che non si opponga al lavoro domenicale, notturno, minorile e, perché no, gratuito e volontario”. Confindustria si dice d’accordo ma chiede sgravi fiscali sugli operai neonati.
La sindrome del direttore straniero, comunque, è contagiosa e ne parlano tutti. Alla Lega, per esempio, si mormora già di un dopo-Salvini: “Ci piace molto il capo del Klu Klux Klan, che però non vuole lasciare l’Alabama”, dicono in via Bellerio. E aggiungono: “I nostri amici di Casa Pound vorrebbero un tedesco, ma quelli che piacciono a loro sono già stati impiccati a Norimberga, o hanno novantanove anni e vivono nascosti in Argentina”.
L’ipotesi di avere una classe dirigente straniera non spaventa per nulla il Pd, che vanta una radicata cultura europeista: a capo della destra berlusconiana, per esempio, al Nazareno si vedrebbe bene il francese Verdin, o l’austriaco Verdinen, o persino lo svedese Verdinson, e purché votino le riforme costituzionali insieme loro, accetterebbero persino il portoghese Verdinho o l’estone Verdinov.
Più complessa la situazione per enti pubblici e grandi aziende di Stato. Alla Rai, per esempio, si valutano le nomine dei nuovi direttori dei telegiornali. Certo, il problema con un direttore straniero sarebbe la lingua, ma alla fine basterà spiegargli come si dice in italiano “Very well, Matteo!”, oppure “Very good, Matteo!” e le differenze con il presente sarebbero minime. La comprensione dell’azione governativa e della ciclopica ondata di riforme, non sarebbe un problema, tanto le scrive Confindustria e sono quasi tutte in inglese, a partire dal Jobs Act. Per Eni e Enel, invece, posti assai delicati nell’equilibrio del potere, si pensa a una pattuglia di manager britannici, tutti nati a Rignan-on-Arn. Un tweet del Presidente del Consiglio ha già dato il via libera: “Why not? #Italyripart”.
E la società civile? Anche lì, fanno notare in molti, servirebbe un ricambio, magari mettere nei giornali direttori stranieri, ma su questo punto a Palazzo Chigi sono più prudenti: “Sarebbe un lavoraccio tradurre tutte le veline che mandiamo ogni giorno, senza contare che la frase ‘Renzi a suoi’ non è traducibile in molte lingue senza vergognarsi”.
 Ma dunque confinano, si toccano, si somigliano, le campagne pugliesi in mano ai caporali, la luccicante modernità di Amazon, la Gran Bretagna conservatrice? Com’è possibile? A leggere le cronache di questi giorni si direbbe che il minimo comun denominatore è quello: sfruttamento e mortificazione del lavoro. Dall’inchiesta del New York Times, per esempio, l’impero Amazon esce, eticamente, a pezzi. Lavoratori costretti alle ottanta ore settimanali e spiati anche in bagno, addirittura esperimenti (si può dire fuor di battuta: su cavie umane) su come aumentare la produttività, lavoratrici incinte e lavoratori malati licenziati. Jeff Bezos, il capo di quell’impero da 250 miliardi di dollari, ha risposto indignato, ma l’inchiesta non è contestabile: il più fulgido esempio di modernissima azienda ne esce come una galera.
Ma dunque confinano, si toccano, si somigliano, le campagne pugliesi in mano ai caporali, la luccicante modernità di Amazon, la Gran Bretagna conservatrice? Com’è possibile? A leggere le cronache di questi giorni si direbbe che il minimo comun denominatore è quello: sfruttamento e mortificazione del lavoro. Dall’inchiesta del New York Times, per esempio, l’impero Amazon esce, eticamente, a pezzi. Lavoratori costretti alle ottanta ore settimanali e spiati anche in bagno, addirittura esperimenti (si può dire fuor di battuta: su cavie umane) su come aumentare la produttività, lavoratrici incinte e lavoratori malati licenziati. Jeff Bezos, il capo di quell’impero da 250 miliardi di dollari, ha risposto indignato, ma l’inchiesta non è contestabile: il più fulgido esempio di modernissima azienda ne esce come una galera.
Il salto dai grandi depositi di Amazon ai campi pugliesi sembra improponibile, eppure. Eppure basta leggere la storia di Paola Clemente, morta di fatica nei campi: si alzava alle tre di notte, tornava a volte dopo dodici-quindici ore tra viaggio e lavoro, per ventisette euro, il marito se l’è andata a riprendere nella camera mortuaria del cimitero di Andria, morta di lavoro. Dunque nell’era del turboliberismo, della crescita, dell’elogio del profitto senza se e senza ma, chi resta schiacciato è il lavoro, e insieme a lui, ovvio, i lavoratori. Sembrerebbe un fenomeno che avvolge il pianeta: in Gran Bretagna il governo conservatore parla di stroncare la “welfare-dipendenza”, cioè di creare infinite difficoltà a chi usufruisce dei sussidi, allo scopo di ridurli e con l’effetto di umiliare chi ne usufruisce. Sono più che segnali: è il trionfo di un’ideologia che ha seppellito tutte le altre al grido vile e interessato di “basta con le ideologie”. A resistere è rimasta l’ideologia più vecchia del mondo, lo sfruttamento. Una cosa così introiettata, così intimamente accettata che è diventata un cavallo di battaglia anche delle sinistre al governo. L’Unità che esalta i lavoratori della Elettrolux che decidono “liberamente” di lavorare a Ferragosto (quel “liberamente” dice tutto, e contiene tutta la vergogna degli attuali rapporti di forza tra lavoratori e imprese), la serena accettazione dei ribassi salariali perché “siamo in crisi”, il marchionnismo, nuovo fordismo 2.0, dove l’unica variabile indipendente è il profitto dell’azienda e tutto – anche la dignità di chi vi contribuisce lavorando – deve essere al suo servizio. Il linciaggio mediatico dei professori precari che non vogliono spostarsi di mille chilometri per guadagnare, non si sa per quanto, mille euro al mese, è un’altra variante dell’equazione: il lavoro non c’è e chi ha la fortuna di averlo si lamenta? Intollerabile. E via con la lapidazione di gente che ha studiato una vita e lavora (male) da anni, accusata oggi di chiedere privilegi anziché elementari diritti. In questo scenario (globale, non solo italiano), fa sorridere la polemica sulla sinistra italiana (attuale? Ex? Futura? Alternativa? Possibile?). Ne parlarono su questo giornale, una settimana fa, Antonio Padellaro e Giuseppe Civati, ognuno con i propri ottimi argomenti. E si disse dell’irrilevanza di una nuova possibile pattuglia di sinistra, o dei diritti dei gay, o della liberalizzazione delle canne, o delle sedicenti riforme o controriforme, eccetera eccetera. Ma del lavoro, della dignità del lavoro, della schiavitù che ci assedia – assecondata e accettata per “necessità” come fu sempre nella storia del mondo anche da chi si definisce “di sinistra” – poco o nulla. Eppure se non si (ri)parte da lì, da un diritto al lavoro dignitoso, ogni nuovo diritto sembrerà un premio di consolazione, poco più che orpello, concessione, regalia. In nome del profitto.
Diciamo così: D di Repubblica, per uno speciale sull’arte, mi ha chiesto un luogo, un posto, un monumento. Ecco. E io ho pensato a questo.
 Un fenomeno che non si riesce a spiegare, che la scienza non sa decifrare, che nemmeno i maghi e i veggenti riescono a interpretare. Come mai, dannazione, invece di cliccare sulla notizia “Suora diventa lapdancer” o sul titolo “Cane lupo di Taiwan sa le tabelline”, gli italiani si siano letti avidamente il carteggio Staino-Cuperlo, una cosa che pesa sulla società italiana come un documentario sull’accoppiamento delle lumache. Masochismo estivo, probabilmente, o meglio ancora un portato delle molte sfumature che si vendono in libreria: “Caro, questa sera ti frusto con il gatto a nove code”. “No, tesoro, fammi più male ancora, leggimi la lettera di Staino a Cuperlo”.
Un fenomeno che non si riesce a spiegare, che la scienza non sa decifrare, che nemmeno i maghi e i veggenti riescono a interpretare. Come mai, dannazione, invece di cliccare sulla notizia “Suora diventa lapdancer” o sul titolo “Cane lupo di Taiwan sa le tabelline”, gli italiani si siano letti avidamente il carteggio Staino-Cuperlo, una cosa che pesa sulla società italiana come un documentario sull’accoppiamento delle lumache. Masochismo estivo, probabilmente, o meglio ancora un portato delle molte sfumature che si vendono in libreria: “Caro, questa sera ti frusto con il gatto a nove code”. “No, tesoro, fammi più male ancora, leggimi la lettera di Staino a Cuperlo”.
In ogni caso, e al netto dello scambio epistolare tra un gigante della satira (Cuperlo) e un titano del renzismo (Staino), è il caso di dedicare qualche riflessione al succo della questione. E cioè al fremente dibattito su cosa sia di sinistra e cosa no, una questione davvero entusiasmante, un dibattito che sarà apprezzatissimo, per esempio, dagli schiavi che raccolgono i pomodori nei campi pugliesi morendo nelle piantagioni come nell’Alabama dell’800.
Se ci pensate, è il modo migliore per parlare d’altro, per spostare la discussione dalle cose vere (che so, i tagli alla sanità, Confindustria che applaude, lo sconto agli evasori fiscali, una legge sul falso in bilancio peggiore di quella che fece Berlusconi, cosucce cosi) a un piano aleatorio e teorico, dove vale tutto. Da qui l’entusiasmante diatriba su siamo di sinistra, no, non lo siete, lo eravate, ma solo un po’, sui bordi, anzi no, eccetera eccetera, con tutte le varianti del caso: niente ci verrà risparmiato. Dopo le interessantissime discussioni sulla prova costume, ecco le schermaglie sulla “prova sinistra”.
Disse Matteo Renzi nel febbraio del 2014, quando ancora pareva un burbanzoso innovatore che avrebbe rottamato il passato cinico e baro, che il suo era “Il governo più di sinistra degli ultimi trent’anni”, che ancora oggi – dopo che ne ha dette migliaia – resta la sua battuta migliore. Poco più di un anno dopo, quel governo così di sinistra proponeva nella stessa settimana un taglio delle tasse sui profitti delle imprese (non sul lavoro, non sugli investimenti, non sulle vite dei cittadini, no, no, proprio sui profitti) e contestualmente un taglio della sanità pubblica. Ora, per convincere tutti che questa sia una cosa di sinistra ci sono molte strade: dall’ipnosi di massa alla distribuzione di pasticche lisergiche. Si sceglie invece una strada più tortuosa: attaccare la sinistra del Pd dicendo che non capisce il senso profondamente di sinistra di tutto questo. La sinistra Pd, dal canto suo e parlandone da viva, gioca il ruolo delle cantanti liriche nelle opere più entusiasmanti, cioè canta per un intero atto “Muoio… muoio… ah, guardate come muoio, me tapina… muoio”, e così avanti per giorni e giorni, senza morire mai, senza andarsene mai e soprattutto votando con il partito quando ce n’è bisogno, salvo rari casi. La stessa sinistra Pd che oggi si fa alfiere e portavoce della “sinistra” è quella che votava compatta il governo Monti, la legge Fornero, il pareggio di bilancio nella Costituzione. Insomma, c’è un concetto di sinistra molto variabile e ballerino, che si sventola oggi sì, domani no, dopodomani vedremo cosa ci conviene, e la sensazione è che possa passare qualunque porcata galattica purché la si dica “di sinistra”. Intanto, negli ultimi trent’anni la forbice tra rendite e profitti e redditi da lavoro si è allargata a dismisura: i ricchi sono più ricchi e i poveri più poveri, ma di questo – che è l’unico argomento su cui tessere una teoria di sinistra ai tempi del colera – non si occupa nessuno. Uff, che noia… uff, che palle. Vuoi mettere leggere cosa ne pensa Staino?
Vedi a volte le disgrazie. Insomma, mi chiedono dieci canzoni e io gliele dico. Poi me ne vengono in mente ottomila e seicento che non ho detto. Ma, insomma, sapete, eh! Grazie a Severino Salvemini di Sette. (Grazie sempre per la mia fotina ai tempi del trattato di Yalta). Qui sotto
 Dunque riassumiamo: “Basta piagnistei”. Una variante. L’ennesima, del “basta piangersi addosso”, rimbocchiamoci le maniche, basta lamentarsi e ognuno aggiunga a piacere fino a esaurimento scorte (peraltro inesauribili). C’è qualcosa di nuovo, anzi, di antico, nella nuova polemica del Caro Leader, eccezionalmente lanciata dal Giappone. E’ più di una frecciatina a questo o quello (i giannizzeri del Capo si affannano a dire che la frase non era rivolta a Saviano) ed è persino più di una filosofia contingente, quelle piccole pillole di saggezza renzista di cui è disseminato il cammino del governo. Dietro, accanto, sopra e sotto l’esortazione a non lamentarsi, a non fare piagnistei, c’è l’essenza stessa del potere. Chi ricorda i burbanzosi nuovisti renzisti alla vigilia della “scalata” (cit.), avrà la sporta piena di lamentazioni. Era un piagnisteo continuo, uno stillicidio di acide lamentazioni: e non ci fanno votare alle primarie come vorremmo, e sono antichi, e sono cattivi con noi che siamo il nuovo, e ammazzano un’intera generazione, e le rubano il futuro con le loro pensioni da favola (e mica parlavano delle pensioni d’oro, sia chiaro). I palchi della Leopolda pre-marcia erano essenzialmente questo: il grido di dolore di una generazione in camicia bianca e ritratti di Blair che lamentava e denunciava l’inverecondo complotto ai suoi danni: ecco, ci bloccano! Un piagnisteo in piena regola che toccava vette di lirismo epico quando si innestava sulla questione generazionale: nugoli di trenta-quarantenni affranti dal non avere il potere e le possibilità che avevano avuto i trenta-quarantenni prima di loro. Mano ai fazzoletti, si piangeva un bel po’. Poi, cambiato verso, basta. Il piagnisteo non vale più, perché adesso comandano loro e lamentarsi è diventato gufismo applicato, reato federale. Che ci sia in effetti da lamentarsi un po’ lo vedono tutti (la questione del Sud, mai messo così male dai tempi dello sbarco dei Mille e forse pure da prima è da manuale), ma ogni visione della realtà che non collimi con le sorti luminose e progressive che arrivano (arrivano? Stanno arrivando? Arriveranno? E lasciatelo lavorare, no?) è considerata attività antipatriottica.
Dunque riassumiamo: “Basta piagnistei”. Una variante. L’ennesima, del “basta piangersi addosso”, rimbocchiamoci le maniche, basta lamentarsi e ognuno aggiunga a piacere fino a esaurimento scorte (peraltro inesauribili). C’è qualcosa di nuovo, anzi, di antico, nella nuova polemica del Caro Leader, eccezionalmente lanciata dal Giappone. E’ più di una frecciatina a questo o quello (i giannizzeri del Capo si affannano a dire che la frase non era rivolta a Saviano) ed è persino più di una filosofia contingente, quelle piccole pillole di saggezza renzista di cui è disseminato il cammino del governo. Dietro, accanto, sopra e sotto l’esortazione a non lamentarsi, a non fare piagnistei, c’è l’essenza stessa del potere. Chi ricorda i burbanzosi nuovisti renzisti alla vigilia della “scalata” (cit.), avrà la sporta piena di lamentazioni. Era un piagnisteo continuo, uno stillicidio di acide lamentazioni: e non ci fanno votare alle primarie come vorremmo, e sono antichi, e sono cattivi con noi che siamo il nuovo, e ammazzano un’intera generazione, e le rubano il futuro con le loro pensioni da favola (e mica parlavano delle pensioni d’oro, sia chiaro). I palchi della Leopolda pre-marcia erano essenzialmente questo: il grido di dolore di una generazione in camicia bianca e ritratti di Blair che lamentava e denunciava l’inverecondo complotto ai suoi danni: ecco, ci bloccano! Un piagnisteo in piena regola che toccava vette di lirismo epico quando si innestava sulla questione generazionale: nugoli di trenta-quarantenni affranti dal non avere il potere e le possibilità che avevano avuto i trenta-quarantenni prima di loro. Mano ai fazzoletti, si piangeva un bel po’. Poi, cambiato verso, basta. Il piagnisteo non vale più, perché adesso comandano loro e lamentarsi è diventato gufismo applicato, reato federale. Che ci sia in effetti da lamentarsi un po’ lo vedono tutti (la questione del Sud, mai messo così male dai tempi dello sbarco dei Mille e forse pure da prima è da manuale), ma ogni visione della realtà che non collimi con le sorti luminose e progressive che arrivano (arrivano? Stanno arrivando? Arriveranno? E lasciatelo lavorare, no?) è considerata attività antipatriottica.
Dunque non un meccanismo del renzismo – pfui – ma un meccanismo intrinseco del potere: quando erano di là, “calpesti e derisi”, come dice l’Inno, riempivano fazzoletti di lacrime come alla prima di Love Story, ora che sono di qua, nella stanza dei bottoni, chi piange, o anche solo segnala quello che non va è uno che “sa solo lamentarsi”. Tracciata questa linea filosofica del “non piangete, bambine”, il resto viene da sé come naturale corollario. Esempio di scuola, il mirabolante ministro Franceschini, che inaugurando la Palestra Grande di Pompei (apertura al pubblico in ritardo di duemila anni) si toglie alcuni sassolini delle scarpe e chiede provocatoriamente se questa buona notizia avrà sui giornali lo stesso spazio di quando Pompei crolla in testa ai turisti. E’ più che una domanda peregrina: è scema. Perché nei paesi civili, e giustamente, la gente considera quel che funziona normale e quel che non funziona degno di segnalazione, nota e denuncia. E dunque nessun giornale titolerà mai “Traffico regolare sull’A1”, ma magari scriverà mezza pagina nel caso di “Ingorgo spaventoso in autostrada”. Dunque, il ribaltamento, assai bislacco, è questo: si invoca la normalità chiedendo di fare una cosa anormale: celebrare l’ovvio e censurare o silenziare l’eccezione. Con in più la consegna dell’illusione alle masse: “ehi, rimboccatevi le maniche!”. Bello, edificante, un po’ coreano del Nord. Ma quando si rimboccano le maniche, i nemici del piagnisteo, mica risollevano l’economia del Sud o fanno decollare l’occupazione, no. Al massimo puliscono qualche muro dalle scritte. Senza piagnistei.
 Dunque mettiamola così: il medico che per curarti la polmonite ti ha amputato una gamba ora ti guarda perplesso. Dannazione, la polmonite non è passata. Dunque propone di amputarti l’altra gamba. Sembra una storiella per chirurghi, e invece è la storia del prodigioso Fondo Monetario Internazionale, quello che di fatto gestisce e controlla l’economia mondiale, un medico che se lavorasse in corsia farebbe più morti della peste del Seicento. La nuova vulgata ora è questa: bravini, avete fatto qualche sforzo nella direzione da noi indicata (traduco: vi siete tagliati una gamba), ma non basta. Per essere felici e tornare a correre nelle praterie del benessere dovrete tagliarvi pure quell’altra. Quasi tutti riportano con grande enfasi le parole dell’illustre medico, invece di rincorrerlo, come sarebbe più comprensibile, con un martello molto pesante. E dunque ecco: per riavere il tasso di occupazione pre-crisi, l’Italia dovrà aspettare ancora una ventina d’anni, e questo se tutto va bene e si fanno le riforme che il Fondo Monetario prescrive. Tra queste, tenetevi forte, la contrattazione decentrata di secondo livello (in italiano: basta contratti nazionali, ogni fabbrica discuta col proprio imprenditore), rivedere i modelli retributivi (in italiano: guadagnare tutti un po’ meno), cambiare il sistema educativo (in italiano: trasformare la scuola in una fabbrica di mano d’opera). Siamo ancora lì: invece di alzarsi e cominciare a inveire, come farebbero in ogni ospedale del mondo i parenti del degente, al ministero dell’economia dicono che insomma, loro quelle cose le stanno già facendo. Disperante.
Dunque mettiamola così: il medico che per curarti la polmonite ti ha amputato una gamba ora ti guarda perplesso. Dannazione, la polmonite non è passata. Dunque propone di amputarti l’altra gamba. Sembra una storiella per chirurghi, e invece è la storia del prodigioso Fondo Monetario Internazionale, quello che di fatto gestisce e controlla l’economia mondiale, un medico che se lavorasse in corsia farebbe più morti della peste del Seicento. La nuova vulgata ora è questa: bravini, avete fatto qualche sforzo nella direzione da noi indicata (traduco: vi siete tagliati una gamba), ma non basta. Per essere felici e tornare a correre nelle praterie del benessere dovrete tagliarvi pure quell’altra. Quasi tutti riportano con grande enfasi le parole dell’illustre medico, invece di rincorrerlo, come sarebbe più comprensibile, con un martello molto pesante. E dunque ecco: per riavere il tasso di occupazione pre-crisi, l’Italia dovrà aspettare ancora una ventina d’anni, e questo se tutto va bene e si fanno le riforme che il Fondo Monetario prescrive. Tra queste, tenetevi forte, la contrattazione decentrata di secondo livello (in italiano: basta contratti nazionali, ogni fabbrica discuta col proprio imprenditore), rivedere i modelli retributivi (in italiano: guadagnare tutti un po’ meno), cambiare il sistema educativo (in italiano: trasformare la scuola in una fabbrica di mano d’opera). Siamo ancora lì: invece di alzarsi e cominciare a inveire, come farebbero in ogni ospedale del mondo i parenti del degente, al ministero dell’economia dicono che insomma, loro quelle cose le stanno già facendo. Disperante.
Fortunatamente, nota qualcuno, non è raro che il Fondo Monetario prenda della cantonate, ma pare che questo non infici in alcun modo il fatto che le sue ricette vengano accolte come sacre e inviolabili. Insomma: la politica economica degli Stati la fanno quei signori lì, e gli stati si adeguano. Ne fa in qualche modo fede l’accanirsi del ministero del lavoro sui dati dell’occupazione, diffusi a piene mani anche con criteri un po’ risibili. Esempio: se nella famiglia Brambilla lavorava solo il padre e ora, avventurosamente o per merito, ha trovato lavoro anche il figlio, è possibile rintracciare i titoloni sui giornali: “Brambilla: raddoppiata l’occupazione!”, segue dibattito. Invece si dice poco e male che i contratti a tempo indeterminato (si fa per dire, perché senza articolo 18 sono tutti a termine a capriccio del padrone) sono quasi tutti sostitutivi di altre posizioni, cha la disoccupazione resta mostruosa, che l’80 per cento e più dei nuovi contratti è a tempo determinato, cioè il vecchio caro precariato che si voleva (ehmm…) sconfiggere.
Sono numeri che schiantano il paese, ma che in qualche caso – solo per osservatori attenti – sotterrano anche una certa retorica farlocca dispiegata a piene mani. Basta pensare all’enfasi con cui si propugna come vincente e risolutiva la figura dell’imprenditore. Non c’è talk show, pagina economica o rotocalco che non abbia in bella vista il geniale imprenditore (delle salsicce, dei gelati, delle giacche a vento in piuma d’oca) che tiene la lezioncina su quanto è bello fare i padroni, con conseguente invito ai “giovani”: dai fatelo anche voi! Risultati devastanti. Da un lato frustrazione per chi non ha un papà finanziatore. Dall’altro gradi applausi per piccole, a volte geniali, start-up, salvo poi andare a vedere e scoprire che fatturano milioni e hanno un dipendente: la segretaria (se va bene). Creare valore per sé e non lavoro e benessere per tutti, insomma, è considerato modernissimo e à la page. Sempre in attesa, ovviamente, che il medico dica: perbacco, nemmeno tagliare un’altra gamba ha fatto passare questa fastidiosa polmonite, propongo di amputare un braccio. Applauso del paziente.
Eccoci qui, qualche data agostana per Dove sei stanotte.
Il 1 agosto al Festival Una Torre di Libri a Torre Pellice, Torino, che è un bel festival davvero (l’incontro è alle 15.30 al Parco delle Betulle, in via D’Azeglio). Tutto il programma della manifestazione lo trovate qui.
L’8 agosto, invece, sarò a Zelbio (Como) per Zelbio Cult, che è un piccolo delizioso festival in un piccolo delizioso posto affacciato sul lago (ore 21, teatro di Selbio), la locandona è qui.
il 23 agosto (domenica) tocca ancora alle Marche, per Ventimilarighesottoimari, che è anche quello un festival interessante (alle 21.30 nel cortile della Rocca Roverasca), ma di questo parleremo più avanti, che c’è tempo.
Insomma, chi vuole, o ha voglia, o passa di lì… ci vendiamo, eh!

 Domenica sera è morto Giorgio Banali, che tutti abbiamo sempre chiamato Sergio e che per noi che gli volevamo bene era “Tato”, anzi, “il Tato Banali”. E’ morto a Varese, aveva 85 anni, era già vecchio – questo lo diceva lui, con un sorriso degli occhi dietro gli occhiali – quando noi giovanetti facevamo Cuore. Io scrivevo di musica per l’Unità e Michele Serra mi chiese se ci stavo a fare Cuore con loro, che usciva dal guscio del grande giornale del grande partito e andava da solo in edicola, non avevo nemmeno trent’anni, cazzo.
Domenica sera è morto Giorgio Banali, che tutti abbiamo sempre chiamato Sergio e che per noi che gli volevamo bene era “Tato”, anzi, “il Tato Banali”. E’ morto a Varese, aveva 85 anni, era già vecchio – questo lo diceva lui, con un sorriso degli occhi dietro gli occhiali – quando noi giovanetti facevamo Cuore. Io scrivevo di musica per l’Unità e Michele Serra mi chiese se ci stavo a fare Cuore con loro, che usciva dal guscio del grande giornale del grande partito e andava da solo in edicola, non avevo nemmeno trent’anni, cazzo.
La squadra cresceva, c’erano già Michele, Andrea Aloi (me l’ha detto lui con un sms, che è morto il Tato), e Piergiorgio Paterlini (che ha scritto un bel ricordo del Tato, qui). Sono arrivato io che ancora stavamo all’Unità di via Fulvio Testi, a Milano, in una specie di scantinato vicino alle linotype (sì, è assurdo, si facevano ancora i giornali col piombo). Poi, poco dopo, sono arrivati anche Luca Bottura, Lia Celi, Carlo Marulli, Roberto Grassilli, e la famiglia era tutta lì – piccola, stretta – pronta a trasferirsi a Bologna. E c’era il Tato Banali.
Che era l’uomo della macchina, quello che teneva il traffico, che curava che arrivasse tutto, che disegnava, all’inizio, le pagine, che occhieggiava che tutto andasse bene, che era capace di guardare una foto o una vignetta da lontano e dire: “L’è storta!”. Aveva fatto il caporedattore all’Unità per trent’anni, e per me che facevo il giornalista ma sognavo di fare i giornali, era un pezzo di passato modernissimo. Lui scherzava di sé con una modestia assurda – “sono il compagno tempi e metodi” –, non voleva il suo nome da nessuna parte, nemmeno nella gerenza del giornale, e storceva il naso quando ridevamo un po’ troppo del Partito (sì, faceva ridere già allora). Ma la sua era un’ortodossia intelligente, spiritosa, vivace, e alla fine rideva sempre con noi.  Probabilmente pensava che fossimo matti, e ci voleva bene. Giocava ad essere umile e noi lo prendevamo in giro per questo, era un gioco tra fratelli. Era lui che teneva insieme con una gentilezza persino esagerata quella banda di ego burbanzosi e scomposti, e insieme a noi anche le decine e decine di artisti che ci mandavano vignette, disegni, pezzi. Era lui che quando staccavo dalla mia scrivania, quando me ne andavo dalle riunioni, quando tornavo a casa, diceva ridendo finto-severo: “Dove vai, compagno Robecchi, che il sole è ancora alto?”, e questo qualunque ora fosse. Ora non so mettere in fila le cose che mi ha insegnato il Tato Banali, e comunque non mi andrebbe di fare elenchi. Di sicuro mi ha insegnato cosa vuol dire essere gentili, ma gentili per davvero, e non so nemmeno se ho imparato, ma comunque. Della sua vita privata non voglio dire, ma so che era gentile anche in quella, che qualcuno glielo rimproverava, e lui era gentile lo stesso, di una gentilezza irriducibile. So che lo prendevamo in giro, e che noi ragazzini potevamo farlo perché eravamo ammirati, affascinati e onorati della sua storia che veniva giù per la storia del partito e del glorioso giornale come una resina pazzesca di sapienza, esperienza, aneddoti, storie, umanità, racconti, abilità, intelligenza. Lo tiravamo dentro a forza nelle foto, quando c’era da farle in gruppo, anche quelle più cretine, e lui si scherniva, ma poi giocava – sempre – con noi. Mi mandò, dopo anni che non ci vedevamo, un suo libro sulla Resistenza. Era bello, era vero, non so più nemmeno dove l’ho messo perché non sono gentile come era lui, ma era bello davvero.
Probabilmente pensava che fossimo matti, e ci voleva bene. Giocava ad essere umile e noi lo prendevamo in giro per questo, era un gioco tra fratelli. Era lui che teneva insieme con una gentilezza persino esagerata quella banda di ego burbanzosi e scomposti, e insieme a noi anche le decine e decine di artisti che ci mandavano vignette, disegni, pezzi. Era lui che quando staccavo dalla mia scrivania, quando me ne andavo dalle riunioni, quando tornavo a casa, diceva ridendo finto-severo: “Dove vai, compagno Robecchi, che il sole è ancora alto?”, e questo qualunque ora fosse. Ora non so mettere in fila le cose che mi ha insegnato il Tato Banali, e comunque non mi andrebbe di fare elenchi. Di sicuro mi ha insegnato cosa vuol dire essere gentili, ma gentili per davvero, e non so nemmeno se ho imparato, ma comunque. Della sua vita privata non voglio dire, ma so che era gentile anche in quella, che qualcuno glielo rimproverava, e lui era gentile lo stesso, di una gentilezza irriducibile. So che lo prendevamo in giro, e che noi ragazzini potevamo farlo perché eravamo ammirati, affascinati e onorati della sua storia che veniva giù per la storia del partito e del glorioso giornale come una resina pazzesca di sapienza, esperienza, aneddoti, storie, umanità, racconti, abilità, intelligenza. Lo tiravamo dentro a forza nelle foto, quando c’era da farle in gruppo, anche quelle più cretine, e lui si scherniva, ma poi giocava – sempre – con noi. Mi mandò, dopo anni che non ci vedevamo, un suo libro sulla Resistenza. Era bello, era vero, non so più nemmeno dove l’ho messo perché non sono gentile come era lui, ma era bello davvero.
Adesso è morto e non c’è nient’altro da dire.
Questa è una piccola storia che parte da una buona notizia. La buona notizia è che i lavoratori Whirpool (ri)avranno il loro posto di lavoro, e accanto a questa c’è un’altra buona notizia: governo, lavoratori e sindacato hanno agito insieme per fare un accordo. E’ una buona notizia per i lavoratori e anche per la politica: dimostra che il sindacato serve eccome, non è quell’ingombrante corpo intermedio che si dice di voler eliminare un giorno sì e l’altro pure. Bene. Ma veniamo alla propaganda.
Avevo notato il tweet trionfale del Presidente del Consiglio, ansioso (come è nelle cose) di intestarsi un successo.
Guardate bene la foto (cliccate se volete ingrandirla). Cosa manca? Manca il leader del sindacato che è stato più decisivo nella trattativa, Maurizio Landini della Fiom, che è per inciso, tra i presenti, l’unico che potrà, forse, un giorno, chissà, essere avversario poltico di Renzi. Ci sono tutti: i vertici della multinazionale, il presidente che firma, la ministra dell’industria, i rappresentanti di Cisl e Uil.
Where is Landini?
Notata la strabiliante assenza dalla foto (Whirpool, misione compiuta! Sono bravo, eh? Visto che fico?), rivado con la memoria ad alcune reminescenze storiche (non ho fatto il militare a Cuneo, no, ma alcuni esamini di storia contemporanea…) e mi ricordo di una figura molto temuta e potente nella Mosca degli anni Trenta, il Glavnačpups, che era il Direttore in Capo della Gestione del Consenso, una specie di capo supremo della propaganda sovietica (c’era Stalin, mica la Boschi, eh!), insomma, il guardiano di quel che si può, non si può, o è meglio non dire. Rido. Faccio questo tweet:
 Con mia sorpresa mi risponde (a strettissmo giro, pochi minuti) Filippo Sensi, detto @nomfup, che il lavoro di Glavnačpups lo fa per davvero. Mi dice che le foto della firma del contratto Whirpool (missione compiuta! Sono o non sono il vostro eroe?), stanno sul sito di Palazzo Chigi, e mi fa gentile dono di un’immagine dove compare (wow!) anche Landini
Con mia sorpresa mi risponde (a strettissmo giro, pochi minuti) Filippo Sensi, detto @nomfup, che il lavoro di Glavnačpups lo fa per davvero. Mi dice che le foto della firma del contratto Whirpool (missione compiuta! Sono o non sono il vostro eroe?), stanno sul sito di Palazzo Chigi, e mi fa gentile dono di un’immagine dove compare (wow!) anche Landini
E’ una buona mossa: Landini non è stato cancellato nelle foto, come Trozkij e i suoi amici dalle immagini sotto il palco di Lenin a San Pietroburgo, per carità. Le foto con dentro anche lui ci sono, sul sito di Palazzo Chigi, insomma, un luogo per feticisti della politica. Mentre la foto senza Landini, quella twittata dal Caro Leader in persona (Missione compiuta! Sposatemi!) ha fatto il giro dei giornali, dei Tg, delle cronache e l’hanno vista tutti, e certi Tg ci hanno pure fatto il sermoncino.
Mi tocca rispondere, insomma:

La cosa finisce lì, come è giusto che sia. Ma intanto: chi ha visto i Tg, i giornali, la propaganda, ha visto la foto senza uno dei protagonisti della trattativa, tra l’altro l’unico che potrebbe, chissà, in prospettiva, essere un antagonista politico del capo. Missione compiuta davvero: il Glavnačpups ha fatto il suo lavoro. Non a Mosca nel ’35, no. In Italia oggi. E questa è la piccola storiella, la cui morale è: la propaganda fa il suo dovere, certo. Ma noi – noi tutti – dobbiamo imparare a fare il nostro, cioè riconoscerla e distinguerla dalla realtà
 E dunque un’altra Terra – Kepler452b – con un altro sole, altre albe, altri tramonti, e magari altre vite, ma sul serio, che stappano come una bottiglia di champagne tutta l’immaginazione possibile sul mondo parallelo. Magari gente che ci fa le foto, a quei tramonti, e le manda alla ragazza. E poi, ora che salta il tappo della fascinazione per qualcosa lontano là fuori che ci somiglia: come si sta qua, come si sta là, e se ci sono – come dovrebbe e sarebbe giusto – altri terrestri, diciamo kepleriani, in qualche modo fratelli come sono fratelli i due pianeti. E allora sapere, sapere subito: ehi, amici, qui dicono che siete più avanti di noi, più anziani. Questo è bene, dai, spiegateci come avete fatto a cavarvela. Non avete isole di plastica in mezzo agli oceani vero? E ci mangiate tutti lassù, o è come qua che metà fanno la fame, metà se la cavano e uno su mille sta come un pascià? Vi scannerete mica anche voi su quale Dio sia migliore spero! Se siete invecchiati così bene da assomigliarci, avrete risolto delle cose che magari noi stiamo ancora pasticciando nel nostro stupido modo terrestre! Oggi ci sembrano tanti 1440 anni luce, e in effetti sì, non ti basta un pieno della macchina, ma magari domani chissà, e potremmo vederci, che so, in un bar a metà strada, e parlarne un po’ tranquilli davanti a un caffè o a cosa diavolo bevete lassù. Uno specchio per guardarci, un’altra Terra per misurarci, è un lusso grosso che non dovremmo sprecare. Ce l’avete la luna? Noi sulla nostra ci siamo stati, non c’è niente, ma da lì abbiamo visto quanto è bella la Terra da lontano, da vicino un po’ meno, ma… Mandate foto! Fate sapere, insegnateci qualcosa di utile. Siamo noi, siamo i terrestri, vostri fratelli, vedete? Ancora non ci conosciamo e siamo già qui a chiedervi consigli e dritte. Spero davvero che siate un po’ meno fessi di noi… lo spero per voi, ma anche per noi, davvero. Ciao.
E dunque un’altra Terra – Kepler452b – con un altro sole, altre albe, altri tramonti, e magari altre vite, ma sul serio, che stappano come una bottiglia di champagne tutta l’immaginazione possibile sul mondo parallelo. Magari gente che ci fa le foto, a quei tramonti, e le manda alla ragazza. E poi, ora che salta il tappo della fascinazione per qualcosa lontano là fuori che ci somiglia: come si sta qua, come si sta là, e se ci sono – come dovrebbe e sarebbe giusto – altri terrestri, diciamo kepleriani, in qualche modo fratelli come sono fratelli i due pianeti. E allora sapere, sapere subito: ehi, amici, qui dicono che siete più avanti di noi, più anziani. Questo è bene, dai, spiegateci come avete fatto a cavarvela. Non avete isole di plastica in mezzo agli oceani vero? E ci mangiate tutti lassù, o è come qua che metà fanno la fame, metà se la cavano e uno su mille sta come un pascià? Vi scannerete mica anche voi su quale Dio sia migliore spero! Se siete invecchiati così bene da assomigliarci, avrete risolto delle cose che magari noi stiamo ancora pasticciando nel nostro stupido modo terrestre! Oggi ci sembrano tanti 1440 anni luce, e in effetti sì, non ti basta un pieno della macchina, ma magari domani chissà, e potremmo vederci, che so, in un bar a metà strada, e parlarne un po’ tranquilli davanti a un caffè o a cosa diavolo bevete lassù. Uno specchio per guardarci, un’altra Terra per misurarci, è un lusso grosso che non dovremmo sprecare. Ce l’avete la luna? Noi sulla nostra ci siamo stati, non c’è niente, ma da lì abbiamo visto quanto è bella la Terra da lontano, da vicino un po’ meno, ma… Mandate foto! Fate sapere, insegnateci qualcosa di utile. Siamo noi, siamo i terrestri, vostri fratelli, vedete? Ancora non ci conosciamo e siamo già qui a chiedervi consigli e dritte. Spero davvero che siate un po’ meno fessi di noi… lo spero per voi, ma anche per noi, davvero. Ciao.
 E così, dopo le sarde in saor, le birre del Belgio, i manicaretti austriaci e le meraviglie gastronomiche del Ghana, un altro poderoso contenuto ha riempito i padiglioni di Expo, per l’occasione sede di partito: l’annuncio sulle tasse lanciato da un Matteo Renzi in trance agonistica. “Meno tasse per tutti”, non è male, come slogan, non fosse che porta un po’ sfiga, ma si sa che Matteo non è scaramantico e si gioca quella carta per rastrellare sul terreno gli orfani di Silvio, parlandone da vivo. E dunque, gioco, partita, incontro: Matteo dice “no tasse” e se sei gufo e ti metti a dire “sì tasse” passi pure per fesso. Come se qualcuno dicesse: “Italiani! Mai più bronchite” e l’opposizione fosse costretta a urlare: “Sì, sì, viva la bronchite”. Insomma il renzismo come continuazione del berlusconismo con altri mezzi. Oppure, più raffinata ipotesi: il berlusconismo come spossante, interminabile prova generale dello spettacolo con cui va in scena Matteo. Accecati, applaudono anche giornaloni e telegiornali. Gente che solitamente geme come l’albero di un veliero al solo nominare un aumento del deficit. E ora, invece, un coro di hurrà. Poi meno tasse per chi, per cosa, a favore di chi, per tagliare quali servizi, ovviamente non si dice, il capo dei pirati annuncia che troverà un tesoro, e nessuno della ciurma che gridi: “Prima vediamolo!”
E così, dopo le sarde in saor, le birre del Belgio, i manicaretti austriaci e le meraviglie gastronomiche del Ghana, un altro poderoso contenuto ha riempito i padiglioni di Expo, per l’occasione sede di partito: l’annuncio sulle tasse lanciato da un Matteo Renzi in trance agonistica. “Meno tasse per tutti”, non è male, come slogan, non fosse che porta un po’ sfiga, ma si sa che Matteo non è scaramantico e si gioca quella carta per rastrellare sul terreno gli orfani di Silvio, parlandone da vivo. E dunque, gioco, partita, incontro: Matteo dice “no tasse” e se sei gufo e ti metti a dire “sì tasse” passi pure per fesso. Come se qualcuno dicesse: “Italiani! Mai più bronchite” e l’opposizione fosse costretta a urlare: “Sì, sì, viva la bronchite”. Insomma il renzismo come continuazione del berlusconismo con altri mezzi. Oppure, più raffinata ipotesi: il berlusconismo come spossante, interminabile prova generale dello spettacolo con cui va in scena Matteo. Accecati, applaudono anche giornaloni e telegiornali. Gente che solitamente geme come l’albero di un veliero al solo nominare un aumento del deficit. E ora, invece, un coro di hurrà. Poi meno tasse per chi, per cosa, a favore di chi, per tagliare quali servizi, ovviamente non si dice, il capo dei pirati annuncia che troverà un tesoro, e nessuno della ciurma che gridi: “Prima vediamolo!”
Ma passi, non ha senso criticare la propaganda. Più divertente andare a leggere cosa dicevano i plaudenti renzisti delle prime file quando la pièce del “Meno tasse per tutti” la recitava l’unto dal Signore. Dai pacati giudizi politici di Finocchiaro (“L’abolizione totale dell’Imu sulla prima casa non sarebbe misura utile al paese”), all’intervento alla Camera del dem Fanucci (“Abolizione totale dell’Imu grave errore”), fino all’immancabile Dario Nardella (“Tutta quest’euforia sull’abolizione dell’Imu mi pare esagerata. Prima capiamo bene a quale prezzo la togliamo”). Spettacolo. E fin qui i politici. Perché poi al coro si aggiungevano gli agit-prop a tassametro, capaci di concedersi ben altre licenze poetiche, come il “comunicatore” Francesco Nicodemo, sempre lui, the genius: “Povertà disperazione disoccupazione e noi parliamo dell’Imu. Andatevene a fanculo”. Implacabile, tranchant, capace di puntare allo scranno più alto, ancora lui: “Vabbuò, Napolitano, tutto ‘sto discorso e non dici che l’abolizione dell’Imu è una vaccata?”. Eccoli lì, sono gli stessi che ora battono le mani per l’annunciata abolizione dell’Imu. Parliamo di due anni fa, non di due secoli, si metta a verbale anche questo.
Ma sì, lo so cosa si dirà: solo gli imbecilli non cambiano mai idea. Ma tutti insieme? In coro? Tutti nello stesso momento appena il capo schiocca le dita? Chiunque vede che in questo modo la faccenda degli imbecilli e del cambiare idea muta un po’ di prospettiva. La paura è di entrare nel cono d’ombra, di essere espulsi dal gotha del renzismo, un po’ come quei funzionari nordcoreani che si distraggono e non ridono alle battute del Caro Leader: puff, spariti nel nulla. Viene in mente – spiace citare un bravissimo fascistone – il Giovannino Guareschi del “Contrordine compagni”, ma quello è: il testacoda del renzismo modernista che diventa più leaderistico e acritico e gerarchico del vecchio Pci togliattiano degli anni Cinquanta. Chissà che ora non si lavori di photoshop sulle foto ufficiali per cancellare quelle dichiarazioni e quei tweet oggi così divertenti da leggere ex-post. Photoshop e bianchetto, del resto, già usati sul nuovo sito del Pd, dove, cercando, non trovate un Bersani, un D’Alema, un Veltroni, e nemmeno un Berlinguer o un Gramsci. Niente, c’è solo Matteo, la storia parte con lui, come del resto ci spiega il claim pubblicitario della nuova Unità: “Il passato sta cambiando”. Eh, appunto.
Eccoci. Mercoledì 22 luglio (alle 20) apre l’arena estiva di piazza Vittorio, a Roma. Una buona scusa (eheh!) per presentare Dove sei stanotte a Roma. Dopo un po’ di giri qui e là, arrivare a Roma, e in quella piazza, è un vero piacere. La serata è organizzata dalla libreria N’Importe Quoi, che di solito anima il chiostro di San Pietro in Vincoli. Insieme a me con Dove sei stanotte ci sarà Daniela Ranieri, firma de Il Fatto Quotidiano (esimia collega, quindi), con il suo Mille esempi di cani smarriti (Ponte alle Grazie) e la serata sarà coordinata da Edoardo inglese, che chiederà di libri, storie e musiche che stanno nei libri (quindi il vecchio Bob avrà il suo spazietto, credo). E’ tutto. Se ci siete, passate, se avete voglia venite, eccetera eccetera.

Mercoledì 22 luglio, Roma, piazza Vittorio Arena Estiva, ore 20
 Pena di morte e ergastolo per il cadavere. E poi passarci sopra con lo schiacchasassi, come nei cartoni animati, e magari buttato dalla rupe (Tarpea, già che ci siamo), e raccolto con un coretto di marameo, gesti dell’ombrello, pernacchie a mano aperta. Quel che succede a Alexis Tsipras, nel giubilo generale degli europei – quelli di destra, ovvio, quelli di “sinistra”, altrettanto ovvio – e dei loro giornaloni potenti (e giornalini, ci metto pure l’Unità) è un caso di scuola. Insomma, il destino dei leader della sinistra che non vuole essere – finché può, finché sa – la finta sinistra liberista à la page col desiderio di essere come tutti, è quello lì: morte e distruzione, umiliazione e sberleffo. Ognuno cerchi i suoi esempi nella memoria e nelle vecchie cronache. Lo spagnolo Zapatero che sembrava il messia e poi si zapaterizzò velocemente nel tran tran e nella quasi scomparsa. Nel nostro piccolo, gli Ingroia suscitatori di chissà quali speranze (peregrine, va detto) e poi dissoltosi come un ghiacciolo lasciato in macchina a ferragosto… Antò, fa caldo.
Pena di morte e ergastolo per il cadavere. E poi passarci sopra con lo schiacchasassi, come nei cartoni animati, e magari buttato dalla rupe (Tarpea, già che ci siamo), e raccolto con un coretto di marameo, gesti dell’ombrello, pernacchie a mano aperta. Quel che succede a Alexis Tsipras, nel giubilo generale degli europei – quelli di destra, ovvio, quelli di “sinistra”, altrettanto ovvio – e dei loro giornaloni potenti (e giornalini, ci metto pure l’Unità) è un caso di scuola. Insomma, il destino dei leader della sinistra che non vuole essere – finché può, finché sa – la finta sinistra liberista à la page col desiderio di essere come tutti, è quello lì: morte e distruzione, umiliazione e sberleffo. Ognuno cerchi i suoi esempi nella memoria e nelle vecchie cronache. Lo spagnolo Zapatero che sembrava il messia e poi si zapaterizzò velocemente nel tran tran e nella quasi scomparsa. Nel nostro piccolo, gli Ingroia suscitatori di chissà quali speranze (peregrine, va detto) e poi dissoltosi come un ghiacciolo lasciato in macchina a ferragosto… Antò, fa caldo.
E questo per il passato. E per il futuro, invece si vedrà, ma è chiaro che si gioca anche di sberleffo preventivo, basti leggere certi giudizi su Landini, su Civati, su chiunque in qualche modo si permetta, alimentati a suon di sentenze e ironie dai commentatori schieratissimi di destra e – ancora – di “sinistra”.
Ma insomma, Tsipras fa caso a sé, e per vari motivi. Il primo: non è una comparsa ma un protagonista, uno che ha vinto le elezioni (lui), che guida un paese, non una promessa che si prepara a guidarlo un domani, chissà, forse, vedremo. Poi perché i giudizi su di lui hanno oscillato come pendoli impazziti all’oscillare delle vicende greche degli ultimi mesi. Cattivo comunista e pessimo debitore prima, nella fase della paura che in qualche modo ce la facesse. Poi, per un paio di giorni, schifoso calabraghe quando portava le sue proposte in Europa. Poi di nuovo diabolico agitatore e cattivo maestro. E poi – qui il colmo, il testacoda – populista quando chiese al suo popolo di promuovere o bocciare la linea del suo governo, cosa davvero incredibile che un capo di governo capace di indire un referendum in sei giorni, portare a votare tutti, e vincere, sia chiamato “populista” anziché “democratico”, ma tant’è. E poi, ultimo atto della tragedia (là) e farsa (qui): la sconfitta e l’umiliazione, salutate con un boato di gioia. E si capisce, certo. Il tentativo di ribaltare il pensiero unico liberista-monetarista non è riuscito, la paura rientra, si certifica che non solo non è possibile cambiare il gioco, ma che chi ci prova verrà schiacciato senza pietà. Sollievo, insomma, e il solito “guai ai vinti” che si conosce. Con un aggiunta di astio e bile: che ora chi temeva uno Tsipras in qualche modo vincente – o almeno non perdente – sulla scena mondiale non si accontenta di vincere, ma vuole lo scalpo da portare all’accampamento. E così si assiste allo spettacolo indecente di una destra ultraliberista e di una sinistra ultraparacula che gli rimprovera di non averla saputa realizzare, quella rivoluzione che li fece, per qualche minuto, scusate il francesismo, cagare addosso. Amici del Fmi e sostenitori di Schauble che dicono oggi, su Tsipras, le stesse cose dei black bloc greci in rivolta ad Atene: venduto, accomodante, lacché della Banca Europea. C’è del furore che si spiega solo così: Tsipras gli aveva messo una fifa blu. E si sa come vanno le cose da queste parti, e lo spiegò bene Michele Serra: che “Preferiamo rassegnarci in compagnia che ribellarci da soli”. Ecco, ad Alexis Tsipras, tra un insulto e l’altro, stanno spiegando proprio questo. Con grande sollievo.
 La storia non mai già scritta, eppure capita che la si sia già letta. E allora nei giorni della battaglia di Atene, conclusa con la marcia trionfale dei generali del Fondo Monetario sotto il Partenone, si è forse esagerato con le metafore e le allegorie. Ma sì, dai, quelle cose a base di carrarmati e blitzkrieg, con il Beethoven dell’Inno alla Gioia mai così wagneriano, e le condizioni poste alla Grecia molto simili a ordini secchi urlati in tedesco: in fila! Marciare! Spalle al muro! Un déja vu potente, che chiama spontaneamente l’equazione, essendo almeno la terza volta in cent’anni che si vede la Germania senza argini europei.
La storia non mai già scritta, eppure capita che la si sia già letta. E allora nei giorni della battaglia di Atene, conclusa con la marcia trionfale dei generali del Fondo Monetario sotto il Partenone, si è forse esagerato con le metafore e le allegorie. Ma sì, dai, quelle cose a base di carrarmati e blitzkrieg, con il Beethoven dell’Inno alla Gioia mai così wagneriano, e le condizioni poste alla Grecia molto simili a ordini secchi urlati in tedesco: in fila! Marciare! Spalle al muro! Un déja vu potente, che chiama spontaneamente l’equazione, essendo almeno la terza volta in cent’anni che si vede la Germania senza argini europei.
E però: troppo facile. Va bene per la vignetta, va bene per il paradosso, che sono preziosi, eppure la metafora è un’altra, l’immagine è per così dire più moderna: è quella della testa di cavallo nel letto, della “proposta che non puoi rifiutare”.
Insomma, non il Terzo Reich, ma Il Padrino.
Si sa che il creditore tende a non ammazzare chi gli deve dei soldi, per il semplice motivo che poi il morto non pagherà i debiti. Tenderà piuttosto a mandargli qualche picciotto armato a spaventarlo, metterà qualche ragioniere a gestire i suoi affari (il gioco d’azzardo a Chicago, l’alcol illegale nel proibizionismo, le pensioni greche, la sanità in Portogallo, il mercato del lavoro in Italia…). Ma anche alla regola aurea di non ammazzare il debitore ci sono eccezioni. Per esempio una lezione dura e un’umiliazione cocente potranno sì, far perdere qualche dollaro al Boss, ma saranno preziosissimo esempio per gli altri debitori. Dunque non solo colpirne uno per educarne cento (ventisei, nel caso europeo), ma addirittura sacrificarne uno per tener buoni tutti.
Questo è stato fatto dall’Eurogruppo a guida Shauble-Merkel alla Grecia ribelle. E le metafore belliche in stile Terzo Reich dipendono appunto dal fatto che passano gli anni, ma le parole no, e la parola è: rappresaglia.
Ammesso che ora gli sconfitti si adeguino alle sanzioni dei vincitori, sia chinando la testa, sia cambiando governo e certificando che le elezioni greche si svolgono a Berlino, una cosa è certa: il Boss guarderà soddisfatto come le altre famiglie si ritirano intimorite con la coda tra le gambe. La soluzione greca non riguarda la Grecia, riguarda tutti gli altri, assistere oggi indifferenti all’umiliazione di Atene significa una cosa sola: essere tutti umiliabili domani. E già si vedono gli effetti. Altri debitori in bilico sulle curve pericolose dei loro precarissimi conti già plaudono alla soluzione. Dovendo schierarsi, lo fanno con il Boss a cui devono molti soldi, illudendosi che quando verrà il momento quello sarà con loro più comprensivo: stupidi, perché non s’è mai visto uno squalo dire “sono sazio”, o “non ho più fame”.
Ed ecco allora la pioggia di tweet e commenti di colonnelli e caporalmaggiori renzisti che plaudono al “capolavoro politico”, alla “soluzione finalmente trovata”, alla “buona notizia”. Con le parole che dicono persino più di quanto si vorrebbe, come nel delizioso – da incorniciare – tweet della signora Serracchiani Debora che dice: “Impariamo tutti la lezione”. Ecco, appunto.
Che se vai a guardare le riforme chieste alla Grecia insieme alla testa dei suoi leader e al sangue del suo popolo, ci trovi proprio quelle che ci si vanta di aver fatto qui, tipo i licenziamenti collettivi. Fatto!, come diceva Silvio buonanima.
E si dirà, sì, ma i soldi, sì, ma i debiti… E questo mentre in silenzio e zitto zitto qualche funzionario a Berlino ristrutturava senza clamori il debito dell’Austria: premio per esser stati in silenzio, sconti secchi di un miliardo e mezzo, apprezzamento per non aver alzato la voce e la testa come i greci. Il messaggio è questo: siate docili e vivrete. Don Vito Corleone non avrebbe saputo dirlo – e farlo – meglio.
E’ un po’ diff icile immaginare Napoleone che, osservando dalla collina il suo esercito in rotta a Waterloo, si volta verso i generali e dice: “Ecco, non abbiamo saputo comunicare le cose buone che abbiamo fatto! Chiamatemi quelli della comunicazione!”. Altri tempi, paradosso improponibile. Proviamo con uno più moderno. I difensori del Brasile, sotto di sette pappine con la Germania, si guardano tra loro e si dicono: “Peccato, siamo più bravi noi, ma non riusciamo a farlo capire alla gente che guarda la partita”.
icile immaginare Napoleone che, osservando dalla collina il suo esercito in rotta a Waterloo, si volta verso i generali e dice: “Ecco, non abbiamo saputo comunicare le cose buone che abbiamo fatto! Chiamatemi quelli della comunicazione!”. Altri tempi, paradosso improponibile. Proviamo con uno più moderno. I difensori del Brasile, sotto di sette pappine con la Germania, si guardano tra loro e si dicono: “Peccato, siamo più bravi noi, ma non riusciamo a farlo capire alla gente che guarda la partita”.
Ecco, un pochino sta andando così a Matteo Renzi: l’altro giorno, con l’Europa che sobbolliva, Hollande e Merkel che facevano il loro vertice senza di lui, la Grecia che gridava il suo no, la Borsa di Milano in picchiata, interveniva a un incontro con i suoi deputati e senatori per dire che “dobbiamo comunicare meglio”. Ora, qui non è che si scende dalla montagna del sapone, e si sa benissimo – essendo nati e cresciuti dopo Carosello – che la comunicazione, la sua manipolazione e il suo sapiente uso sono faccende strategiche. Che la “narrazione” – o lo storytelling, come lo chiamano i renzisti col master – sia importante è noto. E però è noto anche che bisogna saperla fare. Piccolo esempio. Se il cielo è nuvoloso con qualche sprazzo d’azzurro, potrai anche dire che tornerà il sole, e che nel caso sarà merito tuo. Se invece consigli la gente di mettere il costume, le infradito e il doposole e di correre al mare mentre diluvia e tira vento, la tua narrazione non solo è truffaldina, ma ti fa fare un po’ la figura del pirla. Sembra scienza (Wow! Scienza delle comunicazioni! Cool!), ma è una cosa piuttosto semplice. Chiedete al signor Silvio se ripeterebbe quella frase su “i ristoranti sono pieni” mentre la crisi mordeva le chiappe a (quasi) tutti. No, non lo farebbe. Il rischio di sbagliare la narrazione (va tutto bene, ottimismo, tranquilli, ci pensa lui, guarda che meraviglia!) si complica poi strada facendo. Perché ti costringe a una scelta: o insisti con quella, anche a costo di smentire una realtà che vedono tutti, oppure cambi narrazione, nel qual caso la gente penserà (ecco, sto fatto che la gente pensa è una variabile di cui al Pd tengono poco conto) che dici la prima cosa che ti salta in mente, purché ti serva.Ma non facciamo gli ingenui e non attribuiamo al povero renzismo in affanno problemi che sono di tutti. Presentare una pasta scotta e mal condita come un manicaretto da chef stellato è un tipico vizio della politica (tutta), e può persino funzionare. Ma funziona solo a patto che chi si inventa la bugia (pardon, la narrazione) sappia qual è la realtà. Invece, pare che ai burbanzosi colonnelli renzisti, per non dire del generale in capo, sfugga questo principio fondamentale: è una scemenza farsi convincere dalla propria stessa propaganda. Un errore fatale, che le vicende greche hanno magistralmente mostrato. I “comunicatori” del Pd hanno passato così tanti giorni (insieme ai poteri forti, ai grandi giornali, a tutte le tivù) a dire che i greci avrebbero votato “sì” con grande responsabilità, che ci hanno creduto davvero. Fare “il mediatore” tra Berlino e Atene ora non sarà facile, dopo aver tifato Berlino, portato allo stadio lo striscione “viva Merkel”, insultato in tutti i modi Tsipras e Varoufakis, tirato in ballo Pericle col famoso metodo “a cazzo. Perché nella narrazione e dello storytelling renzista bisogna tenere a mente anche questo: passato un anno e mezzo, la gente non ci crede più, e però se lo ricorda, prende nota, e la prossima volta non ascolta nemmeno. Urge riflessione, insomma, e invece lì siamo ancora al pensiero binario: “noi ottimisti / voi gufi”. Bisognerà regalare ai “narratori” un neon gigantesco con scritto: “Non funziona!”. E magari anche un altro che dica: “Ancora coi gufi, che palle!”
 Ora, diciamolo, comunque la si pensi sulla crisi greca, il referendum, i livori della signora Merkel, i debiti, Alexis Tsipras e tutto il cucuzzaro, una cosa è innegabile: si usano le parole un po’ a vanvera, con il consolidato e tradizionale metodo “a cazzo”. La più gettonata al momento è la parola “populismo”. Una brutta bestia, si sa, a patto di mettersi d’accordo su cosa vuol dire. Già sul termine si registravano sbandamenti e scarsa tenuta di strada, ma ora che i grandi commentatori dei grandi giornali ci spiegano che indire un referendum per chiedere ai greci una conferma o una bocciatura alla linea del loro governo è “populismo”, il testacoda è completo. La pretesa secondo cui dare la parola agli elettori sia una specie di barbatrucco antidemocratico suona in effetti assai bizzarra, specie in una comunità, l’Europa, che parla di democrazia ogni minuto, vantandosi di esserne uno dei santuari. Un continente dove la pregiudiziale antifascista è andata un po’ gambe all’aria (vedi l’Ungheria, vedi i movimenti filonazi), ma dove cresce la pregiudiziale antipopulista, con la parola usata quasi sempre per indicare chi non si attiene al pensiero unico, il cui guardiano sarebbe una specie di banca. Va bene, ci sono i pro e ci sono i contro. Da qui al referendum chiunque, ma proprio chiunque, spiegherà al popolo greco che votando “no” si metterà ancor più nei guai, che si rischia il disastro, eccetera eccetera. Per cui, tirate le somme, sarebbe “populismo” chiedere a un popolo di esprimersi nelle urne, ma non lo è interferire in quello che quel popolo scriverà sulla scheda. Il capo dei banchieri, il presidente della Commissione Europea, i vari leader del continente che indicano ai greci come votare, pregandoli di votare “sì” e sottoponendoli a ogni tipo di pressioni sarebbero invece sinceri democratici antipopulisti. Mah.
Ora, diciamolo, comunque la si pensi sulla crisi greca, il referendum, i livori della signora Merkel, i debiti, Alexis Tsipras e tutto il cucuzzaro, una cosa è innegabile: si usano le parole un po’ a vanvera, con il consolidato e tradizionale metodo “a cazzo”. La più gettonata al momento è la parola “populismo”. Una brutta bestia, si sa, a patto di mettersi d’accordo su cosa vuol dire. Già sul termine si registravano sbandamenti e scarsa tenuta di strada, ma ora che i grandi commentatori dei grandi giornali ci spiegano che indire un referendum per chiedere ai greci una conferma o una bocciatura alla linea del loro governo è “populismo”, il testacoda è completo. La pretesa secondo cui dare la parola agli elettori sia una specie di barbatrucco antidemocratico suona in effetti assai bizzarra, specie in una comunità, l’Europa, che parla di democrazia ogni minuto, vantandosi di esserne uno dei santuari. Un continente dove la pregiudiziale antifascista è andata un po’ gambe all’aria (vedi l’Ungheria, vedi i movimenti filonazi), ma dove cresce la pregiudiziale antipopulista, con la parola usata quasi sempre per indicare chi non si attiene al pensiero unico, il cui guardiano sarebbe una specie di banca. Va bene, ci sono i pro e ci sono i contro. Da qui al referendum chiunque, ma proprio chiunque, spiegherà al popolo greco che votando “no” si metterà ancor più nei guai, che si rischia il disastro, eccetera eccetera. Per cui, tirate le somme, sarebbe “populismo” chiedere a un popolo di esprimersi nelle urne, ma non lo è interferire in quello che quel popolo scriverà sulla scheda. Il capo dei banchieri, il presidente della Commissione Europea, i vari leader del continente che indicano ai greci come votare, pregandoli di votare “sì” e sottoponendoli a ogni tipo di pressioni sarebbero invece sinceri democratici antipopulisti. Mah.
Si aggiungano al pasticcio un paio di dettagli. Uno, per così dire, tutto politico e un altro più legato alla comunicazione della paura. La questione politica è abbastanza semplice: al governo greco guidato da Tsipras non si fanno gli sconti clamorosi e spaventosi che si fecero volentieri a chi, in Grecia, fece quei debiti. In sostanza, chi indebitò la Grecia fino alle orecchie andava quasi bene e non era populista, chi invece arrivò dopo (eletto, si badi bene, non scrivendo su twitter “Samaras stai sereno”), ereditando una situazione disastrosa e cercando di trattare una ristrutturazione del debito, è populista e va punito. Si noti en passant che la rata del debito greco che oggi Tsipras non riesce a pagare è di 1,6 miliardi, mentre le Borse ne hanno bruciati in un solo giorno 287: è come se per tentare di recuperare una cinquecento incidentata si desse fuoco a una decina di Ferrari, lo chiamano capitalismo, una cosa ben poco populista ma abbastanza scema anche lei. L’altra questione riguarda una specie di nazionalismo dei soldi, quel meccanismo tragicomico per cui si vede gente normale, che lavora, paga il mutuo, che arriva si e no alla fine del mese, gridare indignata che “i greci ci devono dei soldi e non ce li danno”. E’ la stessa gente che dava una quindicina di miliardi al fondo salva-banche senza battere ciglio, la qual cosa è abbastanza strabiliante ma comprensibile e molto furba: soldi per le banche ne abbiamo, soldi per un popolo in ginocchio no. Atteggiamento incoraggiato e caldeggiato, spinto da giornali, commenti, reportage, pensosi corsivi. Insomma, un populismo vero usato per picchiare un populismo presunto.
Nel giugno scorso si è svolto a Palermo, nel bellissimo festival Una Marina di Libri, l’incontro-presentazione su Dove sei stanotte, insieme a Santo Piazzese e Antonio Manzini. Insomma, loro erano quelli bravi, e poi c’ero anch’io. Se interessa, Sellerio ha messo on line tutto l’incontro (in tre parti) e io metto qui sotto… solo per annoiatissimi, fans estremi di Manzini e Piazzese. Insomma… sta qua, vedete voi…
Qui sotto, la bella intervista di Francesco Musolino per La Gazzetta del Sud. Cliccare per leggere (pdf)
 Roba da Orwell, neolingua e Grande Fratello. Nome e cognome: Jobs act, quella legge sul lavoro detta in inglese per fregare i gonzi e scritta da Confindustria per “superare” (sic) lo Statuto dei Lavoratori. Ciambella riuscita (con la fiducia, ovviamente), ma con molti buchi. E qualche autogol. I solerti salariati della propaganda renzista non facevano in tempo a sbandierare un comunicato del ministero del lavoro (18 giugno) che rassicurava, e troncava, e sopiva, che venivano impietosamente sbugiardati il giorno dopo dal garante della Privacy, che ammoniva sul rischio di “indebita profilazione delle persone che lavorano”. In italiano: il controllo elettronico della vita dei lavoratori. Insomma, fate attenzione, siate gentili, si valuti, si vigili… le solite belle parole, ma rimane il fatto che il Jobs act consente controlli capillari: una festa per le aziende, piccole e grandi (di privacy e Rai dice, qui accanto, Carlo Tecce).
Roba da Orwell, neolingua e Grande Fratello. Nome e cognome: Jobs act, quella legge sul lavoro detta in inglese per fregare i gonzi e scritta da Confindustria per “superare” (sic) lo Statuto dei Lavoratori. Ciambella riuscita (con la fiducia, ovviamente), ma con molti buchi. E qualche autogol. I solerti salariati della propaganda renzista non facevano in tempo a sbandierare un comunicato del ministero del lavoro (18 giugno) che rassicurava, e troncava, e sopiva, che venivano impietosamente sbugiardati il giorno dopo dal garante della Privacy, che ammoniva sul rischio di “indebita profilazione delle persone che lavorano”. In italiano: il controllo elettronico della vita dei lavoratori. Insomma, fate attenzione, siate gentili, si valuti, si vigili… le solite belle parole, ma rimane il fatto che il Jobs act consente controlli capillari: una festa per le aziende, piccole e grandi (di privacy e Rai dice, qui accanto, Carlo Tecce).
Che poi, a ben guardare, il Jobs atc liberalizza, sì. Liberalizza, per l’esattezza, comportamenti di enorme scorrettezza padronale. Come la proposta del marzo scorso di Fincantieri, che pretendeva di inserire microchip negli scarponi degli operai, poi accantonata grazie alle proteste Fiom. O come accade (anche ora, mentre leggete) nel suggestivo scenario di Expo, dove i lavoratori forniti da Manpower devono avere una app nel cellulare (collegata alla mail fornita all’assunzione, cioè alla mail personale) che permette di controllarne minuto per minuto, tramite wi-fi e gps, gli spostamenti. E non solo, come sospettano NidiL Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, perché sarebbe tecnicamente possibile anche il monitoraggio delle memorie dei telefonini e delle mail private. Forse è questo che si intende con “Expo, un modello per il Paese”: più controlli per tutti.
 E’ vero che le frasi da scrivere sulla bandiera sarebbero numerose. L’immortale “tengo famiglia” va sempre bene, certo, e anche “state sereni” ci starebbe. Ma suggerirei, per aggiornare il repertorio, un più moderno motto che sta diventando pian piano slogan e simbolo perfetto per descrivere il Paese: “Era meglio il rendering”. Come tutti sanno, il rendering è la simulazione grafica di come verrà una cosa una volta fatta. Esempio: si costruisce su un’area pubblica e si mostra il rendering di come verrà il progetto a costruzione ultimata: molto verde, bimbi che giocano, parchi, panchine e le case sullo sfondo. Quando si va a vedere il progetto finito, quasi sempre le cose sono un po’ diverse: il cemento è di più, il verde di meno, le fronde ombrose diventano alberelli stenti, le panchine non ci sono. I meravigliosi rendering di Expo, per dire, mostravano acqua a non finire, barchette che la navigavano, orti a perdita d’occhio, agricoltura sostenibile e natura, mentre a cose fatte c’è una bellissima Gardaland, ma senza le giostre. L’ultimo caso di “era meglio il rendering” riguarda sempre Milano, ma è cosa piccola e, se vogliamo, tenera e affettuosa. Il grande campo di grano tra i grattacieli di Porta Nuova, opera di Land Art dell’artista Agnes Danes, spiccava nel rendering come una meravigliosa macchia gialla tra le architetture avveniristiche, una specie di “Van Gogh nella terra della speculazione e del mojito”, ed è invece un campo invaso dalle erbacce che farebbe la disperazione di ogni contadino. Si dà la colpa all’acqua che ristagna, al terreno poco adatto, al “troppo bio” della coltivazione. E va bene. Resta il fatto che, appunto, “era meglio il rendering”.
E’ vero che le frasi da scrivere sulla bandiera sarebbero numerose. L’immortale “tengo famiglia” va sempre bene, certo, e anche “state sereni” ci starebbe. Ma suggerirei, per aggiornare il repertorio, un più moderno motto che sta diventando pian piano slogan e simbolo perfetto per descrivere il Paese: “Era meglio il rendering”. Come tutti sanno, il rendering è la simulazione grafica di come verrà una cosa una volta fatta. Esempio: si costruisce su un’area pubblica e si mostra il rendering di come verrà il progetto a costruzione ultimata: molto verde, bimbi che giocano, parchi, panchine e le case sullo sfondo. Quando si va a vedere il progetto finito, quasi sempre le cose sono un po’ diverse: il cemento è di più, il verde di meno, le fronde ombrose diventano alberelli stenti, le panchine non ci sono. I meravigliosi rendering di Expo, per dire, mostravano acqua a non finire, barchette che la navigavano, orti a perdita d’occhio, agricoltura sostenibile e natura, mentre a cose fatte c’è una bellissima Gardaland, ma senza le giostre. L’ultimo caso di “era meglio il rendering” riguarda sempre Milano, ma è cosa piccola e, se vogliamo, tenera e affettuosa. Il grande campo di grano tra i grattacieli di Porta Nuova, opera di Land Art dell’artista Agnes Danes, spiccava nel rendering come una meravigliosa macchia gialla tra le architetture avveniristiche, una specie di “Van Gogh nella terra della speculazione e del mojito”, ed è invece un campo invaso dalle erbacce che farebbe la disperazione di ogni contadino. Si dà la colpa all’acqua che ristagna, al terreno poco adatto, al “troppo bio” della coltivazione. E va bene. Resta il fatto che, appunto, “era meglio il rendering”.
I guai arrivano quando si applica questa faccenda del rendering alla vita dei cittadini e alla politica che la determina. Della legge sul falso in bilancio, per esempio, era meglio il rendering: sembrava una costruzione strabiliante, un rimedio perfetto ai disastri fatti da quel signore che aboliva il falso in bilancio di tutti per non andare in galera con i falsi in bilancio suoi. Bello. Poi, a costruzione conclusa, chiuso il cantiere e tagliato il nastro (cioè scritto tutto sulla Gazzetta Ufficiale) si scopre che era meglio il rendering, e che l’opera reale ha buchi così grossi da farci passare, per dire, un Ligresti.
Visto con il senno di poi (che è il senno di oggi), di tutto il renzismo applicato che subiamo ogni giorno era meglio il rendering. Si mostravano skyline pulitissimi e fascinosi, rottamazioni implacabili della “vecchia politica” (uff!) e generazioni che ricominciavano a vedere il loro futuro. Poi, uscendo dalla simulazione grafica, ci si ritrova con i De Luca ineleggibili ma eletti, per fare solo un caso di scuola (ma sarebbero numerosi). Nel rendering del Jobs act si vedevano precari che acquisivano diritti impensabili, garanzie per i lavoratori atipici, prospettive per precari prima inimmaginabili. Poi, a cantiere finito e nastro tagliato, ci si trova con i lavoratori spiati, occupazione che non cresce, e i precari sono ancora quasi tutti lì, a fare un coro di voci stanche che dice: “Eccheccazzo, era meglio il rendering”. Con la burbanzosa arroganza di chi ha studiato più Jeeg Robot che Gramsci, persino Matteo Renzi lo ammette: il Renzi Uno (lui e i suoi pards che attaccano la diligenza) era meglio del Renzi Due (lui che governa in piena continuità con la politica precedente). Insomma, anche di Renzi, e per ammissione dello stesso Renzi, “era meglio il rendering”.









































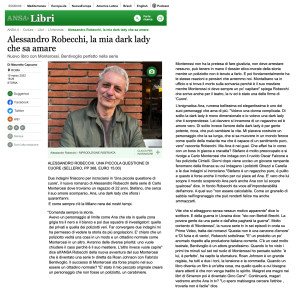




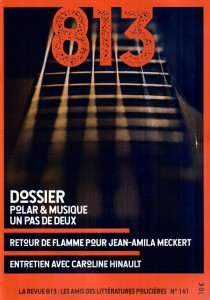

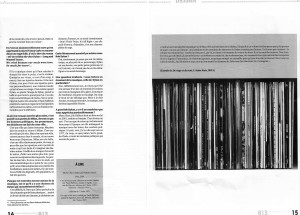

















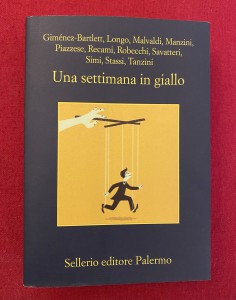




















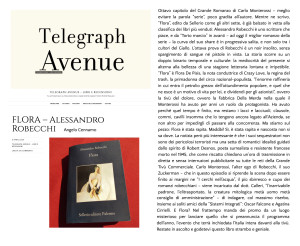












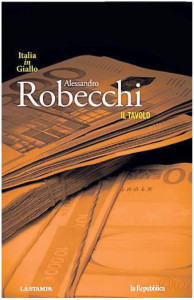












































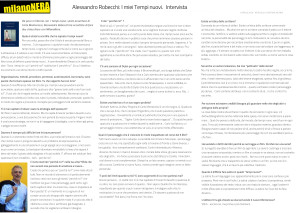
























































































































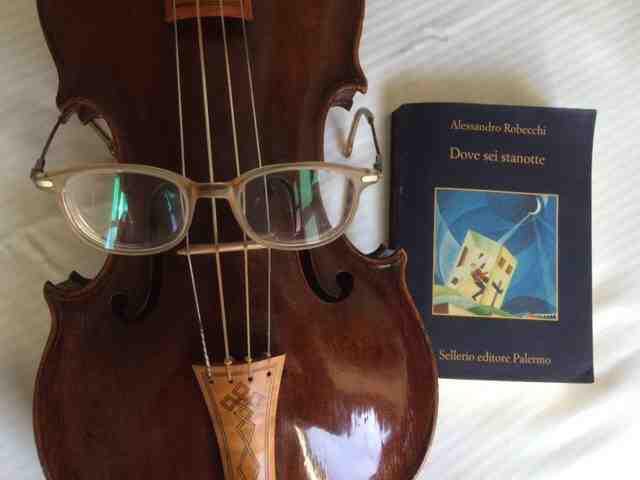






-